 «Dobbiamo dimostrare che la libertà e la sicurezza sono possibili solo se riusciamo a rompere l’isolamento che i restringimenti alla libera mobilità e l’attacco ai salari e al welfare stanno imponendo su tutti: migranti, precarie ed operai».
«Dobbiamo dimostrare che la libertà e la sicurezza sono possibili solo se riusciamo a rompere l’isolamento che i restringimenti alla libera mobilità e l’attacco ai salari e al welfare stanno imponendo su tutti: migranti, precarie ed operai».
connessioniprecarie online, 9 gennaio 2017 (c.m.c.)
L’anno nuovo dei migranti inizia con la svolta securitaria annunciata da un governo nato per portare al voto il paese. Gli annunci dicono che a Bologna come in altre città italiane riapriranno i Cie (uno per ogni regione), mentre il ministro degli Interni e il capo della Polizia promettono una stretta nella politica delle espulsioni: controlli sui luoghi di lavoro per scovare gli irregolari e intensificazione degli accordi bilaterali con i paesi di provenienza per assicurare i rimpatri. L’obiettivo è raddoppiare le espulsioni, che quest’anno si sono fermate a “sole” 5000. La speranza è di raggiungere le 20000 all’anno.
Apparentemente è l’esibizione di forza di un governo che si fa vanto di aver casualmente incontrato in un controllo di routine per le strade di Sesto San Giovanni l’uomo che ha messo a segno la strage di Berlino. Si mettono in mostra i muscoli per convincere i cittadini, a cui il mix di crisi e politiche neoliberali ha sottratto salario e strappato via diritti e welfare, che lo Stato si preoccupa della loro sicurezza. È un risarcimento per chi in questi anni ha perso molto, se non tutto. Perché la sicurezza, come si usa dire negli ambienti di governo, non è un tema della destra, ma riguarda tutti. Per la verità, questo simulacro di sicurezza è l’unica cosa che questo governo può offrire ai cittadini che a breve saranno chiamati alle urne, dato che di fare marcia indietro su Jobs Act, voucher e tutto ciò che ruota attorno a salario e welfare non se ne parla proprio.
La tranquilla e regolare forza dello Stato e l’eroismo dei singoli, che quando non salutano con la mano tesa sanno piazzarla sul grilletto per sparare: è la ricetta per contenere una rabbia diffusa e poco disposta a seguire indicazioni politiche. I migranti sono così l’oggetto di uno scambio talmente ignobile da non poter essere nominato: cacciamo loro perché non possiamo e non vogliamo scacciare le vostre paure quotidiane.
Non si tratta però soltanto di pura retorica autoritaria. Dopo aver respinto le domande di asilo di decine di migliaia di migranti bisognerà pure trovare un posto dove metterli, che non siano i parchi e i ponti dove già vivono. Cie ed espulsioni rientrano allora nella logica del razzismo istituzionale. Sono il tassello mancante, e tutto sommato più a buon mercato, della politica dei dinieghi e dell’emergenza con cui fino ad ora è stato governato l’afflusso dei migranti rifugiati.
Contro questa politica, nelle ultime settimane, a Bologna, Milano e Roma i migranti hanno rotto il silenzio civile e civico su come viene gestita la presenza dei richiedenti asilo, denunciando come il razzismo istituzionale di Questure e Prefetture produca una situazione di attesa in cui i migranti sono costretti a lavorare in condizioni di assoluta precarietà.
Un minimo di realismo permette di capire che la svolta securitaria non può essere e nemmeno vuole essere la soluzione finale alla clandestinità. Essa appare piuttosto come un tentativo di diminuire il numero di migranti sulla soglia dell’irregolarità e inviare un messaggio prima che la bolla dei dinieghi esploda. La cifra di 10000 espulsioni annue è infatti irrisoria: solo nel 2015 le commissioni territoriali hanno “prodotto” 41mila clandestini, per non parlare di chi perde il permesso di soggiorno perché manca lavoro o per reddito insufficiente, o delle crescenti difficoltà di ottenere i documenti dalle Questure, che ormai ritirano le carte di soggiorno perfino ai minori. Il messaggio è per i migranti, ma anche per chi migrante non è: l’unico scopo possibile è quello di perpetrare una segmentazione del mercato del lavoro funzionale a tenere i salari sotto controllo.
La riapertura dei Cie è allora una misura di prevenzione che conserva e anzi intensifica le condizioni per lo sfruttamento, tanto più che il lavoro nero potrà continuare a contare su un discreto bacino d’utenza. La vita nei nuovi Cie sarà poi come quella molti migranti hanno già hanno già conosciuto nei vecchi Cie. Sarà un’esistenza ingiusta, misera e indifferente come quella che sperimentano oggi nei centri di accoglienza. Per questo e non per altro la storia dei Cie e dei centri d’accoglienza è costellata di rivolte, da ultima quella che ha coinvolto il centro di Cona.
Nella filiera che dalle commissioni territoriali alle Questure arriva fino alle espulsioni, passando per i Cie, si produce dunque clandestinizzazione mobile e flessibile, che assicura la presenza di una forza lavoro migrante sulla soglia dell’irregolarità che, se non vuole essere espulsa, deve accettare il ricatto insito nella propria condizione. A loro e agli altri, operai e precarie, si garantisce esclusivamente di mantenere inalterata la propria solitudine.
Contro questo esito non basta un moto d’indignazione democratica e in pelle bianca. C’è bisogno di uno scarto profondo nei comportamenti e nelle scelte politiche. Nessuno può pensare di approfittare della vetrina mediatica per farsi pubblicità con proclami e iniziative simboliche. Queste cose ci sono state già troppe volte e non sono più accettabili. Chi davvero vuole opporsi alla riapertura dei Cie deve necessariamente coniugare il proprio antirazzismo con l’iniziativa autonoma dei migranti.
Occorre oggi la capacità di attaccare la solitudine alla quale il piano securitario vuole condannare tutti, partendo dai migranti anche perché i migranti stessi stanno indicando una strada: la necessità di ribellarsi a una politica della paura che vuole mettere a tacere non solo i migranti, ma anche precari e precarie, operai e operaie. Stabilire una connessione tra tutte queste figure è la sola strada per opporsi alla riapertura dei Cie in Italia e a Bologna.
La nostra risposta deve superare i confini angusti della nostra giusta indignazione. Deve mostrare che la riapertura dei Cie vuole colpire con più violenza i migranti per chiudere altri spazi di libertà e mettere politicamente a tacere anche chi pensa così di essere più “sicuro”.
Contro l’ignobile scambio che ci viene proposto dobbiamo dimostrare che la libertà e la sicurezza sono possibili solo se riusciamo a rompere l’isolamento che i restringimenti alla libera mobilità e l’attacco ai salari e al welfare stanno imponendo su tutti: migranti, precarie ed operai.
 «In Italia infatti a fronte delle migliaia di migranti spesso concentrati nelle stesse strutture in condizioni bestiali, esiste un patrimonio vuoto o inutilizzato di case o appartamenti superiore ad otto milioni di unità».
«In Italia infatti a fronte delle migliaia di migranti spesso concentrati nelle stesse strutture in condizioni bestiali, esiste un patrimonio vuoto o inutilizzato di case o appartamenti superiore ad otto milioni di unità». il manifesto
, 7
gennaio 2017 (c.m.c.)
Assistere agli spettacoli da dannati della terra» offerti, oggi come ieri, da Cpa e Cie – e per di più nel nostro paese con milioni dei case vuote da rendita finanziario-immobiliare – è mostruosamente grottesco e inaccettabile. Sono da condividere le uscite di coloro che in queste ore ricordano i continui e clamorosi tragici fallimenti delle strutture a grande concentrazione di immigrati, le tristi sigle di questi anni: Cpa, Cie , Cat, per indicare soluzioni molto diverse. Così come da condividere sono le posizioni di chi – come Luigi Manconi- argomenta la sostanziale mistificazione che sta dietro alla categoria di clandestino; laddove sostanzialmente tutti coloro che arrivano (ormai riconosciuti e schedati) fuggono da disastri sociali o bellici o ambientali.
Sarebbe bene che Marco Minniti guardasse più a Papa Francesco e meno a Matteo Salvini; i tentativi di mediazione impossibili tra approcci troppo diversi, se non opposti, hanno significato disastri,troppo spesso.
Il frettoloso annuncio di «una stretta a controlli e espulsioni» rischia di mettere in crisi quel poco di buono che il governo – tramite le prefetture – sta esprimendo, in termini di presa d’atto dei fallimenti delle macrostrutture citate (a parte sprechi ,corruzione e mafie) e di cooperazione con i comuni disponibili e con l’Anci per l’inserimento di ridotti nuclei di migranti in quanti più comuni possibile. Tali strategie possono e devono diventare politiche permanenti nel periodo medio-lungo . Da comprendere nelle azioni di riqualificazione urbanistica e sociale di città e territori.
In Italia infatti a fronte delle migliaia di migranti spesso concentrati nelle stesse strutture in condizioni bestiali, esiste un patrimonio vuoto o inutilizzato di case o appartamenti superiore ad otto milioni di unità (Istat,2011) ; di queste quasi il 60 % sono effettivamente vuote . Mentre circa 450.000 edifici risultano completamente abbandonati. E parliamo solo di abitazioni, perché se aggiungiamo i volumi ex industriali e commerciali le cifre crescono di molto.
Il «vuoto nazionale» è talmente rilevante da costituire un enorme monumento allo spreco sociale , economico e ambientale.
Oltre che una ferita al paesaggio del Belpaese , anche per il consumo di suolo che ha comportato. Le cifre sono tali da permettere non solo azioni di accoglienza molto più vaste di quelle di cui oggi si parla , ma anche il totale soddisfacimento della domanda abitativa da disagio interno (poco più di 250.000 famiglie: solo le case vuote di Roma e Milano basterebbero quasi a soddisfare tale domanda).
Un problema è rappresentato dal fatto che oltre due terzi di tale patrimonio è privato . Ma proprio per questo l’accoglienza deve diventare una delle componenti fondamentali delle azioni, non solo abitative ma di nuova qualità civile e ambientale delle città. Come già avviene in alcuni comuni – in primis Riace in Calabria – si possono ricercare accordi che portino a protocolli di utilità sociale con i proprietari disponibili (che ne hanno il vantaggio del riuso del bene, spesso con azioni di piccola ristrutturazione o manutenzione straordinaria).
Mentre, laddove la proprietà è rappresentata da persone non fisiche – spesso immobiliari a scopo di lucro – che tengono fuori dal mercato sociale milioni di appartamenti, sovente esentasse perché dichiarati «beni destinati alla vendita» (tutti gli ultimi governi hanno annunciato di voler cancellare tale paradossale iniquità, ma ancora non è successo nulla) vanno ricercati gli idonei strumenti coercitivi: dalla tassazione progressiva sul vuoto/inutilizzato fino alla requisizione per pubblica utilità
L’Anci sottolinea come i migranti ospitati potrebbero svolgere a paga sociale lavori utili alle strutture urbane come raccolta differenziata, piccole riparazioni, cura degli arredi del verde, etc. In realtà – come sottolineato di recente dalla Società dei Territorialisti- tale presenza può agire aspetti molto più strutturali, favorendo la ricostituzione di tessuti socioculturali, oggi spariti, fino alla riqualificazione dei paesaggi urbani e abitativi.
Di più i migranti possono essere gli attori principali di opzioni di sviluppo sostenibile territorializzato – più che mai necessari-soprattutto nei centri abbandonati, che, come già avviene in alcuni contesti meridionali, possono vivere nuove stagioni di sostenibilità sociale legate all’agrorurale e al visiting socioculturale del paesaggio, per esempio. I centri della Piana di Gioia Tauro possono vedere un futuro di riqualificazione sostenibile legato alle strategie di accoglienza, se i migranti passano dai campi simil-profughi in cui vivono oggi a Rosarno e dintorni ad abitare le strutture vuote dei paesi del contesto.
 «Se definiamo e trattiamo come clandestini tutti gli irregolari si avrà un effetto sicuro: spingeremo verso l’illegalità criminale proprio coloro che vogliono emergere alla legalità della regolarizzazione».
«Se definiamo e trattiamo come clandestini tutti gli irregolari si avrà un effetto sicuro: spingeremo verso l’illegalità criminale proprio coloro che vogliono emergere alla legalità della regolarizzazione».
il manifesto, 6 gennaio 2017 (p.d.)
Il Ministro dell’interno, Marco Minniti, che è persona intelligente e tutt’altro che sprovveduta, già ha dovuto ridimensionare l’annuncio sfuggitogli, nonostante l’accortezza che connota il suo stile pubblico. Il proposito di istituire «un Cie in ogni Regione» ha avuto vita breve, appena una manciata di ore, ed è sembrato rispondere più all’intento di sedare ansie diffuse che a quello di realizzare una strategia razionale. Per una serie di ragioni rivelatesi, alla luce dalla storia pregressa dei Cie (dal 1998 a oggi), inconfutabili.
In estrema sintesi, i Cie rappresentano un autentico fallimento. Prendete quella sigla: l’acronimo richiama due funzioni – identificazione ed espulsione – che costituiscono lo statuto giuridico dei Cie e la loro sola finalità normativa.
Nel tempo trascorso dall’approvazione della legge n. 40 del 1998, l’identificazione ha riguardato solo una quota minoritaria degli stranieri trattenuti in questi centri: e il dato stride con quella percentuale di oltre il 94% di identificati, grazie a procedure e a strutture diverse da quelle dei Cie, tra le persone sbarcate in Italia nel 2016. Insomma, in base a quanto appena detto, la funzione istituzionale dei Cie risulta residuale se non praticamente esaurita.
Per quanto riguarda le espulsioni, la vicenda di Anis Amri, l’attentatore di Berlino, è la dimostrazione più limpida, e allo stesso tempo drammatica, di come tutte le misure di cui in questi giorni si è discusso con tanta foga siano approssimative, anche quando utili; e ancora più spesso sgangherate, quando si affidano a messaggi emotivi, destinati a blandire le pulsioni più oscure della società. Anis Amri trascorre quattro anni in un carcere italiano e viene poi trattenuto nel Cie di Caltanissetta, dove viene avviata la pratica di espulsione. Ma accade che le autorità consolari della Tunisia, che pure ha sottoscritto un accordo per la riammissione, si rifiutano di riconoscere Amri come connazionale.
Di conseguenza, il provvedimento di espulsione risulta ineseguibile e Amri, che ha espiato la sua pena, torna libero. Ma il futuro esecutore della strage di Berlino è persona identificata, riconosciuta, fotosegnalata, della quale sono state rilevate le impronte digitali e il cui curriculum criminale e giudiziario, sociale e persino politico (si ipotizza una possibile radicalizzazione) è stato regolarmente depositato nella banca dati europea. Quella banca dati a cui accedono le forze di intelligence e di polizia dei diversi paesi dell’Unione. Nonostante ciò, Amri non solo può organizzare e realizzare il suo progetto terroristico, ma può attraversare tre (forse quattro) paesi europei prima di trovare la morte a Sesto San Giovanni.
Se ne ricava che anche provvedimenti opportuni, come gli accordi con le nazioni extraeuropee, non offrono soluzioni miracolistiche: perché si tratta di paesi profondamente instabili, o lacerati da guerre civili, o soggetti a regimi totalitari; e perché, infine, quegli stessi paesi non hanno alcun interesse a riammettere connazionali che potrebbero rappresentare una minaccia per l’ordine interno.
La fragilità di tutte le soluzioni prospettate significa forse che non vi siano vie d’uscita e che sia fatale arrendersi? Assolutamente no: ancora una volta, è la vicenda di Amri che segnala in maniera inconfutabile come la debolezza delle strategie antiterroristiche risieda nell’impreparazione e nell’inefficienza degli apparati di intelligence e delle forze di polizia; e innanzitutto nel disastroso deficit di comunicazione e cooperazione a livello europeo. Come è potuto accadere, infatti, che il responsabile di una strage atroce, pur se da tempo conosciuto, identificato e segnalato, non sia stato intercettato e fermato? E se fosse vero, come pure credo, che non tutto – e non tutte le insidie, e non tutti i terroristi potenziali – può essere previsto e prevenuto, resta indiscutibile che è lì, esattamente lì, che si deve intervenire, concentrare le energie, focalizzare l’attenzione e le forze.
Dunque, circoscrivere e selezionare gli obiettivi veri, quelli che possono costituire una minaccia reale. E, invece, si fa l’esatto contrario: nel momento in cui si definiscono clandestini tutti gli irregolari, e si trattano tutti gli irregolari come clandestini e terroristi, e su questo meccanismo di sospetto si organizzano le politiche del controllo e della repressione, si ottengono due risultati analogamente perversi. Si finisce col trascurare i nemici veri e si trasformano in nemici coloro che nemici non sono affatto. Se definiamo e trattiamo come clandestini tutti gli irregolari – per esempio, la gran massa di quanti sono impiegati in nero in agricoltura o nell’edilizia – si avrà un effetto sicuro: spingeremo verso l’illegalità criminale proprio coloro che vogliono emergere alla legalità della regolarizzazione.
Ancora una volta, dunque, si dimostra come solo politiche sociali intelligenti rappresentino il contesto indispensabile per contrastare i fenomeni criminali.
Infine, il ministro dell’Interno ha detto: «I Cie non avranno nulla a che fare con il passato». Voglio considerarla una condanna inappellabile per ciò che sono stati e sono oggi i Cie: strutture orribili, dove vengono violati costantemente i diritti fondamentali della persona. Un non luogo precipitato nel non tempo.
 «Di per sé la paura non è negativa, è l’altra faccia della prudenza. Il problema è quando viene amplificata, per interesse».
«Di per sé la paura non è negativa, è l’altra faccia della prudenza. Il problema è quando viene amplificata, per interesse».
Il Fatto Quotidiano, 6 gennaio 2017 (p.d.)
Franco Cardini, storico medievalista e voce critica sulle ipocrisie e le semplificazioni dell'Occidente iper capitalista, alla paura ha dedicato un libro: La paura e l'arroganza (in chiara opposizione alle tesi di Oriana Fallaci nel suo La rabbia e l’orgoglio) che ospita scritti di autori come Noam Chomsky, Massimo Fini, Alain de Benoist e l'Ayatollah Seyed Ali Khamenei. Secondo Cardini la paura collettiva, elemento che si ritrova in ogni epoca e civiltà, ha dei picchi nei periodi di decadenza e ignoranza diffusa, anche perché è un sentimento che si autoalimenta. Per contrastarla, serve senso critico, cultura, consapevolezza.
Professor Franco Cardini, stiamo attraversando un periodo fertile per le psicosi collettive?
La paura c’è sempre stata. Come dicono gli psicanalisti, è una capacità eccessiva di esercitare la propria fantasia. E di per sé la paura non è un elemento negativo: è anche l'altra faccia della prudenza. Il problema sorge quando viene amplificata, per interesse. Perché poi le paure tendono a riprodursi da sole.
È quello che succede in questo inizio d’anno?
C'è una specie di forza policentrica in atto che alimenta le paure. In alcuni casi, per esempio la paura dei diversi, dei migranti, lo scopo è ottenere una facile ricaduta politica. Se le democrazie fossero gestite da persone che, come si diceva nell'800, hanno a cuore il bene dei cittadini, questo non succederebbe.
È una classica tesi della sinistra anticapitalista che la paura sia funzionale alla società dei consumi.
In queste tesi c'è molto di vero. Si pensi solo a tutto il surplus di provvedimenti adottati per la sicurezza aeroportuale dopo l'attacco alle Torri Gemelle negli Stati Uniti. È stato notato che hanno dato la stura a un enorme business, non solo per le apparecchiature di controllo: si sono fatti nuovi affari con cose come le buste di plastica per contenere i liquidi; è aumentato il fatturato degli aeroporti con le vendite di bibite o panini a causa delle lunghe code che si formano per i controlli.
Qual è il ruolo dei media?
Il modo di fare informazione può alimentare la paura ma anche tenerla lontana. Faccio un esempio: il Tupolev russo caduto nel Mar Nero a Natale con a bordo il coro dell'Armata Rossa, che è una istituzione nazionale. I russi hanno subito smentito che si trattasse di terrorismo e hanno imposto una sorta di silenzio stampa. E infatti lì non s’è creato alcun panico terrorismo. Se fosse successa da noi una cosa simile si sarebbe parlato di ‘colpo al cuore dell'occidente’, aumentando ancora di più le psicosi. Sono due approcci opposti, ma spiegano il ruolo dell'informazione. In Italia purtroppo abbiamo un tipo di informazione prevalente che non invita alla critica ma all'esagerazione delle sensazioni.
E quindi?
Bisogna fare appello alla cultura, al senso critico e della responsabilità per contrastare le paure. Nella società dell'immagine e dello spettacolo ormai ciò che succede è ciò che succede sui media. Se una cosa accade e non ne parla nessuno è come se non accadesse, mentre se non accade davvero ma i media ne parlano, è come se fosse successa. Le centrali terroristiche ci vivono su questo. L'impatto della loro attività è dovuto per il 10 per cento alle loro azioni, per il 90 per cento al fatto che se ne parla.
Ora l'informazione viene presa in gran parte dal Web che è un po' un territorio selvaggio. Quali sono le conseguenze?
È un po’come nel caso delle infezioni. Bisogna rassegnarsi al fatto che siamo tutti vulnerabili alla sovraesposizione di notizie non controllate e non verificabili. Cosa che ci espone più facilmente alle paure. Col tempo, come per le infezioni, svilupperemo degli anticorpi, o almeno lo spero. Il rischio è che dopo la paura subentri la rassegnazione e il fatalismo, dei commenti che cadono nel vuoto, senza una vera consapevolezza. Il problema è che l'Italia è una società culturalmente e civilmente molto debole. Si deve rendere conto che certi problemi vanno affrontati. Bisogna fare appello alla cultura, al senso di responsabilità.
La psicosi terrorismo però non è un problema solo italiano.
Ieri ho attraversato Parigi all’una di notte. Era assolutamente deserta. È gravissimo. Bisognerebbe reagire al terrorismo, come cittadini, senza modificare il proprio stile di vita, rispondere come se niente fosse. Anche perché è un problema che andrà avanti a lungo.
Perché?
Credo che il Califfato avrà un’agonia molto lenta. Sono solo in 50 mila i combattenti ma sopravvivono nonostante tutte le forze armate che li contrastano. La ragione sta nel fatto che evidentemente sono funzionali a interessi ben radicati.

Articoli di Ernesto Milanesi, Carlo Lania, Leo Lancari, Rachele Gonnelli, sulle più recenti malefatte della politica italiana di respingimento dei profughi, esuli e sfrattati del continenteil manifesto, 4 gennaio 2017
TENDOPOLI DI CONA AL COLLASSO
E LA MORTE DI SANDRINE INNESCA LA RIVOLTA
di Ernesto Milanesi
«I richiedenti asilo stipati al freddo e al buio nella ex base missilistica nelle campagne veneziane. Una bomba a orologeria. Il dramma della giovane rifugiata ivoriana colpita da malore Si era imbarcata in Libia ed era in attesa del riconoscimento dello status»
SANDRINE BAKAYOKO, 25 anni, si era imbarcata con il compagno nelle coste della Libia: dal 30 agosto erano in Italia, da tre mesi nell’ex base missilistica in mezzo alla campagna, aspettando sempre il riconoscimento di rifugiati. Lunedì mattina la ragazza è entrata in uno dei bagni, nell’area riservata alle donne, che possono chiudersi a chiave. Non vedendola più, il compagno ha dato l’allarme alla coop che gestisce la struttura. Forzata la porta, Sandrine era a terra priva di sensi. Alle 12.48 è partita la telefonata al 118 che ha inviato un’ambulanza da Cavarzere e l’auto medica da Piove di Sacco. Poco dopo le 13 i soccorritori hanno tentato di rianimarla inutilmente: alle 13.46 la constatazione del decesso in ospedale. Secondo l’autopsia effettuata dal medico legale Silvano Zancaner, si è trattato di «tromboembolia polmonare bilaterale fulminante» come hanno confermato il procuratore capo ad interim Carlo Nordio e il pm Lucia D’Alessandro soprattutto per smentire ogni voce di «emergenza sanitaria» a Cona.
Ma la morte di Sandrine nella notte aveva riacceso la miccia della protesta fra i 1.400 migranti, per lo più africani: circondati i container e gli uffici amministrativi dove si era rifugiato il personale della Edeco, accesi falò all’interno, pronti a resistere anche alle forze dell’ordine. Solo in mattinata la trattativa e il “rilascio” delle persone, anche se alcune auto sono state bersagliate dai manifestanti che hanno poi tentato di bloccare l’ingresso dei furgoni con i pasti.
LENTAMENTE, LA RABBIA si è placata. Il cancello d’ingresso presidiato da celerini e carabinieri in assetto anti-sommossa. Il questore Angelo Sanna “sul campo” a garantire la situazione. E Simone Borile di nuovo alle prese con una “grana” per la coop che monopolizza l’accoglienza dei migranti.
Tuttavia, adesso Cona è davvero al centro dell’attenzione. Ai cronisti l’ingresso non viene permesso, nonostante i migranti vogliano documentare le loro condizioni di vita. Sono le stesse verificate dalla delegazione del Progetto Melting Pot che a giugno relazionava così: «Non è un Cas, non è un Cara, non è un hub. È un luogo “temporaneo emergenziale” che sopperisce alla mancata accoglienza dei comuni veneti. L’agibilità della tendopoli è stata regolarmente acquisita tramite parere dell’Asl che il 1 aprile 2016 ha inviato la sua relazione spiegando che la struttura può ospitare 540 persone, considerando che per ogni persona bastano 3,50 metri quadrati e occorre che vi sia un bagno e una doccia ogni 12 persone».
Oggi a Cona torna in “visita” Giovanni Paglia, che ha monitorato la struttura insieme al gruppo di avvocati, medici e volontari locali. «C’ero stato il 16 novembre e poi ho depositato una circostanziata interrogazione-denuncia al ministro dell’Interno senza ricevere risposta» spiega il deputato Sel, «Già allora l’impressione era di un luogo fuori controllo: la sanità scaricata sui medici di base, sovraffollamento e servizi igienici sotto pressione, pochi operatori, pasti consumati in piedi, tende senza nemmeno un armadietto. Insomma, si capiva che Cona poteva esplodere da un momento all’altro…».
E la rivolta di lunedì notte per la morte di Sandrine era stata preceduta da altri episodi che segnalavano il disagio dei migranti. Il 30 agosto alcune decine avevano occupato la strada: un pacifico sit in sui tempi biblici delle pratiche sulla richiesta d’asilo. E già un anno fa un centinaio di ospiti della struttura (che allora ne conteneva la metà) lamentavano le carenze igienico-sanitarie.
Ieri mattina i profughi di Cona hanno invocato di nuovo l’intervento del prefetto Carlo Boffi, proprio perché nell’ex base missilistica fa freddo e manca l’illuminazione senza dimenticare i letti a castello ammassati per un numero di persone triplo rispetto all’originale agibilità.
Infine, il tam-tam della protesta dei migranti in Veneto cresce. A Vicenza, circa 70 richiedenti asilo hanno incontrato il vice-prefetto davanti alla caserma Sasso: contestavano le strutture dell’associazione Mediterraneo per il freddo, gli abiti e l’affollamento. A Verona, invece, i residenti dell’ostello Santa Chiara nel quartiere Veronetta hanno protestato per la qualità del cibo paralizzando il traffico, rovesciando i cassonetti e sfogandosi con le auto in sosta.
LE MANI SUL BUSINESS DEI PROFUGHI.
MA IL “SISTEMA” DI BORILE & C NON È INOSSIDABILE
di Ernesto Milanesi
«Gare anomale nelle prefetture venete. Fatture, contratti e maltrattamenti. Le inchieste sui bandi vinti da Ecofficina e Edeco, le due coop gestite dall'ex Dc e Forza Italia»
Dal consorzio inter-comunale dei rifiuti alle coop “sussidiarie” non solo ai migranti. La vicenda di Cona rinvia al profilo di Simone Borile e alle inchieste aperte dalle Procure di Padova e Rovigo.
Borile è un ex Dc, poi consigliere provinciale di Forza Italia, che ha ottenuto più di un incarico pubblico: dal CdA dell’istituto per minorati della vita Configliachi a quello dell’Ater fino alla breve presidenza del Parco Colli Euganei. Poi passa al Consorzio Padova Sud, anche con il ruolo di direttore di Padova Tre Srl (gestione dei rifiuti nei Comuni della Bassa). Proprio su iniziativa di questa società nasce nel 2011 la prima coop: Ecofficina Educational che fornisce servizi e gestisce asili nido, con al vertice Paolo Mastellaro, esponente del Pd. Nel febbraio 2015, la “scissione”: da una parte Edeco con sede a Battaglia Terme e Sara Felpati – moglie di Borile – come amministratore; dall’altra Ecofficina Servizi con sede a Este gestita da Mastellaro che colleziona progetti di educazione ambientale nelle scuole pagati dal Consorzio.
Edeco, invece, si dedica solo ai profughi. Non solo a Cona, perché ha ottenuto anche le ex basi militari a Bagnoli di Sopra (Padova) e Oderzo (Treviso) e l’anno scorso si è occupata dell’ex caserma Prandina, hub provvisorio nel centro di Padova. Un vero affare: più di 15 milioni secondo l’ultimo bilancio che contabilizza 180 dipendenti, di cui solo una cinquantina soci della cooperativa.
Ma il “sistema” di Borile & C non è inossidabile. A maggio 2015, il pm Federica Baccaglini apre un fascicolo sul bando per venti posti del servizio Sprar a Due Carrare: «Carte false» con l’avallo di una funzionaria della prefettura. E si moltiplicano i guai giudiziari con la Guardia di Finanza che setaccia le fatture delle due coop, le verifiche dei carabinieri sugli addetti alle pulizie, la denuncia per maltrattamenti e truffa nelle strutture di Montagnana. A quel punto diventa inevitabile la “scomunica” di Ugo Campagnaro, presidente regionale di Confcooperative: «Non esiste una legge che impedisce di ospitare centinaia di profughi in un’unica struttura. Questo però è un sistema che non risponde alle logiche della buona accoglienza, della qualità dell’intervento, dell’integrazione e della relazione. È un modello che guarda soprattutto al business. E per questo vogliamo prendere le distanze da un simile soggetto e dalla maniera in cui opera».
Del resto, la cronaca di Andrea Priante pubblicata otto mesi fa dal Corriere Veneto non lasciava molti dubbi sullo stile di Edeco: «Lavorerò sei giorni su sette, dalle 9 del mattino alle 7 di sera. Il pagamento sarà in voucher: 200 euro alla settimana, che togliendo la pausa pranzo fanno 3 euro e 70 centesimi l’ora. Ma presto, se tutto andrà bene, arriverà un vero contratto e allora lo stipendio supererà i mille euro al mese…». Come sulla situazione nella vecchia base nella campagna veneziana: «Mi diventa subito lampante quale sia il problema più grande: uomini di Paesi, culture e religioni diverse, stipati come polli dentro stanze disadorne, possono trasformare quel posto in una bomba a orologeria».
Un’anomalia riassunta dalle cifre: su circa 10 mila profughi accolti in Veneto oltre 2 mila risultano affidati alle coop di Borile. «Chi protegge Ecofficina?» chiedeva a settembre il M5S con la parlamentare Silvia Benedetti e i consiglieri comunali della Bassa padovana Luca Martinello, Andrea Bernardini, Filippo Gallocchio, Francesco Roin e Lorella Giordan. Sollecitavano l’intervento di Autorità anti-corruzione e Corte dei Conti sulla regolarità delle gare nelle prefetture venete. Finora, senza risposta.
IL VIMINALE AI PREFETTI:
BASTA SITUAZIONI A RISCHIO
di Carlo Lania
«Una circolare invita ad alleggerire i comuni con più migranti. Via al piano con l’Anci»
Situazioni come quella vista in questi giorni a Cona non devono più verificarsi. Per questo il Viminale ha già inviato una circolare ai prefetti invitandoli a decongestionare al più presto le situazioni maggiormente a rischio e a non inviare più profughi nei comuni che già li ospitano. E’ il primo punto dell’accordo raggiunto il 14 dicembre scorso dal ministro Marco Minniti con l’Anci, l’Associazione dei comuni italiani, per un nuovo piano nazionale per la distribuzione dei migranti sul territorio. Piano che ha uno dei sui punti forza in un modello di accoglienza più diffusa e ragionata rispetto a oggi, insieme una serie di incentivi economici per i comuni. Nella speranza di riuscire così a convincere anche quei sindaci – e sono la maggioranza – che finora hanno voltato le spalle alle ripetute richieste di aprire le porte ai richiedenti asilo.
Per questo nei giorni scorsi è partita una circolare con cui il responsabile del Dipartimento Immigrazione del ministero degli Interni, Mario Morcone, oltre a spiegare i dettagli del piano ha chiesto ai prefetti di non caricare ulteriormente le amministrazioni che già accolgono migranti, cominciando anzi a decongestionare le situazioni più pesanti.
Il dato dal quale il piano ha preso avvio è la constatazione amara di un fallimento: degli 8.000 comuni italiani, oggi solo 2.600 accolgono migranti e di questi appena 1.300 partecipano al sistema Sprar, il programma di protezione richiedenti asilo e rifugiati. Ed è solo tra questi 2.600 municipi che sono distribuiti i circa 180 mila migranti in prima accoglienza. Chiaro che in questo modo le situazioni di tensione e malessere per tutti – popolazioni locali e migranti – rischiano di essere all’ordine del giorno. Partendo dunque dalla necessità di rimettere mano a un sistema che da tempo mostra la corda, si è arrivati a stabilire un numero massimo di migranti che un comune accogliere in base alla sua popolazione: 2,5 ogni mille persone per i comuni con più di 2.000 abitanti, vale a dire che una cittadina con diecimila abitanti si troverebbe a gestire al massimo 25 richiedenti asilo. Cifra più che ragionevole e sufficiente a non creare particolari tensioni.
L’Anci ha chiesto però di tutelare maggiormente i piccoli comuni, quelli con meno di 2.000 abitanti e di stabilire percentuali diverse per le aree metropolitane. Due punti che costituiranno l’ordine del giorno di un nuovo incontro tra i rappresentanti dei sindaci e il ministero Minniti previsto per i prossimi giorni. La proposta avanzata dai sindaci, che sembra però trovare d’accordo anche il Viminale, è quella di non destinare più di tre, quattro migranti ai comuni più piccoli e fissare in 1,5 richiedenti asilo ogni mille abitanti la quota per le grandi città.
L’intenzione è quella di coinvolgere al massimo i primi cittadini, chiedendo di preparare loro stessi i progetti per l’accoglienza e l’integrazione senza dover più subire decisioni dall’alto. «Se un sindaco sa quanti migranti arriveranno nel suo territorio, dove alloggeranno e cosa faranno, può anche accettarli», spiega il primo cittadino di Prato Matteo Biffoni, responsabile Immigrazione per l’Anci. Tanto più che, in maniera volontaria, i migranti potranno essere utilizzati per lavori utili alla cittadinanza, come la pulizia dei giardini o l’assistenza agli anziani. «Lavori che non sostituiscono ma che andrebbero ad aggiungersi a quelli svolti dagli italiani, e senza alcun costo per le comunità», ci tiene a precisare il sindaco di Prato.
C’è infine il capitolo che riguarda gli incentivi economici. Proprio in questi giorni sono in distribuzione i fondi stanziati dal governo Renzi per i comuni che già accolgono richiedenti asilo: 500 euro a profugo per un totale di 100 milioni che i sindaci potranno utilizzare come vorranno e non vincolati a progetti legati all’accoglienza. I sindaci – e questo è un altro punto che verrà affrontato con Minniti, chiedono inoltre di poter infrangere il patto di stabilità e di assumere personale in più per i settori che si trovano maggiormente sotto pressione come, ad esempio, le anagrafi comunali, i servizi sociali e le polizie municipali. Ma anche che i 100 milioni stanziati da Renzi come una tantum, diventino un contributo strutturale, magari i destinando 0,50 euro al giorno per ogni migrante ospitato. Soldi da utilizzare naturalmente per tutti i cittadini.
Dopo la firma di dicembre, entro gennaio di arriverà alla definizione dei particolari sia con l’Anci con in sede di Conferenza Stato-Ragioni in modo da poter partire al più presto. «Certo, i tempi sono lunghi – conclude Biffoni – e si arriverà a regime non prima della fine dell’anno quando potremo finalmente tracciare un primo bilancio. Ma finalmente si è presa la strada giusta per evitare che in futuro si ripetano situazioni come quelle che stiamo vedendo in questi giorni».
MANCONI: «ATTENZIONE
A CRIMINALIZZAZIONI PERICOLOSE »
di Leo Lancari
«Luigi Manconi, presidente commissione Diritti umani del Senato. "La quasi totalità dei migranti che arriva in Italia viene registrata. Non stiamo parlando quindi di un esercito di clandestini senza nome e senza volto"»
<img src="http://ilmanifesto.info/cms/wp-content/uploads/2017/01/03/04desk2-sotto-destra-valigia-ceuta-migranti-b6.jpg" />
«Che senso ha la parola d’ordine ’un Cie in ogni regione’? Si sta rilanciando l’equazione sciagurata irregolare uguale terrorista, spingendo così alla clandestinità quanti invece vorrebbero emergere alla legalità della regolarizzazione». Il presidente della commissione Diritti umani del Senato Luigi Manconi non è per niente convinto delle misure contro gli immigrati irregolari annunciate dal ministro degli Interni Marco Minniti.
L’attentato di Berlino ha provocato una svolta repressiva nella gestione dei migranti irregolari.
Credo che la discussione pubblica sia profondamente deformata da tre paradossi. Il primo riguarda la questione dei rimpatri. Anis Amri, l’attentatore di Berlino, ha trascorso quattro anni in un carcere italiano, poi è stato trasferito nel Cie di Caltanissetta per essere rimpatriato ma le autorità consolari tunisine, nonostante vi sia un accordo di riammissione, si rifiutano di riconoscerlo come loro concittadino. Dunque gli viene notificato l’ordine di lasciare l’Italia. La sua storia giudiziaria – comprese le notizie riguardanti una sua possibile radicalizzazione – viene registrata nel database comune a tutti gli stati europei. Parliamo quindi di uno straniero identificato, passato attraverso tutte le procedure della legge, i cui movimenti sono stati monitorati e comunicati tra le forze di polizia dei diversi paesi. Nonostante ciò, non è stato possibile impedire l’attacco di Berlino.
Questo significa che bisogna arrendersi?
No, piuttosto che non esistono soluzioni miracolose.
E il secondo paradosso?
Il secondo paradosso riguarda il reato di clandestinità: norma inutile, meramente simbolica e schiettamente reazionaria che punisce non un atto ma una condizione esistenziale. Per giunta lenta perché, in ragione di quanto previsto dal nostro ordinamento, esige un lungo iter processuale (tre gradi di giudizio). Per questo e per la violazione del fondamentale diritto umano alla libertà di movimento, andava abrogata. Ma così non si è fatto per sudditanza psicologica nei confronti delle destre. Ora, finalmente, si rivela un arnese arruginito. E poi c’è il terzo paradosso che riguarda l’identificazione degli stranieri. Di oltre il 90% delle 180.000 persone sbarcate nel 2016 in Italia conosciamo dati anagrafici e impronte digitali grazie al foto-segnalamento che avviene appena giunti sulle nostre coste. Dunque la quasi totalità dei migranti sbarcati viene registrata e i dati vengono acquisiti all’interno di una banca-dati europea. Perciò non stiamo parlando di un esercito di clandestini senza volto e senza nome.
Resta il problema di una scarsa collaborazione e scambio di informazione tra le varie polizie europee.
La vera questione sicurezza è rappresentata proprio dalla debolezza dell’attività di intelligence, controllo del territorio e cooperazione a livello europeo. Come dimostra in maniera lampante la vicenda di Amri, il problema è rappresentato dalla scarsa efficienza dell’attività di prevenzione nei confronti di coloro che operano a fini terroristici. Si tratta, dunque, di concentrare l’attenzione, focalizzare gli interventi e selezionare con intelligenza gli obiettivi. E, invece, si fa l’esatto contrario: si rilancia l’equazione “irregolare uguale clandestino uguale terrorista”. É un’assimilazione sciagurata, che ha l’effetto di criminalizzare chi è irregolare esclusivamente per necessità e di spingere verso la clandestinità criminale quanti, al contrario, vorrebbero emergere alla legalità della regolarizzazione. Nella stragrande maggioranza dei casi chi è chiamato clandestino è, in realtà, uno straniero che non ha un titolo valido per vivere nel nostro paese per una serie di ragioni, prima tra tutte una normativa estremamente rigida ed escludente, con requisiti sempre più discriminatori. E clandestine, va ricordato, sono le migliaia di persone impiegate “in nero” nell’agricoltura e nell’edilizia.
Verso le quali come bisogna agire?
Si tratta di persone da regolarizzare e non da chiudere in un Centro di identificazione ed espulsione. Del resto, la popolazione trattenuta in quei centri ne è la dimostrazione: ex-detenuti, stranieri residenti in Italia da anni ma che hanno perso il lavoro, vittime di tratta, persone apolidi, diciottenni nati e cresciuti in Italia ma privi di cittadinanza. E parliamo di strutture dove i diritti fondamentali vengono costantemente violati, i cui costi sono enormi e che presentano un bilancio disastroso: nella migliore delle ipotesi appena la metà dei trattenuti viene rimpatriata. Qual è il senso, dunque di una parola d’ordine come «un Cie in ogni regione»?
«Oltre il 77 percento dei circa 180 mila profughi entrati nel sistema di asilo italiano vive in un limbo, ammassato in mega strutture inadatte»
Il Veneto della rivolta di Cona, governato dalla Lega Nord, è una delle regioni meno virtuose a livello di buone pratiche per l’accoglienza ai migranti e richiedenti asilo. Su un totale di 14.221 immigrati presenti sul suo territorio al 30 novembre scorso (dati del Viminale), appena 519 sono quelli che hanno trovato posto nel circuito Sprar, mentre quasi 11 mila (10.627) persone sono state ammassate nelle cosiddette «strutture temporanee» gestite dalle Prefetture con una modalità che non riesce ad uscire da logiche emergenziali e basate su mega strutture di contenimento.
In tutta Italia la mancanza di collaborazione degli enti locali, su cui si basano i bandi dei progetti Sprar, che dovrebbero formare una rete capillarmente diffusa di accoglienza accurata e finalizzata a integrare economicamente e socialmente i migranti in piccoli nuclei, tende a rigenerare logiche securitarie di contenimento in mega strutture come ex caserme o alberghi vuoti.
La Sicilia – come si vede dal grafico – è la regione più virtuosa in questo senso, dove i migranti ospitati negli Sprar sono 4.259, pari però a quelli ancora nel limbo dei Cas, centri di prima accoglienza. Al vecchio piano Sprar del 2015 hanno partecipato soltanto 339 comuni (su 7.983, dopo le ultime fusioni imposte per spending review), 29 province e 8 unioni comunali in 10 regioni. I progetti Sprar 2016 sono appena scaduti e dall’8 agosto scorso il Viminale ha riformato il sistema di accesso cercando di aumentarne la capienza con premi fiscali e agevolazioni agli enti locali che accettano di parteciparvi.
Il ministero dell’Interno non ha mai sposato in modo sistematico l’accoglienza diffusa ma nell’ultimo anno, sulla scia della battaglia delle associazioni antirazziste e umanitarie oltre che a causa delle inchieste della magistratura e dei richiami delle commissioni per i diritti umani di Strasburgo, almeno la tipologia funzionale alla detenzione e ai respingimenti dei migranti economici dei Cie sembrava avviata a un lento dissolvimento.
A rianimare invece l’idea di risolvere il problema dei profughi utilizzando mega strutture come ex caserme – sempre utilizzate dalle prefetture quando non sanno dove dare un tetto ai migranti in arrivo dagli Hotspot – è stata anche una delle ultime puntate di Report prima dell’addio di Milena Gabanelli alla Rai.
Poi il nuovo governo Gentiloni ha spostato Angelino Alfano, che proprio fuggendo dalla gestione della politica sull’immigrazione, poco politicamente redditizio nel centrodestra, è approdato alla Farnesina, lasciando al Viminale Marco Minniti che ha inaugurato il suo dicastero promettendo un ritorno in pompa magna di Cie ed espulsioni, proprio come Matteo Salvini ha sempre sbraitato di volere.
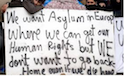 Un articolo di Alessandra Ziniti e due interviste di Massimo Vanni e Paolo Rodari al presidente della Toscana e al Patriarca di Venezia.
Un articolo di Alessandra Ziniti e due interviste di Massimo Vanni e Paolo Rodari al presidente della Toscana e al Patriarca di Venezia.
La Repubblica, 4 gennaio 2017, con qualche domanda in postilla
RABBIA E POLEMICHE
di Alessandra Ziniti
«Serracchiani: io contraria. Dubbi dei sindaci Da Verona a Vicenza, migranti in protesta»
QUEI pochi che sono rimasti aprono e chiudono a singhiozzo tra un incendio e una rivolta. Le bocche cucite con ago e filo degli ospiti di Ponte Galeria, i padiglioni in fiamme di Lampedusa e Brindisi, le pietrate dei siriani rinchiusi a Bari nel centro poi devastato dal fuoco. Filo spinato e luridi stanzoni, giacigli per terra e servizi igienici indecorosi, pericolose promiscuità e soprattutto lunghissimi periodi di “detenzione” in attesa di quell’espulsione che, nel 60 per cento dei casi, continua ad essere impossibile. E attorno “pezzi” d’Italia chiamati ad una difficilissima convivenza.
È una raffica di no quella che, all’indomani dei disordini di Cona seguiti ieri da altre proteste di migranti a Verona e Vicenza, respinge il piano di riapertura dei Cie annunciato dal ministro dell’Interno Marco Minniti. Governatori e sindaci, associazioni umanitarie e sindacati di polizia, esponenti di vertice della stessa maggioranza di governo dicono no al progetto, accolto invece positivamente da Salvini che chiede espulsioni di massa e forze di centrodestra, con il quale il Viminale intende dare una stretta all’emergenza clandestini. «Appena possibile ascolteremo il ministro Minniti. Vogliamo capire se predisporre i Cie in ogni regione sia realmente la risposta giusta all’emergenza immigrazione — dice perplesso il presidente della commissione di inchiesta sui migranti Federico Gelli, del Pd — L’esempio del Cpa di Cona ribadisce l’inadeguatezza di queste strutture che troppo spesso diventano ghetti difficili da gestire ». Con Minniti chiede di parlare anche la presidente del Friuli Venezia Giulia Debora Serracchiani, d’accordo sull’esigenza di maggiori espulsioni ma «assolutamente contraria ai Cie così come li abbiamo conosciuti a Gradisca».
Un Cie in ogni regione per arrivare al raddoppio dei rimpatri di chi non ha diritto a rimanere nel nostro paese. I posti effettivamente attivi in questo momento, a causa del continuo apri e chiudi delle strutture teatro di rivolte da parte degli ospiti, sono 359, meno della metà di quelli originariamente previsti dagli spazi degli unici cinque Cie rimasti in Italia: Roma, Torino, Caltanissetta, Brindisi e Bari (da diversi mesi chiusi dopo gli ultimi danneggiamenti). Per arrivare in tempi brevi all’obiettivo 2000, la strada più breve è la riattivazione di almeno una parte degli altri otto Cie che negli ultimi anni sono stati riconvertiti in hotspot (come Lampedusa e Trapani), in centri di prima accoglienza o per richiedenti asilo o di chiudere perché riconosciuti, come dice monsignor Giancarlo Perego della Cei «centri ingestibili ed esplosivi».
C’è un numero che parla più di altri: dei 175.000 migranti nel circuito dell’accoglienza in Italia più di 150.000 sono ospiti di centri di accoglienza, solo 25.000 nel sistema Sprar che prevede una vera integrazione.
Cpa o Cie poco importa: è di strutture pronte ad esplodere che hanno paura sindaci e governatori. Lo aveva detto subito il sindaco di Lampedusa Giusi Nicolini memore dell’isola trasformata in una prigione a cielo aperto, ma lo dice anche il governatore del Veneto Zaia: «Centri come Cona devono chiudere. Tenere in ostaggio gli operatori, dare fuoco a cose, sono proteste che non si possono giustificare. Bisogna attuare la politica dei rimpatri iniziando da questi signori che fanno casino». Dal centro di via Corelli a Milano a quello di Gradisca d’Isonzo, da Crotone a Catanzaro, da Modena alla ex caserma Chiarini di Bologna. Il governo riprende in mano la lista delle strutture che si potrebbero riaprire velocemente. E già si alzano le barricate. Non ha remore Sandra Zampa, vicepresidente del Pd: «A Bologna non faremo riaprire il Cie. Mi spiace che l’idea sia di un ministro del mio partito. Sono posti disumani. Inseguire i leghisti è un errore».
“SONO STATI UN FALLIMENTO,
RIAPRIRLI NON HA SENSO”
Massimo Vanni intervista Enrico Rossi
«Il presidente della Toscana Rossi: servono accordi bilaterali che rendano effettive le espulsioni»
FIRENZE.«Non possiamo riproporre ciò che è già fallito». Non parlate di Cie al presidente della Regione Toscana Enrico Rossi. Si mise di traverso quando, sei anni fa, fu il ministro leghista Maroni a lanciarli. E si mette di traverso pure adesso.
Presidente Rossi, la Toscana non ha Cie. Il ministro Minniti però ne vuole uno per ogni regione.
«Esiste un rapporto della commissione diritti umani del Senato del febbraio 2016 che dimostra in modo scientifico e documentato come i Cie non servano assolutamente a dare effettività ai provvedimenti di espulsione. Gli unici Cie che conosciamo sono luoghi disastrosi per i diritti umani».
Cosa servirebbe secondo lei?
«Senza accordi bilaterali con i paesi d’origine, e soprattutto senza una normativa che differenzi le espulsioni con accompagnamento forzato dalle semplici intimazioni, che dovrebbero essere la norma secondo le direttive europee, non ci sarà nessun incremento di sicurezza e di effettività delle espulsioni. Si moltiplicheranno invece i problemi che hanno portato alla chiusura di molti Cie negli scorsi anni».
Salvini incita alle espulsioni di massa.
«Appunto. La paura è concreta, come il senso di insicurezza. Salvini dà fiato alle trombe della destra populista. Ma l’equazione tra straniero clandestino e terrorista è una follia. Per questo bisogna continuare col modello che ha funzionato di più. Non certo con quello che ha fallito del tutto, come i Cie».
Quale modello ha funzionato di più?
«Alle caserme di 1.400 persone, come a Cona, o ai Cara come a Foggia, la Toscana ha opposto il modello dell’accoglienza diffusa sul territorio. Piccoli gruppi da includere nelle comunità e anche da coinvolgere in lavori socialmente utili, come da molte parti si sta già facendo».
Non sembra il modello del governo.
«Purtroppo è la conferma di una mancanza di una politica generale per l’integrazione e la regolazione dei flussi. La riapertura dei Cie non è la risposta. Non si può riproporre ciò che è già fallito. Ed è singolare che lo Stato rischi di trasformare i richiedenti asilo in clandestini da espellere. Forse c’è bisogno di un intervento legislativo. Il paradosso è che rischia di essere espulso chi lavora perché diventa clandestino».
Un intervento legislativo con un Pd oggi diviso?
«Noi siamo stati sempre contrari alle grandi concentrazioni. E mi pare un errore riproporre i Cie in questo modo. Chiedo adesso al governo che le Regioni siano coinvolte nel necessario ripensamento di tutte le politiche dell’integrazione e della sicurezza».
“BASTA CENTRITROPPO AFFOLLATI,
SONO I PIÙ PERICOLOSI”
Paolo Rodari intervista Francesco Moraglia
«Il patriarca diVenezia Moraglia: in quelle strutture il clima è surriscaldato e l’incendio puòscoppiare per un niente»
CITTÀ DEL VATICANO. «Una volta di più risalta l’inadeguatezza e la pericolosità della concentrazione di uomini e donne in un’unica struttura, non è il primo momento di difficoltà che si manifesta in un anno a Cona e basta un niente in un clima già surriscaldato per far scoppiare l’incendio. Ciò che preoccupa è che questo produrrà una reazione di rigetto dell’immigrazione in quanto tale».Così dice Francesco Moraglia, patriarca di Venezia, che rivolge anzitutto un pensiero a Sandrine, la giovane ivoriana deceduta nel Centro, la donna «che è passata attraverso terribili vicissitudini e ha finito per incontrare la morte».
Come dovrebbe avvenire questa accoglienza?
«Bisogna lavorare insieme per una soluzione condivisa ed equa verso questi uomini e donne, verso gli abitanti dei territori che li hanno accolti, verso gli operatori. Un’accoglienza diffusa ed equilibrata a piccoli gruppi non solo di uomini ma di uomini, donne e bambini sul territorio dice una soluzione praticabile ma solo se c’è una condivisa assunzione di responsabilità tra territorio, istituzioni e soprattutto da parte della politica».
Può essere legittima l’espulsione?
«Le autorità valuteranno in modo obiettivo e con serenità i fatti, eventuali responsabilità e l’adozione di eventuali provvedimenti. Credo che vadano garantiti i diritti di tutti, degli abitanti, degli operatori, degli immigrati, con un senso di giustizia che sia autentica, umana e capace di cogliere una situazione divenuta ormai esasperante».
Come rispondere a chi accusa la Chiesa di essere debole e di favorire l’arrivo di potenziali terroristi?
«Le persone vanno accolte in base a un progetto di vera e obiettiva integrazione. Non si tratta di essere deboli o forti, si tratta di rispondere al Vangelo di Gesù che genera una cultura e propone un tipo di convivenza sociale ».
Quali sono le condizioni secondo le quali l’accoglienza dei profughi deve avvenire?
«Un’accoglienza saggia, non buonista. Accoglienza che diventi vera integrazione attraverso un reale progetto che abbia quote certe e ragionevoli di immigrati accolti nei differenti Stati europei ed extra europei».
Come deve comportarsi l’Europa?
«Bisogna che la grande politica non scarichi sul territorio, sulle nostre strade e neppure sui prefetti e sui sindaci, un problema epocale e che riguarda interi continenti. Non è giusto che l’Italia sia lasciata sola e non ottenga supporti che le sono dovuti in quanto confine sud del Mediterraneo; l’Europa non può continuare a chiedere agli Stati membri sacrifici senza metterli in condizioni di operare ».
postilla
In una recente intervista(la Repubblica, 2 gennaio 2017) La sindaca dell’avamposto storico dell’Europaverso il mondo degli sfrattati dalla terra, Giusi Nicolini, si è riferita alle parole pronunciate dal presidente della Repubblica nel suodiscorso di Capodanno: «L’equazione immigrato uguale terrorista è ingiusta einaccettabile, ma devono essere posti in essere tutti gli sforzi e le misure disicurezza per impedire che, nel nostro Paese, si radichino presenze minaccioseo predicatori di morte». Parole giuste, quelle di Mattarella; a condizione che si impedisca di predicare la morte non soloai forestieri, ma anche agli indigeni come l’attuale leader dellaLega.
Ma c’è una domanda che vogliamo rivolgere a chi dispone delle informazioni necessarie. Chi sono questi “immigrati irregolari”? da dovevengono, da dove e da che cosa fuggono? E quali sono le condizioni chetroveranno quando li avranno rimpatriati? Se fuggono dalla tortura e dalla morteche domina nel loro paese li restituiranno agli assassini? Se fuggono dallamiseria (magari provocata dalle nostre multinazionali ), li restituiranno all’inumanitàdella situazione dalla quale tentano di fuggire?. E – domanda finale – chi,quando, con che autorità e trasparenza sono ha stabilito le regole in base alle quali sisepara chi ha diritto a vivere da chi è dannato a morire?Sarebbe bello sequalcuno più autorevole di noi ponesse queste domanda al ministro Minniti, o magarial premier Gentiloni, o addirittura al presidente della Repubblica

Il Fatto quotidiano/diritti online, 13 dicembre 2016 (p.s.)
Il Tar del Friuli Venezia Giulia ha giudicato illegittima l'”ordinanza antibarboni” emessa dal sindaco di Trieste, Roberto Dipiazza, per vietare accattonaggio, capannelli di persone e consumazione di cibi e bevande in luoghi pubblici. I giudici amministrativi hanno accolto il ricorso di un richiedente asilo pakistano, portando all’annullamento della sanzione di 50 euro per essere stato trovato a dormire all’aperto in città. Per il Tar, l’amministrazione locale può varare ordinanze solo per “fronteggiare eventi e pericoli eccezionali ed emergenziali” che minaccino “l’incolumità pubblica” e la “sicurezza urbana”, e che non possano essere affrontati in via ordinaria.
Il provvedimento, che è stato firmato dal vicesindaco della Lega Nord Pierpaolo Roberti, era stato emesso a fine settembre ed era valido fino allo scorso 15 novembre, ma molte delle sue indicazioni sono state riprese nella proposta di regolamento della Polizia municipale presentata dalla Giunta comunale e ora all’esame del Consiglio. Questo nuovo regolamento di polizia urbana, non entrato ancora in vigore, prevede multe fino a 900 euro non solo per i mendicanti ma anche per chi dà loro offerte in denaro.
Il rifugiato che ha visto riconosciute le proprie ragioni è stato assistito dai legali dell’Associazione per gli studi giuridici sull’immigrazione. La decisione del Tar, però, non fa retrocedere la giunta guidata da Dipiazza (Forza Italia), che – spiega il vicesindaco – non farà un solo passo indietro sulla strada della lotta ai senzatetto. «La volontà dell’amministrazione – continua Roberti – rimane la stessa, ovvero adottare tutti i provvedimenti possibili affinché Trieste torni ad essere una città bella, pulita e sicura: quindi nel frattempo si è dato il via all’iter per l’approvazione del nuovo regolamento di Polizia urbana, in arrivo in aula consiliare all’inizio del prossimo anno. Un nuovo atto amministrativo che supererà tutte le eccezioni sollevate dal Tar».
Il nuovo regolamento “antidegrado” verrà discusso in aula a partire da gennaio, ma sui social network è già cominciata la protesta organizzata da alcuni cittadini: la prima manifestazione si terrà il 21 dicembre, data in cui è prevista una “Marcia degli zaini“ con bivacco per “sfidare” l’amministrazione.
L’organizzatore dell’iniziativa è il giornalista e attivista Luigi Nacci che ricorda come la città “è stata prospera quando regnava il disordine, quando ci vivevano almeno cinquantamila persone più di oggi, le vie erano un turbinio di genti e lingue, la città intera era un bivacco a cielo aperto”. Critiche all’ordinanza arrivano anche dalle organizzazioni del mondo cattolico, tra cui Caritas, Comunità di Sant’Egidio e Comunità di San Martino al Campo.
L’ERRORE DEI CIE, LETTERA APERTA AL MINISTRO MINNITI
di Francesca Chiavacci
Caro ministro Minniti, se il buongiorno si vede dal mattino, la proposta di affidare ancora una volta le politiche sull’immigrazione ai Centri di Identificazione ed Espulsione (Cie), è vecchia e stantia ancor prima di essere avviata.
Ci hanno già provato – sapendo che si tratta solo di un’uscita propagandistica, che alimenta odio e razzismo e favorisce i predicatori d’odio – ministri e governi precedenti, senza ottenere alcun risultato concreto.
Nel suo messaggio di fine anno, il presidente Sergio Mattarella è intervenuto con autorevolezza per lanciare un monito contro il collegamento sbagliato tra immigrazione e terrorismo. Che invece è proprio quello che sottostà alla proposta di aumentare il numero dei Cie e quindi delle espulsioni.
La storia recente, d’altra parte, dimostra come sia impossibile aumentare il numero dei rimpatri degli irregolari attraverso i Centri d’identificazione e di espulsione.
Basterebbe andarsi a rileggere le conclusioni della Commissione De Mistura, voluta dall’allora ministro dell’Interno Amato e alla quale anche l’Arci partecipò, per sapere che si tratta di uno strumento ingiusto perché introduce un percorso differenziato per gli stranieri, meno garanzie e meno diritti, negando la nostra Costituzione e il principio di uguaglianza davanti alla legge.
Uno strumento sbagliato perché non è di sanzioni per chi non rispetta le regole che c’è bisogno in un Paese che ha una legislazione concretamente impraticabile, ma di canali d’accesso regolari, sia per ricerca di lavoro sia per richiesta di protezione internazionale (canali da sempre chiusi, in particolare negli ultimi anni, nei quali non è stato emanato il decreto flussi, se non per gli stagionali, favorendo gli ingressi irregolari).
Uno strumento inutile. Dati alla mano, un rimpatrio reale, e non fittizio come quelli a cui si riferiscono i giornali in questi giorni, attraverso i Cie, costa cifre esorbitanti, colpisce quasi esclusivamente persone che hanno perso il lavoro, riguardando comunque, anche quando i Cie erano 14, poche migliaia di persone.
Se non si vuole consegnare questo Paese ai Salvini e alle destre xenofobe, bisogna mettere in campo una politica che punti a impedire le morti da frontiera, lo sfruttamento dei lavoratori e delle lavoratrici, le diseguaglianze crescenti, la povertà diffusa, fermare l’odio contrastando gli argomenti di cui si nutre e raccontando la verità.
È sulla base della nostra esperienza concreta di questi anni, dei dati concreti che sono in possesso del suo Ministero e del fallimento di esperienze simili attuate in altri Paesi dell’Ue che le chiediamo, signor ministro, di congelare ogni iniziativa volta ad aumentare il numero dei Cie e di aprire un confronto con le organizzazioni sociali, laiche e religiose, con i sindacati e le organizzazioni di categoria, riaprendo quel Tavolo Immigrazione Nazionale che da anni è stato bloccato, per mettere in campo iniziative concrete nel campo dell’immigrazione e dell’asilo, a partire dall’esperienza dei soggetti del Terzo settore e delle organizzazioni sociali che quotidianamente, nei territori, si confrontano con le persone, con le loro storie e i loro diritti.
In attesa di un cortese riscontro, cordiali saluti.
Francesca Chiavacci è presidente nazionale dell’Arci
«I CIE? SOLO PER CHI COMMETTE DEI REATI»
Intervista di Carlo Lania a Matteo Biffoni
Il governo vuole riaprire i Cie, che ne pensa?Nessuno crede che i Cie siano la panacea di tutti i mali. Possono servire se utilizzati per quello che dovrebbero davvero essere, cioè dei luoghi in cui vengono reclusi in attesa di espulsione i cittadini non comunitari che hanno commesso dei reati. In questo senso sì, oggi possono servire, naturalmente rispettando i diritti costituzionali dei migranti, anche per quanto concerne il tempo di permanenza.
Il rischio è che si generalizzi e che vengano richiusi tutti gli irregolari solo per facilitare le espulsioni.
Dai numeri che sembra fare il ministro Minniti non pare essere così. Minniti parla di 10mila persone, numero che potrebbe effettivamente riguardare quanti hanno commesso un reato. Se parlassimo degli irregolari la cifra sarebbe per forza di cose molto più ampia. Su questi ultimi dobbiamo fare un ragionamento e decidere cosa fare perché stanno arrivando a compimento i percorsi di quanti hanno fatto richiesta di asilo, hanno avuto una risposta negativa dalla commissione territoriale e hanno concluso anche il ricorso con una risposta negativa. Penso che vada fatta una scelta, perché se la legge prevede l’allontanamento, l’allontanamento va fatto. Si tratta però di una decisione del governo alla quale noi come amministratori, che dobbiamo gestire l’impatto sul territorio, ci adegueremo, certo partecipando al confronto sul tema che immagino ci sarà.
In passato i Cie si sono dimostrati un fallimento. Un’esperienza negativa che ora potrebbe ripetersi.
E infatti non devono essere strutture che replicano quella esperienza negativa. Devono essere quello per cui teoricamente sono nati: ripeto, punti di appoggio per coloro che hanno commesso dei reati in attesa di essere allontanati dal territorio. Però attenzione. Noi dobbiamo ragionare su che impostazione diamo a queste persone che fanno richiesta di asilo e se la vedono respingere. Che cosa ne facciamo? Tecnicamente anche queste vanno allontanate, perché l’impatto sul territorio è forte. Altrimenti bisogna avere gli strumenti per gestirle: vanno potenziati i servizi sociali, i servizi di interpretariato, l’educazione civica, perché non possiamo lasciarle in mezzo a una strada, né possiamo indebolire le forme di tutela che eroghiamo al momento. Stiamo parlando di persone fragili, che in larga parte non possono farcela da sole.
Si parla di rimpatri, ma mancano gli accordi per poterli mettere in atto.E questo è infatti un altro pezzo del ragionamento legato all’allontanamento. Chiaramente bisogna essere conseguenti, quindi fare a monte gli accordi con i paesi di origine diventa un altro tassello fondamentale.
Ma lei accetterebbe un Cie nel suo territorio?
Se esistessero le condizioni logistiche e a patto che sia una struttura destinata a chi ha commesso dei reati e deve essere rimpatriato in tempi rapidi.
Il sindaco di Prato Matteo Biffoni è il responsabile Immigrazione per l’Anci.
 «Bruciando denaro abbiamo elevato i moderni monumenti delle nostre fobie, espressione architettonica di comunità sterili incapaci di confronto con l’alterità».
«Bruciando denaro abbiamo elevato i moderni monumenti delle nostre fobie, espressione architettonica di comunità sterili incapaci di confronto con l’alterità».
Il Fatto Quotidiano online, 31 dicembre 2016 (c.m.c.)
E’ iniziato il 2017 e se vogliamo solo immaginarlo come un anno migliore del precedente, il primo compito sarà quello di iniziare a buttare giù i tanti “muri” che ci siamo affannati a costruire. E’ prioritario nella misura in cui risulta vero quanto sostenuto da Roberto Saviano che, nel ripercorrere gli eventi salienti dell’anno appena concluso nel programma ‘Imagine‘, ha designato la parola “muri” come quella più rappresentativa. «Il 2016 – ha commentato Saviano – è stato l’anno dell’esclusione, l’anno con più muri per la storia dell’umanità».
Nel 2015 ci eravamo lasciati commuovere dall’interminabile fila di disperati che univa Lesbo a Berlino arrivando a spendere parole di ammirazione verso le coraggiose scelte di Angela Merkel improntate ad un “Refugees welcome”. Eravamo stati trascinati dall’onda emotiva suscitata dalla foto simbolo di Aylan, il bimbo siriano che, nella sua t-shirt rossa e i suoi pantaloncini blu, piegati all’altezza della vita, sembrava dormire sulla spiaggia turca di Bodrum.
Nel 2016 ci siamo risvegliati, abbiamo asciugato le lacrime e ci siamo dedicati alla costruzione di muri, in Europa come in Italia. La solidarietà è stata spazzata via dalla paura e alla brezza delle belle intenzioni è subentrato il ciclone populista.
Nella primavera del 2016 abbiamo sbarrato la strada dei migranti con l’accordo firmato con la Turchia. Il “muro di Erdogan” ci è costato tre miliardi di euro e così nessun profugo è più giunto dalle coste turche. Qualche mese dopo si è deciso di salvaguardare il “muro del Mediterraneo” rafforzando le frontiere dell’Unione, dando vita a un sistema di implementazione di Frontex attraverso l’istituzione di una guardia costiera europea. Ad essa si è aggiunta una guardia di frontiera con un costo complessivo vicino ai 250 milioni di euro. Nessuno lo nega: i muri costano.
Negli stessi mesi in Italia è stato costruito il “muro degli hotspot” che separa migranti economici dai richiedenti asilo ed entrambi dal resto del Paese.
Una conseguenza del nuovo approccio è stato l’ampliamento di altri “muri”, quelli dei Cie (Centri di espulsione ed identificazione) che nel 2016, con l’apertura di quelli di Brindisi, Crotone e Trapani, sono diventati otto. Muro genera muro come la paura genera paura.
Per costruire nuovi “muri” e rafforzarne i vecchi ci si è adoperati anche a livello di amministrazione locale. Le baraccopoli istituzionali, chiamati anche “campi nomadi” o più bucolicamente “villaggi”, sono spazi mantenuti nel 2016 per continuare a segregare, concentrare, escludere, per separare un corpo ritenuto “malato” da quello considerato “sano”.
«I campi, informali o istituzionali – scrive Antonio Ciniero, ricercatore presso l’International centre of interdisciplinary studies on migrations – sono oggi l’emblema di una cittadinanza e di un’accoglienza mancata. Un dispositivo politico di controllo e subordinazione dei soggetti considerati indesiderabili che viene esteso a un numero sempre più alto di persone».
Abbiamo innalzato muri separatori, uno dietro l’altro, freneticamente. Bruciando denaro abbiamo elevato i moderni monumenti delle nostre fobie, espressione architettonica di comunità sterili incapaci di confronto con l’alterità.
«Campi sosta, baraccopoli istituzionali, ghetti, tendopoli temporanee – continua Ciniero – così come tutti gli altri campi nati ai confini e nel cuore dell’Europa, hotspot, Centri di accoglienza per richiedenti asilo (Cara) e altri luoghi para-istituzionali, pensati per un’accoglienza ambivalente che assume i connotati dell’esclusione, pur nelle loro differenze, sono accomunati dal fatto di costringere la vita dei soggetti che vivono o transitano al loro interno a una continua provvisorietà e subalternità, sospendendone e violandone i diritti fondamentali. Processi di segregazione e confinamento che si pensava consegnati alla storia e che invece riaffiorano con sempre maggiore frequenza, frutto di politiche ancora schiacciate nell’alveo della logica emergenziale».
L’eredità che ci consegna il 2016 sono i “muri della segregazione” interni ed esterni al territorio nazionale, sia quelli fisici che quelli mentali. L’urgenza per il 2017 quindi sarà l’impegno di abbatterli, a partire dalla Capitale.
Nella città di Roma le due delibere di iniziativa popolare, quella relativa all’accoglienza dei migranti e quella sul superamento dei campi rom, predisposte dal comitato Accogliamoci e sottoscritte da 6.000 cittadini romani, incarnano questa urgenza e indicano soluzioni concrete e sostenibili per abbattere i “muri” presenti nella Capitale. Spetterà all’Assemblea Capitolina regalarci la prima buona notizia del 2017.
 «L’Europa politica disgregata e in crisi, è stata messa di fronte alla propria inadeguatezza».
«L’Europa politica disgregata e in crisi, è stata messa di fronte alla propria inadeguatezza».
Internazionale online, 29 dicembre 2016 (p.d.)
Se il 2015 è stato l’anno del motto
refugees welcome (benvenuti rifugiati) rivolto dai cittadini europei,
da Lesbo a Berlino, al milione di profughi arrivati nel continente sopratutto dalla Siria, il 2016 è stato l’anno del ripristino dei controlli alle frontiere interne, della costruzione dei muri, degli accordi di rimpatrio, del record di morti nel Mediterraneo e della militarizzazione dei confini. Nel 2015 di fronte all’immagine delle famiglie siriane in cammino attraverso l’Europa con le loro poche cose, l’opinione pubblica e anche qualche
leader del vecchio continente avevano preso in considerazione una politica di moderata apertura delle frontiere. Prima tra tutte
la decisione della cancelliera tedesca Angela Merkel nell’estate del 2015 di sospendere il
regolamento di Dublino, la legislazione comune europea sull’asilo che impone ai migranti di chiedere protezione nel primo paese di ingresso dell’Unione. Questa timida, tintinnante apertura si è richiusa velocemente nell’anno che è appena trascorso. Nel giro di pochi mesi, sotto i colpi di campagne populiste sempre più aggressive condotte dai partiti nazionalisti e dell’estrema destra in molti paesi europei, si è imposta una narrazione negativa sui migranti, capro espiatorio perfetto di un’Europa politica disgregata e in crisi, messa di fronte alla propria inadeguatezza nel governare fenomeni transnazionali come la migrazione.
In sociologia si è parlato spesso della “funzione specchio” dell’immigrazione: mentre raccontiamo quello che l’Europa ha deciso di fare per affrontare la questione migratoria, ci accorgiamo che stiamo descrivendo in realtà i limiti delle istituzioni e delle politiche europee nel loro complesso, le loro inadeguatezze, che sono venute alla luce proprio attraverso il fenomeno dell’immigrazione e della sua gestione disastrosa. Ecco alcune tappe di questo rapido cambiamento di prospettiva, avvenuto sulla pelle di migliaia di persone. Tra molti segnali di chiusura, abbiamo voluto ricordare due pratiche di apertura, ancora minoritarie, che l’Italia ha sperimentato proprio nel 2016: i corridoi umanitari e il potenziamento del Sistema di protezione dei richiedenti asilo e rifugiati (Sprar), un modello di accoglienza virtuoso per richiedenti asilo e rifugiati.
L’accordo con la Turchia
L’evento più importante dell’anno per quanto riguarda le politiche migratorie è stato l’accordo che
Bruxelles ha firmato il 18 marzo con Ankara per chiudere definitivamente la rotta che aveva portato migliaia di persone in Grecia dalle coste turche. L’accordo ha di fatto interrotto la cosiddetta rotta balcanica che collegava la Turchia con l’Europa nordoccidentale, attraverso la Grecia, la Macedonia, la Serbia, l’Ungheria, l’Austria e gli altri paesi dei Balcani. La rotta era già stata in parte bloccata nei primi mesi dell’anno a causa del ripristino parziale dei controlli di frontiera da parte di alcuni paesi, come l’Ungheria e la Macedonia, e dalla costruzioni di muri e recinzioni
come quella lunga 175 chilometri che separa l’Ungheria dalla Serbia, voluta dal governo di Viktor Orbán. In cambio di tre miliardi di euro in aiuti, Ankara si è impegnata con l’Unione europea a non lasciare partire i profughi dalle sue coste e ad accettare che quelli arrivati in Grecia dopo il 20 marzo fossero deportati di nuovo in territorio turco.
Le organizzazioni per i diritti umani hanno denunciato l’irregolarità dell’accordo, accusandolo di violare il diritto internazionale, e hanno presentato diversi ricorsi alla Corte europea di giustizia. Una delle conseguenze più gravi dell’accordo è stata che 55mila profughi che si trovavano in Grecia sono rimasti bloccati in campi di fortuna come quello di Idomeni al confine con la Macedonia, o nei campi governativi, senza poter accedere né all’asilo né al ricongiungimento familiare. Fenomeni simili, anche se in dimensioni ridotte, sono stati registrati in tutti i paesi della rotta balcanica, dove migliaia di persone sono rimaste in un limbo burocratico, impossibilitate a chiedere asilo o a raggiungere i propri familiari in altri paesi dell’Unione europea. Dopo lo sgombero dei campi informali, in Grecia i profughi sono stati trasferiti in campi gestiti dal governo greco, allestiti in fabbriche abbandonate e vecchi magazzini, in tende e in condizioni di precarietà definite dalle organizzazioni non governative “pericolose e inadatte per la vita umana”.
Durante l’estate i profughi presenti in Grecia sono stati censiti dalle autorità greche ed europee e sono stati indirizzati verso la richiesta del ricollocamento in altri paesi europei, prevista dall’Agenda europea sull’immigrazione entrata in vigore nel settembre del 2015. Ma i ricollocamenti sono partiti molto lentamente (solo 1.549 persone sono partite dall’Italia e 5.437 dalla Grecia su un totale di 40mila previste) e migliaia di persone vivono ancora in condizioni disumane nei campi gestiti dal governo in tutta la Grecia, e in molti altri paesi dei Balcani come la Serbia. Il 40 per cento dei profughi bloccati in Grecia è costituito da bambini che almeno da un anno non frequentano le scuole, se non quelle autoorganizzate all’interno dei campi.
Un’altra conseguenza dell’accordo tra Unione europea e Turchia è stata l’emergenza umanitaria che si è aperta nelle isole greche: sedicimila profughi
sono rimasti bloccati a Lesbo, Chios e Samos, che si sono trasformate in prigioni a cielo aperto. Nei centri di identificazione sulle isole,
i cosiddetti hotspot, i profughi arrivati dopo il 20 marzo sono stati rinchiusi in attesa di essere identificati ed eventualmente rimandati in Turchia, come previsto dall’accordo. Negli
hotspot greci, i profughi
vivono in tende, in situazioni igienico-sanitarie precarie, esposti al freddo e alle intemperie. La tensione all’interno dei campi provoca spesso scontri e rivolte, che sono pericolose soprattutto per le persone rinchiuse nei centri. Il 24 novembre nell’hotspot di Moria sull’isola di Lesbo l’ennesima protesta dei migranti
ha provocato un incendio nel quale hanno perso la vita una donna e un bambino.
L’approccio hotspot
Nel settembre del 2015 è entrata in vigore l’Agenda europea sull’immigrazione,
approvata nel maggio del 2015, che prevede il ricollocamento dei migranti all’interno dell’Unione europea in base a un sistema di quote. Questo sistema teorizza e impone una divisione netta dei migranti in due categorie: i cosiddetti migranti economici e i profughi. Le linee guida imposte dall’Unione hanno cambiato in maniera radicale il sistema di accoglienza dei migranti nei paesi di arrivo, come l’Italia e la Grecia, che da paesi di transito si sono trasformati in paesi di destinazione.
La distinzione tra migranti economici e profughi, stabilisce di fatto che i migranti possano accedere a una forma di protezione in Europa in base alla loro nazionalità. Hanno diritto a essere accolti i siriani, gli eritrei e gli iracheni, quelli cioè a cui è riconosciuta una protezione nella maggior parte dei paesi europei, mentre tutti gli altri rientrano nella categoria dei migranti economici. In questa categoria finiscono anche coloro che scappano dalla guerra in Libia, o da quella in Afghanistan, oppure i migranti che fuggono da governi dittatoriali come quello gambiano e quello etiope. Per queste altre nazionalità è possibile richiedere l’asilo in Italia, ma senza troppe speranze di avere un responso positivo alla propria domanda. In Italia nei primi sei mesi del 2016 le domande d’asilo sono aumentate del 60 per cento e le risposte negative (i dinieghi) sono state il 60 per cento. Un numero altissimo di persone in questo modo è diventato irregolare, senza documenti e senza diritti, dopo essere passato nelle maglie del sistema di accoglienza italiano che di fatto ha prodotto clandestinità, invece che integrazione.
Nei paesi di arrivo dei migranti sono stati istituiti dei centri per l’identificazione: appunto gli hotspot. Se in passato i migranti che arrivavano nel sud dell’Europa cercavano di sottrarsi al sistema di accoglienza istituzionale e di raggiungere il paese di destinazione con i propri mezzi, dopo l’entrata in vigore dell’Agenda questo non è più vero. In Italia nel 2016 sono stati fotosegnalati e identificati il 99 per cento dei migranti arrivati: molti di loro hanno chiesto di essere ricollocati, altri hanno fatto domanda d’asilo. Amnesty international e altre organizzazioni per i diritti umani hanno denunciato la pressione attuata dall’Unione europea sulle autorità di Italia e Grecia per l’identificazione massiccia dei migranti. “Un processo di screening non fondato su alcuna legislazione e fatto con troppa fretta – quando le persone sono ancora troppo stanche o traumatizzate dal viaggio per poter prendere parte in modo consapevole a questo processo, e prima che abbiano avuto la possibilità di ricevere informazioni adeguate sui loro diritti e sulle conseguenze legali delle loro dichiarazioni – rischia di negare a coloro che fuggono da conflitti e persecuzioni l’accesso alla protezione alla quale hanno diritto”, scrive Amnesty international nel suo rapporto Hotspot Italy, in cui denuncia le violazioni avvenute contro i migranti nei centri di identificazione italiani. A causa della lentezza del sistema di ricollocamento per quote, la maggior parte dei migranti che avevano aderito al programma è rimasto in attesa per mesi. Molti, stanchi di aspettare, hanno lasciato i centri e si sono rimessi in viaggio. Questo ha determinato una situazione complicata in alcune città italiane come Roma, Ventimiglia, Milano, Como, Bolzano. In queste città è stato registrato un flusso di persone che sostavano per alcuni giorni e che si dichiaravano in viaggio verso in Nordeuropa, ma a differenza dei migranti che erano in transito l’anno precedente, quelli in transito nel 2016 erano stati tutti identificati allo sbarco e alcuni avevano già chiesto di essere ricollocati. E per questo avevano perso il diritto di chiedere asilo in altri paesi europei ma allo stesso tempo, essendosi allontanati dai centri di accoglienza, avevano perso il diritto di essere assistiti dal sistema italiano. Inoltre alle frontiere di Ventimiglia e a Chiasso sono stati registrati numerosi casi di respingimento (tra i respinti molti minori) come denunciato dall’Asgi, da Amnesty international e da altre organizzazioni non governative. Queste persone, rimandate in Italia, sono state trasferite nell’hotspot di Taranto in un programma che le autorità italiane hanno definito di “alleggerimento delle frontiere”.
Un’altra conseguenza dell’approccio hotspot è stato l’ampliamento della rete dei Centri di espulsione e identificazione (Cie), come documentato dal Rapporto diritti dell’associazione A buon diritto. Fino a ottobre del 2015 i Cie erano cinque (Torino, Roma, Bari, Caltanissetta e Trapani) e nel 2016 sono diventati otto con l’apertura di quelli di Brindisi, Crotone Sant’Anna e con la conversione del centro di Trapani in un hotspot. Il 4 agosto 2016 inoltre è stato firmato un accordo di collaborazione tra la polizia del Sudan e quella italiana che è stato all’origine di alcuni rimpatri. Il 24 agosto 2016 quaranta migranti sudanesi sono stati fermati a Ventimiglia e trasferiti nell’hotspot di Taranto dove il 22 agosto sono stati raggiunti da un decreto di espulsione. Il 24 agosto da Taranto 48 sudanesi sono stati trasferiti a Torino per essere rimpatriati. Alcuni di questi migranti erano originari del Darfur e hanno denunciato i rischi a cui andavano incontro con il rimpatrio.
La militarizzazione delle frontiere
Il presidente della Commissione europea Jean-Claude Juncker, nel gennaio del 2016, aveva detto che per salvare il sistema Schengen sarebbe stato necessario rafforzare il controllo delle frontiere esterne dell’Unione. “Reinsediamenti, ricollocamenti e protezione delle frontiere vanno assieme. Ho fiducia che nel 2016 faremo dei buoni progressi”,
aveva affermato Juncker, inaugurando il semestre olandese di presidenza europea e lanciando l’idea di una guardia di frontiera comune. In effetti nel 2016 questa idea si è realizzata. Il 14 settembre 2016
è stata approvata la creazione di una guardia di frontiera e costiera europea, che in pratica corrisponde al rafforzamento di Frontex, l’agenzia europea di controllo delle frontiere esterne. Il nuovo corpo, diventato operativo già a metà ottobre, non dispone di guardie di frontiera proprie, ma può contare su 1.500 agenti scelti tra le guardie di frontiera nazionali, pronte a intervenire in caso di emergenza in uno dei paesi dell’Unione. I primi 120 agenti della guardia di frontiera europea
sono stati schierati al confine tra Bulgaria e Turchia, per scoraggiare i profughi ad attraversare il confine. Tra i compiti dell’agenzia europea ci sono quelli di valutare la capacità degli stati di controllare le frontiere esterne, affiancare le guardie costiere e frontaliere nazionali negli interventi contro l’immigrazione irregolare o il traffico di esseri umani, coordinare questi interventi, occuparsi delle deportazioni e dei rimpatri, coordinarsi con gli stati extraeuropei per la gestione delle frontiere. Come
ha commentato il giurista Fulvio Vassallo Paleologo “si tratta di una espansione delle attività dell’agenzia Frontex e di una sua maggiore autonomia nello stabilire
rapporti diretti con le autorità di polizia dei paesi terzi, anche in vista di possibili operazioni di rimpatrio o di respingimento”. Questo a fronte di un investimento economico importante che ha come scopo non la salvaguardia della vita umana, né il soccorso delle persone in difficoltà, bensì la militarizzazione delle frontiere.
Nel dicembre del 2016 a bordo della nave San Giorgio della marina militare italiana è cominciato anche l’addestramento di 62 agenti della guardia costiera libica, nell’ambito dell’Operazione Sophia, del dispositivo militare Eunavfor Med, a cui ha collaborato anche Frontex. Lo scopo dell’addestramento dei libici rientra nel piano di lotta al traffico di esseri umani e di rafforzamento del controllo delle frontiere. Secondo il rapporto Border wars dello studioso Mark Akkerman “il bilancio di Frontex tra il 2005 e il 2016 è aumentato del 3.688 per cento”, ed è passato da 6,3 milioni a 254 milioni di euro all’anno. Dal 2014 è quasi triplicato, passando da 97 milioni ai 281 milioni di euro previsti per il 2017. A beneficiare di queste politiche sono soprattutto le aziende militari, tecnologiche e della sicurezza. Border wars mostra che l’industria delle armi non solo ha beneficiato della militarizzazione delle frontiere europee, ma ha anche fatto pressioni e ha incoraggiato questo approccio facendo attività di lobby. Akkerman ha inoltre mostrato come molte aziende che stanno facendo affari con Frontex sono le stesse che vendono armi ai paesi del Medio Oriente e dell’Africa da cui i migranti cercano di scappare, venendo in Europa. Questo dispendio economico senza precedenti per il controllo delle frontiere esterne è coinciso con un numero record di morti nel Mediterraneo: secondo i dati raccolti delle Nazioni Unite nel 2016 hanno perso la vita 5.011 persone durante la traversata del Mediterraneo, 1.300 in più di quelle morte nel 2015 (3.771).
I corridoi umanitari dal Libano
Tra molte cattive notizie che riguardano l’immigrazione, il 2016 è stato segnato anche da qualche buona notizia
come l’apertura di corridoi umanitari dal Libano all’Italia per i profughi siriani. Interamente finanziati dalla Comunità di Sant’Egidio, dalla chiesa valdese e dalle chiese evangeliche italiane, i corridoi umanitari
hanno portato in Italia dal Libano a più riprese circa 500 profughi siriani, in una maniera legale e sicura. Si è trattato di un progetto pilota che ha coinvolto principalmente le persone più vulnerabili, famiglie e individui con problemi di salute, ma ha mostrato agli stati europei che una via di buon senso per gestire i flussi migratori e combattere il traffico di esseri umani in alcuni contesti è possibile. Il progetto è stato interamente finanziato dai suoi promotori che si sono occupati anche di sistemare i profughi in diversi progetti di accoglienza in tutta Italia. Il governo italiano si è occupato di fornire un visto umanitario “a territorialità limitata” per i profughi e di regolare le questioni burocratiche con le autorità libanesi. In tutto, nel giro di due anni dovrebbero arrivare mille persone con questo sistema, dal Libano e dal Marocco, e ultimamente Sant’Egidio ha annunciato di voler aprire
un corridoio umanitario anche dall’Etiopia, in collaborazione con la Cei, la Caritas e Migrantes. Dovrebbero arrivare dal paese africano circa 500 persone nel corso del prossimo anno. Qualche stato europeo, come la Francia, e molte organizzazioni umanitarie hanno mostrato interesse per il progetto che potrebbe essere quindi emulato in altri paesi nei prossimi anni.
Il rafforzamento del sistema di accoglienza Sprar
Al momento in Italia il 70 per cento dei profughi e dei richiedenti asilo
è ospitato da un Centro di accoglienza straordinaria (Cas). I Cas sono centri nati per far fronte all’emergenza degli arrivi dopo le cosiddette primavere arabe del 2011 e sono diventati un sistema parallelo e preponderante rispetto a quello dell’accoglienza ordinaria dei richiedenti asilo nel paese, il Sistema di protezione richiedenti asilo e rifugiati (Sprar). La qualità dei servizi offerti dai Cas, spesso allestiti in strutture turistiche e alberghiere, è disomogenea, così come lo è la loro collocazione sul territorio nazionale. Rispetto ai Cas, gli Sprar hanno standard di qualità più alti, che sono fissati da regole ben precise e hanno come scopo l’integrazione a lungo termine del richiedente asilo e non solo la sua accoglienza temporanea. Inoltre i centri Sprar sono soggetti a una rendicontazione economica più rigorosa, e sono quindi meno soggetti ad abusi e a malversazioni. Per questo nel 2016 il ministero dell’interno ha mostrato la volontà di superare il doppio binario dell’accoglienza italiano e di favorire la diffusione del sistema degli Sprar, che al momento ospitano solo il 20 per cento dei profughi e dei richiedenti asilo nel paese. Il 10 agosto 2016 un decreto governativo
ha stabilito che gli Sprar non saranno più finanziati con dei bandi periodici, ma continuativamente in base a un sistema di accreditamento permanente e ai finanziamenti disponibili. Inoltre per contrastare la reticenza dei comuni italiani ad aderire ai progetti Sprar (su ottomila comuni italiani solo 1.800 hanno accolto i migranti nel 2016) a ottobre una circolare del ministero dell’interno ha stabilito che se il comune aderisce allo Sprar otterrà la progressiva diminuzione della presenza dei Cas sul suo territorio e inoltre riceverà 500 euro all’anno per ogni accolto.
L’unica debolezza di questo sistema è che l’adesione al sistema Sprar è volontaria per i comuni, mentre la distribuzione dei migranti per regione nel sistema dei Cas è disposta dal ministero dell’interno attraverso le prefetture ed è obbligatoria. Questo elemento continuerà in parte a favorire la diffusione dei centri straordinari, anche se gli incentivi economici ai comuni virtuosi potrebbero rappresentare un punto di partenza per favorire l’idea dell’immigrazione come risorsa invece che come problema.

Il Fatto Quotidiano, 30 dicembre 2016 (p.d.)
Nella fiaba Pollicino lascia dietro di sé le briciole di pane per ritrovare la strada verso casa. Nella realtà, tragica, del caso Regeni, la verità raccoglie le briciole, passo dopo passo, senza mai arrivare alla meta finale.
Le dichiarazioni spontanee di Mohamed Abdallah, leader del sindacato egiziano degli ambulanti, rappresentano una delle tante briciole, insufficienti per arrivare alla verità: dare volti e nomi ai responsabili, mandanti ed esecutori materiali, del brutale assassinio di Giulio Regeni. Tanto clamore per le parole di Abdallah, quando, alla prova dei fatti, il suo ruolo nella vicenda era chiaro e la Procura di Roma ne era a conoscenza dal 9 settembre scorso: “È stato Mohamed Abdallah a vendere Giulio alla polizia. Lui stesso ha ribadito che Regeni era una spia e che gli avrebbe chiesto delle ‘informazioni’. Lui è sempre stato convinto che Giulio fosse una spia e come tale l’ha venduto”. È il sunto dell’intervista rilasciata al Fatto da Hoda Kamel, ricercatrice egiziana e amica di Giulio Regeni, alla fine dello scorso aprile. Una briciola importante nel cammino verso la ricerca della verità, confermata dalle parole del procuratore del Cairo, Nabil Sadek, in occasione delle ultime ‘visite di cortesia’ ai colleghi romani e ai genitori del ricercatore friulano.
Sadek aveva confermato il ruolo di Abdallah nella vicenda, ma soprattutto che la polizia aveva ‘attenzionato’ Regeni nei giorni immediatamente precedenti alla scomparsa, la sera del 25 gennaio 2015. Abdallah mercoledì scorso ha rilasciato una intervista alla versione araba dello Huffington Post, i contenuti sono stati ripresi in Italia dall’Espresso: “Regeni interrogava i venditori su questioni che riguardavano la sicurezza nazionale. Chiunque al mio posto avrebbe avvisato le autorità, sono orgoglioso di averlo denunciato. Ho registrato l’ultima telefonata con lui, il 22 gennaio, e l’ho spedita agli Interni”.
Le briciole, necessarie dopo tanto fumo. Depistaggi fantasiosi, a volte irritanti, come nel caso in cui lo studente dell’Università di Cambridge era stato ritenuto un omosessuale e un drogato, quasi che queste condizioni potessero giustificarne la morte. E poi la “sparatoria” con una banda di rapinatori che si conclude con una intera famiglia egiziana sterminata, indicata dalla polizia come responsabile della morte di Regeni, dopo il ritrovamento dei suoi documenti nella casa dei sospettati.
Dopo le false verità messe in scena dall’Egitto di al-Sisi, il cambio di atteggiamento, le visite, reciproche, degli inquirenti, le parziali ammissioni delle autorità del Cairo a proposito dello scenario di fondo. Tentativi di normalizzazione, compresa la presenza del ministro del turismo alla Fiera di Rimini per il rilancio del settore e dei collegamenti aerei; oppure l’arrivo al Cairo, a gennaio, del nuovo ambasciatore italiano, Giampaolo Cantini. Colpi di spugna, tentativi di normalizzare i rapporti tra due Stati, amici di interessi. Le parole del nuovo premier ed ex ministro degli Esteri, Paolo Gentiloni, nella conferenza stampa di fine anno sul caso Regeni, aggiungono poco: “C’è una strada che il governo italiano ha cercato di seguire, della fermezza e della collaborazione – ha detto l’ex responsabile della Farnesina –questa è la linea che abbiamo introdotto con l’Egitto”.
Intanto si avvicina il primo anniversario dalla scomparsa di Giulio Regeni, avvenuta in una giornata particolare per l’Egitto: il quinto anniversario dalla rivoluzione di piazza Tahrir, quella che ha prodotto un terremoto istituzionale senza precedenti, portando alla caduta di Hosni Mubarak e alla successiva presa del potere della Fratellanza Musulmana. Giulio era stato tutto il giorno nel suo appartamento, uscendo intorno alle 20 dalla stanza al civico 8 di via Yanbo, nel quartiere di Doqqi, sulla rive ovest del Nilo. Quattrocento metri a piedi per raggiungere la stazione della metropolitana di Bohooth. Alla quarta fermata del convoglio, Naguib, Giulio è sceso, con l’obiettivo di tornare nei pressi di piazza Tahrir, a Bab al-Louq. Obbligato a farlo, visto che la fermata centrale quel giorno era stata chiusa dalla polizia per motivi di sicurezza. Regeni doveva incontrare un amico italiano e assieme a lui raggiungere l’abitazione di un docente di sociologia e criminologia che li stava aspettando. Da Naguib dl ricercatore si sono perse le sue tracce. Il suo cellulare è tornato attivo per qualche minuto il 26 gennaio, per poi non riaccendersi più. Gli otto giorni successivi sono stati carichi di ansia, fino a quando i passeggeri di un minivan diretto ad Alessandria, costretti a una sosta, non si sono accorti di quel cadavere in un fosso.
 La Casa della Carità di Milano si prepara a celebrare il Natale con un Presepe che ci ricorda che le migrazioni forzate hanno sempre accompagnato la storia delle donne e degli uomini; anche di una coppia di genitori, Maria e Giuseppe, che, per i cristiani, sono stati i principali attori della Natività».
La Casa della Carità di Milano si prepara a celebrare il Natale con un Presepe che ci ricorda che le migrazioni forzate hanno sempre accompagnato la storia delle donne e degli uomini; anche di una coppia di genitori, Maria e Giuseppe, che, per i cristiani, sono stati i principali attori della Natività».
casadellacarità.org, 9 dicembre 2016 (m.c.g.)
Come vuole la tradizione, nel giorno dell'Immacolata abbiamo allestito il Presepe che quest'anno racconta le storie delle persone che incontriamo ogni giorno
Anche la Casa della carità si appresta a vivere il Natale. Come vuole la tradizione, nel giorno dell'Immacolata abbiamo allestito il Presepe, che è stato collocato proprio davanti all'ingresso di via Brambilla 10. Una tradizione che si rinnova di anno in anno, con la scena della nascita di Gesù che cambia sempre "forma", grazie alla fantasia della nostra operatrice Iole, che realizza il Presepe insieme alla collega di SoStare Chiara e ai preziosi volontari Gigi e Gianni.
«Credo che la Natività sia una storia di straordinaria contemporaneità, che continua a parlare al nostro presente. Nel pensare al Presepe di quest'anno, ho quindi chiesto a Iole che esso avesse un legame ancor più stretto con le storie che qui alla Casa della carità ascoltiamo tutti i giorni: le storie di coloro che bussano alla nostra porta chiedendo non solo di essere accolti, ma anche di essere ascoltati e riconosciuti in quanto esseri umani portatori di diritti e dignità, e non solo numeri, come invece spesso accade», ha detto don Virginio Colmegna.

Nell'allestire la scena, Iole ha allora pensato al brano biblico in cui si dice: «In quei giorni un decreto di Cesare Augusto ordinò che si facesse il censimento di tutta la terra [...] Mentre si trovavano in quel luogo, si compirono per lei i giorni del parto». Per questo, a far da sfondo alla Sacra Famiglia sono dei rotoli di pergamena scritti in aramaico, a rappresentare i registri del censimento. Per collegarsi all'oggi, in primo piano davanti a Maria, Giuseppe e al Bambino ci sono invece decine di passaporti: di ogni parte del mondo, di diversi colori, nuovi oppure sgualciti a causa delle traversie dei viaggi che i proprietari hanno compiuto per arrivare fino a qui.
«Se al tempo di Gesù i registri erano lo strumento che attestava l'identità, oggi è il passaporto a dire chi sei e da dove vieni, dove puoi e soprattutto dove non puoi andare. In questo episodio Maria e Giuseppe compiono un viaggio verso Betlemme per farsi registrare, quindi per vedere riconosciuta la propria identità e la propria presenza. Millenni dopo, lo stesso accade per le centinaia di persone che si rivolgono alla Casa da ogni parte del mondo, chiedendo di poter essere registrate in via Brambilla [sede della Casa della casa della Carità la cui Fondazione è presieduta da don Virginio Colmegna], affinché vengano loro riconosciuti i più elementari diritti di cittadinanza», spiega l'operatrice.
 Astensione "storica" perché fino a ieri gli Usa non avevano mai votato "contro" Israele. Ma Netanyahu va avanti come una
Astensione "storica" perché fino a ieri gli Usa non avevano mai votato "contro" Israele. Ma Netanyahu va avanti come una
Panzerdivision. E l'ingiustizia in Terrasanta continua, contro la Palestina. il manifesto, 24 dicembre 2016
Grazie a una astensione, senza alcun dubbio storica, degli Stati Uniti, ieri sera il Consiglio di Sicurezza dell’Onu ha approvato una risoluzione di aperta condanna degli insediamenti coloniali israeliani costruiti contro il diritto internazionale nei Territori palestinesi occupati. Le colonie – si legge nel testo – «non hanno validità legale». E’ il colpo di coda di Obama che Benyamin Netanyahu temeva e che ha cercato in tutti i modi di impedire. Gli Stati Uniti non possono appoggiare gli insediamenti coloniali e la soluzione dei Due Stati nello stesso tempo, ha spiegato la decisione di astenersi l’ambasciatrice americana all’Onu, Samantha Power. Rabbiosa la reazione di Israele. «Né il Consiglio di sicurezza dell’Onu né l’Unesco possono spezzare il legame fra il popolo di Israele e la terra di Israele», ha urlato l’ambasciatore israeliano all’Onu, Danny Danon sorvolando il “dettaglio” che i Territori palestinesi occupati non sono parte di Israele. Dopo aver sistematicamente bloccato all’Onu per otto anni ogni risoluzione di condanna dello Stato ebraico, Barack Obama ha inflitto un duro colpo a Netanyahu. Si è vendicato degli attacchi israeliani subiti per anni. Netanyahu inoltre non aveva esitato, nel marzo 2015, ad umiliarlo di fronte al Congresso Usa parlando contro l’accordo sul nucleare iraniano fortemente voluto dalla Casa Bianca.
È finita a stracci in faccia. Netanyahu, ingrato, dimenticando il recente via libera della Casa Bianca a un piano di aiuti militari a Israele per 40 miliardi di dollari nei prossimi dieci anni, in anticipo sul voto di ieri sera, usando un funzionario governativo aveva accusato Obama e il segretario di stato John Kerry di aver messo in atto una «spregevole mossa contro Israele alle Nazioni Unite». Il presidente americano uscente, aveva aggiunto il funzionario, ha coordinato le mosse all’Onu con i palestinesi per riaffermare lo status di città occupata di Gerusalemme e della sua zona araba: «L’amministrazione Usa ha segretamente confezionato con i palestinesi, alle spalle di Israele, una risoluzione estrema che avrebbe dato il vento in poppa al terrorismo e al boicottaggio e che avrebbe fatto del Muro del Pianto territorio palestinese occupato». Obama, ha aggiunto, «avrebbe dovuto subito dichiarare la sua volontà di mettere il veto su questa risoluzione, invece l’ha sostenuta. Questo è un abbandono che rompe decenni di politica americana a protezione di Israele all’Onu e mina le prospettive di lavorare con la prossima Amministrazione nel far avanzare la pace».

». il manifesto, 24 dicembre 2016 (c.m.c.)
Il terrorismo che colpisce nel mucchio è difficile da combattere. Ma scoprire una cellula attiva tra popolazioni insediate da tempo in Europa (base indispensabile per ogni attività terroristica) è molto più difficile che individuare un terrorista imboscato tra un gruppo di profughi. Soprattutto se alla loro registrazione all’arrivo – o alla partenza con corridoi umanitari – corrispondesse il diritto a una libera circolazione in tutta Europa.
Perché ciò per cui i profughi si oppongono alla registrazione, o la rendono inefficace, è il timore di rimanere intrappolati nel paese di sbarco. Che poi si traduce spesso nel famigerato decreto di espulsione differito che lascia allo sbando decine di migliaia di profughi (come Amis Amri) che il governo italiano non sa né rimpatriare né controllare rendendo facile il loro reclutamento da parte della Jihad.
La gravità della situazione impone di alzare lo sguardo sulle radici del problema. Dal secondo dopoguerra l’Europa, a partire dai suoi stati centrali, è diventata un’area di massiccia immigrazione: profughi dai paesi dell’Est (circa 10 milioni), migranti dai paesi meridionali (quasi altrettanti), poi anche dai paesi della sponda sud ed est del Mediterraneo, dalle ex colonie africane e del subcontinente indiano. Dall’ultimo decennio del secolo scorso gli arrivi sono proseguiti investendo anche i paesi dell’Europa mediterranea che prima avevano alimentato una parte cospicua di quel flusso.
Sono stati coinvolti più di 50 milioni di persone, molte delle quali, con i loro figli, sono poi diventate cittadini dei paesi di arrivo; per questo i migranti che non sono ancora cittadini europei sono solo 20 milioni circa. La maggior parte di quel flusso era costituita da «migranti economici» alla ricerca di un lavoro e di condizioni di vita migliori.
I più il lavoro l’hanno trovato, tranne poi perderlo e venir relegati in ghetti e banlieu nel passaggio dalla prima alla seconda generazione. Senza di loro l’Europa però non avrebbe mai conosciuto i «miracoli economici» degli anni ’50 e ’60 né il più stentato sviluppo dei decenni successivi e sarebbe rimasta in gran parte un continente sottosviluppato. E lo sarà ben presto, e sempre di più, se continuerà a cercar di fermare i nuovi arrivi.
Per una denatalità irreversibile, infatti, l’Ue (Regno unito compreso) perde circa 3 milioni di abitanti all’anno. Nel 2050, senza l’apporto di nuovi migranti, invece dei 500 milioni attuali ci saranno solo 400 milioni di abitanti, più o meno autoctoni: in maggioranza vecchi e sclerotizzati dal punto di vista fisico, economico e soprattutto culturale: una cosa che in Italia si comincia a vedere già ora. Eppure si sta facendo di tutto per fermare o per respingere i nuovi arrivi. Fino a pochi anni fa arrivava in Europa una media di 1,5 milioni di «migranti economici» all’anno (300mila in Italia, tutti o quasi regolarizzati da sanatorie di destra e sinistra). Ma l’anno scorso, invece, 1,5 milioni di profughi (170mila in Italia, in gran parte «in transito») sono stati considerati un onere insostenibile. Che cosa ha provocato quella inversione di rotta?
I governi dell'unione Europea hanno risposto alla crisi del 2008, tutt’ora in corso, con politiche di austerità che hanno portato a 25 milioni il numero dei disoccupati ufficiali (quelli effettivi sono molti di più). Se non c’è più lavoro, reddito, casa e assistenza per tanti cittadini europei non ce ne può essere per i nuovi arrivati: questo è l’argomento alla base della svolta impressa alle politiche migratorie.
A questa chiusura delle frontiere e delle menti si è poi sovrapposta un’ondata di «islamofobia» alimentata dalle stragi perpetrate da membri o simpatizzanti di organizzazioni terroristiche islamiste. Alla sensazione diffusa che «sono troppi», alimentata dall’austerità, si è così mescolato, ad opera dei numerosi imprenditori politici della paura, il tentativo di attribuire all’arrivo dei profughi la proliferazione del terrorismo.
Oggi di fronte alla marea montante delle destre razziste Angela Merkel sembra rappresentare un baluardo, nonostante le sue oscillazioni e i suoi arretramenti. Ma all’origine della «crisi dei migranti», cioè dell’idea che per loro non ci sia più posto in Europa, c’è proprio l’austerità di cui la Merkel è la principale sponsor. E senza affrontarne le cause, la sua collocazione politica l’ha posta sulla china di un progressivo cedimento all’oltranzismo xenofobo.
Ma è soprattutto il metodo adottato per arginare la «piena» dei profughi che ad essere per molti versi criminale e carico di rischi. L’accordo con Erdogan, che ispira tutti gli altri accordi con paesi di origine o transito di profughi, imprigiona milioni di esseri umani nelle mani di governi e bande armate che hanno già dimostrato una vocazione a sfruttarli fino all’osso per poi farne scempio. Ma espone anche gli Stati europei al ricatto (già messo in atto a suo tempo da Gheddafi e oggi ventilato da Erdogan) di aprire le dighe di quei flussi se i rispettivi governi non saranno acquiescenti.
Ma alcuni semplici punti vanno messi in chiaro.
1. I profughi di oggi fuggono in gran parte da quelle stesse forze che sono gli ispiratori, se non gli organizzatori, degli attentati che stanno insanguinando le città europee. Respingerli significa ributtarli in loro balia e, in mancanza di alternative, costringere una parte a diventarne le future reclute.
2. La politica dei rimpatri è impraticabile se non per piccoli gruppi: per mancanza di interlocutori affidabili, per il costo (tanto è vero che vengono espulsi «per finta»), per il rischio di pagarla avallando le peggiori dittature e, non ultimo, perché è una politica di sterminio, anche se «esternalizzato».
3. La distinzione tra migranti economici e profughi politici su cui si regge la prospettiva dei rimpatri è un alibi privo di basi: sono tutti migranti ambientali, mossi da conflitti sempre più atroci innescati da un deterioramento radicale del loro habitat. C’è ormai una sovrapposizione netta tra i paesi centroafricani investiti dalla crisi climatica, quelli coinvolti in conflitti riconducibili a organizzazioni islamiste e l’origine dei maggiori flussi di profughi.
Ma anche la guerra civile (e mondiale) in Siria è partita da una rivolta contro il feroce regime di Assad innescata dal deterioramento ambientale del territorio; di quel fiume di profughi, e delle devastazione e degli orrori che li hanno fatti fuggire, i governi europei recano una pesante responsabilità: attraverso la Nato e la Turchia, appoggiandosi sui più feroci regimi mediorientali, non hanno esitato a fare della popolazione siriana in rivolta un ostaggio delle peggiori bande islamiste, Isis compreso, di cui ora sono il bersaglio. E facendo entrare i campo i bombardieri russi che hanno trasformato la guerra in conflitto mondiale.
4. Trasformare l’Europa in una fortezza, posto che sia possibile, significa metterla in mano a forze razziste e antidemocratiche al suo interno; ma anche perpetuare uno stato di guerra al di fuori dei suoi confini. Se nella fortezza non si può più entrare, diventerà sempre più difficile anche uscirne. Qualcuno farà mai turismo o affari leciti in luoghi come lo Stato islamico o tra i Boko haram?
5. Per questo restiutuire a ogni cittadino europeo i diritti sociali, civili e politici e garantire ai profughi i diritti che spettano a ogni essere umano è un’unica battaglia. Ed è l’unico modo, alla lunga, di prosciugare lo stagno dove sguazza il terrorismo islamista.
 «La necessità di una corretta informazione come antidoto all’hate speech è il contributo che abbiamo ritenuto di portare ai lavori della Commissione contro l’intolleranza e l’odio».
«La necessità di una corretta informazione come antidoto all’hate speech è il contributo che abbiamo ritenuto di portare ai lavori della Commissione contro l’intolleranza e l’odio».
Articolo21 online, 20 dicembre 2016 (c.m.c.)
Un anno fa, nel presentare la precedente edizione di questo rapporto, definivamo “impressionante” ma “non sorprendente” la quantità di articoli e di servizi televisivi che i media italiani avevano dedicato all’immigrazione nel corso del 2015: una crescita da 70 al 180 per cento nella carta stampata e fino al 400 per cento nelle tv.
“Non sorprendente” perché nel corso di quell’anno si erano verificati alcuni eventi che, in base agli ordinari “criteri di notiziabilità”, erano di rilevanza assoluta ed era dunque fisiologico che avessero prodotto un gran numero di articoli e di servizi: il naufragio del 18 aprile (a pochi mesi dalla sospensione dell’operazione Mare Nostrum) con 800 vittime, e la morte del piccolo Aylan Kurdi con quella sequenza fotografica che commosse il mondo.
Nel 2016 non si sono verificati eventi di quella portata eppure – ci dice l’analisi dell’Osservatorio di Pavia – quei numeri impressionanti si sono sostanzialmente ripetuti: una leggera flessione quanto ai servizi televisivi, un ulteriore incremento nei titoli delle prime pagine dei quotidiani nazionali.
Il dato quantitativo, insomma, si è stabilizzato: si parla molto più di prima dell’immigrazione, anche in assenza di notizie clamorose. Se negli anni passati se ne parlava in occasione di tragedie del mare, di gravi fatti di cronaca nera, dei ciclici aumenti degli sbarchi (le “invasioni”) e, spesso in chiave emergenziale, in coincidenza con le campagne elettorali, adesso se ne parla con continuità, quasi tutti i giorni, e vi si arriva attraverso percorsi un tempo praticati, raramente, da pochi specialisti del settore: dalle analisi sull’organizzazione del lavoro a quelle sull’equilibrio del sistema pensionistico, dagli studi sulla nuova imprenditoria ai rimedi per frenare lo spopolamento delle zone interne. Il tema dell’immigrazione è entrato, in modo strutturale e pervasivo, nel sistema dell’informazione.
L’approdo auspicato da anni – far uscire l’emigrazione dall’eterna emergenza e considerarla finalmente una delle ordinarie tematiche sociali del nostro Paese e del nostro tempo – è stato dunque raggiunto dai media italiani? O è stato il tema a espandersi in una misura tale da imporsi ai media, anche quelli che lo snobbavano considerandolo di scarsissimo appeal per i loro lettori e ascoltatori? È difficile dare una risposta netta. Di certo i due processi non sono alternativi tra loro.
L’impressione è che si siano verificati entrambi. L’immigrazione, attraverso la sua drammatica forza autonoma, si è imposta come tema centrale dell’agenda europea e, contemporaneamente, è cresciuto il numero dei professionisti che hanno deciso di approfondirlo. Ipotesi, quest’ultima, che avanziamo anche alla luce della grande partecipazione dei colleghi alle iniziative formative che abbiamo curato in questi dodici mesi.
A confermare l’avvenuto “approdo alla normalità” il calo della “componente ansiogena” delle notizie e il comparire, nei toni e negli stili delle notizie sull’immigrazione, di modelli tipici dell’informazione politica. Se negli anni scorsi i media più ostili all’accoglienza abbondavano di allarmi, adesso utilizzano lo strumento dell’ironia, e a volte del sarcasmo. È più difficile brandire un tema diventato “normale” e si preferisce, quando è possibile, liquidarlo. In un certo senso, mentre se ne vorrebbe contestare la legittimità, si conferma attraverso il linguaggio il pieno ingresso dell’immigrazione nell’agenda politica.
Ma la conferma più chiara viene da alcuni dei dati illustrati in questo rapporto. Gli analisti dell’Osservatorio di Pavia hanno rilevato che nei servizi sull’immigrazione mandati in onda nel corso del 2016 dai tg nella fascia prime time, i politici italiani sono presenti una volta ogni tre e quelli europei una volta ogni cinque. Complessivamente, i politici sono dunque presenti, quando si parla di immigrazione, in un servizio su due. Una percentuale che cala drasticamente quando si esamina la presenza di esponenti politici in servizi dedicati ad altre tematiche pure di grande rilevanza sociale.
Inoltre, quanto alla carta stampata, si è constatato che nella metà dei titoli dedicati all’immigrazione si fa riferimento esplicito a esponenti politici italiani e/o europei. Come ben sanno i colleghi che ci hanno seguito in questi anni, il nostro “chiodo fisso”, l’assunto metodologico che ci guida, è chiarire che le regole della Carta di Roma non costituiscono un mansionario per giornalisti “buoni” e “politicamente corretti”. Il nostro codice deontologico non fa altro che riferire a un tema particolarmente complesso e delicato qual è l’immigrazione le regole deontologiche generali. Su questo assunto si fonda la convinzione che, sperimentandole sull’immigrazione, possiamo migliorare e affinare le nostre capacità professionali. Proprio come un chirurgo che migliora le tecniche operatorie intervenendo sul corpo dei pazienti più fragili.
I dati sulla crescente presenza di esponenti politici nei servizi dedicati all’immigrazione, mentre rappresentano una formidabile conferma della “normalizzazione” del tema, sono anche una conferma della tendenza del nostro sistema informativo ad assecondare l’agenda politica. Un’agenda nella quale l’immigrazione compare come terreno di scontro.
Abbiamo preso atto, finalmente, del fatto che era ora di smetterla di usare toni ansiogeni ed emergenziali per un fenomeno che dura da più di vent’anni, ma la politica ancora non l’ha fatto. Lo scontro si riaccende in seguito a eventi connessi per larga parte all’accoglienza. Gli sbarchi sono diventati “normali”, ma non lo è ancora quel che succede un attimo dopo. Raccontiamo nei dettagli che “sono arrivati”, ma continuiamo a spiegare molto poco perché “sono partiti”. Teniamo la conta dei migranti e dei rifugiati vittime del Mediterraneo e riferiamo di indagini e processi che hanno per protagonisti trafficanti di esseri umani, ma non raccontiamo con altrettanta attenzione i canali alternativi sicuri e legali già attivi, dal reinsediamento ai corridoi umanitari.
La possibilità di un’informazione completa sull’immigrazione – un’informazione che, tra l’altro, sappia spiegare a lettori e telespettatori non solo gli effetti degli arrivi, ma anche le cause delle partenze e delle fughe – continua e entrare in conflitto con una politica che non riesce a trovare un orizzonte condiviso e parla (e litiga) con un’intensità tale da togliere spazio alla voce dei diretti interessati. E che, ancora, sostanzialmente impone la sua agenda, interferendo anche nei percorsi virtuosi.
Diminuisce l’utilizzo di un termine giuridicamente inappropriato come “clandestino”, ma si enfatizza lo status di rifugiato dell’autore di un reato. Anche quando non lo è, come nel caso delle violenze contro le donne compiute la notte di Capodanno a Colonia. Un quadro che conferma la necessità di un sistema di informazione che segua percorsi autonomi, che vada a fondo nelle notizie, che fornisca ai cittadini un quadro completo dei problemi in modo che possano formarsi un giudizio. Come si vede, partendo dall’immigrazione si arriva a conclusioni che riguardano tutti i giornalisti, anche quelli che si occupano di tutt’altro.
La “normalizzazione” ha determinato anche un abbassamento dei toni. Questo Rapporto ci dice che l’hate speech, il discorso d’odio, non riguarda in modo diretto il sistema dei media tradizionali. Non “produciamo” hate speech e, nella generalità dei casi, evitiamo di diventarne veicolo. Facciamo, con una certa efficacia, da filtro. Una buona notizia. Tuttavia dovremmo riflettere sul fatto che l’hate speech, quello che dilaga nei social network, trova alimento nella cattiva informazione. Ed è questa la ragione per cui non possiamo sentirci innocenti.
La necessità di una corretta informazione come antidoto all’hate speech è il contributo che abbiamo ritenuto di portare ai lavori della Commissione contro l’intolleranza e l’odio, la Commissione Joe Cox, istituita su iniziativa della presidente della Camera Laura Boldrini. Consideriamo il fatto della sua istituzione il primo tentativo di ragionare assieme, anche sulle modalità di formazione dell’agenda, tra politica, associazioni umanitarie e professionisti della comunicazione.
Un confronto utile a definire senza equivoci i reciproci ambiti. Ma anche necessario al sistema dell’informazione che ha nei social network dei formidabili alleati e delle insidiose serpi in seno. Se, infatti, per un verso i social consentono di diffondere in una misura un tempo impensabile i contenuti informativi, per altro verso agiscono come organi di informazione autonomi, privi di un direttore responsabile e animati da una moltitudine di redattori, alcuni dei quali totalmente irresponsabili, che diffondono notizie false che in alcuni casi configurano autentici incitamenti all’odio razziale.
Il filtro dei media professionali non è da solo sufficiente in assenza di regole certe che impongano ai social di attenersi alle norme dell’ordinamento giuridico a cui sono sottoposti i loro utenti, i cittadini dei Paesi in cui operano. Questo è il terreno nel quale gli operatori dell’informazione e la politica devono, con urgenza, incontrarsi.

CITTÀ DEL VATICANO «È brutto, è brutto...». L’arcivescovo Nunzio Galantino è appena uscito da una riunione, sera tardi, ancora non sapeva. Berlino, il mercatino di Natale, il camion che piomba sulla folla come a Nizza, i morti. «Questi atti, con la loro disumanità, vogliono paralizzarci la vita. A questo mira chi compie questa violenza bestiale». Il segretario generale della Cei resta in silenzio per un attimo, sospira. «Per questo dobbiamo continuare a vivere, è evidente».
Eccellenza, l’Italia e l’Europa sono piene di mercatini di Natale. Già prima del Giubileo la Chiesa invitò a non cedere alla paura. Che si può dire, ora?
«Chi fa queste cose si propone proprio di paralizzarci. A Natale, ovvio, l’impatto è ancora più brutto. Si capisce la paura, lo scoraggiamento, la rassegnazione. Ma non è un segno di incoscienza dire: non possiamo fare il loro gioco e dare a queste persone il potere di annientare qualsiasi voglia di vivere, di andare avanti, di cambiare. Eppure non basta affermare tutto questo».
In che senso?
«Dire che non bisogna farsi vincere dalla violenza e dalla paura può essere una frase stupida e vuota, se non è seguita dall’impegno di ciascuno a prendersi le proprie responsabilità. Ad essere tutti più uniti, più tolleranti. E guardarsi dalla violenza, anche nell’uso del linguaggio».
C'è una violenza diffusa?
«Io non voglio mettere tutto insieme. Però la volgarità e l’aggressività del linguaggio alimentano un clima che incattivisce le persone e allontana gli sforzi di convivenza pacifica. Esiste anche un terrorismo del linguaggio, si uccide anche con la calunnia. Guardi nei media, in tv, la politica. Per non parlare dei social network: la parola di un imbecille vale come quella di un Nobel, come diceva Eco, e spesso la parola di un violento o di un guerrafondaio ha molto più sostegno».
Torneranno le polemiche sullo scontro di civiltà...
«Ogni violenza è ingiustificabile e inaccettabile, tanto più per motivi religiosi. Ma lo scontro di civiltà è ciò che si propongono i violenti. Se anche ci fosse questo, e io non lo credo, al fondo c’è soltanto egoismo e sopraffazione. Guadagna chi ha interessi di potere o denaro, chi commercia in armi. Alla fine, nelle guerre, va a morire la povera gente. I signori si arricchiscono».
C’è stato anche l’assassinio ad Ankara dell’ambasciatore russo...
«Bisognerà capire cosa c’è dietro, non si uccide un ambasciatore così, per caso. Anche questo innescherà un meccanismo di ritorsioni...».
Nel 2017 saranno passati cent’anni dalla «lettera ai capi dei popoli belligeranti» di Benedetto XV, l'«inutile strage» della Grande guerra. Francesco parla di una «terza guerra mondiale a pezzi», rischia di essere altrettanto inascoltato?
«Temo di sì, i Papi finora sono stati inascoltati: egoismi e interessi hanno la meglio. Senza risalire a Benedetto XV, pensiamo alle parole chiare di Giovanni Paolo II all’inizio della Guerra del Golfo. Francesco ci sta inviando a rispettare la vita. Il terrorista non rispetta la vita. E nemmeno chi usa violenza, anche verbale».
Che si può fare?
«Tante cose belle che si fanno in questi giorni sono trattate alla stregua di addobbi natalizi: passata la festa, li si ripone negli scatoloni. Lo sforzo per la pace deve andare avanti».

«». La Repubblica, 19 dicembre 2016 (c.m.c.)
L’immigrazione è un capitolo centrale dello “spettacolo della vita”, che scorre sugli schermi e sulle pagine dei media. Ogni giorno, senza soluzione di continuità. Riflesso di un’emergenza infinita, visto che i flussi di migranti non finiscono mai. Mentre gli sbarchi proseguono. E il fondo del mare intorno a noi si è trasformato in un cimitero sommerso. Gli immigrati e l’immigrazione hanno “invaso” anche i media. Lo conferma il IV Rapporto curato da “Carta di Roma”.
Visto che la frequenza degli articoli e dei titoli sull’argomento, nel 2016, è aumentata di oltre il 10%, rispetto al 2015. Quando si era osservata la crescita più significativa dall’avvio di questo Osservatorio. Nell’ultimo anno, i servizi dedicati all’argomento nei telegiornali risultano 2954, con una media di quasi 10 notizie al giorno. Insomma, gli immigrati sono divenuti un tema dominante di cronaca e dibattito pubblico. Uno spazio fisso nelle prime pagine dei giornali e nei titoli di apertura dei tg nazionali di prima serata. Quasi una “rubrica”. Hanno occupato anche la comunicazione sui social media.
Intanto, la paura degli “altri” non accenna a declinare. Nel mese di aprile 2016, in Italia, l’indice di preoccupazione verso gli immigrati è salito al 41% (Sondaggio Demos): 10 punti di più rispetto all’aprile 2010.
Tuttavia, la frequenza degli articoli e dei titoli non si riflette sulla drammatizzazione “narrativa” dell’argomento. Gli sbarchi continui degli immigrati, infatti, sui media non fanno più grande rumore. Non sono sottolineati con enfasi e toni particolarmente ostili. Fatte salve, ovviamente, le differenze di testata. L’invasione degli immigrati sui media, nell’ultimo anno, si presenta e viene presentata, invece, come un fenomeno (quasi) “normale”, nella sua costante crescita.
Anche se le polemiche e l’allarme sui migranti non sono cessati. Non si sono spenti. Ma vengono espressi e amplificati non tanto dai media e dai “mediatori”, cioè, i giornalisti. Come mostra Il Rapporto redatto da “Carta di Roma”, sono, invece, usati (spesso strumentalmente) dagli esponenti politici e di partito. In oltre metà dei casi, peraltro, il tema dell’immigrazione è affrontato in chiave politica europea. Meglio, di polemica (anti)europea. Così, l’allarme e la tensione verso gli immigrati, sui media, nell’ultimo periodo si sono stemperati.
Perché l’immigrazione appare “un’emergenza normale”. E gli immigrati, “un popolo senza volto”. Inoltre, perché le voci dei politici che ne parlano sono ancor più “impopolari”. E intercettano il risentimento “popolare”.
Tuttavia, diversi media producono diversi messaggi, anche quando il contenuto è lo stesso. La distinzione più importante, al proposito, riguarda - e divide - i media tradizionali e nuovi. Perché si traduce nella distinzione fra comunicazione “mediata” - espressa dai media e dai mediatori - e “immediata”, orizzontale — espressa direttamente dalle persone. Sui social media, senza filtri. È qui che la comunicazione rischia di diventare - e spesso diventa - più violenta, quando si parla di migranti e di immigrazione. E qui, proprio per questo, è necessario esercitare maggiore sorveglianza. Sorvegliando i sorveglianti. Visto che i social media e la rete sono considerati canali di “sorveglianza” nei confronti del potere. Ma non sempre esercitano il medesimo auto- controllo. Su loro stessi.
Per questo, in futuro, occorrerà analizzare in modo più attento la presenza degli immigrati sui media. Sui diversi canali di informazione. Per evitare la scissione, sempre più evidente, fra la normalizzazione del fenomeno sui media tradizionali e la drammatizzazione che subisce sui media nuovi e immediati. Per tenere sotto controllo la paura, ma anche la pietà. Perché la pietà può essere, a sua volta, “feroce”, quando diventa spettacolo. Come avviene, sempre più spesso, nel caso dell’immigrazione. Che l’informazione ha normalizzato. Fin quasi a nasconderla. Nell’ombra dell’indifferenza. Con il rischio di nascondere - e dissimulare - anche l’intolleranza. Un sentimento tutt’altro che “normalizzato”.
Meglio, però, non fingere. E se è impossibile azzerare il razzismo e neutralizzare i razzisti, conviene renderli evidenti. Poi, a ciascuno il compito di agire e di reagire di conseguenza.
 «I migranti sbarcati in Italia scappano da guerre, violenze, persecuzioni, miserie, conflitti. Il 18 dicembre è una data importante, segnata per ricordare le loro storie, le loro vicende
«I migranti sbarcati in Italia scappano da guerre, violenze, persecuzioni, miserie, conflitti. Il 18 dicembre è una data importante, segnata per ricordare le loro storie, le loro vicende
». Corriere della sera, Corriere sociale online, 18 dicembre 2016, con postilla sulla JP Morgan
Se guardi nella profondità dei suoi occhi, puoi ancora vedere tracce del riflesso di dolori e violenze che lo accompagnano sin da quando era molto piccolo. Ed ora che di anni ne ha 18, Kone sta provando ad allontanare dalla sua vita i momenti più drammatici e difficili per realizzare i suoi sogni più ambiziosi e confidare in un futuro più generoso del passato. Perché Kone, della Costa d’Avorio, ha perso il papà molto presto ed è cresciuto con la madre, attivista politica dell’opposizione. A soli 9 anni, però, ha assistito al pestaggio e all’arresto della madre da parte della polizia governativa. A quel punto, Kone ha iniziato il suo viaggio. Fisico e mentale. Ha seguito il tragitto compiuto da migliaia di migranti che ogni anno transitano dal Mali e dal Niger per arrivare in Libia. E’ in questa terra martoriata e in piena guerra civile che ha svolto lavori saltuari per pagarsi le tratte del viaggio, per garantirsi la miglior vita possibile dopo l’inferno che aveva vissuto e toccato con mano.
"Sosteniamoci" per minori stranieri non accompagnati
Kone fa parte dei 15 mila minori arrivati nel 2016 sulle coste italiane senza genitori, bambini in condizioni al limite della sopravvivenza ed in fuga da contesti di guerra, violenza, povertà. Adolescenti di 12-17 anni, provenienti da Paesi diversi, come Egitto, Gambia, Albania, Eritrea, Nigeria, Guinea, Costa d’Avorio e Somalia. Secondo gli ultimi dati del Ministero dell’Interno. Kone nella città di Bergamo ha trovato la risposta al suo viaggio migratorio. Perché fa parte dei 25 minori stranieri non accompagnati inseriti nel progetto "SOSteniamoci", l’iniziativa realizzata da Cesvi con il sostegno di Brembo per favorire l’autonomia socioeconomica dei ragazzi, supportandoli nella realizzazione del loro progetto di vita tramite la creazione di percorsi formativi a cui farà seguito un processo di inserimento lavorativo in varie realtà del bergamasco.
Quella di Kone, dunque, è una storia destinata a cambiare, ad evolvere in un sentiero di piena integrazione nella comunità e di acquisizioni di competenze professionali. Ma per tutti gli altri?
La giornata internazionale di solidarietà
Dal primo gennaio al 31 ottobre 2016 sono più di 158.795 i migranti sbarcati in Italia. Scappano da guerre, violenze, persecuzioni, miserie, conflitti. Il 18 dicembre è una data importante, segnata per ricordare le loro storie, le loro vicende. La Giornata Internazionale di Solidarietà con i Migranti, infatti, è stata istituita nel 2000 dall’Organizzazione delle Nazioni Unite perché in questo stesso giorno del 1990, l’Assemblea Generale dell’ONU aveva adottato la Convenzione Internazionale per la tutela dei diritti di tutti i lavoratori migranti e dei membri delle loro famiglie. Ed allora storie come quelle di Kone aiutano fare memoria, a creare una maggiore coscienza sul fenomeno dell’immigrazione, ad approfondire meglio cosa succede nei loro Paesi e cosa c’è dietro la fuga che troppo spesso coincide con la perdita di numerose vite umane durante il cosiddetto viaggio della speranza.
In fuga da Boko Haram
Grace ha 40 anni e vive in Nigeria. Circa sei anni il suo villaggio è stato attaccato, saccheggiato e distrutto da Boko Haram. Grace in quel periodo era incinta e viveva col marito ed il figlio di 12 anni. L’intera famiglia è stata catturata dalle milizie jihadiste. Grace nel periodo di prigionia ha dovuto subire ogni forma di schiavitù, ha fatto lavori pesanti, ha sofferto tanto, ma in qualche modo è riuscita a scappare e a far perdere le sue tracce.
E’ tornata nel suo villaggio ed ha aspettato il ritorno dei suoi cari. Durante la straziante attesa ha anche partorito il suo secondo bambino. Il marito un giorno ha fatto ritorno a casa, ma l’altro suo figlio non è più tornato al villaggio. Lo sta ancora aspettando, perché è convinta che sia ancora sotto le mani di Boko Haram, utilizzato probabilmente come bambino soldato.
Una delle più gravi crisi umanitarie si sta consumando in Africa proprio a causa degli attacchi indiscriminati di Boko Haram ed a pagarne le conseguenze come Grace e la sua famiglia sono 21 milione di persone; 2,6 milioni di persone, invece, sono state costrette a lasciare le loro case per evitare la morte.
E’ una migrazione silenziosa e dimenticata dall’opinione pubblica che coinvolge la regione del bacino del Lago Ciad dove si affacciano il Camerun, il Niger, la Nigeria e il Ciad. Dal 2009 l’area è stata assediata da Boko Haram nel tentativo di instaurare un califfato islamico in Africa occidentale; le violenze delle milizie dell’estremista jihadista si sono concentrate in particolare nel nord-est della Nigeria. «Tra gli esuli vi è un ampio numero di bambine che sono state sottoposte a violenze di ogni tipo – spiega Tiziana Fattori, Direttore Nazionale di Plan International Italia – .
Alle bambine tocca pagare sempre doppio in quanto quelle abusate vengono stigmatizzate dalle comunità, specie se rimaste incinte durante la cattura. Infatti molte di loro non vogliono tornare nel loro villaggio, temendo il disonore per la loro famiglia che le ripudierebbe». Di conseguenza, i programmi in loco di "Plan International" per i bambini migranti hanno due focus: la protezione infantile e l’aiuto alle vittime di violenza di genere. Ma di recente Plan International ha anche aperto due uffici per avviare un programma dedicata alla ricerca dei bambini scomparsi, proprio come nel caso di Grace che nonostante tutto non ha ancora perso la speranza.
Contrastare la tratta di esseri umani
Quello di Seny, invece, è stato un viaggio di ritorno. Disoccupazione, mercato locale sottosviluppato, mancanza di competenze professionali, il giovane è partito dalla sua terra, dal Senegal per sognare un futuro migliore in Europa. Non sapeva che la morte è un prezzo concreto da pagare se ci si mette in viaggio senza essere a conoscenza dei pericoli o di che cosa sia la tratta di esseri umani. Anche Seny è stato fortunato. Perché al suo arrivo in Italia è stato accolto in Centro di Accoglienza in Sicilia. E’ qui che il giovane ha conosciuto gli operatori di Missioni Don Bosco e VIS (Volontariato Internazionale per lo Sviluppo), le due realtà promotrici della campagna "Stop-Tratta – Qui si tratta di essere/i umani", rivolta a cinque Paesi di origine e transito dell’Africa Sub-Sahariana: Ghana, Senegal, Nigeria, Costa d’Avorio ed Etiopia.
Attraverso il progetto, quindi, Seny è tornato nel villaggio da cui era partito per incontrare e parlare con la sua gente, con la sua comunità d’origine. Ha raccontato, a chi lo conosce da sempre, il terribile viaggio che ha dovuto affrontare, i pericoli, le insidie.
Non a caso, la campagna è nata dalla necessità di contrastare il traffico di esseri umani attraverso la sensibilizzazione dei potenziali migranti sui rischi del viaggio verso l’Europa, dalla detenzione alla morte, fornendo informazioni utili attraverso i social network e contenuti nelle lingue locali per favorire una scelta consapevole. Seny ha portato la sua diretta testimonianza. Ma il lavoro di VIS e Missioni Don Bosco prosegue nei cinque Paesi coinvolti con l’attivazione di corsi di formazione professionale. Idraulica, sartoria, informatica, agricoltura, elettromeccanica e tanto altro. Perché al viaggio, i migranti devono preferire sfruttare le risorse e le ricchezze offerte dai loro territori e le varie competenze professionali acquisite.
Il lavoro per l'integrazione
Intanto, proprio nella Giornata nata nel rispetto della Convenzione Internazionale per la tutela dei diritti di tutti i lavoratori migranti e dei membri delle loro famiglie, prende il via Work 4 Integration»
, il progetto promosso dall’Organizzazione Umanitaria Soleterre-Strategie di pace destinato a 120 cittadini migranti residenti nella provincia di Milano disoccupati o a rischio disoccupazione. Tra il 2010 e il 2014 il tasso di occupazione a livello nazionale è diminuito del 5,5 %, passando dal 68,1 % al 62,6 %. All’interno di questo scenario, quindi, i migranti sono vittime di discriminazioni (retribuzione, condizioni di lavoro, possibilità di carriera), segregazione orizzontale e verticale in settori e mansioni specifici e di iper-specializzazione che porta fino al de-mansionamento, fenomeno per cui l’Italia presenta i tassi più alti d’Europa e che rappresenta dunque un tratto caratteristico del modello d’integrazione italiano.
Le difficoltà primarie che gli immigrati in Italia devono affrontare nella ricerca del lavoro sono le conoscenze linguistiche, in particolare la terminologia specifica del settore lavorativo, il livello di istruzione e le competenze tecniche che potrebbero non aderire agli standard italiani. E’ qui che si inserisce il progetto finanziato dalla JP Morgan Chase Foundation, che per 18 mesi coinvolgerà i migranti residenti nella provincia di Milano in attività che facilitano l’accesso all’informazione, alla formazione e all’inserimento lavorativo. Obiettivo dell’iniziativa è assicurare il benessere psicosociale di uomini e donne adulti e neo-maggiorenni, sostenendo i loro percorsi migratori con particolare attenzione alla dimensione lavorativa, e sensibilizzare le aziende su questi delicati temi.
postilla
Il riferimento alla JP Morgan (quella multinazionale che ha raccomandato ai governi dell'Europa del Sud di rendere le loro costituzioni meno favorevoli ai diritti dei lavoratori e alla democrazia) fa venire in mente brutti pensieri. E in particolare fa ricordare quanto sia labile il confine tra neoschiavismo e offerta di attività ai migranti. Oltre all'affidabilità della rete d'accoglienza, la garanzia è forse costituita dall'offrire occasioni di lavoro non a migranti singoli, ma a gruppi capaci di autodeterminazione.
 «L’attivismo di Renzi per tornare al potere appartiene al campo del tragico. Senza più alcuna credibile capacità offensiva, la sua presenza al timone è la garanzia più certa del naufragio inevitabile.».
«L’attivismo di Renzi per tornare al potere appartiene al campo del tragico. Senza più alcuna credibile capacità offensiva, la sua presenza al timone è la garanzia più certa del naufragio inevitabile.».
il manifesto 18 dicembre 2016
L’assemblea di oggi del Partito democratico dovrebbe rispondere a una domanda: quali caratteri di sistema ha la sconfitta di Matteo Renzi? Il plebiscito, che lo ha travolto, è il frutto di un processo lungo di perdita di ogni credibilità.
Nessun leader può vincere in una contesa se la sua stessa parola, a maggior ragione dopo un abbandono così riluttante, è percepita come ingannevole. Quando il loro leader ha perso l’ethos, ovvero il carattere, l’immagine che rende rispettabile, e degna di essere seguita, una figura pubblica, i ceti politici di supporto devono prendere gli accorgimenti inevitabili: affidarsi a un altro capo per sopravvivere. Occorre che qualcuno persuada i dirigenti del Pd oggi riuniti che è necessario che "pria facciate al duce spento/successor novo, e di voi cura ei prenda". Ma il Pd, che ha scambiato la personalizzazione della politica con il partito della persona, ha smembrato questo argine. E quindi, mentre il sistema bipolare proprio con il referendum ha replicato il grande crollo del 2013, si coltiva l’illusione di una sua restaurazione imminente, ad opera dello stesso leader annichilito, che crede di avere in dote un potere personale.
Dopo il tracollo di dicembre, che è il compimento di un ciclo e non una eruzione improvvisa di cieca protesta, Renzi non ha più alcuna seria possibilità di trionfo. Questo non significa che ormai irrilevante risulti la sua ombra nella prossima battaglia. «Nessun problema politico – spiegava Bismarck – giunge ad una completa soluzione di tipo matematico. I nodi appaiono, hanno i loro tempi, e poi scompaiono soltanto sotto altri problemi». Finché non si completa il seppellimento del capo, la cui fascinazione è dileguata, altri problemi non compaiono a strutturare i nuovi conflitti.
Non porterà alcun effetto ricostituente per la democrazia la cura rivoltante di un governo sotto tutela dei consoli gigliati spediti a presidiare palazzo Chigi. Accresce ancor più la rabbia un esecutivo che occupa il tempo solo per scaldare la poltrona vacante e riconsegnarla al capo voglioso di riavere lo scettro che ha solo accantonato per qualche mese.
Un leader del tutto annebbiato impone alle sue truppe una mappa irrealistica di risalita perché è saltato il sistema bipolare. Renzi pensa ancora ad un traino leaderistico esercitato dal capo con un preteso dono carismatico: spento rito delle primarie, incoronazione nella marcia dei gazebo e poi assalto disperato al palazzo. Il punto di debolezza della sua strategia è evidente: confida in un nuovo congegno maggioritario per blindare un bipolarismo solo immaginario.
L’attivismo di Renzi per tornare al potere appartiene al campo del tragico. Senza più alcuna credibile capacità offensiva, la sua presenza al timone è la garanzia più certa del naufragio inevitabile. Anche per questa sua vulnerabilità estrema il M5S lo ha irriso chiedendogli di rimanere a palazzo Chigi sino al voto. Non spaventa più come leader in ascesa, e perciò da temere, e anzi il suo spettro, che emana il volto sfigurato di una potenza in decadenza, incrementa le chances di successo dei nemici. È il peggio che possa capitare per un leader.
La conseguenza della sua nuova scalata alla guida del Pd sarebbe l’esplosione inevitabile del suo partito, entro il quale proprio il suo comando assoluto costituisce il principale elemento divisivo e l’ostacolo insuperabile ad ogni ipotesi di alleanza. Che i notabili del suo giro non ne tengano conto, e fingano di essere ancora sedotti dalla promessa di un simulacro di ordine bipolare, è anch’essa una manifestazione di propensione al tragico.
L’abbandono renziano, con la nostalgia dell’immediato ritorno, coltiva il vizio assurdo di esorcizzare un sistema tripolare con l’energia, con la stabilizzazione di una conquista del centro mediante un regime personale da consolidare attraverso la ripresa economica. Orfano del bipolarismo violato dal popolo, Renzi può mantenerne in vita una caricatura, con il progetto evaporato del partito della nazione, che assorbe i residui del berlusconismo e si erge a paladino del sistema della legittimazione che combatte e isola le forze antisistema (la Lega e il M5S).
Rientrano nel grottesco le gesta di un leader che dal buen retiro di Rignano minaccia di tornare presto al palazzo brandendo un’ipotesi già sconfitta: il bileaderismo. Renzi? È un problema in astratto risolto che però resiste complicando così le trame di un sistema che non può dedicarsi alle nuove questioni perché deviato dalle velleità di ritorno in sella di un leader del passato. Eppure l’accantonamento di Renzi è la condizione, non sufficiente e però indispensabile, per rispondere ai segnali sempre più preoccupanti di involuzione del sistema.
 A Parigi una grande manifestazione per protestare contro la strage di Aleppo, nel resto del mondo è silenzio. I governi del Primo mondo che non contrastano gli stragisti ne sono complici. Stefano Montefiore intervista Raphaël Glucksmann, uno degli organizzatori della protesta.
A Parigi una grande manifestazione per protestare contro la strage di Aleppo, nel resto del mondo è silenzio. I governi del Primo mondo che non contrastano gli stragisti ne sono complici. Stefano Montefiore intervista Raphaël Glucksmann, uno degli organizzatori della protesta.
Corriere dellasera, 14 dicembre 2016
PARIGI «Ad Aleppo stiamo assistendo alla riedizione degli orrori di Srebrenica in Bosnia e di Grozny in Cecenia, con una differenza. Questa volta i massacri sono raccontati minuto per minuto, su Twitter, dalle stesse vittime. La distrazione dei nostri governi e delle nostre opinioni pubbliche è il segno della débâcle dell’Occidente, dell’umanesimo, dell’Europa». Raphaël Glucksmann ha organizzato ieri, con Amnesty International, Médecins du Monde e altre organizzazioni umanitarie, una manifestazione a Parigi in solidarietà con le vittime di Putin e di Bashar Assad in Siria.
Nei primi anni dell’era Internet si diceva «Auschwitz non sarà più possibile perché la verità emergerà subito». In effetti grazie alla rete sappiamo di un massacro in corso, eppure non riusciamo a fermarlo.«Il merito di Internet e dei social network è quello almeno di toglierci la scusa, non potremo dire “non sapevamo” perché sappiamo tutto e mentre accade. Questo ci responsabilizza e rende l’inazione delle democrazie occidentali ancora più colpevole e difficile da difendere».
È un momento di svolta per l’Occidente?
«Purtroppo sì, mi pare un fiasco umanitario che marcherà le coscienze e la Storia. L’Occidente e l’Europa non hanno voce in capitolo. I nostri migliori dirigenti sono ridotti al ruolo di commentatori: giudicano il crimine invece di provare a impedirlo. L’amministrazione Usa parla di peggiore catastrofe del XXI secolo, ma non è in grado di fare nulla. Nel nuovo mondo Putin e Erdogan decideranno tutto senza di noi, senza badare a diritti umani e leggi internazionali».
Non entra in gioco anche una certa confusione dell’opinione pubblica? Quando si parla di Siria si tende a pensare al luogo dove lo Stato islamico tiene le sue basi. In Francia il nuovo favorito all’Eliseo, François Fillon, ha detto in tv che ci sono due campi in Siria: i terroristi e gli altri, e lui sta con gli altri.
«Ma quel che lui descrive non è la realtà. Gli attentati in Francia hanno fatto vacillare le nostre coscienze, e ormai in nome della lotta al terrorismo tutto è autorizzato. La prima vittima è la verità. Ma ad Aleppo non c’è l’Isis. I terroristi dello Stato islamico sono stati cacciati via da Aleppo. Radendo al suolo una città dove non ci sono terroristi, Putin e Assad fanno del terrorismo di Stato. La nostra guerra contro lo Stato islamico è giusta e va condotta fino in fondo. Ma che c’entrano le donne, i bambini e gli uomini di Aleppo?».
Che cosa potrebbero fare i cittadini europei?
«Ognuno si sente impotente e pensa che fare campagne sui social network o scendere in piazza sia ben poca cosa. È una goccia, ma tante gocce potrebbero creare un movimento di opinione capace di condizionare i politici, per esempio i candidati alle presidenziali francesi».
Molti chiedono la fine delle sanzioni contro la Russia.
«Bisognerebbe fare il contrario e inasprirle, semmai. Nessuno vuole una Terza guerra mondiale, ma tra scatenare una guerra contro la Russia e il non fare nulla c’è molto in mezzo, e si chiama politica. L’Europa dovrebbe, ora o mai più, trovare una posizione politica forte e unitaria se non vuole ridursi a fare da cagnolino di Putin e Trump. Per esempio pensando a boicottare i Mondiali di calcio 2018 in Russia, che altrimenti saranno una gigantesca macchina di propaganda al servizio del presidente russo che assieme al suo alleato siriano Bashar Assad sta compiendo il massacro di Aleppo».
 Nonostante la potenza di fuoco mediatico, la forte capacità di acquisizione del consenso con i mille strumenti del dominio moderno, temono un altro fprte segnale di dissenso popolare. Le inventano tutte per sopravvivere nella loro palude.
Nonostante la potenza di fuoco mediatico, la forte capacità di acquisizione del consenso con i mille strumenti del dominio moderno, temono un altro fprte segnale di dissenso popolare. Le inventano tutte per sopravvivere nella loro palude.
Il manifesto, 14 dicembre 2016
Se quello sulla Costituzione ha provocato un terremoto, il referendum sul jobs act potrebbe essere uno tsunami di proporzioni ancora più imponenti, elettoralmente e socialmente. Non è difficile immaginare come voterebbero gli italiani sul tema del lavoro, giustamente in cima alle preoccupazioni di tutti, giovani in prima fila, saldamente in testa ai sondaggi sulle priorità del paese. Ed è la ragione per cui questo voto molto probabilmente ci verrà sottratto.
Tutto dipende da quanto durerà il governo, cioè quando Renzi deciderà di staccare la spina a Gentiloni, perché in caso di elezioni anticipate il referendum appunto salterebbe. E il più interessato a farlo naufragare è proprio Renzi, davvero costretto a ritirarsi a vita privata nel caso di un’altra batosta.
Ora il tema torna di attualità e in controluce agita gli schieramenti politici. Come dimostra il botta e risposta a distanza tra il ministro del lavoro Poletti, e la leader della Cgil Susanna Camusso.
Il ministro è sicuro che «si andrà alle elezioni prima del referendum». In replica Camusso ha esortato a «lasciar lavorare la Corte provando a essere rispettosi e a non fare pressioni». In soccorso di Poletti (che poi ha chiesto di non essere strumentalizzato, così cadendo nella classica excusatio non petita accusatio manifesta), ieri è arrivata anche Confindustria, guardia scelta renziana, con il suo presidente Boccia a dare l’allarme generale, paventando il rischio del blocco delle assunzioni in caso di referendum sul jobs act. Senza nemmeno l’onestà intellettuale di riconoscere che le assunzioni (senza più l’articolo 18) sono state il frutto dei poderosi sgravi fiscali offerti da Renzi, e che, finiti quelli, subito i posti di lavoro sono scesi in picchiata sostituiti da milioni di voucher che inondavano il mercato del precariato.
Il panico per il referendum sul jobs act ha un po’ ravvivato il clima depresso in cui si stava svolgendo il rito del voto di fiducia al governo. Che si è concluso come era iniziato. Con le aule parlamentari semivuote, gli interventi recitati nel deserto dei banchi di camera e senato. E gli addetti ai lavori attenti a leggere tra le righe del mesto dibattito, per capire quando si andrà a votare, o, per riprendere le parole del capogruppo del Pd, Zanda, quando arriverà al capolinea «il limitato orizzonte elettorale del governo».
Si potrebbe anche dire che a decidere la data delle elezioni sarà il vincitore del prossimo congresso del Pd, quindi Renzi.
Ma proprio sulla tabella di marcia che dovrebbe portarci alle prossime elezioni va a sbattere un appuntamento che potrebbe chiamarci alle urne in primavera, appunto il referendum chiesto dalla Cgil con la raccolta di un milione di firme (anzi: tre milioni, uno per ogni quesito). Nel caso di elezioni anticipate non potrebbe essere celebrato.
Naturalmente si deve prima pronunciare la Corte costituzionale chiamata a rispondere sull’ammissibilità dei quesiti, ma superata questa prova, si dovrebbe procedere alla fissazione della data referendaria che può cadere in un arco temporale che va da aprile a giugno.
Questo ingorgo elettorale la storia della nostra Repubblica lo conosce bene. Altre volte nel passato è successo che per far saltare i referendum gli italiani fossero chiamati al voto anticipato.
E’ evidente che nelle prossime settimane e mesi assisteremo a vari tentativi di disinnescare la mina del referendum. Il più semplice e probabile sarà appunto far cadere il governo-fotocopia entro giugno, giusto in tempo utile per evitare un’altra poderosa onda antigovernativa. Oppure si tenterà di escogitare qualche marchingegno legislativo per dire che del referendum non c’è più bisogno.
 ».
».
Il manifesto, 15 dicembre 2016 (c.m.c.)
Il grado di sofisticazione cui oggi è giunta l’analisi dei flussi elettorali ci consente di cogliere aspetti importanti del voto referendario. È stato a ragione segnalato il carattere «sociale» visibile nella geografia del No lungo la Penisola: la periferia delle città rispetto al loro centro, il Sud rispetto al Nord, i disoccupati rispetto agli occupati, i giovani rispetto agli anziani.
Ma uno sguardo alla cartografia del Sì non è meno interessante per la conferma di tale lettura. Esso fa intravedere le nette fratture, non solo generalmente sociali, ma di classe, che lacerano la società italiana. Le disuguaglianze crescenti dell’ultimo decennio hanno creato nel Paese due mondi separati: quello dei ceti che godono di reddito sufficiente e di sicurezza e possono affrontare la riduzione del welfare e la politica di austerità, e quello degli strati che indietreggiano verso la povertà o nella povertà sono già precipitati.
Quella cartografia ci mostra anche - certo all’ingrosso - un profilo sociologico delle base di consenso di cui godeva il governo Renzi e a cui lo stesso presidente del Consiglio guardava per il proprio progetto di affermazione. È in parte anche la base sociale di questo Pd, che rappresenta ormai prevalentemente gli interessi della media borghesia cittadina, gruppi finanziari e imprenditoriali, settori della stampa, del mondo intellettuale, parte del quale crede di appartenere ancora a una gloriosa tradizione e non si è accorto in quale nuovo continente è approdato.
La vittoria del No è dunque anche l’espressione di un conflitto sociale contro una strategia «classista» di governo che ormai mostrava nitidamente - al di là degli elementi di modernizzazione pur presenti in alcune iniziative - il suo carattere di progetto di «governo della crisi» fondato sul consolidamento di un blocco di classe.
La linea economica di questo esecutivo, l’abbiamo rilevato più volte, consisteva nel tentativo di rilanciare l’economia italiana tramite un rilevante afflusso di investimenti esteri attratti dai vantaggi offerti alla libera valorizzazione dei capitali. Nulla di diverso dallo schema neocoloniale perseguito dal ceto politico dell’Occidente negli ultimi anni. A tal fine si è offerta, o si è cercato di offrire, nuova flessibilità del lavoro (Jobs act), scuola subordinata ai bisogni del mercato del lavoro, agevolazioni fiscali alle imprese, esecutivo libero da eccessivi vincoli di procedure democratiche, ecc.
C’è un passaggio rivelatore, nella politica economica del passato governo, che mostra nitidamente la scelta di consolidamento di un blocco sociale contro le ragioni stesse dell’economia produttiva e di un possibile rilancio della domanda interna: l’esenzione dell’Imu dalla prima casa. Com’è possibile, in un Paese che in meno di 10 anni ha perso il 25% della sua base produttiva, premiare a tal punto la rendita fondiaria, se non per la ragione che Renzi voleva radicare il suo potere nei ceti abbienti della società italiana?
Nel voto del No c’è dunque la sconfitta di questa strategia, che non ha rilanciato l’economia italiana, non ha scalfito la disoccupazione dilagante, non ha ridotto ma esasperato le disuguaglianze, non ha contenuto ma moltiplicato la precarietà del lavoro, non ha attenuato ma accresciuto l’emarginazione della gioventù, non ha sollevato le sorti del Sud, ma ne ha spinto i ceti più deboli nella disperazione sociale.
Forse mai come in questo voto referendario c’è stato tanto conflitto politico contro le classi dirigenti e il loro governo.
Ma questa vittoria che oggi ci esalta, ci inquieta al tempo stesso. Esistono tutte le condizioni perché la sinistra si metta in sintonia con le grandi masse popolari del nostro Paese, con i ceti produttivi, con le nuove generazioni, con le genti del Sud, con i gruppi intellettuali, anche con quelli di area Pd, che devono prendere atto dell’inadeguatezza della loro lettura della crisi e del capitalismo attuale.
Ma dov’è la voce della sinistra? Sel ha compiuto il gesto generoso di sciogliersi per favorire un nuovo processo di aggregazione e si aspettavano le mosse e le iniziative di Sinistra Italiana. Quest’ultima doveva celebrare il proprio congresso fondativo in questo dicembre e lo ha spostato a febbraio. E nel frattempo? I gruppi dirigenti di SI, con l’apporto anche di intellettuali d’area, stanno elaborando una piattaforma programmatica che si mette alle spalle decenni di riformismo neoliberista. Sul piano teorico e culturale si sta scrivendo una nuova pagina progettuale.
Ma è evidente in questo momento l’assenza di senso del tempo, la capacità di seguire le scansioni della lotta in corso con spirito d’iniziativa e creatività di manovra. È oggi, non domani, che è necessario mostrare, ai mille gruppi dispersi della sinistra, ai lavoratori, ai giovani, un punto di riferimento, un centro aggregatore dotato di un serio progetto riformatore, all’altezza delle sfide che l’Italia deve affrontare. Non sappiamo da tempo che, se il nuovo partito nascerà a ridosso delle elezioni, verrà valutato dagli italiani come l’ennesimo tentativo di un ceto politico marginale di ritagliarsi uno spazio qualunque nella rappresentanza parlamentare?
«La crisi si è aperta perché il governo ha ritenuto di aver subito un'epica sconfitta elettorale, ma si è chiusa con lo stesso governo che prendeva a calci nel sedere ognuno dei 19 milioni di italiani che l'hanno sconfitto». Huffington Post online, 23 dicembre 2016
Rino Formica e Aldo Busi non hanno un granché in comune. Eppure, mentre il neo presidente del Consiglio Paolo Gentiloni finiva di leggere la lista dei ministri, mi sono venuti in mente tutti e due. Busi per il titolo di un suo libro - Cazzi e canguri (pochissimi i canguri) -, Formica per il suo più celebre detto, quello per cui «la politica è sangue e merda». Epigrafe perfetta per questo governo: pochissimo - tuttavia - il sangue.
Intendiamoci: durante tutta la campagna referendaria mi sono sgolato (insieme a molti altri: come ricordava oggi il presidente dell'Anpi Carlo Smuraglia in una intervista adamantina) a dire che non ci sarebbe dovuto essere alcun nesso tra riforma costituzionale e sorte del governo. A dire che, in caso di vittoria del No, non avremmo mai chiesto le dimissioni di Renzi: perché era stato un errore (un suo gravissimo errore) mescolare due cose che avrebbero dovuto invece rimanere ben distinte. Ma ormai era fatta, e il combinato disposto (ormai ci siamo affezionati all'espressione) tra l'alta affluenza e il numero dei No non ha lasciato scampo a Matteo Renzi, che si è autocondannato a recitare il suo copione fino in fondo.
Ma...: qua inizia il 'ma', che stasera è esploso in tutta la sua imbarazzante dimensione. La bestemmia era quella del 'governo costituente': e allora avrebbe dovuto lasciare tutto il governo, che si era impegnato per il Sì come un sol uomo, facendo strame di ogni dignità delle istituzioni. E invece no: non si è dimesso il governo, si è dimesso il Capo.
E questo certifica senza possibilità ciò che era evidente da mesi: un partito, un governo, un Paese sono stati inchiodati per mesi dalla incredibile irresponsabilità di un aspirante capo che cercava la consacrazione della folla. Siamo nel 2016, c'è internet, mandiamo una sonda su Marte, ma la spiegazione dello psicodramma collettivo che abbiamo vissuto è chiusa nell'unico mito che gli psicanalisti di corte delle leopolde e delle televisioni non hanno citato: quello di Narciso.
Ora che Narciso è stato inghiottito dallo stagno nero in cui si specchiava, a noi rimane per l'appunto lo stagno: quello della stagnante politica italiana, in cui siamo ripiombati subito, come per malìa. E qui entra in scena l'altra faccia di Narciso, quella del politicante da prima Repubblica (senza un briciolo della cultura di un Rino Formica, però). Che ora si rotola nel fango pur di ottenere che i suoi riescano a tenere un piede nella porta che gli si sta per chiudere in faccia.
E lo fa con il più incredibile disprezzo per quegli stessi 19 milioni di italiani che (a suo stesso dire) l'hanno licenziato: come è possibile che la Boschi sia sempre lì, e in un ruolo chiave? E l'idea grottesca di Lotti ministro dello Sport? Un soluzione che avrebbe fatto arrossire un Forlani o un Nicolazzi: evviva la modernizzazione della vita politica! La logica del Gattopardo non basta più: ora nulla cambia, perché nulla cambi.
Per non parlare della disinvoltura con cui mettiamo Angelino Alfano a capo della nostra diplomazia: tanto valeva metterci Lino Banfi, che è anche più noto, all'estero. O del cinismo con cui all'Ambiente viene confermato l'incredibile Galletti, e ai Beni Culturali viene cementato l'eterno autoreggente Dario Franceschini, che ogni giorno fa rimpiangere Sandro Bondi a chiunque sappia cos'è (o meglio cos'era) il patrimonio culturale.
Insomma: la crisi si è aperta perché il governo ha ritenuto di aver subito un'epica sconfitta elettorale, ma si è chiusa con lo stesso governo che prendeva a calci nel sedere ognuno dei 19 milioni di italiani che l'hanno sconfitto.
I più scafati osservatori notano che Gentiloni e il Quirinale sono riusciti a mettere in sicurezza i Servizi, sottraendoli al Giglio Magico. Può anche darsi che sia vero (tuttavia, in che Paese vivremmo se la partita fosse stata davvero questa?), ma l'unica cosa evidente ai comuni mortali è che l'ondata di sdegno che sta sollevando questo governo 'con pochissimo sangue' sortirà un unico risultato: far guadagnare ai 5 Stelle la maggioranza assoluta dei seggi in Parlamento. Anche senza Italicum: basta il Gentilonum.
Questo è quello che scrive il giornale che è stato tra i maggiori sostenitori di Renzi e del SI al referendum. Bisogna essere proprio ciechi per credere che con Renzi e il renzismo ci possa essre salvezza, e speranza di uscire dal baratro nel quale siamo precipitati.
La Repubblica, 13 dicembre 2016
Ieri sera, mentre i ministri giuravano al Quirinale, qualcuno faceva notare con ironia che il nuovo governo sarebbe stato perfetto se avesse vinto il Sì. In quel caso al posto di Gentiloni avremmo visto ancora Renzi, ma per il resto nessuna differenza. Maria Elena Boschi sarebbe stata premiata come in effetti è avvenuto: sottosegretario alla presidenza del Consiglio, un posto chiave per il quale occorre esperienza, tatto e profonda conoscenza della macchina statale. Doti che l’ex ministra delle Riforme non ha mai mostrato di possedere, se non altro per via della giovane età. In questo caso, tuttavia, le sarà sufficiente tener d’occhio il calendario delle nomine nei grandi enti e negli altri centri di potere, badando che i prescelti non siano sgraditi al segretario del Pd. Luca Lotti sarebbe diventato ministro, sia pure senza portafoglio. E davvero lo è diventato, mantenendo peraltro il suo ufficio a Palazzo Chigi, con competenza sull’editoria e, per buona misura, anche sul Cipe. In caso di vittoria del Sì il ministro dell’Interno avrebbe potuto pretendere un premio alla propria lealtà. Lo ha ottenuto lo stesso, visto che Alfano è da ieri ministro degli Esteri, responsabile delle relazioni internazionali dell’Italia, forse la poltrona più importante.
Si pensava che fosse interesse del nuovo presidente del Consiglio marcare un qualche grado di autonomia e non consegnarsi mani e piedi alla polemica dei Cinque Stelle e della Lega. Invece il tema del governo fotocopia, agitato dalle opposizioni, acquista legittimazione e addirittura viene sbandierato da un segmento scontento e frustrato della maggioranza come il gruppo di Denis Verdini, rimasto a mani vuote. Quasi fotocopia, per la verità: si deve riconoscere che l’ingresso di Anna Finocchiaro, parlamentare competente e da tutti stimata, è una delle poche note positive. Insieme ad altre due. La prima è la nomina di De Vincenti a ministro della Coesione nazionale, pur se il governo avrebbe tratto vantaggio dalla sua permanenza a Palazzo Chigi come sottosegretario alla presidenza e gestore dei dossier più delicati (il lavoro che da oggi, come si è detto, dovrebbe esser svolto da Maria Elena Boschi).
La seconda novità è la decisione di Gentiloni di trattenere per sé le deleghe sui servizi di sicurezza che nel precedente esecutivo erano nelle mani di Minniti, persona affidabile a cui è stata data la responsabilità del Viminale. Non è dato sapere con certezza se in questa scelta abbia pesato il consiglio di Mattarella. Di certo è fallito il complicato percorso di cui si vociferava e che avrebbe dovuto concludersi con le deleghe assegnate a Luca Lotti, l’efficiente amico e consigliere di Renzi. Questo è il punto politicamente più rilevante della giornata. La prova indiretta che il governo Gentiloni vive, come è ovvio, dell’appoggio parlamentare del Pd e dei centristi, ma anche di una buona relazione fra il nuovo premier e il capo dello Stato. È in una certa misura, o almeno dovrebbe essere, una sorta di “governo del presidente” che si appoggia da un lato al Parlamento e dall’altro al Quirinale. Al punto che si poteva immaginare che l’influenza del Colle riuscisse a favorire la nascita di un esecutivo dal profilo più alto e soprattutto più innovativo.
Così non è stato e il calcolo di Gentiloni è oggi quello di non approfondire il solco con Largo del Nazareno. Dove in effetti Renzi agisce come se il referendum avesse regalato al Pd un successo da coltivare con cura. L’idea, un filo paradossale, è che il 41 per cento del Sì costituisce un patrimonio del Pd e del suo leader. Quindi il problema è quello di non disperdere quei voti e di metterli nell’urna delle prossime politiche. Il che spiega anche perché nessun esponente del No sia stato invitato a entrare nel governo semi-fotocopia. Si capisce che il cammino di Gentiloni è impervio, forse più di quanto egli stesso immaginasse. Tuttavia il futuro è ancora da scrivere. Il nodo della legge elettorale resta cruciale e qui i toni misurati e concilianti del presidente del Consiglio, che non vuole invadere lo spazio del Parlamento, permetteranno — si spera — alle parti politiche di avviare un negoziato serio. Non saranno le “larghe intese”, ma è chiaro che la legge avrà bisogno del concorso di Berlusconi. Il che apre scenari non del tutto prevedibili.
 «In Italia infatti a fronte delle migliaia di migranti spesso concentrati nelle stesse strutture in condizioni bestiali, esiste un patrimonio vuoto o inutilizzato di case o appartamenti superiore ad otto milioni di unità». il manifesto, 7 gennaio 2017 (c.m.c.)
«In Italia infatti a fronte delle migliaia di migranti spesso concentrati nelle stesse strutture in condizioni bestiali, esiste un patrimonio vuoto o inutilizzato di case o appartamenti superiore ad otto milioni di unità». il manifesto, 7 gennaio 2017 (c.m.c.)

 «Dobbiamo dimostrare che la libertà e la sicurezza sono possibili solo se riusciamo a rompere l’isolamento che i restringimenti alla libera mobilità e l’attacco ai salari e al welfare stanno imponendo su tutti: migranti, precarie ed operai».
«Dobbiamo dimostrare che la libertà e la sicurezza sono possibili solo se riusciamo a rompere l’isolamento che i restringimenti alla libera mobilità e l’attacco ai salari e al welfare stanno imponendo su tutti: migranti, precarie ed operai».


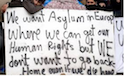


 «Bruciando denaro abbiamo elevato i moderni monumenti delle nostre fobie, espressione architettonica di comunità sterili incapaci di confronto con l’alterità».
«Bruciando denaro abbiamo elevato i moderni monumenti delle nostre fobie, espressione architettonica di comunità sterili incapaci di confronto con l’alterità». 





 «La necessità di una corretta informazione come antidoto all’hate speech è il contributo che abbiamo ritenuto di portare ai lavori della Commissione contro l’intolleranza e l’odio».
«La necessità di una corretta informazione come antidoto all’hate speech è il contributo che abbiamo ritenuto di portare ai lavori della Commissione contro l’intolleranza e l’odio». 

 «I migranti sbarcati in Italia scappano da guerre, violenze, persecuzioni, miserie, conflitti. Il 18 dicembre è una data importante, segnata per ricordare le loro storie, le loro vicende
«I migranti sbarcati in Italia scappano da guerre, violenze, persecuzioni, miserie, conflitti. Il 18 dicembre è una data importante, segnata per ricordare le loro storie, le loro vicende


 ».
». 