 «Un progetto per una nuova sinistra non può che ripartire da quel "pieno sviluppo della persona umana" che l'articolo 3 della Costituzione indica come bussola alla Repubblica. Mai come in questa estate essere e restare umani appare un obiettivo rivoluzionario».
«Un progetto per una nuova sinistra non può che ripartire da quel "pieno sviluppo della persona umana" che l'articolo 3 della Costituzione indica come bussola alla Repubblica. Mai come in questa estate essere e restare umani appare un obiettivo rivoluzionario».
Huffington Post online, 9 agosto 2017
Disumano. Tutto, in questa terribile estate 2017 ci pare disumano. Il caldo mostruoso e il fuoco che divorano l'Italia: e le piogge che iniziano a sgretolarlo, al Nord. E disumano appare un discorso politico che di fronte alla più grande questione del nostro tempo, la migrazione di una parte crescente dell'umanità, reagisce invocando la polizia. Un muro di divise che faccia nel Mediterraneo quello che vorrebbe fare il muro di Trump al confine col Messico.
Eppure no: è tutto terribilmente umano. È stato l'uomo a cambiare il clima. È stato l'uomo a innescare la grande migrazione: sono state la diseguaglianza, l'ingiustizia, la desertificazione, lo sfruttamento selvaggio dell'Africa, la stolta politica internazionale e le guerre umanitarie. "Ascoltate, e intendetemi bene: è dal cuore dell'uomo che escono i propositi di male", dice Gesù nel Vangelo di Marco.
Umano, dunque: terrificantemente umano. Di una umanità sfigurata dalla paura, dalla rabbia, dall'avidità. Parliamo di tutto questo quando parliamo della vittoria della destra: peggio, di una egemonia culturale della destra che si estende sul discorso pubblico. Una egemonia culturale che domina – piaccia o non piaccia: è un fatto – il maggior partito italiano: già di centro-sinistra, oggi inequivocabilmente vittima del pensiero unico della destra della paura e dell'odio. E ci sono almeno tre differenti tipi di destra che si stanno mangiando oggi il corpo del Pd.
La prima è quella che ha dominato il pensiero unico del centrosinistra negli ultimi decenni: quella del neoliberismo appena travestito da terza via blairiana. Quella per cui ormai siamo non solo in una economia, ma in una società, di mercato. A cui non c'è alternativa. Per esempio: nella legge sulla concorrenza approvata la settimana scorsa c'è un articolo che distrugge alla radice l'idea stessa di tutela dei beni culturali. Che si potranno esportare con una semplice autocertificazione basata sulle soglie di valore. Il denaro come unico metro, la totale libertà dell'individuo, l'abdicazione dello Stato. Un articolo esplicitamente scritto dalla lobby dei mercanti d'arte, un cui rappresentante sedeva nella commissione, nominata dal ministro Franceschini, che ha scritto la legge.
Un provvedimento settoriale, certo: ma che confermando ancora che il denaro è l'unica misura della libertà chiarisce molto bene l'orizzonte anti-umano di questo "centrosinistra".
La seconda destra è quella, più tradizionale,
del ministro Minniti. Una destra law and order che vuole mettere la polizia a bordo delle navi Ong: una destra perfino un po' grottesca, perché vorrebbe resuscitare la faccia poliziesca dello Stato avendo però smontato del tutto lo Stato. Se non è la Guardia Costiera a governare la situazione, nel Mediterraneo, è perché centrodestra e centrosinistra hanno indistinguibilmente distrutto lo Stato, definanziando e disprezzando tutto ciò che è pubblico, dalle forze di polizia alla scuola, dalla sanità alla forestale, dalle biblioteche ai pubblici ministeri. E non è certo militarizzando le Ong che si ricostruisce lo Stato. Come non è con il reato di immigrazione clandestina che si può sperare di affrontare l'età delle migrazioni.
La terza destra
è quella di Matteo Renzi. Una destra anarcoide, individualista e populista. Una destra che sostituisce allo Stato una somma di gated communities: comunità separate dai soldi, divise per censo. Una destra che non ha nessuna chiusura verso le libertà individuali, anzi le incoraggia in chiave antisociale. Gratificando privatamente i cittadini a cui si toglie ogni dimensione pubblica, sociale, comunitaria.
E, come ha scritto Guido Mazzoni in
una analisi molto fine:
«Se un certo fondo di anarchismo unisce la destra populista al modello liberale classico, ciò che li separa è l'ethos. La destra populista costruisce se stessa attorno a un'antitesi netta, identitaria, fra Noi e Loro. ... Il senso comune cui la destra populista si richiama nasce dall'arcaico: è l'ethos dei primi occupanti, che separa i legittimi dagli illegittimi, i normali dagli anormali, gli autoctoni dai barbari. Il gruppo dei primi occupanti trasforma la propria identità nel corso del tempo, includendo gruppi di secondi occupanti radicati, o mostrandosi più tollerante verso identità di genere e comportamenti che fino a qualche anno fa avrebbero portato all'esclusione, ma non viene mai meno l'asimmetria fra chi viene-prima e chi viene-dopo».
È esattamente questa la chiave culturale che permette di comprendere l'affermazione di Renzi sull'"aiutiamoli a casa loro".
Dove il punto è la contrapposizione delle case: la nostra, la loro. Un fortissimo richiamo identitario: il conflitto tra "Noi" e "Loro" che prende il posto del conflitto di classe e di censo, negato, rimosso, depotenziato. E questa terza destra, si badi, non è solo del leader: la mutazione riguarda tutto il partito, come dimostrano le affermazioni di una esponente della segreteria Pd sulla "razza italiana" da perpetuare, quelle di un senatore sul fatto che salvare vite umane non è un obiettivo (perché sono le Loro vite, beninteso), quelle della sindaca che aumenta le tasse a chi accoglie Loro.
Mi pare che se non si prenda atto di questa triplice involuzione destrorsa del Partito democratico tutti i discorsi sul futuro della Sinistra italiana non faranno i conti con la realtà. È davvero possibile un centrosinistra se il centro è questo? E una forza come Mdp (che vota la legge sulla concorrenza e sostiene il governo del Codice Minniti) ambisce a contrastare l'egemonia culturale di questa nuova destra espansiva, o ne è a sua volta vittima? Sono questi i nodi da sciogliere.
Perché oggi un progetto per una nuova sinistra non può che ripartire da quel "pieno sviluppo della persona umana" che l'articolo 3 della Costituzione indica come bussola alla Repubblica. Mai come in questa estate essere e restare umani appare un obiettivo rivoluzionario.

«il manifesto, 8 agosto 2017
Negli ultimi giorni qualcosa di spaventosamente grave è accaduto, nella calura di mezza estate. Senza trovare quasi resistenza, con la forza inerte dell’apparente normalità, la dimensione dell’«inumano» è entrata nel nostro orizzonte, l’ha contaminato e occupato facendosi logica politica e linguaggio mediatico. E per questa via ha inferto un colpo mortale al nostro senso morale.
L’«inumano», è bene chiarirlo, non è la mera dimensione ferina della natura contrapposta all’acculturata condizione umana.
Non è il «mostruoso» che appare a prima vista estraneo all’uomo. Al contrario è un atteggiamento propriamente umano: l’«inumano» – come ha scritto Carlo Galli – «è piuttosto il presentarsi attuale della possibilità che l’uomo sia nulla per l’altro uomo».
Che l’Altro sia ridotto a Cosa, indifferente, sacrificabile, o semplicemente ignorabile. Che la vita dell’altro sia destituita di valore primario e ridotta a oggetto di calcolo. Ed è esattamente quanto, sotto gli occhi di tutti, hanno fatto il nostro governo – in primis il suo ministro di polizia Marco Minniti – e la maggior parte dei nostri commentatori politici, in prima pagina e a reti unificate.
Cos’è se non questo – se non, appunto, trionfo dell’inumano – la campagna di ostilità e diffidenza mossa contro le Ong, unici soggetti all’opera nel tentativo prioritario di salvare vite umane, e per questo messe sotto accusa da un’occhiuta «ragion di stato».
O la sconnessa, improvvisata, azione diplomatica e militare dispiegata nel caos libico con l’obiettivo di mobilitare ogni forza, anche le peggiori, per tentare di arrestare la fiumana disperata della nuda vita, anche a costo di consegnarla agli stupratori, ai torturatori, ai miliziani senza scrupoli che non si differenziano in nulla dagli scafisti e dai mercanti di uomini, o di respingerla a morire nel deserto.
Qui non c’è, come suggeriscono le finte anime belle dei media mainstream (e non solo, penso all’ultimo Travaglio) e dei Gabinetti governativi o d’opposizione, la volontà di ricondurre sotto la sovranità della Legge l’anarchismo incontrollato delle organizzazioni umanitarie.
Non è questo lo spirito del famigerato «Codice Minniti» imposto come condizione di operatività in violazione delle antiche, tradizionali Leggi del mare (il trasbordo) e della più genuina etica umanitaria (si pensi al rifiuto di presenze armate a bordo). O il senso dell’invio nel porto di Tripoli delle nostre navi militari.
Qui c’è la volontà, neppur tanto nascosta, di fermare il flusso, costi quel che costi. Di chiudere quei fragili «corridoi umanitari» che in qualche modo le navi di Medici senza frontiere e delle altre organizzazioni tenevano aperti. Di imporre a tutti la logica di Frontex, che non è quella della ricerca e soccorso, ma del respingimento (e il nome dice tutto).
Di fare, con gli strumenti degli Stati e dell’informazione scorretta, quanto fanno gli estremisti di destra di Defend Europe, non a caso proposti come i migliori alleati dei nuovi inquisitori. Di spostare più a sud, nella sabbia del deserto anziché nelle acque del Mare nostrum, lo spettacolo perturbante della morte di massa e il simbolo corporeo dell’Umanità sacrificata.
Non era ancora accaduto, nel lungo dopoguerra almeno, in Europa e nel mondo cosiddetto «civile», che la solidarietà, il salvataggio di vite umane, l’«umanità» come pratica individuale e collettiva, fossero stigmatizzati, circondati di diffidenza, scoraggiati e puniti.
Non si era mai sentita finora un’espressione come «estremismo umanitario», usata in senso spregiativo, come arma contundente. O la formula «crimine umanitario». E nessuno avrebbe probabilmente osato irridere a chi «ideologicamente persegue il solo scopo di salvare vite», quasi fosse al contrario encomiabile chi «pragmaticamente» sacrifica quello scopo ad altre ragioni, più o meno confessabili (un pugno di voti? un effimero consenso? il mantenimento del potere nelle proprie mani?)
A caldo, quando le prime avvisaglie della campagna politica e mediatica si erano manifestate, mi ero annotato una frase di George Steiner, scritta nel ’66. Diceva: «Noi veniamo dopo. Adesso sappiamo che un uomo può leggere Goethe o Rilke la sera, può suonare Bach e Schubert, e quindi, il mattino dopo, recarsi al proprio lavoro ad Auschwitz». Aggiungevo: Anche noi «veniamo dopo».
Dopo quel dopo. Noi oggi sappiamo che un uomo può aver letto Marx e Primo Levi, orecchiato Marcuse e i Francofortesi, militato nel partito che faceva dell’emancipazione dell’Umanità la propria bandiera, esserne diventato un alto dirigente, e tuttavia, in un ufficio climatizzato del proprio ministero firmare la condanna a morte per migliaia di poveri del mondo, senza fare una piega. La cosa può essere sembrata eccessiva a qualcuno. E il paragone fuori luogo. Ma non mi pento di averlo pensato e di averlo scritto.
Consapevole o meno di ciò che fa, chi si fa tramite dell’irrompere del disumano nel nostro mondo è giusto che sia consapevole della gravità di ciò che compie. Della lacerazione etica prima che politica che produce.
Se l’inumano – è ancora Galli a scriverlo – «è il lacerarsi catastrofico della trama etica e logica dell’umano», allora chi a quella rottura contribuisce, quale che sia l’intenzione che lo muove, quale che sia la bandiera politica sotto cui si pone, ne deve portare, appieno, la responsabilità. Così come chi a quella lacerazione intende opporsi non può non schierarsi, e dire da che parte sta. Io sto con chi salva.
 Da anni si moltiplicano le denunce dello scandalo delle galere libiche, eppure il governo italiano continua a consegnare agli "alleati"stupratori torturatori assassini chi tenta di fuggirne.
Da anni si moltiplicano le denunce dello scandalo delle galere libiche, eppure il governo italiano continua a consegnare agli "alleati"stupratori torturatori assassini chi tenta di fuggirne.
La Repubblica, 8 agosto 2017, con riferimenti
«Il dramma dei migranti riportati in Libia “Picchiati e torturati, aiutateci a fuggire”
Le organizzazioni internazionali: nei centri di detenzione le condizioni sono disumane»
LE mani attaccate alle sbarre della cella del centro di detenzione di Abu Sleem dove è rinchiuso senza un filo d’aria insieme ad altre 39 persone, Mounir chiede aiuto ad un delegato del Cir. «Ho 25 anni, vengo dal Gambia, mi hanno rinchiuso di nuovo in questo inferno. Ero partito dalla spiaggia di Garabouli su una barca in legno, ma le guardie del mare ci hanno arrestato e riportato indietro. I guardiani picchiano i bambini, violentano le donne, ci torturano mentre parlano al telefono con i nostri familiari e chiedono altri soldi per liberarci. Aiutateci ad uscire da qui».
È la lotteria del migrante. Chi è soccorso da una nave umanitaria e portato in Italia è salvo, chi viene recuperato dalla guardia costiera libica torna all’inferno. Ottocentoventisei a Sabrata, 128 a Zawia, 43 a Misurata. In mille, come Mounir, nelle ultime 48 ore sono stati soccorsi in mare dai libici e riportati nei centri di detenzione dove, come denunciano le organizzazioni umanitarie, da Amnesty International all’Unhcr, dall’Oim all’Unicef, le condizioni sono disumane e i diritti umani non garantiti. Federico Soda, direttore dell’ufficio di coordinamento per il Mediterraneo dell’Oim (organizzazione presente in Libia ai punti di disimbarco insieme all’Unhcr), lo ha detto chiaro al Comitato Schengen: «Consideriamo inaccettabile fare dei soccorsi in mare per poi riportare i migranti in luoghi le cui condizioni sono considerate inaccettabili in tutto il mondo. Quando la Libia potrà essere considerata un porto di sbarco sicuro faremo altri ragionamenti. Per altro così si continua ad alimentare la tratta e il traffico».
Perché chi sopravvive al suo viaggio dall’inferno e ritorno quasi sempre ci riprova. Soprattutto se, come spesso accade, subito dopo essere riportato a terra dalla guardia costiera libica ed essere registrato e soccorso in uno dei dodici centri di disimbarco attualmente attivi sulla costa finisce immediatamente nelle mani dei trafficanti e viene rinchiuso in uno dei centri di detenzione controllati dalle milizie. Può accadere facilmente soprattutto se a recuperare i profughi sono dipartimenti di guardia costiera come quello di Zawia, guidati da personaggi come Abdulrahman Milad, fino a qualche tempo fa ritenuto trafficante di uomini. È lì, tra quelle mura inaccessibili, dietro quelle sbarre invalicabili che nascondono più di 8.000 persone, stupri e violenze a carico di uomini, donne, bambini sono l’inferno quotidiano.
Quattrocentomila persone pronte a partire, stime ufficiali dell’Oim, che raddoppiano da informazioni ufficiose che arrivano da diverse fonti. Ventinove centri di detenzione, non tutti accessibili alle organizzazioni umanitarie. Roberto Mignone, capomissione dell’Unhcr, è in Libia da tre mesi. Loro riescono a supportare e far liberare gli aventi diritto allo status dei rifugiati, ma tutti gli altri finisconorisucchiati nel grande buco nero dei lager in mano alle milizie. «Noi e i rappresentanti dell’Oim — spiega Mignone — siamo presenti nei dodici punti di disimbarco in cui vengono portate le persone intercettate dalla guardia costiera. Abbiamo migliorato le condizioni di assistenza, distribuiamo kit di soccorso e servizi medici. Poi i migranti vengono tutti portati nei centri di detenzione, uomini, donne, bambini, tutti insieme. In quelli sotto il controllo del dipartimento che combatte l’immigrazione clandestina, nonostante le condizioni di sovraffollamento, mancanza di igiene e insicurezza, riusciamo ad attivare l’assistenza per chi ha diritto allo status di rifugiato, ad ottenerne il rilascio, a fornire loro documenti di richiedente asilo e proviamo a facilitare il rimpatrio volontario. Certo le condizioni sono molto molto complicate».
A sei donne, vittime di abusi sconvolgenti e tenute in schiavitù da un gruppo armato, è andata bene. Tre settimane fa l’Unhcr è riuscita a farle liberare dal centro di detenzione e adesso sono al sicuro in una casa protetta in un paese che ha accettato di accoglierle. Ma sono più di cinquantamila le donne e i bambini, soprattutto dell’area subsahariana — denuncia l’Unicef nel suo ultimo rapporto — che sono passati nell’ultimo anno dai centri di detenzione libici.
Rinviamo alla lettura degli articoli di questi ultimi mesi Italia e Libia in guerra contro i fuggitivi, L'accordo sui migranti con la Libiacrea una Guantanamo. Ma non da oggi sono note le condizioni dei luoghi di contenzione e tortura in Libia. si veda, ad esempio, l'articolo dell'Espresso del 23 giugno 2014
 Alcune domande più che legittime alle quali i politici politicanti non hanno una benché minima idea di come rispondere se non con il silenzio imposto dalle armi.
Alcune domande più che legittime alle quali i politici politicanti non hanno una benché minima idea di come rispondere se non con il silenzio imposto dalle armi.
barbara-spinelli.it blog, 6 agosto 2017 (p.d.)
Il Parlamento italiano ha autorizzato l’invio di navi da guerra nelle acque territoriali libiche con il compito di sostenere la guardia costiera di Tripoli nel contrasto ai trafficanti di uomini e nel rimpatrio di migranti e richiedenti asilo in fuga dalla Libia. La risoluzione, affiancata al tentativo di ridurre le attività di ricerca e soccorso di una serie di ONG, è discutibile e solleva almeno sei interrogativi:
1) Come può la Libia, la cui sovranità sarà secondo il governo italiano integralmente garantita, «controllare i punti di imbarco nel pieno rispetto dei diritti umani», quando non è firmataria della Convenzione di Ginevra, dunque non è imputabile se la viola?
2) Come può dirsi rispettata la sovranità in questione, quando di fatto quest’ultima non esiste? È infatti evidente che il governo di Fāyez al-Sarrāj non esercita alcun monopolio della violenza legittima – presupposto di ogni autentica sovranità – come si evince dalla condanna dell’operazione militare italiana ed europea da parte delle forze politiche e militari che fanno capo al generale Khalifa Haftar.
3) Come può esser garantito il pieno “controllo” dell’UNHCR e dell’OIM sugli hotspot da costruire in Libia, e rendere tale controllo compatibile con la sovranità territoriale libica affermata nella risoluzione parlamentare? E come possono UNHCR e OIM gestire “centri di protezione e assistenza” in un Paese in cui, stando a quanto dichiarato il 16 maggio dallo stesso direttore operativo di Frontex Fabrice Leggeri, «è impossibile effettuare rimpatri», visto che «la situazione è tale da non permettere di considerare la Libia un Paese sicuro»?[1]
4) Come proteggere i migranti e rifugiati dai naufragi, se lo scopo è quello di screditare e ridurre le attività di ricerca e soccorso in mare delle ONG in assenza di robuste operazioni europee di ricerca e soccorso, e senza che sia ancora stata definita una “zona SAR” (Search and Rescue) di competenza libica che abbia come fondamento la Convenzione di cui sopra, e in particolare gli articoli che vietano i respingimenti collettivi (principio di “non-refoulement“)?
5) Come garantire che migranti e profughi soccorsi in mare non verranno riportati a terra e chiusi in centri di detenzione dove, come affermato dalla vicedirettrice di Amnesty International per l’Europa Gauri Van Gulik, «quasi certamente saranno esposti al rischio di subire torture, stupri e anche di essere uccisi»?[2] Qualunque cooperazione con le autorità libiche che porti alla detenzione di migranti da parte della Libia, ha affermato il 2 agosto Judith Sunderland, direttrice di Human Rights Watch per l’Europa e l’Asia centrale: «dovrebbe verificarsi soltanto in presenza di prove chiare che questo tipo di iniziative sia conforme agli standard sui diritti umani, a partire da un miglioramento dimostrabile nel trattamento dei migranti. Ciò richiede un monitoraggio indipendente e trasparente, ma non è stato stabilito alcun sistema di monitoraggio indipendente né per il programma di addestramento, né per i centri di detenzione libici».[3]
6) Come intende il governo italiano rispettare la sentenza con cui, nel febbraio 2012, la Corte europea dei diritti dell’uomo ha affermato che il trasferimento di rifugiati verso la Libia viola l’articolo 3 della Convenzione di Ginevra secondo il quale «nessuno può essere sottoposto a tortura né a pene o trattamenti inumani o degradanti»?[4]
Su una cosa il governo italiano ha ragione: come nel caso dei rifugiati approdati in Grecia, L’Unione europea si è dimostrata incapace di solidarietà. L’impegno a ricollocare in altri Paesi membri un numero minimo di migranti e rifugiati che giungono in Italia o in Grecia è rispettato in minima parte, mentre aumentano i rimpatri in Italia dei rifugiati che a dispetto del sistema Dublino hanno raggiunto altri Paesi dell’Unione.
Questo non giustifica tuttavia la violazione del principio di non respingimento, e tantomeno spiega l’offensiva contro le ONG: in particolare quelle che non hanno firmato il codice di condotta predisposto per loro dal governo italiano con l’appoggio dell’Unione europea. A tutt’oggi, sono del tutto ingiustificate le accuse di collusione con i trafficanti rivolte a organizzazioni come Jugend Rettet e Medici senza frontiere. In assenza di vie legali offerte a chi vuol chiedere asilo in Europa, è abusivo confondere l’attività dei “facilitatori” delle fughe con quella dei trafficanti di esseri umani. Ed è comunque pretestuoso attaccare le Ong in assenza di operazioni europee aggiuntive o alternative di ricerca e soccorso. Ancor più riprovevole è continuare a reclamare il rispetto dell’antiquata legge Bossi-Fini, confondendo migranti privi di documenti e richiedenti asilo.
Non per ultimo, segnaliamo il legame possibile tra l’indagine sulla nave Iuventa (Jugend Rettet) e le operazioni della destra europea “Defend Europe”. È un articolo di Famiglia Cristiana del 4 agosto a denunciare il contatto tra la società di sicurezza privata Imi Security Service di Cristian Ricci – ovvero il gruppo di contractor che ha denunciato le “anomalie” della nave Iuventa, facendo aprire il fascicolo della Procura di Trapani – con l’ex ufficiale della Marina militare Gian Marco Concas, uno dei portavoce di Generazione Identitaria. Esperto di navigazione e skipper, Concas è stato definito come il “direttore tecnico” dell’operazione navale della rete europea anti migranti, che in questi giorni sta muovendo la C-Star nella zona Search and Rescue (Ricerca e Salvataggio) davanti alle acque libiche.[5]
[1] “Diese Migranten sind Opfer der kriminellen Netzwerke”. Interview mit Fabrice Leggeri, “ZDF-Magazin Frontal21”, 16 maggio 2017.
[2] https://www.amnesty.it/missione-navale-italia-pronta-destinare-rifugiati-migranti-verso-orribili-violenze/.
[3] https://www.hrw.org/it/news/2017/08/02/307461.
[4] Sentenza CEDU 23 febbraio 2012, Ricorso n. 27765/09 – Hirsi Jamaa e altri c. Italia.
[5] http://m.famigliacristiana.it/articolo/caos-mediterraneo-quel-link-occulto-tra-defend-europe-e-l-operazione-iuventa.htm.
 Affidare alle navi libiche i fuggitivi, come il governo italiano ha deciso, significa condannarli a subire le stesse torture, gli stessi ricatti, le stesse violenze, le stesse rapine a cui avevano appena cercato di sfuggire.
Affidare alle navi libiche i fuggitivi, come il governo italiano ha deciso, significa condannarli a subire le stesse torture, gli stessi ricatti, le stesse violenze, le stesse rapine a cui avevano appena cercato di sfuggire.
il manifesto, 6 agosto 2017
Coloro che dalle coste della Libia si imbarcano su un gommone o una carretta del mare sono esseri umani in fuga da un paese dove per mesi o anni sono stati imprigionati in condizioni disumane, violati, comprati e venduti, torturati per estorcere riscatti dalle loro famiglie, aggrediti da scabbia e malattie; e dove hanno rischiato fino all’ultimo istante di venir uccisi.
Molti di loro non hanno mai visto il mare e non hanno idea di che cosa li aspetti, ma sanno benissimo che in quel viaggio stanno rischiando ancora una volta la vita.
Chi fugge da un paese del genere avrebbe diritto alla protezione internazionale garantita dalla convenzione di Ginevra, ma solo se è «cittadino» di quel paese. Quei profughi non lo sono; sono arrivati lì da altre terre. Ma fermarli in mare e riportarli in Libia è un vero e proprio respingimento (refoulement, proibito dalla convenzione di Ginevra) di persone perseguitate, anche se materialmente a farlo è la Guardia costiera libica.
Una volta riportati in Libia verranno di nuovo imprigionati in una delle galere da cui sono appena usciti, subiranno le stesse torture, gli stessi ricatti, le stesse violenze, le stesse rapine a cui avevano appena cercato di sfuggire, fino a che non riusciranno a riprendere la via del mare.
Alle Ong che cercano di sottrarre quei profughi a un simile destino di sofferenza e morte andrebbe riconosciuto il titolo di “Giusti” come si è fatto per coloro che ai tempi del nazismo si sono adoperati per salvare degli ebrei dallo sterminio. Invece, ora come allora, vengono trattati come criminali: dai Governi, da molte forze politiche, dalla magistratura, dai media e da una parte crescente dell’opinione pubblica (i social!); sempre più spesso con un linguaggio che tratta le persone salvate e da salvare come ingombri, intrusi, parassiti e invasori da buttare a mare.
Non ci si rende più conto che sono esseri umani: disumanizzare le persone come fossero cose o pidocchi è un percorso verso il razzismo e le sue conseguenze più spietate. Come quello che ha preceduto lo sterminio nazista. Nessuno prova a mettersi nei panni di queste persone in fuga, per le quali gli scafisti che li sfruttano in modo cinico e feroce sono speranza di salvezza, l’ultima risorsa per sottrarsi a violenze e soprusi indicibili. La lotta agli scafisti indetta dal governo italiano e dall’Unione Europea è in realtà una guerra camuffata contro i profughi, contro degli esseri umani braccati. Ed è una guerra che moltiplica il numero e i guadagni di scafisti, autorità libiche corrotte e terroristi: unica alternativa ai canali di immigrazione legale che l’Europa ha chiuso fingendo di proteggere i propri cittadini.
Da tempo le imbarcazioni su cui vengono fatti salire i profughi non sono più in grado di raggiungere l’Italia: sono destinate ad affondare con il loro carico. Ma gli scafisti certo non se ne preoccupano: il viaggio è già stato pagato, e se il «carico» viene riportato in Libia, prima o dopo verrà pagato una seconda e una terza volta.
In queste condizioni, non c’è bisogno che un gommone si sgonfi o che una carretta imbarchi acqua per renderne obbligatorio il salvataggio, anche in acque libiche: quegli esseri umani violati e derubati sono naufraghi fin dal momento in cui salpano e, se non si vuole farli annegare, vanno salvati appena possibile.
Gran parte di quei salvataggi è affidata alle Ong, perché le navi di Frontex e della marina italiana restano nelle retrovie per evitare di dover intervenire in base alla legge del mare; ma gli esseri umani che vengono raccolti in mare da alcune navi delle Ong devono essere trasbordati al più presto su un mezzo più capiente, più sicuro e più veloce; altrimenti le navi che eseguono il soccorso rischiano di affondare per eccesso di carico, oppure non riescono a raccogliere tutte le persone che sono in mare o, ancora, impiegherebbero giorni e giorni per raggiungere un porto, lasciando scoperto il campo di intervento.
Vietare i trasbordi è un delitto come lo è ingiungere alle Ong di imbarcare agenti armati: farlo impedirebbe alle organizzazioni impegnate in interventi in zone di guerra di respingere pretese analoghe delle parti in conflitto, facendo venir meno la neutralità che permette loro di operare.
Né le Ong possono occuparsi delle barche abbandonate, soprattutto in presenza di uomini armati fino ai denti venuti a riprendersele. Solo i mezzi militari di Frontex potrebbero farlo: distruggendo altrettante speranze di chi aspetta ancora di imbarcarsi.
I problemi continuano quando queste persone vengono sbarcate: l’Unione europea appoggia la guerra ai profughi, ma poi se ne lava le mani. Sono problemi dell’Italia; la «selezione» tra sommersi e salvati se la veda lei… I rimpatri, oltre che crudeli e spesso illegali, sono per lo più infattibili e molto costosi.
Così, dopo la selezione, quell’umanità dolente si accumula in Italia, divisa tra clandestinità, lavoro nero, prostituzione e criminalità: quanto basta a mettere ko la vita politica e sociale di tutto paese. Ma cercare di fermare i profughi ai confini settentrionali o a quelli meridionali della Libia accresce solo il numero dei morti.
Dobbiamo guardare in avanti, accogliere in tutta Europa come fratelli coloro che cercano da lei la loro salvezza; adoperarci per creare un grande movimento europeo che lavori e lotti per riportare la pace nei loro paesi (non lo faranno certo i governi impegnati in quelle guerre) e perché i profughi che sono tra noi possano farsi promotori della bonifica ambientale e sociale delle loro terre (non lo faranno certo le multinazionali impegnate nel loro saccheggio). L’alternativa è una notte buia che l’Europa ha già conosciuto e in cui sta per ricadere.
 Una sindaca feroce contro chi pecca di umanità. C'è nel PD bolognese chi chiede che sia espulsa. Ma i suoi maestri quel partito lo dirigono. E Salvini ancora non ha capito.
Una sindaca feroce contro chi pecca di umanità. C'è nel PD bolognese chi chiede che sia espulsa. Ma i suoi maestri quel partito lo dirigono. E Salvini ancora non ha capito.
Corriere di Bologna, 5 agosto 2017
«Alice Zanardi: "Sto solo riportando un disagio sentito da tutta la popolazione". Ma il segretario regionale dem la striglia: "Proclama impraticabile, non risolve i problemi". E Salvini: «Cosa ci fai nel Pd?"»
CODIGORO - Controlli e tasse più alte ai cittadini che ospitano i profughi. È questa la linea dura, targata Pd, voluta da Alice Zanardi, sindaca da un anno di Cogidoro, Comune del Ferrarese di oltre 12 mila abitanti dove hanno trovato casa oltre 100 profughi, di cui 40 appena arrivati e alloggiati in strutture private. La prima cittadina dice di rispondere semplicemente a «un disagio sentito da tutta la popolazione». Ma si prende una strigliata dal segretario pd dell’Emilia-Romagna («No ai facili proclami») e da Bologna arriva anche la richiesta di espellerla dal partito («Sarebbe l’unico segnale democratico degno di questo nome», dice il vicesindaco bolognese Matteo Lepore). Applaude invece il leader della Lega Matteo Salvini.
«Chiedo che siano rispettate le regole
» - Alice Zanardi però non ci sta. «Non la voglio buttare in politica - dice - pretendo solo che le norme vengano rispettate», sottolinea la prima cittadina. «Se c’è la regola del 2,5 migranti per mille abitanti, Codigoro l’ha già abbondantemente sorpassata, indipendentemente da come il Pd la pensa. Solo in un mese da 58 profughi siamo arrivati a 100. Ora basta, come sindaca non faccio altro che riportare un disagio sentito da tutta la popolazione». Ma può veramente alzare le tasse a chi ospita? «Quella sulle tasse è una provocazione. Ma se posso, ammesso che sia legale e possibile farlo, le alzerò per i privati che accolgono», dice.
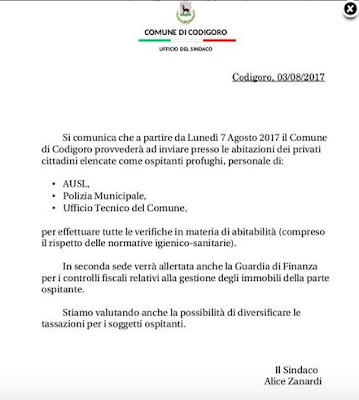 |
| La minaccia per chi compie il reato di umanità |
 «Nei luoghi di soccorso non ci sono armi: ecco perché Msf non accetta la polizia a bordo Il divieto di trasbordare migranti da una nave all’altra ne lascia molti di più in balia delle onde».
«Nei luoghi di soccorso non ci sono armi: ecco perché Msf non accetta la polizia a bordo Il divieto di trasbordare migranti da una nave all’altra ne lascia molti di più in balia delle onde».
La Repubblica, 5 agosto 2017
Io sto con Medici senza Frontiere. Lo voglio dire ed esprimere chiaramente in un momento in cui sta avvenendo la più pericolosa delle dinamiche, ossia la criminalizzazione del gesto umanitario. Sto con Medici senza Frontiere nella decisione di non firmare il codice di condotta per le Ong che fanno salvataggi in mare voluto dal ministro Minniti. È una scelta importante e sostanziale, non un capriccio. Medici Senza Frontiere (Premio Nobel per la Pace 1999) difende un principio fondamentale: la neutralità. Questo significa che avere agenti armati sulle navi sarebbe la fine di questo principio. Il lettore forse ingenuo mi dirà: ma come? È una garanzia per tutti avere agenti armati sulle navi di Msf: per i migranti, per gli operatori volontari, per la sicurezza. Invece non è così e per capirlo basta conoscere le dinamiche di chi opera in situazioni difficili, di emergenza sanitaria, di guerra, dove l’assoluta assenza di armi nei luoghi del soccorso rappresenta la vera protezione. Il segnale di divieto che disegna il kalashnikov inserito nel cerchio rosso sbarrato è fuori di ogni laboratorio, ogni tenda, ogni presidio di Msf, Emergency e non solo.
È l‘elemento fondante che permette alle Ong di agire in sicurezza e con la propria identità. Non avere armi in un luogo di soccorso non significa che sono luoghi dove la legge è sospesa, tutt’altro. Infatti qualsiasi sbarco di profughi che effettua Msf viene coordinato dalla Guardia costiera e una volta a terra c’è totale collaborazione con le forze di polizia. A Mosul, ad Haiti, in Congo i soldati di qualsiasi esercito lasciano le armi fuori dai presidi di Msf. Invece il governo italiano vorrebbe portare agenti armati sulle navi.
Non firmando il codice Msf salva i suoi operatori e la sua condotta, tutte le parti in causa nei conflitti devono sapere che Msf non ha armi, mai, non nasconde soldati sotto le sue pettorine, non è un luogo utilizzato per indagini, ma solo di soccorso.
Questi sono i motivi per i quali Msf non ha sottoscritto il codice. Altre Ong possono firmare il patto Minniti perché non hanno presidi in zone di guerra o perché facendolo sanno di non mettere a repentaglio la propria identità. Ma non Msf. In questa triste fase storica si sta configurando in Italia, come ha scritto Luigi Manconi su il manifesto e come scrive da giorni Avvenire, il “reato umanitario”. È il frutto di mesi di confusione, durante i quali tutte le parti politiche hanno soffiato — in un clima di perenne campagna elettorale — sul fuoco della paura. Dall’aberrante definizione di “taxi del mare” di Di Maio sino a chi pone sullo stesso piano gli affari criminali fatti da Mafia Capitale e il business dei trafficanti con l’attività di chi salva vite. Tutti luoghi comuni banali, semplici, veloci per configurare il “reato umanitario”. L’indagine sulla Ong tedesca Jugend Rettet (che non ha firmato il protocollo Minniti) non c’entra nulla con le insinuazioni fatte sino ad oggi, tese a dimostrare che le Ong sono braccia operative dei trafficanti. Nonostante si cerchi di manipolare il più possibile - come tenta di fare l’aberrante (e come sempre ridicolo) post di Matteo Salvini che parla di Ong che hanno protetto scafisti - secondo la stessa procura di Trapani avrebbero agito «non per denaro» ma per «motivi umanitari». In ogni caso se gli appartenenti a Jugend Rettet hanno commesso reati, verranno processati e, qualora riconosciuti colpevoli, condannati. Quello che sappiamo sino ad oggi è che se hanno violato regole lo hanno fatto per realizzare un corridoio umanitario, come lo definisce Massimo Bordin di Radio Radicale.
Null’altro che questo.
Mi domando a questo punto dove nasce tutto questo odio? Siamo di fronte a dinamiche psicologiche semplici, basterebbe rileggere “Psicologia delle folle” di Gustave Le Bon. Di fronte al senso di colpa d’essere incapaci di agire, dinanzi a centinaia di bambini che annegano nel Mediterraneo, si accusa chi agisce. La stessa cosa avviene con le mafie. Spesso è più facile attaccare chi combatte la mafia piuttosto del mafioso. Un paese al collasso economico e demografico ha l’esigenza di trovare altrove i colpevoli: i migranti sono il capro espiatorio perfetto. Più è semplice la lettura più verrà adottato quel bersaglio. Manca il lavoro? Colpa degli immigrati. Aumentano i crimini? Colpa degli immigrati. Anche se i dati ci smentiscono, anche se si ha una falsa percezione del problema. Furbescamente chi soffia sulla paura, sul razzismo, vuole approfittare della enorme possibilità distraente del dramma immigrazione. Se il problema sono gli immigrati l’incapacità economica di far ripartire il paese, di snellire le dinamiche burocratiche, di contrastare il crimine organizzato diventa un corollario.
La coperta dell’immigrazione protegge tutti. Per cui quando Renzi dichiara «pugno duro contro le Ong che hanno contatti con i trafficanti», senza conoscere i termini dell’indagine, bisognerebbe rispondere che ci sarebbe piaciuto sentirlo tuonare contro la vendita delle armi italiane ai paesi in guerra. Né abbiamo sentito insistere Minniti sulla necessità di aumentare la quota di Pil destinato ai paesi in via di sviluppo che oggi è appena dello 0,17%. Parole legittime le loro ma che li precipitano al di fuori della tradizione di sinistra del paese. Avverto i miei lettori: tutti coloro che non si inseriscono nella canea anti immigrazione e contro le Ong saranno soli. In questo momento l’odio verso le Ong e verso gli immigrati non ha pari, magari le mafie avessero avuto contro tutto questo impegno e questa solerzia. Facciamoci forza, io ne sono consapevole. Bersagliati dalle più basse menzogne, ci vedremo sui social sommersi dalle più comuni banalità. Sarà un profluvio di «portateli a casa tu», «vi fate pagare per fare le anime belle», «buonisti». Ma pazientemente, smontando il fuoco di fila delle bugie ne verremo fuori. Ricordo che non è solo il Mediterraneo a vivere il problema profughi, anzi sono quasi 3 milioni i rifugiati intorno al Lago Chad dove si sta consumando una delle peggiori crisi umanitarie del
 La decadenza profonda della democrazia nella quale viviamo è testimoniata dal fatto che le scelte politiche più impegnative sono compiute in funzione dei voti che si possono raccogliere. Articoli di Andrea Colombo, eAdriana Pollice, il manifesto, 5 agosto 2017
La decadenza profonda della democrazia nella quale viviamo è testimoniata dal fatto che le scelte politiche più impegnative sono compiute in funzione dei voti che si possono raccogliere. Articoli di Andrea Colombo, eAdriana Pollice, il manifesto, 5 agosto 2017
RENZI SCIPPA IL “PUGNO DI FERRO”
A GRILLO E SALVINI
di Andrea Colombo
«Migranti. Il segretario completa la correzione di rotta del partito democratico invocando linea dura contro le Ong. Si è convinto che solo una politica feroce può conquistare voti. Gli avversari reagiscono alla concorrenza. Di Maio: l’avevamo detto prima noi. La Lega: di più, bisogna affondare
le navı
Come se il grottesco duello sulla primogenitura dei tagli ai vitalizi fosse stata solo una prova generale, Pd e M5S si azzuffano di nuovo, si contendono il copyright della guerra alle Ong camuffata sotto il velo di quella ai trafficanti. Ma stavolta la disfida rischia di finire in tragedia, perché in gioco ora non ci sono più le pensioni di un nucleo ristretto di ex parlamentari, ma la sorte di migliaia di persone. Renzi vuole che la firma sotto il proclama di tolleranza zero sia la sua: «Se qualcuna tra le decine di Ong che fanno benissimo il loro lavoro ha contatti con gli scafisti, come potrebbe essere, bisogna usare il pugno di ferro». La replica dei 5S, affidata a Di Maio, arriva immediata: «Ma quale pugno di ferro, faccia di bronzo piuttosto! Quando io sollevai il tema, in aprile, Renzi si mise a sparare a zero contro M5S».
Il Movimento di Grillo non si accontenta di ringhi e ruggiti vuole che «siano attribuiti alle unità nel Mediterraneo i poteri dell’autorità giudiziaria», torna a rinfacciare a Renzi «il patto stretto nel 2014 con Bruxelles per far approdare tutti i migranti del Mediterraneo in Italia». Renzi ha sempre negato che quell’accordo, porti aperti in cambio di flessibilità, sia mai esistito, ma è molto probabile che invece abbia ragione Di Maio, come ha ragione nel rivendicare la paternità della campagna contro le Ong. Certo, messa su questo piano la Lega avrebbe qualche titolo in più per reclamare la corona della muso duro. Invece, con una platea di cacciatori di voti sulla pelle dei migranti così folta, proprio Salvini è costretto a rilanciare oltrepassando i confini dell’assurdo: «Le navi Ong che hanno chiamato gli scafisti non vanno sequestrate ma affondate». Nella ressa s’inserisce Forza Italia: «Fermare immediatamente tutte le Ong che non firmano il Codice».
In superficie il problema è solo quello dei «contatti con i trafficanti» e si tratta di un problema reale, anche se l’idea di mettere sullo stesso piano rapporti stretti per lucro o per salvare migliaia di vite umane non è tra le più brillanti. Ma la campagna sulle Ong maschera in realtà una torsione radicale nella politica italiana nei confronti dei migranti. La «dottrina Minniti» non è a costo zero. Da un lato rende molto più difficili i salvataggi, dall’altro consegna i migranti salvati in mare ai lager libici, quanto di meno rispettoso dei diritti umani si possa immaginare. ««Non ci sono campi o centri per i migranti in Libia ma solo prigioni, alcune controllate dalle autorità, altre dalle milizie e dai trafficanti, e vi sussistono condizioni terrificanti», dichiara l’inviato speciale dell’Unhcr Vincent Cochelet, confermando ciò che aveva denunciato Medici senza frontiere e ripetuto ieri Emergency: «Il Codice di condotta mette a rischio la vita di migliaia di persone. L’invio di navi militari è un atto di guerra contro i migranti».
Le dichiarazione fragorose rilasciate dallo studio di Agorà, con l’abituale improntitudine, dal senatore Pd Stefano Esposito due giorni fa non sono parole in libertà. Rispecchiano la «correzione di rotta» di un Pd convinto che solo una politica feroce sul fronte dell’immigrazione permetta di conquistare voti. Bisogna poter rivendicare di aver fermato gli sbarchi e «i risultati positivi che sta ottenendo l’Italia – spiega Verducci, altro senatore Pd – sono dovuti anche alla dottrina Minniti, imperniata sul governo dei flussi e principalmente sulla interlocuzione con la Libia. Abbiamo salvato centinaia di migliaia di vite, ma c’è un’esigenza fondamentale: quella del governo dei flussi».
Toni e parole molto più civili di quelli adoperati dal collega Esposito, ma il senso è identico. Non è che il Pd abbia perso interesse nei soccorsi. Però quell’esigenza non è più in testa all’agenda, è scivolata dietro quella, tanto più fondamentale con le elezioni vicine, di «governare i flussi». Gli annegamenti o lo strazio dei diritti umani che verrà fatto in Libia come del resto era d’uso prima del 2011, quando pagavamo Gheddafi perché risolvesse il problema per conto dell’Italia e poco male se il prezzo era un deserto cosparso di cadaveri, saranno, come dice la capogruppo di Sinistra italiana al senato Loredana De Petris, «effetti collaterali».
«SE CI COSTRINGONO AD ACCETTARE ILCODICE
LASCIAMO I SOCCORSI»
di Adriana Pollice
«Mediterraneo. Medici senza frontiere, che ieri ha salvato 129 migranti: “Se ce lo vietano andiamo via”»
Non abbiamo nessuna intenzione di aprire un braccio di ferro con lo stato, abbiamo salvato 69mila persone e tutti i nostri interventi sono stati coordinati dalla Guardia Costiera. Quindi se ci costringeranno ad accettare il codice che non abbiamo firmato, Medici senza Frontiere abbandonerà il soccorso dei migranti in mare»: Loris De Filippi, presidente di Msf, chiarisce la posizione dell’organizzazione. Sulle Ong che hanno rifiutato di sottoscrivere le regole di comportamento stilate dal Viminale è aumentata la pressione ad accettarle, dopo il sequestro della Iuventa tre giorni fa.
La vos prudence, nave ammiraglia di Msf, ieri ha salvato 129 persone al largo delle coste libiche: «Non ci sfugge il tentativo mediatico di collegare il procedimento penale con il rifiuto dell’accordo – prosegue – . Se qualcuno ha violato le regole è giusto che paghi. Non so cosa abbiano fatto quei ragazzi tedeschi, magari hanno peccato d’inesperienza». E sull’uso di infiltrati (come avvenuto contro Iuventa): «Nessuno può escludere che anche sulle nostre navi possa esserci polizia sotto copertura. È importante fare attenzione nel reclutamento del personale, noi stiamo molto attenti». Sotto accusa della procura di Trapani i trasbordi da un’imbarcazione di soccorso a un’altra: «In mare – spiega De Filippi – quando arrivano barche cariche di centinaia di persone, le Ong intervengono e, coordinate dalla Guardia costiera, procedono al trasbordo in modo che le persone salvate “riempano” la nave più grossa». Sulla polizia a bordo nessun passo indietro: «Vogliono obbligarci ad accogliere persone armate? Smetteremo di salvare la gente in mare, ma sarebbe una grave sconfitta per tutti. Su uomini armati a bordo e trasbordi non possiamo transigere. Vogliono il braccio di ferro? Ci metteremo da parte».
Ieri iuventa è arrivata sotto scorta nel porto di Trapani: «La Ong respinge ogni accusa. L’unica finalità della Jugend Rettet è salvare vite umane. I ragazzi che erano a bordo hanno già spiegato che non c’entrano nulla con il reato che viene loro contestato» spiega Leonardo Marino, legale dell’organizzazione non governativa tedesca. Nessun di loro risulta indagato. Su richiesta della procura sono stati prelevati anche pc, smartphone e documenti. Il reato ipotizzato è favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, al momento contro ignoti. «Presto sarà pronto il ricorso per ottenere il dissequestro del materiale e della nave – conclude il legale -. Non si può, per pochi episodi da accertare, cancellare quanto di positivo è stato fatto». Un breve messaggio è stato diffuso anche dalla Jugend Rettet: «Nella zona Search and rescue negli ultimi due giorni sono stati recuperati otto cadaveri di migranti. Il sequestro della nostra nave ci impedisce di aiutare».
Sul caso della Ong tedesca è intervenuto Vincent Cochetel, inviato speciale dell’Unhcr (l’agenzia Onu per i rifugiati) per la rotta del Mediterraneo Centrale: «Sta alla giustizia italiana pronunciarsi». Ma sulle condizioni dei migranti in Libia ha aggiunto: «Non ci sono campi o “centri per migranti”, solo prigioni. Alcune controllate dalle autorità, altre da milizie e trafficanti e vi sussistono condizioni orribili. Chiunque venga sbarcato sulle coste libiche torna in queste carceri».
Un ruolo fondamentale nella costruzione dell’inchiesta l’ha giocato la Vos Hestia: sulla nave che fa capo a Save the children si è imbarcato l’infiltrato dello Sco che ha prodotto il dossier di accusa, sullo stesso natante c’erano i due membri della Imi security service che si sono offerti come testimoni alla procura. Ieri Save the children ha spiegato la sua posizione: «Non eravamo a conoscenza della presenza a bordo di un agente di polizia sotto copertura» né controllavano i due uomini della security ma ribadisce «la volontà di continuare a collaborare con le altre organizzazioni».
Una precisazione è arrivata anche dalla tedesca Sea Eye, l’ultima Ong in ordine di tempo ad aver dato la propria disponibilità ad accettare il codice stilato dal Viminale. La firma però non c’è ancora: «C’è l’impegno a siglarlo poiché intendiamo continuare il soccorso marittimo e siamo d’accordo su tutte le regole tranne una: attestare l’idoneità tecnica della nave e del suo equipaggiamento». La Ong non si era presentata all’incontro del 31 luglio convocato dal Viminale, con il sequestro di Iuventa la posizione si è ammorbidita.

J il manifesto, 5 agosto 2017
Il nome della Ong nel mirino della procura di Trapani, Jugend Rettet, cioè «la gioventù salva», chiarisce perfettamente il significato dell’azione dei giovani tedeschi nel Mediterraneo. Solo gente che non ha alcuna responsabilità negli orrori commessi dalla Germania nazista, ma ne porta sulle spalle la terribile memoria, può salvare gli innocenti dalla morte. Ed ecco perché questi ragazzi non vogliono firmare alcun codice che ne limiterebbe l’azione: perché sanno quanto gli stati siano letali e colpevoli di fronte ai trentamila morti del Mediterraneo.

Questo è il punto, come notava Luigi Manconi sul manifesto di ieri: la pretesa di criminalizzare chi ritiene che ci sia una giustizia superiore alle esigenze, vere o presunte, degli stati. E anche alla giustizia terrena. Quando la Svizzera chiuse le frontiere agli ebrei in fuga dal nazismo, ci fu un capitano di polizia, Paul Grüninger, che violò le rigide norme della Confederazione falsificando i visti dei rifugiati ebrei e perciò meritò il titolo e l’onore di «giusto». Fu cacciato dal servizio, senza pensione, e morì in povertà. I giovani tedeschi, da pare loro, ci ricordano che esiste una giustizia più alta di quella delle procure e delle norme emanate da legislatori ciechi ed esecutori ottusi. Un credente ne troverà le radici in Dio, un laico nella ragione o nel semplice, intuitivo ma cogente senso dell’umanità.
 |
| la sacrosanta operazione di contatto per salvare i profughi |
E poi, che infrazioni della legge avrebbero commesso? «Comunicare» con gli «scafisti», quando tutti sanno che in mare aperto si incrociano innumerevoli messaggi? E come non sapere o non capire che spesso i cosiddetti «scafisti» spesso sono poveracci che magari si procurano a un passaggio? Quelli che ci guadagnano davvero stanno a terra, magari nella stessa guardia costiera libica, per quanto ne sappiamo, o in qualsiasi banda che scorrazza in Libia. Questi non li ferma mai nessuno, tantomeno il Minniti l’Africano. L’ossessivo e ripetitivo slogan «guerra ai trafficanti» serve solo a coprire il vero scopo di tutto questo: impedire che le navi delle Ong salvino i migranti. Qualche genio strategico di Frontex – che non ha mai salvato nessuno e tiene le sue navicelle al sicuro nei porti – pensava che se ne annegano un po’ di più, ne arrivano di meno e quindi il conto va in pari. E magari si sente la coscienza a posto. E quindi non stupisce che, come ha scritto la Tageszeitung, «Chi salva i migranti viene fatto fuori».
Il Mediterraneo tra Sicilia e Libia non è un far west, come ha scritto Travaglio, che ora esige legalità, cioè ordine e disciplina, anche in questo nuovo campo. È un tratto di mare strapieno di navi militari e sorvegliato perennemente dai droni, senza che nessuno si preoccupi di trarre in salvo i potenziali naufraghi, tranne le Ong. D’altronde, anche il poliziotto infiltrato sulla nave di Save the Children, ha salvato il suo bambino, il brav’uomo. Ma come l’avrebbe salvato, se non fosse stato sulla nave dei volontari? Detto questo altrove infiltrano gli agenti segreti o i poliziotti tra i narcotrafficanti, noi tra i volontari che salvano i migranti.
Questa è una brutta storia per la giustizia e per gli organi di informazione che pubblicano video insignificanti, cercando di farci credere che rivelino chissà quali segreti. Naturalmente non poteva mancare la soddisfazione di Di Maio né il punto di vista di Renzi che esige un «pugno di ferro».
Spezzeremo le reni alle Ong? Tra l’altro, c’è da giurare che tra qualche tempo, finita la cagnara, andrà come nel caso della Cap Anamour accusata di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina nel 2004 e assolta completamente nel 2009. Per fortuna, ci sono ancora giudici in Italia.
Guai a voi, scribi e farisei ipocriti, che chiudete il regno dei cieli davanti agli uomini! grida Gesù alla folla nel Vangelo di Matteo. Certo, l’Europa non è il regno dei cieli, ma, chissà perché, da giorni queste parole mi rimbombano ossessivamente nella testa.
In una realtà che vorrebbe, da parte di governanti saggi e di popoli civili, la realizzazione di canali sicuri da utilizzare per l'inevitabile esodo, si incolpano quelli che organizzano una supplenza. Articoli di Luigi Manconi e Adriana Pollice. il manifesto, 4 agosto 2017, con postilla
REATO D’ALTRUISMO
di Luigi Manconi
Reato umanitario: come capita non di rado, è stato il quotidiano «dei vescovi» a trovare la definizione più efficace, e moralmente e giuridicamente più intensa, per qualificare la colpevolizzazione delle Ong: e, nel caso specifico, della Jugend Rettet. Il che potrà indurre molti laici, anche solo per questa ragione, a schierarsi dalla parte della magistratura e dello Stato, quasi che gli orientamenti delle chiese e delle organizzazioni umanitarie fossero l’espressione di un profetismo antistatuale e anarcoide.
Altri, e io tra questi, vedono invece in quegli stessi orientamenti un’ispirazione, rigorosamente democratica e liberale, che si rifiuta di ricondurre l’agire umano e l’azione sociale nell’ambito esclusivo degli apparati istituzionali, delle loro norme e del loro ordine superiore.
È un’idea statolatrica, e tendenzialmente autoritaria, che i democratici e i garantisti non possono condividere.
Se gli appartenenti a Jugend Rettet o l’equipaggio della sua nave – ma il pm di Trapani ha parlato solo di «alcuni membri» – hanno commesso reati, vengano processati e, qualora riconosciuti colpevoli, condannati.
Ma finora, dai dati conosciuti e dalle stesse dichiarazioni della procura – avrebbero agito «non per denaro» ma per «motivi umanitari» – si tratterebbe solo ed esclusivamente della realizzazione di un «corridoio umanitario». Così ha suggerito Massimo Bordin nella sua rassegna stampa su Radio radicale.
E a me sembra proprio che di questo si tratti. Uno di quei rarissimi «corridoi umanitari» che possono consentire ingressi sicuri in un’Italia e in un’Europa, dove tutti gli accessi legali risultano ermeticamente serrati.
E, dunque, si può dire che – fatte salve l’indiscussa buona fede della magistratura e la necessità di attenderne le conclusioni – siamo in presenza, sul piano della pubblica opinione e del senso comune, di uno degli effetti della campagna di degradazione del ruolo e delle finalità delle organizzazioni non governative, in corso da mesi. E delle conseguenze di un processo – se possibile ancora più nocivo – di svilimento di alcune categorie fondamentali come quelle di salvataggio, soccorso, aiuto umanitario. Questo è il punto vero, il cuore della controversia in atto e la vera posta in gioco morale e giuridica. E, per ciò stesso, politica.
Dunque, e torniamo al punto di partenza, la falsa rappresentazione da cui guardarsi oggi è quella che vedrebbe uno schieramento, definito «estremismo umanitario», utopistico e velleitario (e tanto tanto naif), e, all’opposto, un fronte ispirato dal realismo politico e dalla geo-strategia, tutto concentrato sul calcolo del rapporto costi-benefici. Ma, a ben vedere, quest’ultimo mostra tutta la sua fragilità. Davvero qualcuno può credere che sia realistica e realizzabile l’ipotesi di chiudere i porti? E di attuare un «blocco navale» nel mare Mediterraneo?
Cosa c’è di più cupamente distopico dell’immaginare che la missione militare, appena approvata dal Parlamento italiano, possa essere efficace in un quadro segnato da un’instabilità oggi irreparabile, come quella del territorio libico e del suo mare?
Se considerato alla luce di questi interrogativi, il reato umanitario di cui si macchierebbero le Ong rappresenta davvero la riproposizione, dopo un secolo e mezzo, di quelle fattispecie penali che precedettero la formazione dello stato di diritto. Reati senza vittime e privi di quella offensività e materialità che sono i requisiti richiesti dal diritto contemporaneo: il vagabondaggio, l’anticlericalismo, il sovversivismo, la propaganda antimonarchica.
Di questi comportamenti, il reato di altruismo rappresenta una sorta di forma disinteressata («non per denaro») e ispirata dalla obbligazione sociale e da quel senso di reciprocità che fonda l’idea contemporanea di comunità e di cittadinanza.
«CONDOTTA UMANITARIA»
SORVEGLIATA SPECIALE
di Adriana Pollice
«Immigrazione. La nave Iuventa è bloccata nel porto di Trapani, l’equipaggio sotto scorta a Lampedusa. L'avvocato della ong tedesca precisa: “Faremo ricorso contro il sequestro. Non c'è nessun indagato, sono liberi cittadini”»
L’equipaggio della nave Iuventa, della Ong tedesca Jugend Rettet, è stato trasferito ieri sotto scorta in alcune abitazioni di Lampedusa. La nave, sequestrata mercoledì su ordine della procura di Trapani, è sorvegliata dalla polizia. L’equipaggio è stato interrogato dagli inquirenti: il fascicolo è a carico di ignori, il reato ipotizzato è favoreggiamento dell’immigrazione clandestina. «Faremo ricorso contro il sequestro. Non c’è nessun indagato, sono liberi cittadini» ha spiegato Leonardo Marino, difensore della Ong, che si è fatta sentire via Twitter: «Per noi il salvataggio di vite umane è e sarà la priorità e ci dispiace non poter operare nella zona di ricerca e salvataggio in questo momento. Stiamo raccogliendo informazioni e solo dopo potremmo valutare le accuse. Speriamo di incontrare le autorità italiane prestissimo».
Jugend Rettet non ha sottoscritto il codice di condotta stilato dal Viminale. Ieri invece è arrivata la firma al regolamento, voluto dal ministro Minniti, da parte di Sea-Eye. Salgono così a quattro (con Moas, Save the children e Proactiva Open Arms) le organizzazioni non governative a essersi allineate. Continuano a opporsi invece Sos Mediterranee, Medici senza frontiere e Sea-Watch. Il commissario europeo per le Migrazioni, Dimitris Avramopoulos, è tornato a chiedere alle Ong l’adesione al codice mentre la sinistra tedesca attacca: «Il sequestro della Iuventa è un ricatto con il quale il governo italiano vuole forzare le Ong a firmare un accordo-bavaglio» dichiara la Linke. Sia Linke che Verdi sottoscrivono le critiche dell’associazione Pro-Asyl, che accusa il governo italiano di violare il diritto internazionale
Fermata martedì dalla Guardia costiera per «controlli di routine», la Iuventa è stata poi sequestrata e trasferita a Trapani, scortata con un grande dispiegamento di forze. Sequestrati documenti e computer, verranno esaminati gli strumenti di bordo per tracciarne i movimenti. L’inchiesta resterà a Trapani: ci sarà il trasferimento alla Dda di Palermo, competente per legge, solo se la procura decidesse di contestata l’associazione criminale.
«Ci sono gravi indizi di colpevolezza. Gli episodi raccolti contribuiscono a sostenere che questa condotta sia abituale» ha spiegato il procuratore Ambrogio Cartosio. Il titolare dell’indagine ha però specificato che la responsabilità degli illeciti è individuale, non ci sarebbero quindi legami tra i trafficanti e la Ong, infatti non è stata contestata l’associazione a delinquere. «Le persone coinvolte non hanno agito per denaro – ha sottolineato -, sulla nave si sono alternati diversi equipaggi e al momento non pare abbiano percepito compensi. La mia personale convinzione è che il motivo della condotta dell’equipaggio sia umanitario».
Ieri Matteo Renzi ha insistito: «Sul tema migratorio, aiutarli davvero a casa loro non è una parolaccia». Mercoledì è intervenuta Giusi Nicolini, che Renzi ha voluto nella segreteria nazionale del Pd. L’ex sindaca di Lampedusa si è smarcata dalle posizioni del segretario dem: «Se si vuole cacciare le Ong dal Mediterraneo vuol dire che si vuole che di migranti ne arrivino di meno e dunque, quando sono a mare, che ne muoiano di più. Questa visione è andata peggiorando fino alla criminalizzazione delle Ong».
Nell’inchiesta, condotta dallo Sco, è stato usato un agente sotto copertura, che ha lavorato sulla nave Vos Hestia di Save the Children. Sono state le rivelazioni di due suoi operatori a far avviare l’indagine, poi assunti dall’agenzia Imi security service. Cartosio ha spiegato: ci sarebbero stati almeno tre casi in cui alcuni componenti dell’equipaggio della Iuventa, non ancora identificati, avrebbero avuto contatti con trafficanti libici e sarebbero intervenuti in operazioni di soccorso senza che i profughi fossero in pericolo. I migranti sarebbero stati trasbordati sulla nave della Ong scortati dai libici. Il reato si configurerebbe anche perché sarebbe mancato l’imminente percolo di vita.
L’accusa si basa sui testimoni che operavano per Save the children, uno di loro avrebbe raccontato ai pm: «La più temeraria era sicuramente la Iuventa che, da quello che ho potuto vedere sul radar, arrivava anche a 13 miglia dalle coste libiche. La Iuventa, che è un’imbarcazione piccola e vetusta, fungeva da piattaforma ed era sempre necessario l’intervento di una nave più grande». I due avrebbero anche riferito di gommoni restituiti agli scafisti.
Ieri Save the Children ha però precisato: «I testimoni fanno parte del personale di sicurezza della società che collabora con l’armatore, dal quale è stata noleggiata la nave Vos Hestia».
postilla
Un sogno. Ci piacerebbe pensare che un giorno, in un saggio governo universale, un tribunale dotato di giudizio e di potere obbligasse i governanti colpevoli di non aver organizzato la fuga e l'accoglienza dei rifugiati a rimborsare di loro tasca e i migranti dei soldi hanno dovuto pagare agli scafisti e agli altri trafficanti.

Libertà e Giustizia chiede con forza al governo Gentiloni di ritirare, o almeno di riconsiderare profondamente, il Codice di Condotta che ha voluto imporre alle Organizzazioni Non Governative che, nel Mediterraneo, svolgono una fuzione umanitaria fondamentale, sopperendo meritoriamente all’ignavia e all’inerzia dei governi.
Come ha notato l’Associazione per gli Studi Giuridici sull’Immigrazione si tratta di una misura che «mina l’efficacia delle attività di soccorso». In altri termini, il costo di questo provvedimento ambiguo e sbagliato rischia di essere misurato in vite umane perdute.
Il Codice Minniti è in contrasto sia con il diritto internazionale del mare sia con ciò che il diritto di asilo impone all’Italia. In particolare, appare perfettamente condivisibile la scelta di alcune ong (come Medici Senza Frontiere, insignita del Premio Nobel per la Pace) di non sottoscrivere l’impegno a non effettuare trasbordi (una misura spesso invece necessaria per salvare le vite dei migranti), così come il rifiuto di portare armi a bordo, e la scelta di non ospitare unità di polizia.
Libertà e Giustizia rileva che il Codice Minniti non ha valore di legge, eppure sta già consentendo al governo di intervenire in modo straordinariamente pesante nello scenario già teso e difficile del Mediterraneo. In sostanza, il governo sta ribaltando la politica italiana verso i migranti senza passare dal Parlamento: un passo drastico, preceduto dalla inaudita minaccia di chiudere i porti, e ora accompagnato da oscure minacce alle ong che rifiutano, del tutto legittimamente, di sottoscrivere il Codice.
Libertà e Giustizia si rivolge anche a tutte le forze che sostengono il governo, e in generale al Parlamento della Repubblica: la lunghissima chiusura estiva delle Camere non può certo essere il pretesto per non discutere di questa terribile svolta anti-umanitaria, una svolta che nega e mortifica i principi fondamentali della nostra Costituzione.

Sinistra italiane e Movimento5Stelle hanno votato contro, Forza Italia e l’area gentiloniano-renziana, fino a Pier Luigi Bersani incluso, hanno votato a favore della guerra italo-libica contro i rifugiati. Articoli di Carlo Lania e Daniela Preziosi. il manifesto, 3 agosto 2017-
LA PRIMA NAVE ITALIANA
È GIÀ IN LIBIA.
L’OIM: «NO AI RESPINGIMENTI»
di Carlo Lania
«Messaggio in Codice. Via libera del parlamento alla missione. Forza Italia vota con la maggioranza, Mdp si spacca. Contrari Si, Lega e M5S»
La prima nave militare italiana si trova già nel porto di Tripoli. Si tratta del pattugliatore Comandante Borsini in servizio con la missione «Mare sicuro» che ieri, subito dopo il via libera del parlamento alla missione, ha ricevuto dallo Stato maggiore della Difesa l’ordine di dirigersi in acque libiche. A bordo ufficiali della squadra navale e del Comando operativo del vertice interforze che dovranno coordinarsi con i colleghi libici per decidere quali e quanti mezzi distogliere dall’attività di Mare sicuro – che opera non distante dalle acque territoriali libiche – per essere impiegati nella nuova operazione di contrasto all’immigrazione. Secondo le autorità di Tripoli serviranno almeno cinque giorni per mettere a punto tutti i particolari tecnici dell’operazione (oltre alle navi, l’area entro la quale utilizzarle e che tipo di supporto dovranno fornire alla Guardia costiera del Paese).
A questo punto l’avventura italiana in Libia è davvero cominciata, con tutto il suo carico di incertezze. Poco prima che la Comandante Borsini puntasse la prua verso il paese nordafricano, erano state Camera e Senato ad autorizzarne il via libera, seppure senza «l’ampio consenso» auspicato dal governo alla vigilia. Mentre Forza Italia si è schierata con la maggioranza, Lega Nord, Sinistra italiana e M5S hanno infatti votato contro e Fratelli d’Italia si è astenuto. Spaccato il Mdp, con alcuni deputati che hanno votato contro, altri che si sono astenuti e, infine, altri ancora che si sono espressi a favore. Al Senato i bersaniani hanno invece votato unanimi a favore.
Difficile capire il clima che già a partire da oggi circonderà la missione. Ieri, con una dichiarazione a metà tra l’apprezzamento e le minacce, il colonnello Ayoub Qassem, portavoce della Marina libica che fa capo al Governo di accordo nazionale guidato dal premier Fayez al Serraj, prima ha riconosciuto come il sostegno italiano abbia contribuito «a migliorare i salvataggi», poi ha definito «vaga» la decisione di Roma di intervenire in acque libiche e promesso di «vigilare con attenzione affinché non venga violata la sovranità delle nostre acque territoriali». Parole che in realtà sembrano servire più a smorzare possibili attacchi interni che un avvertimento alle navi della nostra Marina, tanto più se si pensa che richiedere l’intervento italiano è stato proprio Serraj con una lettera inviata il 23 luglio al presidente del consiglio Paolo Gentiloni.
A destare le preoccupazioni maggiori, però, è ancora la sorte che spetterà ai migranti fermati in acque libiche, a questo punto anche con il contributo italiano. «Consideriamo inaccettabile soccorrere i migranti in mare per poi riportarli in Libia dove vivranno in condizioni che tutto il mondo conosce», ha detto ieri parlando al Comitato Schengen il direttore dell’Ufficio coordinamento per il Mediterraneo dell’Organizzazione internazionale per le migrazioni, Federico Soda. «Cercheranno di attraversare il mare di nuovo, e quindi, di fatto, intensificheranno la tratta e il traffico».
In Libia ci sono circa 30 campi governativi nei quali i migranti sono detenuti. Soda ha spiegato come l’Oim riesca a entrare solo in una ventina di questi dove ha potuto verificare le «condizioni pessime» in cui uomini, donne e bambini sono costretti a vivere. «E in quelli in cui non entriamo si trovano presumibilmente in condizioni peggiori», ha proseguito.
Torture, violenze di ogni tipo e sfruttamento sono all’ordine del giorno eppure per le organizzazioni internazionali finora non c’è alcuna certezza che i migranti che verranno ricondotti in Libia non subiranno le stesse sevizie. Duro il giudizio espresso da Amnesty International sul via libera del parlamento alla missione italiana. «Facilitare l’intercettamento e il ritorno in Libia di migranti e rifugiati – ha detto il vicedirettore dell’organizzazione, Gauri Van Gulik – significherà destinarli ai centri di detenzione del paese dove quasi certamente saranno esposti al rischio di subire torture, stupri e anche di essere uccisi. Il voto di oggi – è la conclusione di Van Gulik – potrebbe rendere le autorità italiane complici di questo orrore».
MDP, IL SÌ ALLA MISSIONE
FINISCE IN MINORANZA»
di Daniela Preziosi
«Libia. Alla camera tra assenti e contrari la maggioranza dei deputati non segue l'indicazione favorevole a un via libera "sofferto". Spaccatura tra gli ex Sel e gli ex Pd che al senato sono da soli e infatti il gruppo resta unito sul voto favorevole»
«Ma no, non ci siamo spaccati, abbiamo avuto una articolazione politica. Ma nulla di drammatico: veniamo da percorsi diversi sui temi della politica estera. E sulle missioni. Ma divisi no: sto preparando un viaggio per il medioriente con Roberto Speranza, a settembre…». In Transatlantico Arturo Scotto minimizza, ma il problema c’è e si vede. Anzi si conta: sulla missione in Libia al senato, dove Mdp è composto da ex Pd, tutti votano sì come un sol uomo. Alla Camera Articolo 1 si fa in tre-quattro, anche più.
Su 43 deputati, in 20 votano sì, in cinque no (come i cugini di Sinistra italiana), uno si astiene, in 13 escono dall’aula – per lo più ex Sel – e il resto sono assenti. Si misurano insomma quelle che in una vecchia sezione si definirebbero «divergenze di analisi». E la famosa «sintesi», che in queste ore viene faticosamente ricercata con Giuliano Pisapia per rimettere in carreggiata «Insieme» , non arriva. Tanto che a Montecitorio Carlo Galli, il filosofo della politica cui spetta l’onere di pronunciare il sì alla mozione governativa a nome del gruppo, deve ricorrere a un’espressione sofferta, parla di «appoggio necessariamente articolato, date le diverse sensibilità presenti».
La linea ufficiale di Mdp è dunque quella di un sì condizionato, ma comunque sì: la decisione del governo «presenta evidenti di criticità, tutte evidenziate nell’atto di indirizzo che abbiamo autonomamente presentato», chiede un «giusto riconoscimento» per il ruolo delle Ong. Eleonora Cimbro ci aggiunge una lamentela per l’ok agli emendamenti di Forza Italia: «Un atteggiamento schizofrenico oppure siamo di fronte a un accordo politico tra Pd e Fi».
Ma alla fine l’appoggio alla mozione della maggioranza non è discussione, «in un’ottica di assunzione di responsabilità nazionale più che di specifica fiducia verso l’esecutivo», dice Galli: esecutivo che pure sostengono, almeno per il momento. In attesa della legge di bilancio, sulla quale già si dichiarano pronti alla rottura.
Dai fuoriusciti di Sel arriva invece un fuoco di fila contro la missione. Per Scotto il sì del parlamento è «un tragico errore», un voto al buio perché l’invio delle navi «trae origine dalla lettera del premier Al Serraj» in cui chiede aiuto all’Italia, che però «il parlamento non ha potuto leggere» (tranne il Copasir).
«La logica del respingimento serve a strizzare l’occhio alla montante pulsione xenofoba», rincara il collega Michele Piras, «l’ingresso italiano nelle acque libiche rischia di generare un contraccolpo ulteriore sulla credibilità interna di Al Serraj» e insomma, «affrontare così un fenomeno colossale è miope ed inutile, un palliativo scorretto». Ancora più duro Florian Kronbichler: «Il passo dal piano politico a quello militare è una dichiarazione di bancarotta dell’Europa nella gestione della crisi migratoria», «governo e parlamento hanno deciso non di aiutare chi fugge, ma di catturare, in modo militare, chi fugge».
Fra le due componenti di Mdp insomma c’è in mezzo un mare di differenze, e sulle missioni militari si capisce: chi proviene dalla sinistra-sinistra lo sa già almeno dai tempi della guerra in Kosovo, per la quale l’allora Prc tolse l’appoggio al governo Prodi: e i Comunisti italiani di Armando Cossutta si scissero da Rifondazione e appoggiarono il governo D’Alema. Quello stesso D’Alema che oggi vuole rimettere insieme tutta la sinistra.
Il Prc, quello di oggi, non si fa sfuggire l’occasione di attaccare i «compagni», gli uni e gli altri: sulla missione in Libia: «Il voto a favore degli esponenti di Mdp e Campo progressista, in coerenza con il disastro combinato quando erano nel Pd, purtroppo conferma che queste formazioni non rappresentano un’alternativa di sinistra per questo paese».
 L’Italia di Salvini, Meloni, Renzi, Gentiloni, Berlusconi e Alfano e la Libia dei negrieri saranno alleati nella guerra armata contro le persone che tentassero di fuggire dagli inferni che il Primo mondo ha creato nelle loro terre. La Libia ha tanto petrolio.
L’Italia di Salvini, Meloni, Renzi, Gentiloni, Berlusconi e Alfano e la Libia dei negrieri saranno alleati nella guerra armata contro le persone che tentassero di fuggire dagli inferni che il Primo mondo ha creato nelle loro terre. La Libia ha tanto petrolio.
Il Fatto quotidiano, 2 agosto 2017
Una missione dai confini operativi labili quella che sta per partire per la Libia. E non tanto per la mancata volontà del governo italiano di stabilirli, quanto per la difficoltà oggettiva di rispettarli, una volta sul campo, trattandosi di un paese diviso e di un’operazione che sarà condotta in gran parte nelle acque territoriali libiche. L’Italia potrà rispondere sparando, se attaccata, e potrà farlo anche se ad essere attaccati saranno i partner libici.
Saranno due le navi italiane impegnate. Un pattugliatore che porterà il team dei nostri ufficiali che dovranno interlo-quire con i loro colleghi libici (da questa interlocuzione deriverà l’area di azione) e una nave logistica (che servirà ad aggiustare altre imbarcazioni). Il pattugliatore sarà stabilmente nel porto di Tripoli (quindi nelle acque territoriali libiche) ed agirà solo su richiesta e mai da solo: questo perché nel caso ci si trovasse in presenza di barconi affondati e di migranti in pericolo di vita dovranno intervenire le motovedette libiche. Per scongiurare due rischi opposti: quello di riportare i naufraghi in Libia, dando il via a respingimenti collettivi vietati dalle convenzioni internazionali.
E quello di portarli in Italia, rischiando un effetto boomerang. È quello il quadro generale illustrato ieri dal ministro degli Esteri, Angelino Alfano e dal ministro della Difesa, Roberta Pinotti, davanti alle Commissioni riunite Esteri e Difesa di Camera e Senato. “L’incontro di Parigi tra Serraj e Haftar è stato definito dall’Economist un piccolo passo. Noi invece gli abbiamo riconosciuto un valore”, ha detto Alfano. Un modo indiretto di confermare che l’accelerazione della missione italiana si deve soprattutto ad evitare di farsi surclassare da Macron.
“Si continua a rimuovere dal dibattito pubblico la
vera causa di instabilità in Libia, ovvero il conflitto a bassa intensità tra Francia e Italia sul futuro assetto del Paese”, ha sottolineato Erasmo Palazzotto di Sinistra italiana. È toccato alla Pinotti dare le linee della missione: “Tutte le attività si svolgeranno sulla base delle e sigenze delle autorità libiche. Non si profila alcuna ingerenza o lesione della sovranitàli bica”. Ci ha anche tenuto a sottolineare che la Libia ha definito una sua area Sar (Search and rescue), cosa che l’Italia voleva.
Ma soprattutto: “Le regole d’ingaggio per i militari italiani saranno quelle previste per l’operazione Mare Sicuro” ma “dovranno essere estese al fatto che la missione diventa bilaterale”. Quindi, “il diritto internazionale prevede la legittima difesa estesa all’uso della forza graduale e proporzionale. I dettagli sono da definire con i libici, ma se gli scafisti sparano contro una nostra nave possiamo intervenire e la stessa cosa vale se è messa a ri schio una nave libica”. Le regole di ingaggio di Mare sicuro sono secretate. E verranno adeguate dopo un tavolo tecnico con la Guardia costiera e la Marina libica. Dunque oggi le Camere votano senza conoscerle.
La Pinotti ha ricordato come la richiesta è partita da una lettera arrivata da Serraj a Gentiloni il 23 luglio. La cosa non è stata priva di problemi: di ritorno dall’incontro con il premier Serraj ha smentito il fatto di aver chiesto aiuto all’Italia. Allora, Gentiloni gli ha chiesto una lettera formale. Questa è arrivata e ieri su richiesta fatta nelle Commissioni è stata letta ai membri del Copasir.
Al netto della richiesta di supporto logistico non c’è niente di specifico. Da sottolineare anche che non ci sarà budget supplementare, oltre a quello di Mare sicuro.
Ieri nelle Commissioni hanno votato contro Sinistra Italiana e Cinque Stelle e non ha votato Mdp. Dovrebbe andare allo stesso modo nelle Aule di Montecitorio e Palazzo Madama. Grazie al sì di Forza Italia i numeri dovrebbero esserci. A quel punto nel giro di un paio di settimane la missione diventerà operativa.
 «Il filo che lega le opere è quello dell’esodo, ma non è facile riuscire a raccontarlo, soprattutto per i Paesi più grandi».
«Il filo che lega le opere è quello dell’esodo, ma non è facile riuscire a raccontarlo, soprattutto per i Paesi più grandi».
il Fatto Quotidiano, 3 agosto 2017 (p.d.)
Da un po’ il governo del mio Paese, dopo aver già liquidato per ragioni essenzialmente economiche l’operazione “Mare nostrum”, vanto della nostra Marina Militare, in pro di una assai meno efficace, ha iniziato a prendersela con le Ong che raccolgono in mare i naufraghi: li salvano o non li salvano davvero? Sono colluse con gli scafisti o animate da principi nobili ma per i quali non c’è spazio? Il Testo unico sull’immigrazione all’articolo 12 recita “non costituiscono reato le attività di soccorso e assistenza umanitaria prestate in Italia nei confronti degli stranieri in condizioni di bisogno comunque presenti nel territorio dello Stato”; e la convenzione Sar obbliga a soccorrere chiunque si trovi in mare anche oltre le acque territoriali. Il “favoreggiamento all’immigrazione clandestina”, per molti odioso (riposa tra l’altro sulla malfamata legge Bossi-Fini), è per fortuna difficile da provare, quando la gente è in mare; e pare che il film Terraferma di Emanuele Crialese (2011) sia passato invano.
Da quando è iniziata questa svolta, ho ripreso in mano il mio Freesa, “documento di viaggio universale” rilasciato dal Padiglione tunisino della 57ma Biennale di Venezia: nelle sue pagine, anziché visti o normative, s’incontrano numeri (i 65,3 milioni di rifugiati del 2015; i 3,2 milioni di richiedenti asilo in attesa di conoscere il loro destino; i 165mila "abitanti" del campo di Kakuma in Kenya) e ideali (anzitutto quello della libertà di movimento, come elaborato sul sito
theabsenceofpaths.com, un progetto che coinvolge anche l’ong maltese Moas). Il Freesa può sembrare l’ennesima, gratuita trovata di un’arte che sbandiera nobili principi, senza additare i veri conflitti o i responsabili; ma s'inserisce in un quadro più ampio.
Se una mostra come la Biennale di Venezia ha un senso, è infatti quello di registrare il clima del mondo in cui viviamo, un orizzonte di attesa che esca dal recinto strettamente estetico e rifletta anche la dinamica sociale e culturale. Tanto più in un’edizione come quella di quest'anno, alquanto insipida fin dal titolo (“Viva Arte Viva”, fino al 26 novembre), e incongruamente suddivisa in isole che richiamano piuttosto un Brek o un parco-giochi (“Padiglione della Terra”, “Padiglione dei colori”, “Padiglione del Tempo e dell’Infinito” e via dicendo). Optando per una selezione di basso profilo, la curatrice Christine Macel ha raccolto poche star (Eliasson, Parreno, Sala, Orozco), un po’di amarcord degli anni che furono (i defunti John Latham, Marwan, Maria Lai, Bas Jan Ader) e molti epigoni. Non mancano cose poetiche, però, come i totem dell'indiana Rina Banerjee, l’arazzo del maliano Abdoulaye Konaté, le precarie figurine della neozelandese Francis Upritchard, il video del giapponese Koki Tanaka, che percorre e conquista lo spazio da casa sua alla centrale nucleare più vicina, e quelli della russa Taus Makhacheva con il funambolo che trasporta quadri sui monti del Caucaso, e con i naufraghi che scompaiono in mare su un barcone capovolto; e naufraghi annegano anche nei dipinti della canadese Hajra Waheed.
I naufraghi, appunto. Come sempre alla Biennale, le partecipazioni dei singoli Paesi sono più vivaci della selezione ufficiale, e spesso la redimono. Quest’anno, sebbene le grandi nazioni preferiscano gingillarsi in cervellotiche astrazioni (taceremo del padiglione italiano, che oscilla fra il mistico e il compiaciuto), un filo rosso che emerge è proprio quello relativo al fenomeno migratorio, ai percorsi dello “straniero”. Storie concrete, documentate con uno slancio che sfugge alla retorica, ed elabora in segno il nocciolo dei problemi: la ferrovia della rotta balcanica nel padiglione sloveno, la tragedia delle famiglie strappate in quello messicano, le maschere dei Mapuche perseguitati in Cile, i cerchi di appartenenza nello Zimbabwe, e soprattutto, nel padiglione sudafricano e in quello australiano (in modi assai diversi), il confronto fra i volti e le parole degli attori di Hollywood e le icone vive e vere dei migranti dei nostri giorni. L’arte che prova, coi suoi mezzi, a riflettere sul mondo.
In questo discorso, ormai globale, l'Italia, al pari della Grecia, non riveste un ruolo marginale: molte storie hanno il loro fulcro nel Mediterraneo, molte immagini sono delle nostre coste. E sono passati già dieci anni dal mirabile trittico Western Union Small Boats di Isaac Julien, tutto ambientato in Sicilia, sulle spiagge che allineano cadaveri e vacanzieri (come in Crialese, appunto), tra i balli nei palazzi del Gattopardo e l'annaspare in acqua delle membra di giovani donne che non sanno nuotare. Ecco allora che il modo in cui l’Italia, messa alla prova dalla colpevole inazione dell'Europa, affronta l'esodo dei disperati, non ha solo una dimensione legislativa e politica, ma anche un valore simbolico e culturale: è da noi che si gioca la partita, da un nostro gesto (quelli dei Paesi balcanici li abbiamo visti: muri e filo spinato) dipende moltissimo. Di quali immagini, di quali parole (d'ordine?), di quali minacce, noi Paese di Fuocoammare, dovremo gloriarci (o vergognarci) un giorno? Dei poliziotti che accolgono schierati i ragazzi di Jugendrettet, o dei porti che respingono le navi di MSF?
La Grecia, nostra compagna in questa difficile vicenda (molti ancora i profughi imbottigliati nel Paese, che pure beneficia dei nefandi accordi dell'Unione con Erdogan), non perde tempo, e crea nel suo padiglione un capolavoro che vale da solo il biglietto di tutta Biennale: in Laboratorio di dilemmi, Yorgos Drivas presenta un'allegoria che parla di cellule epatiche ma in realtà soprattutto nel video finale, in cui recita una magnifica Charlotte Rampling - delinea il problema di come una società può reagire dinanzi al diverso. Tutta la storia è una sorta di riscrittura delle Supplici di Eschilo, una tragedia che, nel mettere in scena l’arrivo e la problematica accoglienza ad Argo delle cinquanta figlie dell’egiziano Danao, ha già detto tutto sul tema delle migrazioni (ne fanno fede i recenti adattamenti di Moni Oadia a Siracusa e di David Greig a Edimburgo): un’opera antica dalla quale una cultura europea meno immemore di sé dovrebbe forse ripartire.
 Ancora ostacoli alle organizzazioni umanitarie che tentano di aiutare i fuggiaschi che tcercano rifugio in luoghi sicuri. Articolo di Carlo Lania e commento diLuigi Manconi.
Ancora ostacoli alle organizzazioni umanitarie che tentano di aiutare i fuggiaschi che tcercano rifugio in luoghi sicuri. Articolo di Carlo Lania e commento diLuigi Manconi.
Il manifesto, 1 agosto 2017
ONG DIVISE,
SOLO IN DUE FIRMANO
IL CODICE-SALVATAGGI
di Carlo Lania
«Codice a sbarre. Msf rifiuta le nuove regole: contrari alla presenza di agenti armati a bordo delle navi e al divieto di trasbordo dei migranti»
Alla fine solo due Ong – Save the Children e Moas – hanno accettato di firmare il codice di comportamento messo a punto dal Viminale per i salvataggi in mare. Medici senza frontiere ha scelto infatti di non accettare le nuove regole e lo stesso ha fatto la tedesca Jugen Rettet. Tutte le altre Ong, Sea-eye, Sea Watch e Sos Mediterranée, peraltro assenti alla riunione di ieri pomeriggio al ministero degli Interni, starebbero ancora valutando il da farsi, mentre disponibilità a firmare il Codice sarebbe stata dichiarata via mail in serata dalla spagnola Proactiva open arms.
L’accordo tra Ong e Viminale, che sembrava quasi raggiunto solo venerdì scorso, alla fine invece è saltato. E adesso le due parti si rimpallano la poca disponibilità a venirsi incontro. Due i punti principali di scontro, sempre gli stessi da quando la trattativa è cominciata: il divieto a effettuare i trasbordi dei migranti tratti in salvo e la presenza a bordo delle navi di agenti di polizia giudiziaria armati. Questioni dirimenti per le Ong, delle quali però l’ultima bozza inviata venerdì sera in visione dal ministero non avrebbe tenuto contro in maniera adeguata. «Ci preoccupa non aver ricevuto garanzie sul fatto che gli agenti salirebbero a bordo disarmati», spiega Tommaso Fabbri, capo missione di Msf Italia. «Se accettassimo, posso immaginare le ripercussioni che potremmo avere negli altri Stati in cui Msf opera e nei quali abbiamo mantenuto il principio di non avere con noi personale armato. Non dimentichiamo che siamo operatori umanitari».
Stessa cosa per quanto riguarda la possibilità di trasferire i migranti salvati a bordo di navi più grandi, come quelle della missione europea Sophia. Le Ong operano spesso su mezzi non particolarmente grandi, adatti per i soccorsi perché possono accostare i barconi senza creare situazioni di pericolo, ma del tutto inadatte a trasferirli in Italia. Un’ipotesi accordo si era trovata sulla possibilità di effettuare i trasbordi sotto controllo e autorizzazione della Guardia costiera italiana, ma alla fine non se ne è fatto nulla. «Nel codice questa possibilità viene prevista come un’eccezione, senza alcuna garanzia per le Ong di non essere costrette a dover tornare verso l’Italia con i migranti a bordo», prosegue Fabbri.
Cosa accadrà adesso è un’incognita per le organizzazioni umanitarie. Di sicuro a nessuna di loro verrà negato l’accesso ai porti, ma dal ministero degli Interni fanno capire che Moas e Save the Children, le due Ong che hanno accettato il Codice, diventeranno degli interlocutori privilegiati e entreranno di fatto nel sistema nel sistema istituzionale dei soccorso. Questo vuol dire che in caso di un barcone che si trovi in difficoltà la sala operativa della Guardia costiera chiamerà a intervenire prima di tutto loro. «Le altre – spiegano sempre al ministero – si assumeranno la responsabilità per quanto riguarda la sicurezza della navigazione e delle persone che si trovano a bordo».
Molto probabilmente verso le Ong che non hanno firmato verranno effettuati dei controlli più serrati per quanto riguarda la strumentazione di bordo, ma è chiaro che l’assenza delle Ong di fronte alle acque libiche, magari perché costrette a trasportare i migranti in un porto italiano, rischia di aumentare il numero dei naufragi.
Per Valerio Neri, direttore generale di Save the Children, Ong che invece ha accettato le nuove regole, «gran parte dei punti indicano cose che già facciamo e ci sono stati chiarimenti su un paio di punti che ci preoccupavano, quindi non abbiamo avuto problemi a firmare. Siamo convinti – ha aggiunto Neri – di aver fatto la cosa corretta e mi dispiace che altre Ong non ci abbiano seguito, ma evidentemente avevano altre sensibilità».
Il mancato accordo con le Ong ha scatenato le reazioni del centrodestra. Per il capogruppo di Forza Italia alla Camera Renato Brunetta ha chiesto al ministro degli Interni Minniti «di chiudere i porti» alle Ong che non hanno sottoscritto le nuove regole, mentre Georgia Meloni, leader di FdI, ha chiesto al governo di sequestrare le loro navi.
ONG NEL MIRINO
PER SPORCARE TUTTO
di Luigi Manconi
La controversia tra le Ong e il governo italiano intorno al codice di regolamentazione dell’attività di salvataggio in mare è questione di grande importanza. Guai a pensare che in discussione sia la maggiore o minore severità dei controlli e la tassatività delle regole di ingaggio o la trasparenza di questo o quel finanziamento.
Fosse così, col buonsenso di tutti i soggetti, le contraddizioni si risolverebbero in breve. Ma non è affatto così: e il motivo è che la posta in gioco è rappresentata dalla stessa categoria di salvataggio.
Per questa ragione, il rifiuto da parte di un’organizzazione autorevole come Medici senza frontiere (premio Nobel per la Pace nel 1999) di sottoscrivere quel codice elaborato dal governo italiano, è un fatto estremamente serio. E male farebbe una persona esperta come il ministro dell’Interno Minniti a sottovalutarlo.
Ma come si è arrivati a questo esito?
Nei primi mesi del 2017, Frontex – agenzia europea della guardia di frontiera – solleva alcuni dubbi sull’operato delle organizzazioni non governative che partecipano all’attività di soccorso nel mare Mediterraneo. Si accende, così, una polemica sulle presunte relazioni tra le stesse Ong e le strutture criminali che gestiscono il traffico di migranti; e sui finanziamenti che alcune di quelle Ong riceverebbero da sostenitori sospetti perché interessati a «destabilizzare il quadro economico del nostro Paese».
Come affermato dal capo della Procura di Catania, Carmelo Zuccaro. La Commissione Difesa del Senato decide, in base a ciò, di avviare un’indagine conoscitiva, conclusa da un documento che deve riconoscere come tutte le accuse nei confronti delle Ong non reggano alla verifica dei fatti.
In quella sede, i più alti gradi della Marina militare, della Guardia costiera e della Guardia di finanza, escludono che siano mai emerse prove di rapporti tra Ong e trafficanti, sottolineando la piena collaborazione in quel tratto di mare tra organismi di coordinamento, imbarcazioni statuali e navi delle associazioni umanitarie. Anche la magistratura siciliana, nel corso delle audizioni, riconosce la sostanziale correttezza delle Ong.
Il procuratore capo di Catania, Zuccaro, sostiene di non disporre di «alcun fondamento probatorio» che suffraghi le proprie ipotesi accusatorie. E tuttavia, nonostante la fermezza della Guardia costiera nel ribadire di avere il pieno controllo di quanto avviene nelle operazioni Sar (Search And Rescue), le conclusioni della Commissione Difesa insistono sulla necessità di un «coordinamento permanente» per razionalizzare «l’attività disordinata» in quel tratto di mare, che sarebbe dovuta alla presenza delle Ong. Se ne conclude che sarebbe necessaria «una contestuale riduzione delle relative imbarcazioni nell’area».
Va detto che, nel corso di questa polemica, sono emersi umori assai pericolosi. In primo luogo, quella velenosa tendenza a «sporcare tutto», che è tanto più irresistibile quanto più il bersaglio del fango da gettare appare lindo, immune da brutture, privo di zone grigie e di ombre sospette. È l’antica pulsione a lordare ciò che è pulito (un muro, un’immagine, una reputazione), a degradare tutto e tutti al livello più basso, a omologare nell’infamia, a confondere nel disgusto universale. Se tutto è miserabile, la mia miseria risulta in qualche misura riscattata o, comunque, attenuata.
Ma c’è anche dell’altro. In quei meccanismi di degradazione, risultano sfigurate, e comunque intaccate, anche quelle categorie che potevano considerarsi intangibili. Indurre a sospettare che il bene possibile, rappresentato da un’attività umanitaria, possa rivelarsi un male contagioso – i soccorritori alleati ai carnefici – contribuisce potentemente a ridurre in macerie principi fondamentali. Le insinuazioni, e la diffidenza che ne consegue, non solo sfregiano le Ong e ne deturpano il prestigio, ma ottengono l’effetto di erodere i valori cui si ispirano. La violenta polemica, pur conclusasi con un pugno di mosche, ma con una persistente ombra di diffidenza da cui nasce anche questa proposta di codice di regolamentazione, mette in discussione quelle categorie di soccorso, salvataggio e aiuto umanitario che rappresentano il fondamento stesso dell’identità umana. Soccorso e salvataggio, infatti, costituiscono il cuore della vita nel momento essenziale in cui quella stessa vita è messa a repentaglio.
Gli uomini riconoscono di essere uniti da una obbligazione etica e sociale quando – innanzitutto quando – è dal rapporto di reciprocità che dipende la loro sopravvivenza. E il fatto che si evochi, in occasione dei salvataggi nel Mediterraneo, la cosiddetta legge del mare sottolinea l’ineludibilità di quel rapporto perché lo colloca geograficamente laddove lo spazio sembra raggiungere la sua assolutezza: il mare, appunto.
È questo che può spiegare i connotati perenni e imprescindibili di quell’obbligo-diritto-dovere al soccorso e al salvataggio come valore irrinunciabile. Non una vocazione utopica né una tentazione profetica nell’affermare tutto ciò. Piuttosto l’esatto contrario: la volontà umile e ostinata di ritrovare – nel fondamento materiale di una mutua necessità – il senso della qualità umana.
 dimentica che chi fugge oggi lo fa perché, per raggiungere il nostro benessere, abbiamo razziato le loro risorse, creando i deserti dove vogliamo respingerli.
dimentica che chi fugge oggi lo fa perché, per raggiungere il nostro benessere, abbiamo razziato le loro risorse, creando i deserti dove vogliamo respingerli.
il manifesto, 29 luglio 2017
«Aiutiamoli a casa loro». E dopo averli "aiutati» per secoli a casa loro, in Africa, schiavizzandoli e depredando le loro risorse, una generazione "ingrata" vuole venire a casa nostra. Deportiamoli, si dice anche a sinistra»
Adesso sono tutti d’accordo, compreso il segretario del Pd che ha sposato in pieno questo slogan che coniò per primo Salvini. Per la verità, la prima volta che ho sentito dire con convinzione «aiutiamoli a casa loro» è stato nel giugno del 2001.
Durante una conversazione con il presidente del Parco delle Cinque Terre, allora attivista del Pds e poi europarlamentare. Un presidente di Parco molto capace che ha trovato un modo intelligente per recuperare i vigneti ed i terrazzamenti nelle stupende colline delle Cinque Terre, cercando di promuovere un turismo sostenibile in un ambiente molto fragile.
Un uomo innamorato della sua terra e convinto oppositore della globalizzazione capitalistica. Ad un certo punto della discussione venne fuori la questione dell’immigrazione e lui mi raccontò di cinque albanesi che avevano accolto con entusiasmo alle Cinque Terre ed erano stati ricambiati con furti e violenze varie. Da qui la sua profonda avversione al fenomeno migratorio e il suo profondo convincimento: «Aiutiamoli a casa loro».
Poco tempo fa mentre attraversavo lo Stretto ho incontrato un amico magistrato, un democratico convinto e conseguente, cattolico socialmente impegnato, da sempre persona sensibile ai temi sociali.
Mentre l’aliscafo saltellava sulle onde, in una giornata da montagne russe, sono sbalzato via dalla poltrona, non per il mal di mare ma quando gli ho sentito dire: «Aiutiamoli a casa loro…qui non possiamo continuare ad accoglierli…anzi dovremmo far star male quelli che ci sono in modo tale che quando telefonano a casa sconsiglino altri a partire…» .
Me lo diceva con sofferenza, vera, con rammarico ma anche con la convinzione che se non vogliamo far vincere Salvini dobbiamo porre un argine a questi flussi migratori. Se li lasciamo a bighellonare tutto il giorno, ospiti di buoni alberghi- sosteneva- questi giovanissimi africani che hanno tutti un telefonino manderanno a casa delle belle immagini e il flusso diventerà una valanga e saremo sommersi.
Come ha lucidamente ribadito ribadito Guido Viale su questo giornale con 180mila profughi o 200mila non si dovrebbe parlare di invasione in un paese con 60 milioni di abitanti.
Cosa avrebbe dovuto dire il popolo libanese quando sono arrivati un milione e mezzo di siriani in un paese di cinque milioni di abitanti? Inoltre, e spesso lo dimentichiamo, abbiamo un saldo demografico negativo di circa 50mila unità l’anno e un saldo migratorio nazionale negativo per oltre 100 mila unità (soprattutto dovuto a giovani italiani studenti e laureati che emigrano in vari paesi del mondo).
Inoltre, negli ultimi anni per via della crisi economica del nostro paese gli stranieri che ritornano nel loro paese sono superiori a quelli che arrivano, in particolare gli albanesi, i marocchini, rumeni, filippini, ecc.
Quindi non c’è nessuna esplosione demografica e non c’è nessun pericolo di invasione se gli immigrati sono ancora oggi l’8,5% della popolazione a fronte di percentuali ben maggiori in diversi paesi europei, dall’Austria all’Irlanda per non parlare della Svizzera.
Malgrado queste evidenze statistiche è entrato nella pelle italica questo virus dell’invasione che porta ogni giorno persone insospettabili a chiedere di respingere i barconi e magari affondarli. Uno degli ultimi casi riguarda un noto intellettuale siciliano, Antonio Presti, l’ideatore di «Fiumara d’arte» famosa a livello internazionale, organizzatore di eventi artistici di assoluto rilievo.
Ebbene proprio lui, in una conferenza stampa che annunciava a Taormina il progetto di riqualificazione del Villaggio Le Rocce di Mazzarò, ad un certo punto denuncia l’arrivo nel paese di una trentina di migranti dicendo testualmente : «Meno italiani più immigrati, è iniziata la sostituzione di popolo»». Ed aggiungendo che «« non è razzismo, ci opponiamo all’invasione di altre culture e alla perdita della nostra identità».
Ho voluto citare questi casi concreti di intellettuali, di persone che hanno operato bene in diversi campi, non di operai disoccupati che temono la concorrenza di chi è costretto a lavorare a salari da fame – come avviene nell’edilizia e in agricoltura – né di persone ideologicamente di destra.
Ho voluto citarli perché dovremmo prendere atto che viviamo in un paese che sta diventando profondamente razzista nella sua stragrande maggioranza. A differenza degli anni ’30 del secolo scorso, oggi nessuno si dichiara apertamente razzista, o parla di razze superiori, ma di diritto a difendersi da una invasione distruttiva, sia sul piano culturale che su quello economico (i soldi ai migranti anziché ai nostri poveri!!).
E sono tutti convinti che «non possiamo accoglierli tutti» e quindi dobbiamo fermarli con ogni mezzo. E, siccome siamo buoni, l’unica cosa che possiamo fare è di «aiutarli a casa loro»». Come? Semplice: con lo sviluppo economico. Se i popoli dell’Africa subsahariana si svilupperanno come abbiamo fatto noi si fermerà l’emigrazione.
Peccato che abbiamo dimenticato o non vogliamo fare i conti con la storia. Le prime grandi ondate migratorie dall’Europa verso altri continenti sono iniziate nei paesi in cui avveniva la rivoluzione industriale, a cominciare dall’Inghilterra, ovvero iniziava quello che chiamiamo sviluppo economico capitalista.
Anche in Italia, nell’ultimo quarto del XIX secolo, le prime ondate migratorie hanno interessato il Piemonte, la Liguria e la Lombardia, cioè le regioni dove è nata la prima rivoluzione industriale italiana. Prima che lo sviluppo economico porti ad un blocco dell’emigrazione possono passare decenni o secoli, come dimostra, tra l’altro il caso emblematico del nostro Mezzogiorno.
E noi italiani che non siamo riusciti in centocinquanta anni a risolvere la questione meridionale, che abbiamo milioni di giovani meridionali precari e/o disoccupati malgrado le politiche di sviluppo adottate nel corso di decenni, gli investimenti a valanga, i poli di sviluppo industriale, il sostegno alle start-up, vorremmo risolvere la «questione africana» esportando il nostro modello di sviluppo?!
E quale aiuto a casa loro vorremmo portare dopo che abbiamo tagliato le poche risorse che c’erano per la cooperazione popolare, quelle delle ong, che in qualche caso aveva dato buoni frutti quando non era caduta nella logica dell’economicismo o dello sviluppismo esasperato.
La cooperazione per garantire un minimo di welfare come scuole, sanità, case, questo sì che serve. Ma, se volessimo veramente «aiutarli a casa loro» ci sarebbe un mezzo immediato: un reddito minimo vitale per tutte le famiglie povere africane.
Si potrebbe cominciare dai paesi dove in questo momento partono il maggior numero di migranti come la Nigeria, Niger, Etiopia, Eritrea, ecc. Ipotizziamo che si riuscisse a dare a tutti i giovani tra i 16 ed i 32 anni un minimo vitale di 200 euro al mese, che mediamente in Africa consentono ad una famiglia di sopravvivere. E ipotizziamo sempre che un primo bacino di utenza sia di circa 100 milioni di giovani.
Il costo mensile sarebbe di 20 miliardi di euro al mese, un terzo di quello che Draghi ha elargito mensilmente al sistema creditizio europeo oberato da titoli spazzatura e crediti inesigibili. Immaginiamo che a Bruxelles passi una decisione del genere, quale sarebbe la reazione? Scandalo! Aiutiamo i giovani africani mentre i nostri sono precari, disoccupati e impoveriti? Morale della favola: quando diciamo «aiutiamoli a casa loro» vogliamo dire ben altro.
Basa un breve excursus storico per rendercene conto. Sono secoli che come europei ««aiutiamo a casa loro»» i popoli africani , latino-americani ed asiatici. Soprattutto gli africani sono stati oggetto delle nostre attenzioni, premure, affetto. Prima di tutto portandogli la civiltà e facendoli uscire da una condizione di uomini semiselvaggi, animisti e antropofagi, trasportandoli a nostre spese nel mondo civile (quello che i comunisti un tempo chiamavano «tratta degli schiavi»).
Poi con l’installazione delle nostre tecniche agricole, delle monoculture più moderne che hanno prodotto un notevole flusso di esportazioni, nonché la valorizzazione delle loro miniere che erano state ignorate per secoli come fonte di ricchezza. Ed ancora gli abbiamo insegnato l’uso delle moderne tecniche militari, li abbiamo fatti passare dall’arco e le lance ai carri armati e agli aerei, li abbiamo aiutati a combattersi nel modo più moderno ed avanzato possibile offrendogli consiglieri militari e le armi più sofisticate.
Infine gli abbiamo insegnato l’uso del denaro e come sia facile prenderlo in prestito e poi doverlo restituire con buoni tassi di interesse, ovvero quella che è la nostra libertà più grande e bella: la libertà di indebitarsi fino al collo.
E dopo aver operato per secoli a casa loro, per il loro benessere, adesso questa generazione ingrata vuole venire a casa nostra con tutti i problemi che già abbiamo… Non è possibile…riportiamoli a casa loro , anzi deportiamoli.

Italia e Francia in rissa concorrenziale per vincere il primato di chi è più dtupido nel comprendere che cos'è l'Esodo del XXI secolo. il manifesto, 29 luglio 2017 (p.d.)
Quello che succede tra Francia e Italia è un groviglio grottesco di velleità geopolitiche, interventismo militare da due soldi, rivalità industriali e diplomatiche. Ma tutto questo contro le azioni umanitarie delle Ong e sulla pelle di migliaia di esseri umani, i migranti che si imbarcano in Libia alla volta dell’Europa. Ma andiamo con ordine.
La nazionalizzazione dei cantieri di Saint Nazaire, da cui escono navi da crociera e militari, è solo un aspetto della politica francese di piccola grandeur nel Mediterraneo e in Africa. La Francia, che nel 2011 aveva lanciato la demenziale guerra in Libia, che ha portato al caos attuale, non poteva tollerare che Fincantieri mettesse le mani su un settore strategico così importante. Alla stessa logica appartiene l’incontro di “pacificazione” promosso da Macron tra Serraj e Haftar, un colloquio che, come ha notato Angelo Del Boca intervistato da Tommaso Di Francesco sul manifesto di giovedì, non cambia nulla dal punto di vista del conflitto di potere in Libia, ma è un affronto evidente all’Italia e alla sua pretesa di rappresentare gli interessi d’Europa nel tratto di mare delicatissimo tra Sicilia e Africa.
Ma sottolineare una volta di più il nazionalismo francese non significa assolvere quello italiano, con la semplice differenza che l’apparato militare gestito dal ministro Pinotti non è paragonabile a quello francese, che già opera in Niger, Ciad e altre zone dell’Africa sub-sahariana. La proposta, da parte di Gentiloni, di inviare le nostre navi nelle acque della Libia contro i «trafficanti», ha il significato di una risposta alla Francia, sia per la questione Fincantieri, sia per il ruolo che Macron vorrebbe in Libia. Come dire: «Macron, stai attento, ci siamo anche noi!». La mossa italiana si situa nel solco delle iniziative di Minniti per far gestire ai libici il controllo dei migranti. E come quelle, creerà solo nuova confusione e sofferenze. Insomma, ruggiti di un topo.
La verità è che la Libia è in mano ai signori della guerra, che Serraj conta sempre meno e che Haftar, il suo rivale in Cirenaica, sostenuto dai francesi (nonché da egiziani e russi) è sempre più potente. Di conseguenza, giorno dopo giorno, si scopre che l’Italia ha puntato sui cavalli perdenti, soprattutto per quanto riguarda il controllo delle risorse petrolifere. La debolezza strategica si somma in questo caso all’incapacità politica (tra l’altro, che fine ha fatto in tutto questo il ministro Alfano?).
La smentita-conferma di Serraj - che, tornato a Tripoli ha prima negato di aver richiesto l’intervento italiano per poi confermare ma precisando che avrà solo una funzione di «supporto» - getta una coltre di ridicolo sull’intera vicenda. È possibile che Serraj si sia accorto che Macron è un po’ più potente di Gentiloni e ora ci abbia ripensato. O magari che tema di sbilanciarsi troppo dalla parte dell’Italia. E comunque di rivelarsi alle fazioni libiche come troppo subalterno all’occidente. Ma, in ogni caso, la faccenda delle navi italiane è un segnale gravissimo per le Ong, a cui si vuole già imporre un insensato codice di comportamento. Se la storia della guerra ai «trafficanti» si tramutasse in un blocco di gommoni e carrette del mare, i costi umani sarebbero enormi. Non solo perché le navi delle Ong sarebbero spinte a diradare o annullare gli interventi, ma perché i migranti sopravvissuti a possibili naufragi sarebbero ricacciati nell’inferno libico.
Ecco un altro risultato dell’ottusità europea e del ruolo delle destre nel condizionare le politiche migratorie. I migranti continueranno ad arrivare in Libia. Ma troveranno un mare pullulante di navi militari pronte a respingerli. Un lavoro sporco che l’Italia, potenza di terz’ordine, vuole svolgere per un’Europa, Francia compresa, incapace di affrontare la questione delle migrazioni. In questi giochi di guerra e di petrolio tutti hanno qualcosa da guadagnare, tranne l’umanità.
 Un resoconto sul rastrellamento degli immigrati "illegali'"nell’era Trump. Storie di ordinaria persecuzione quotidiana: ma la California non è d'accordo,
Un resoconto sul rastrellamento degli immigrati "illegali'"nell’era Trump. Storie di ordinaria persecuzione quotidiana: ma la California non è d'accordo,
The New York Times, 21 luglio 2017 (m.c.g.)
“Criminals off the street, that’s our goal”: è stata questa la parola d’ordine, persecutoria e razzista nei confronti della popolazione immigrata, che ha risuonato martellante della campagna elettorale di Trump. Al di là della minacciata costruzione del muro alla frontiera con il Messico, l’amministrazione Trump si è messa immediatamente all’opera: in tutto il paese gli uffici locali dell’Immigration and Customs Enforcement (ICE) dall’alba alla notte stanno rastrellando le strade e le abitazioni dove risiedono gli immigrati: con ‘successo’, se si considera che, rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso, i rimpatri forzati sono aumentati del 40%. Ma in California siamo molto al di sotto della media.
L’articolo è firmato da due giornaliste del NYT che hanno accompagnato gli agenti dell’ICE durante un rastrellamento notturno nella California del Sud. Si raccontano (e vengono accompagnate da un filmato) le storie disperate di migranti accolti in uno Stato, la California, che ne ospita (con grandi vantaggi economici, poiché si tratta di manodopera a basso costo che si adatta ai lavori più faticosi e meno remunerati) più di 2 milioni e che continua a dichiararsi fermamente contrario alle deportazioni di massa volute da Trump. Molti sceriffi californiani infatti, malgrado le segnalazioni dell’ICI, non confermano l’espulsione.
Più in generale, sono le amministrazioni delle grandi città americane che continuano a opporsi, malgrado le incessanti minacce di ritorsione presidenziale nei confronti delle “sanctuary cities”, al pensiero unico trumpiano secondo il quale tutti i migranti sono delinquenti.
Ma vi sono alcuni punti di debolezza nelle politiche di accoglienza messe in atto prima dell’arrivo di Trump nelle maggiori città santuario. Virtuosamente destinate a favorire l’emersione, queste politiche potrebbero invece risultare molto utili ai ‘persecutori’: all’ICE appunto. Infatti, le procedure di identificazione e registrazione dei migranti, avviate negli anni passati per far emergere i residenti illegali e riconoscere loro un diritto di cittadinanza e l’accesso ai servizi, costituiscono una banca dati preziosa per chi vuole individuare e ‘deportare’ i cittadini indesiderabili.
A San Francisco si è già corso ai ripari, distruggendo tutti i file del Municipal Identification Program, istituito nel 2009 per dare riconoscibilità e aiuto ai migranti illegali. Ma per le altre grandi città che non l’hanno ancora fatto (ad esempio New York) potrebbe aprirsi un ulteriore contenzioso legale, ancora più pericoloso per gli immigrati, fra Washington e i governi locali.
(scelto e presentato da Maria Cristina Gibelli)
The New York Times
A BROADER SWEEP
byJennifer Medina and Miriam Jordan
RIVERSIDE, Calif. — Just after dawn, a line of officers marched to the gate outside Fidel Delgado’s home here with guns drawn, one holding a rifle. Mr. Delgado emerged barechested from his home and with a look of confusion.
“Qué necesita” he asked: What do you need? About 20 minutes later and 10 miles away, Anselmo Morán Lucero sensed exactly why officers had come. He spotted them as he was returning from a night out, and turned his truck around. But an unmarked S.U.V. pulled in front of him and another flashed its lights behind him, blocking his escape.
They asked his name. They asked if he knew why he was being arrested. Mr. Lucero nodded. Every day around the United States, from before sunrise until late into the night, people like Mr. Delgado and Mr. Lucero are being picked up by Immigration and Customs Enforcement officers, the front-line soldiers in President Trump’s crackdown on illegal immigration.
More than 65,000 people have been arrested by the agency since Mr. Trump took office, a nearly 40 percent increase over the same period last year and as sure a sign as any that the United States is a tougher place today to be an undocumented immigrant.
But I.C.E. is in some ways operating in enemy territory in California, home to more than two million undocumented immigrants and hostile to the idea of mass deportations. Because local law enforcement often will not turn over undocumented immigrants in their custody, I.C.E. must make most of their arrests at homes, at workplaces and out on the street, which is more complicated than simply picking people up from jails — and potentially more dangerous.
So when a team of immigration agents gathered at 4:30 on one already warm morning in June, their chief, David Marin, warned them to stay away from any sign of danger.
After going over notes on each of the men they were after, the team pulled out in their unmarked S.U.V.s. Eight hours later, five men would be in custody, awaiting the start of deportation proceedings.
The New York Times followed the team for a day as it navigated the streets and politics of Southern California, and spoke with some of the men it arrested and the families they may soon be leaving behind.
An Unplanned Arrest
As the sun crept above the horizon, the officers gathered on a hill just a few yards away from Mr. Delgado’s home. But it was not Mr. Delgado they had come for; it was his son Mariano.
Mariano Delgado, 24, had returned to Mexico in 2011 after he was convicted of drunken driving. Since illegally re-entering the United States, he has been arrested four times for assault with a deadly weapon.
Immigrants like him are called “criminal aliens,” and there are so many of them in Southern California that Mr. Marin says it is effectively impossible to go after anyone else. But under President Trump, agents are encouraged to also arrest undocumented immigrants without serious criminal records, a break from the Obama administration’s policy of mostly leaving those immigrants alone. So here and across the country, agents now make more “collateral” arrests — undocumented people they come across while looking for someone else. That was about to happen.
When officers, guns out, approached the chain-link fence surrounding the home, the dogs began barking loudly, joining the squawking chickens. Fidel Delgado emerged.The elder Mr. Delgado, 46, and his wife, María Rocha, told the officers that their son had moved to Texas months ago. They readily admitted to being in the country illegally, but added that they worked. Their youngest son, 16, is an American-born citizen. When the agents shook him out of bed, he began to sob.
After taking Mr. Delgado’s fingerprints, they ran them through a database. Within minutes, they learned that he had once crossed the border illegally, twice in the same day, and had been sent back to Mexico.
A couple of officers debated what to do: Should they take both parents and call Child Protective Services for the boy? Did they believe that Mariano Delgado was no longer living there, even though they thought he was home as recently as the week before? “If he doesn’t give up the son, we’re going to take him,” one officer said.
They left the wife behind and led Mr. Delgado to a van, where he was soon shackled. The handcuffs would leave marks.
Later that morning, Ms. Rocha, 50, leaned against the chain-link fence that surrounds their home, bleary-eyed and in shock. “My husband, they had no reason to take him,” she said. “They weren’t searching for him.”
The family has lived in the three-bedroom white house in a blue-collar, semirural enclave of Riverside for three years, paying $1,300 a month in rent. Ms. Rocha, who cleans offices in nearby Corona, a more upscale community, said she brought home about $1,200 a month. Her husband, who milks cows at a dairy, earns about $12 an hour.
The couple married in Mexico 24 years ago, just before heading north. “We came here for a better life,” she said. In all her years in the United States, she said, she had never had problems with “la migra,” as the immigration agency is known. By the afternoon, Mr. Delgado had been released by the immigration agents, who decided that he was not a threat to public safety. He was given a notice that he must comply with any orders from immigration agents and returned to work the next day.
Agency Under a Microscope
Before heading out to their targets for the day, the I.C.E. team gathered in the darkness in the parking lot of a small hardware store. Mr. Marin, the enforcement supervisor, quizzed his officers:
What time will this man start to leave his home? Which way will that one turn when he pulls out of his driveway? When will the other one arrive back from his night shift? The officers had been watching the men they were after for days, learning their habits so they could capture them easily.
Mr. Marin, 48, has worked in immigration enforcement for more than two decades, starting when the agency was called Immigration and Naturalization Services. In the 1990s, he said, officers would spend much of their time rounding up immigrants in front of home repair stores, routinely arresting people so many times that they would know them by sight. Within hours of a bus ride returning them to Mexico, Mr. Marin said, they would be on their way to the United States again.
Like roughly half of the other officers, Mr. Marin began his career in the military, serving as a Marine. He amassed tattoos the way others collect shot glasses: On his left forearm is the first letter of the word “Christian” written in Arabic, commemorating his work collecting intelligence on the Taliban in Pakistan.
Though he had to pass a basic Spanish course early in his career, today Mr. Marin hardly speaks a word of it. But many officers do. Nearly 40 percent of Mr. Marin’s officers are Latino, he said, and many of them hear refrains of “How can you do this to your own people?” They do not apologize.But the agency is under a microscope here. Arrests in the Los Angeles region are up only 17 percent since Mr. Trump took office, far less than in the rest of the country, according to I.C.E. statistics.
Members of Congress and local officials routinely call Mr. Marin’s cellphone when they hear of arrests in their area.
“People want to know if we’ve gone into schools, if we’re standing in the market, but that’s not what we do,” Mr. Marin said, driving before dawn. “We know an arrest is a traumatic event for a family. We know the impact it has, and we take it very seriously.”
Luck Runs Out
While Mr. Delgado was being questioned, other members of the team were waiting for Mr. Lucero, who had already been deported once. Mr. Lucero, 51, and his wife, Jamie, 47, arrived from a small village in the Mexican state of Puebla more than three decades ago. He had built a thriving landscaping business, tending to yards of homes in upscale Orange County.
In 2006, Mr. Lucero was convicted in a domestic violence case and spent several months in jail, then was deported. But he had reconciled with his wife and was eager to return to her and their six children, two of them born in the United States. So he crossed the border illegally again.
Immigration officials had tried to get the Orange County sheriff’s office to hold Mr. Lucero for them when he was in jail for a day on a new domestic violence charge in 2014. But the sheriff declined, according to I.C.E. Many California sheriff and police departments do not cooperate with immigration officials, saying it erodes trust in law enforcement among immigrant populations. Mr. Trump has threated to punish these so-called sanctuary cities and counties, saying they harbor lawbreakers. For several nights before the I.C.E. team showed up, Mr. Lucero said, he had dreams of immigration agents coming to get him. The night before, he and his wife tried their luck at a nearby casino, playing the slot machines until daybreak. They had won a couple of hundred dollars and left just before 6 a.m.
When they began driving home, Ms. Lucero’s brother, with whom the family lives, warned them that immigration officers were near. But Mr. Lucero was unable to evade them.Hours after his arrest, Jamie Lucero, her eyes red with tears, pulled out a blue folder with Mr. Lucero’s papers neatly organized, including documents showing he had completed an anger-management program and followed the rules of probation from his domestic violence case. She was planning to take the folder with her when she visited him in detention, though the papers are unlikely to have a bearing on his new deportation case.
Their 29-year-old son, Urie, said that the week before, four officers had come to the door holding a picture of a bald man they said they were after. They never mentioned the man’s name, and Urie Lucero said he did not recognize the man. But the officers came inside the home and looked around. The family is convinced that the visit and the picture of the bald man were ruses to try to scope out Anselmo Lucero’s whereabouts. “That’s how they are getting people,” Urie Lucero said.
Jamie Lucero said the officers had told her not to bother paying for a lawyer because he faced certain deportation.
By lunchtime, the agents had five immigrants in custody: three of their six targets of the day, as well as Mr. Delgado and another man they found in the home of a target. Typically, officers successfully arrest about half the people they are looking for, Mr. Marin said, so this was a good day. “Criminals off the street, that’s our goal,” he said while standing inside the San Bernardino processing center, where immigrants from the region are taken each day.
The men they had arrested sat inside a small holding cell clutching their brown-bag lunch of a turkey sandwich and apple. Mr. Marin and one of his deputies headed for lunch at a small Mexican taqueria.
A broader sweep. A day in the field with immigration enforcers in California, a state hostile to President Trump’s efforts to step up deportation - The New York Times
https://www.nytimes.com/.../immigration-enforcement-california...
 L'interesse dell'Europa a utilizzare le persone che fuggono dai loro deserti è simmetrico rispetto all'interesse dei migranti di trovare un'occupazione. Ma per trovare la sintesi occorre un'Europa profondamente diversa dall'UE.
L'interesse dell'Europa a utilizzare le persone che fuggono dai loro deserti è simmetrico rispetto all'interesse dei migranti di trovare un'occupazione. Ma per trovare la sintesi occorre un'Europa profondamente diversa dall'UE. il manifesto
, 26 luglio 2017
Il terrore e il furore con cui l’Unione Europea e il governo italiano affrontano l’arrivo dei profughi nascono dall’oblio del passato e dall’incapacità di guardare al futuro. I profughi che hanno raggiunto l’Europa nel 2015 (l’anno di maggior afflusso) sono meno dei migranti economici arrivati o legalizzati ogni anno prima del 2008. Con quei migranti l’Europa aveva realizzato la sua ricostruzione postbellica, il miracolo economico e conquistato la posizione di rilievo mondiale che oggi sta perdendo. Ma quel milione e mezzo è solo la metà degli abitanti che un’Europa sempre più vecchia perde ogni anno.
Così tra non molto i governi europei dovranno richiamare nei loro paesi i fratelli e i figli di quegli esseri umani che oggi cercano di far annegare nel Mediterraneo, far morire di sete nel Sahara, far schiavizzare dalle bande che controllano la Libia, far azzannare dai cani e bastonare dalle guardie alle barriere di filo spinato dei Balcani. Perché in un’Europa sempre più vecchia non sarà solo impossibile pagarsi le pensioni; un paese con pochi giovani, pochi bambini, senza gioia, senza creatività, senza iniziativa, senza capacità di confrontarsi con l’altro da sé è condannato a chiudersi e morire.
Chiusura di cui l’Italia è stata destinata a far le spese per prima: mentre il suo governo cerca di spostare i confini dell’Europa al di sotto della Libia, per non farvi entrare chi scappa da dittature, guerre o disastri ambientali, gli altri governi dell’Unione europea hanno invece spostato da tempo quei confini alle Alpi: di lì non si passa; i profughi, se proprio si devono salvare, se li tenga l’Italia.
Stanno facendo del nostro paese quello che il Governo italiano vorrebbe fare della Libia: un deposito di esseri umani a perdere, con tutto il caos che ne consegue. I rimpatri sono costosi e per lo più impraticabili; i respingimenti non ottengono altro effetto che alzare il numero dei morti. Ma se i profughi si sa solo trattenerli per un anno o sei mesi in degradanti contenitori per poi mettere per strada sia coloro a cui viene denegato che coloro a cui viene riconosciuto l’asilo, consegnandoli al lavoro nero, alla criminalità, alla prostituzione, a una clandestinità imposta per legge, allora sì, questo renderà invivibile il paese. I 180 mila profughi del 2016 non sono un gran numero per un paese di 60 milioni di abitanti. Ma con i 200 mila di quest’anno raddoppiano e l’anno prossimo saranno 600 mila o forse più, e così via; non c’è alternativa di destra – respingimenti e rimpatri – che valga: quelle alternative sono state già tutte tentate senza risultati.
Nessun dubbio che un’Unione europea come questa, dove ciascuno va per conto suo, sia destinata a crollare: messe ai margini Italia e Grecia, perso il Regno unito, sarà comunque difficile tener dentro paesi come Ungheria, Polonia e compagnia. D’altronde, un’Europa assediata dalle guerre, dall’Ucraina al Sahrawi, passando per Siria, Iraq, Afghanistan, Israele, Yemen, Sud Sudan, Libia, Ciad, Mali, Nigeria, Repubblica Centroafricana, e altro ancora, si sta trasformando in una fortezza: in cui forse non si entra più (ma c’è già abbondanza di materiale umano esplosivo al suo interno); ma da cui non si potrà neanche più uscire. O solo con le armi: a combattere contro quelle che stiamo vendendo a piene mani in quegli stessi paesi.
Nel mondo d’oggi non si può più stare da soli e per questo l’Europa va ricostituita; ma dalle fondamenta; le sue classi dirigenti non sono in grado di farlo, e nemmeno di concepirlo: hanno smesso da tempo di pensare, non vedono né passato né futuro, vivono in un eterno presente; tutt’altro che innocente. La questione dei profughi andava affrontata dall’inizio, ben prima del semestre di presidenza italiana, come una questione di tutta l’Unione, da mettere davanti a tutto il resto, come aveva cercato di prospettare, tra i tanti, Barbara Spinelli subito dopo la sua elezione al Parlamento europeo. Invece si sono persi tre anni. «Davanti a tutto il resto» non vuol dir solo corridoi umanitari ragionevolmente selettivi invece del massacro in corso, che procura guadagni e poteri immensi a scafisti, aguzzini del deserto e affiliati all’Isis.
Vuol dire rovesciare il tavolo dell’austerità. L’Europa ha bisogno di quei migranti; per integrarli deve innanzitutto offrire a loro e, insieme, ai 25 milioni di disoccupati creati con la crisi, un lavoro. Per mettere tutte quelle persone al lavoro ci vuole un grande piano di investimenti diffusi.
Quel piano è la conversione ecologica, come prescritto dagli impegni presi al vertice di Parigi. Ma è un piano che non può riguardare solo l’Europa: deve coinvolgere anche i paesi di origine dei nuovi arrivati: non si tratta di «aiutarli a casa loro», bensì di aiutarli qui in Europa (che non è casa nostra) ad aver voce e a rendersi parte attiva della pacificazione dei loro paesi in guerra; e, quando potranno tornarvi (e molti non aspettano altro), della loro ricostruzione, del loro risanamento ambientale e sociale, della loro conversione ecologica, con progetti e interventi analoghi a quelli da sviluppare qui.
E’ inutile vaneggiare di piani Marshall per l’Africa senza dir a chi sono diretti: protagonisti della rinascita di quei paesi non possono essere né le multinazionali che la stanno devastando, né i suoi governi corrotti e sanguinari che costringono a fuggire la parte migliore dei loro concittadini, ma solo una nuova grande leva di migranti e di cooperanti europei impegnati a costruire insieme non solo una nuova Europa qui, ma anche una grande comunità euro-afro-mediterranea là; aperta alla libera circolazione non dei capitali, ma delle persone e delle loro aspirazioni.

“
“Non c’è niente di più misterioso o di più bello di un muro. Già me lo vedo; laggiù nel prato, che si erge come un’immane barriera contro il tempo”, La musica del caso, 1990, Paul Auster.
1. Nel recente incontro tra Papa Francesco e Angela Merkel è emersa “sintonia sulla necessità di abbattere i muri”. Non è stato detto a quali, dei tanti muri già eretti o in corso di costruzione, l’auspicio si riferisca, ma è poco probabile si tratti di quello tra la Turchia e la Siria, ormai quasi completato. La gigantesca opera, che si estende lungo cinquecento cinquanta sei dei novecento undici chilometri della linea di confine, consiste in una serie di blocchi di calcestruzzo alti tre metri, larghi due e del peso di quattordici tonnellate ciascuno, sovrastati da sessanta centimetri di filo spinato e con sessanta sette torri di avvistamento.
I lavori sono iniziati nel 2014, in seguito alle pressanti richieste degli Stati Uniti e dell’Europa di chiudere la “frontiera porosa” e impedire il passaggio di estremisti e terroristi. L’allora presidente Obama aveva più volte ammonito la Turchia a fare di più per “sigillare” il confine ed ora, a sancire la complicità con l’occidente, il governo turco orgoglioso per lo stato di avanzamento del muro può dichiarare “siamo nella stessa barca con i nostri alleati, stiamo facendo del nostro meglio”. E del loro meglio si accingono a fare anche lungo i confini con l’Iran e con l’Iraq dove è stata avviata la costruzione di altri due muri, rispettivamente di settanta e novantadue chilometri.
2. I muri, che provocano sofferenza e morte per migliaia di esseri umani, sono anche grandi infrastrutture e, come tutte le grandi opere, procurano enormi profitti alle imprese che le costruiscono. I progetti dei muri turchi, coordinati dai ministeri della difesa e delle finanze, sono stati affidati a TOKI, la società di proprietà dello stato, fondata trent’anni fa per costruire case popolari e che si è espansa fino a controllare l’intero settore dell’edilizia e dell’urbanistica. Presieduta da Ergun Turan, fedelissimo di Erdogan, e posta sotto il personale controllo del primo ministro, è diventata uno dei cardini su cui si regge il regime. Ufficialmente è un ente senza scopo di lucro ma, avendo la facoltà di espropriare terreni e proprietà pubbliche e private e di cambiarne le destinazioni, ad esempio trasformando un parco in centro commerciale (come è successo a Gezi park) o distruggendo le città abitate dai curdi per rinnovarle e renderle “attraenti al turismo internazionale” (come ha fatto a Diyarbakir) il suo potere è enorme. Secondo gli oppositori, l’intoccabilità di Toki, che non è stata scalfita nemmeno dai pur numerosi scandali e accuse di corruzione, deriva dal fatto che gira i suoi profitti al governo e ai suoi amici.

3. Un muro non è una linea sulla carta, un segno topografico come dicono gli architetti, ma un manufatto tridimensionale che riconfigurando i rapporti tra chi sta da una parte e dall’altra e le loro condizioni di vita, cambia la geografia e la storia del territorio al quale viene imposto. L’intenzione della Turchia di occupare la parte settentrionale della Siria è nota da tempo e, secondo molti osservatori, di fatto il muro ha già spostato il confine. Meno attenzione, invece, è stata data ai progetti di sviluppo immobiliare di Erdogan, la cui visione per la regione, una volta “ripulita dai terroristi jihadisti e curdi”, è di costruirvi una città nuova. “Possiamo farlo in meno di un anno”, ha detto, “siamo esperti in costruzioni e infrastrutture, quello di cui abbiamo bisogno è solo un flusso costante di investimenti”. … Con un linguaggio che abilmente maschera con la retorica dell’intervento umanitario il furto della terra e i relativi grandi affari, ha concluso “oltre a case adatte alla locale tradizione architettonica, costruiremo scuole ed ospedali e così elimineremo il trauma psicologico della popolazione….. bisogna avviare una campagna internazionale per la raccolta dei fondi e poi noi siamo
A Gerusalemme, nel luogo sacro a più religioni, ciò che si oppone alla pace e fomenta lo scontro non è il contrasto tra le fedi, ma la lotta di Israele per imporre il proprio potere oltre ogni limite. Articoli di Michele Giorgio, Zvi Schuldiner e intervista a Uraib al Rintawi. il manifesto, 22 luglio 2017
TRE PALESTINESI UCCISI
DAL FUOCO DEI COLONI
E DAI PROIETTILI DELLA POLIZIA
di Michele Giorgio
«Gerusalemme. Scontri intorno alla Spianata delle moschee e in Cisgiordania. Oltre ai tre morti la Mezzaluna rossa parla di 390 feriti. E ora si parla di una nuova Intifada in risposta alle politiche di Netanyahu»
Quattro giovani palestinesi uccisi, 390 feriti o contusi. Per Gerusalemme Est è stata una delle giornate più insanguinate degli ultimi anni. Cariche della polizia israeliana contro manifestanti palestinesi, con fuoco ad altezza d’uomo, come quelle di ieri non si vedevano dal 2014, quando le tensioni e la rabbia innescate dall’omicidio del 15enne Mohammed Abu Khdeir, compiuto da estremisti israeliani per vendicare il sequestro e l’assassinio di tre adolescenti ebrei, per giorni trasformarono la zona araba di Gerusalemme Est in un campo di battaglia. Quanto si è visto ieri è stata la ovvia conseguenza della decisione del premier israeliano di non rimuovere – malgrado, secondo i media, il parere favorevole dei servizi di sicurezza – i metal detector installati ad alcuni degli ingressi della Spianata delle moschee di al Aqsa e della Roccia dopo l’attacco armato palestinese della scorsa settimana (due poliziotti uccisi).
Giorni di trattative frenetiche e di pressioni arabe su Washington per spingere Israele a revocare le nuove misure, gli scontri notturni tra palestinesi e polizia nei quartieri di Silwan e Issawiyeh, non hanno scosso in alcun modo Benyamin Netanyahu che ha confermato, «per ora», l’impiego dei metal detector e di altri sistemi di controllo di chi varca gli ingressi della Spianata. È stata una decisione politica anche se il premier spiega di aver fatto la sua scelta sulla base delle motivazioni offerte dalle forze dell’ordine. Una prova di forza in realtà, per dire ad arabi e palestinesi che Israele non cede alle pressioni e conferma le sue rivendicazioni sulla Spianata, che per gli ebrei è il Monte del Tempio. Il portavoce della polizia, Micky Rosenfeld, ha parlato chiaro: «I metal detector rimarranno dove sono per settimane, per mesi se necessario». Per i palestinesi si tratta di una palese violazione di uno status quo che non assegna in alcun modo a Israele l’esclusiva della sicurezza e del controllo del sito religioso.
L’esercito israeliano ieri aveva predisposto dozzine di posti di blocco ovunque in Cisgiordania per fermare i palestinesi diretti a Gerusalemme, in risposta all’appello lanciato dalle autorità islamiche e dai partiti politici in difesa di al Aqsa. I militari hanno bloccato prima degli ingressi in città decine di autobus e automobili. La polizia da parte sua ha negato l’accesso all’area delle moschee ai palestinesi maschi con meno di 50 anni. Nonostante ciò migliaia di palestinesi residenti a Gerusalemme si sono diretti in massa verso la Spianata, con l’intenzione però di pregare in strada, in modo da non legittimare i metal detector installati da Israele. Ad attenderli c’erano circa 3mila poliziotti schierati prima dell’alba in tutta la zona. Già prima della preghiera erano scoppiati scontri davanti alla Porta di Damasco e alla Porta dei Leoni, la più vicina alla Spianata. Piano piano si sono diffusi in vari quartieri della zona araba di Gerusalemme, infine hanno raggiunto Betlemme, Hebron, Qalandiya e altri centri abitati della Cisgiordania. La polizia a Gerusalemme ha prima lanciato granate assordati e lacrimogeni, poi ha aperto il fuoco. Filmati che girano in rete mostrano la violenza delle cariche dei poliziotti in assetto antisommossa e appoggiati da automezzi pesanti. Si sono riviste scene dell’Intifada e degli scontri del 2014 in una città che si vorrebbe “pacificata” sotto il controllo totale di Israele. Non a caso il ministero degli esteri israeliano ieri diffondeva tweet per invitare i turisti a visitare la città vecchia perché era tutto «sotto controllo».
La prima vittima, Mohammad Sharaf, però non è stata colpita dalla polizia nei pressi della Spianata ma nel quartiere di Ras al-Amud, di fronte alla città vecchia, da spadi un “civile” israeliano – probabilmente un abitante della colonia ebraica costruita in quella zona qualche anno fa dal miliardario australiano Mosckoviz – in circostanze che ieri sera non erano state ancora chiarite. Un altro giovane palestinese, Muhammad Abu Ghanam, ferito al Monte degli Ulivi durante gli scontri con la polizia, si è spento all’ospedale Makassed. Entrambi sono stati seppelliti subito dalle famiglie timorose che la polizia potesse confiscare i loro corpi. Gli agenti in ogni caso non hanno mancato di lanciarsi in blitz negli ospedali per arrestare i feriti, 390 secondo fonti della Mezzaluna rossa: la maggior parte intossicati dai gas lacrimogeni, 38 a Gerusalemme e 66 in Cisgiordania da pallottole vere e proiettili di gomma. Tra i feriti ci sono anche cinque gli agenti di polizia israeliani. Il terzo palestinese ucciso, Muhammad Khalaf, è stato colpito durante una manifestazione ad Abu Dis, un sobborgo di Gerusalemme che si trova dietro il Muro costruito da Israele intorno alla città. Khalaf era un attivista del Fronte democratico per la liberazione della Palestina.
Una notte gonfia di dolore e rabbia è scesa ieri sera su Gerusalemme Est. L’inizio di una nuova Intifada non è più lontano.
GUIDA AI CONFUSI
SU ULTRADESTRA E ISLAMOFOBIA
di Zvi Schuldiner
«Il gioco di Tel Aviv: la questione è non il metal detector sulla Spianata o la telecamera di sorveglianza. Il governo Netanyahu sfrutta l’apatia generale e l’islamofobia europea per proseguire con l’occupazione»
Che cosa sta davvero accadendo nella discussa e sacra Spianata delle Moschee – per i musulmani – o Monte del Tempio – per gli israeliani?
Mentre scrivo queste righe, in questo venerdì problematico e pieno di tensione, sono già tre i palestinesi morti, oltre a due feriti gravi e vari altri feriti leggeri. È il bilancio degli scontri registrati durante le preghiere del venerdì, stavolta recitate all’esterno della Spianata delle Moschee.
All’inizio della guerra del 1967, le truppe israeliane conquistano la città vecchia di Gerusalemme. Un soldato patriota ed entusiasta sale sul tetto della sacra Moschea di Al Aqsa e issa la bandiera israeliana. Il ministro della difesa Moshe Dayan ordina di toglierla immediatamente; capisce bene che si tratta di un affronto a uno dei luoghi più sacri per i musulmani.
Dayan, insomma, avviava un’occupazione dai risvolti drammatici, da un lato con pugno di ferro ma dall’altro con passi pragmatici e concilianti. I vari governi israeliani succedutisi nel tempo hanno sempre mostrato di rendersi conto che la Spianata delle Moschee era un luogo potenzialmente esplosivo; innescarlo poteva avere conseguenze terribili.
Dunque, badarono a frenare i fondamentalisti ebrei che sognavano il ripristino del tempio, elemento centrale delle concezioni messianiche – il tempio la posto delle moschee. Ma nel 1996, poco dopo essere diventato primo ministro, Benjamin Netaniahu, ebbro del successo elettorale, ordina di aprire un tunnel che porta alla Spianata.
Esplodono gli scontri: cento palestinesi e 17 soldati israeliani rimangono uccisi. Il premier è costretto a fare alcune concessioni ad Arafat rispetto a Hebron. Nel 2000, il premier Ehud Barak autorizza la visita di Ariel Sharon alla Spianata e la provocazione innesca la seconda Intifada. Nel frattempo altri incidenti provocano non poche vittime.
La settimana scorsa, tre israeliani, arabi palestinesi della città di Um El Fahem, imbevuti di ideologia fondamentalista (oppure no) portano nottetempo armi nella moschea e il giorno seguente attaccano i poliziotti in servizio, uccidendone due; gli aggressori sono a loro volta uccisi.
Come se non bastasse, i tre poliziotti morti sono drusi; un fatto che aggiunge benzina al fuoco delle tensioni fra arabi israeliani e drusi israeliani.
L’impulsivo ministro della polizia Gilard Ardan, schierato all’estrema destra, è il nuovo eroe. Più veloce di qualunque pensiero – va detto che l’attuale governo israeliano si distingue per l’incapacità di riflettere – induce Netanyahu a compiere passi che aggravano la tensione in un luogo pericoloso come la dinamite.
Senza consultare i giordani – con i quali, seppure in modo semiufficiale, vengono in genere prese le decisioni rispetto alla Spianata –, il governo israeliano dichiara il divieto di accesso alle moschee per due giorni, «per ragioni di sicurezza» e fa disporre telecamere di sorveglianza e metal detector, destinati a controllare e a bloccare l’ingresso di altre armi.
I leader religiosi musulmani non accettano queste apparecchiature, sostenendo che si tratta di una violazione dello status quo deciso fra le parti – israeliani, palestinesi, giordani. La polizia – grazie al suo problematico ministro – sostiene che si tratta di un passo minimo necessario per questioni di sicurezza e che ci sono telecamere sul Muro del Pianto, a cento metri di distanza, come negli aeroporti, nei supermercati e via dicendo.
Ma l’esercito israeliano e i servizi segreti fanno notare che, benché in effetti le apparecchiature di sicurezza siano in uso in molti luoghi, nel caso specifico sarebbe raccomandabile rimuoverle perché provocano tensioni e potrebbero far deflagrare nuovamente la situazione. Insomma, suggeriscono una visione strategica e chiedono al primo ministro di trovare la formula per una «ritirata onorevole».
Sabato notte il premier va in Francia, baci e abbracci con il giovane presidente; poi si reca da amici veri, in Ungheria. Netanyahu si sente a proprio agio con gli ultrà di Ungheria, Polonia, Repubblica Ceca e Slovacchia.
Beh, certo, Orbán ha ordinato una campagna dai tratti antisemiti contro quell’orribile ebreo, George Soros, ma Soros per Netanyahu è una vergogna, un vero nemico che appoggia gruppi antiisraeliani, come ad esempio le organizzazioni per i diritti umani in Israele.
Ebbene, l’Europa deve capire che Israele è la frontiera che bloccherà la barbarie musulmana; invece di criticare lo Stato ebraico, gli europei devono rendersi conto che è una ricetta per la vittoria, altrimenti saranno sconfitti. In soldoni, è questo l’ammonimento che il grande premier dà agli statisti europei che non capiscono troppo bene la situazione laggiù.
Poi Netanyahu torna in patria e si trova di fronte a un grave dilemma. L’ultradestra spiega che la discussione non verte intorno alle telecamere e ai metal detector; piuttosto, è in gioco la sovranità del paese e il governo deve sottolineare con forza che Israele è sovrana anche sulla Spianata, senza arrendersi alle pressioni dall’estero o alla minaccia di situazioni esplosive.
Netanyahu non può mostrarsi meno radicale dei suoi alleati di destra e va avanti nella direzione suggerita dalla polizia.
Un morto, due, venti? Non ha importanza. Il punto è come fare per impedire qualunque accordo suscettibile di portare a una pace israelo-palestinese. Stavamo dimenticando l’annuncio del ministro dell’habitat che ha un magnifico programma: costruire case secondo piani che dividerebbero ulteriormente la Cisgiordania occupata.
Grazie all’apatia generale e all’islamofobia europea, il governo di Israele potrà proseguire con l’occupazione. Una politica che rende la pace impossibile.
LA SPARTIZIONE DI AL AQSA
È UN PROCESSO GIÀ IN ATTO
intervista di Michele Giorgio
«Intervista. Parla l'analista Uraib al Rintawi: il governo israeliano punta a dividere la Spianata delle moschee ma le sue politiche aggressive a Gerusalemme frenano la "normalizzazione" con i Paesi arabi»
Sulle ragioni delle proteste palestinesi e le implicazioni in Medio Oriente della crisi a Gerusalemme e delle politiche del governo Netanyahu, abbiamo intervistato l’analista arabo ed editoralista del quotidiano al Dustour Uraib al Rintawi.
Le nuove misure israeliane per la Spianata delle moschee hanno innescato proteste e manifestazioni a Gerusalemme che non si vedevano dal 2014.
«L’escalation era inevitabile. Ed è destinata ad aggravarsi se il governo Netanyahu non revocherà subito le misure che ha annunciato per la Spianata della moschea di al Aqsa e non farà rimuovere subito i metal detector installare sul sito religioso. I palestinesi sanno che sul piatto c’è la difesa dello status quo per la Spianata delle moschee che è in vigore da 50 anni. Il fatto che Netanyahu descriva come temporanee le misure varato è un altro campanello d’allarme perché tutto ciò che per Israele ha un carattere transitorio nei Territori palestinesi occupati poi si è rivela permanente«.
I palestinesi denunciano un tentativo di Israele di creare sulla Spianata delle moschee una situazione simile a quella della Tomba dei Patriarchi ad Hebron, ossia la spartizione dell’area in cui sorgono le moschee di Al Aqsa e della Roccia di Gerusalemme considerata dall’Ebraismo il Monte del biblico Tempio.«Non si tratta di un tentativo ma di un piano a mio avviso molto concreto e in atto. La storia insegna come l’applicazione di presunte misure di sicurezza da parte Israele si sia poi rivelata il percorso per realizzare progetti politici. I segnali sono chiari, è sufficiente osservare in quali aree sono stati installati i metal detector sulla Spianata per rendersi conto, che di fatto, tracciano una bozza di divisione del sito. Ed è significativo che, nel frattempo, nonostante la tensione, sia garantito l’accesso sulla Spianata ai turisti israeliani che in realtà non sono turisti ma estremisti religiosi che spingono per la ricostruzione del Tempio ebraico, coloni ed esponenti della destra radicale. L’attacco armato della scorsa settimana in cui sono stati uccisi due poliziotti ha fornito alle autorità israeliane un pretesto per avviare la realizzazione di piani che erano nel cassetto da tempo».
Come valuta la reazione della Giordania, paese che si proclama custode di al Aqsa. Qualcuno la considera fiacca.
«Non sono d’accordo. La Giordania sul piano diplomatico sta facendo quanto è nei suoi poteri per persuadere gli Usa, l’Europa e altri Paesi a fare il possibile per imporre la retromarcia a Netanyahu. L’importanza della Spianata e il mantenimento dello status quo all’interno della mura antiche di Gerusalemme restano un punto fermo nella politica del Regno. A ciò si aggiunge il fatto che il governo deve tenere conto anche dei sentimenti popolari. Oggi (ieri per chi legge, ndr) sono scesi strada ad Amman e in altre città migliaia di giordani per protestare contro Israele e in difesa delle moschee di Gerusalemme. Non si vedevano dimostrazioni tanto ampie e le autorità ne devono tenere conto. E non si può dimenticare che la Giordania ospita milioni di palestinesi».
I passi fatti da Netanyahu avranno un impatto negativo sulle relazioni dietro le quinte che Israele ha allacciato con alcuni Paesi arabi, a cominciare dall’Arabia saudita.
«È inevitabile. Persino quei Paesi arabi che con entusiasmo procedono verso la normalizzazione dei rapporti con Israele saranno costretti a frenare, sotto l’onda di sdegno che attraversa le loro opinioni pubbliche. Senza dimenticare che quanto accade in questi giorni a Gerusalemme rafforza gli islamisti più radicali che accusano i loro governi di collaborazionismo con Israele. Per chi governa nel Golfo è una brutta notizia vedere i palestinesi in strada a manifestare per i loro diritti e contro le politiche di Israele. Vuol dire che dovranno mettere in frigorifero i loro piani».
LE CHIESE CRISTIANE
A DIFESA DEI LUOGHI DELL'ISLAM
di red.
«Gerusalemme. I patriarchi e gli arcivescovi delle chiese della Città Santa chiedono il rispetto di al-Aqsa e il diritto dei musulmani alla preghiera. E ieri, a pregare fuori dalla Spianata, accanto ai fedeli musulmani anche palestinesi cristiani»
«Noi, capi delle chiese di Gerusalemme, esprimiamo la nostra grave preoccupazione per la recente escalation di sviluppi violenti intorno a Haram ash-Sharif [la Spianata delle Moschee] e il nostro dolore per la perdita di vite umane». Così inizia il comunicato congiunto delle chiese cristiane della Città Santa, firmato dai patriarcati greco-ortodosso, cattolico, armeno ortodosso, copto, siriano ortodosso, etiope ortodosso, maronita, luterano evangelico, greco-melchita-cattolico, siriano cattolico e armeno cattolico e dalla Custodia di Terra Santa e la Chiesa episcopale di Gerusalemme e Medio Oriente
Una presa di posizione importante, che si unisce alle immagini che ieri giungevano da Gerusalemme: palestinesi cristiani che pregavano accanto ai musulmani fuori dalla Spianata. «Siamo preoccupati per ogni cambiamento dello status quo della Moschea di al-Aqsa e della Città Santa di Gerusalemme – scrivono i patriarchi e gli arcivescovi – Ogni minaccia alla sua integrità potrebbe condurre facilmente a serie e imprevedibili conseguenze. Riteniamo che la custodia del regno hashemita di Giordania sulla Moschea di al-Aqsa e sui luoghi sacri di Gerusalemme e della Terra Santa garantisca il diritto di tutti i musulmani ad accedere liberamente e a pregare ad al-Aqsa, secondo quanto previsto dallo status quo».
 Una forte invettiva contro i mille silenzi dei mass media sulla giungla di delitti che giorno dopo giorno vengono compiuti in Africa. I nostri posteri ci ricorderanno come noi oggi ricordiamo i nazisti?,
Una forte invettiva contro i mille silenzi dei mass media sulla giungla di delitti che giorno dopo giorno vengono compiuti in Africa. I nostri posteri ci ricorderanno come noi oggi ricordiamo i nazisti?,
FNSI (Federazione italiana stampa italiana), 18 luglio 2017 (m.c.g.)
Scusatemi se mi rivolgo a voi in questa torrida estate, ma è la crescente sofferenza dei più poveri ed emarginati che mi spinge a farlo. Per questo come missionario uso la penna (anch’io appartengo alla vostra categoria) per far sentire il loro grido, un grido che trova sempre meno spazio nei mass-media italiani.
Trovo infatti la maggior parte dei nostri media, sia cartacei che televisivi, così provinciali, così superficiali, così ben integrati nel mercato globale. So che i mass-media , purtroppo, sono nelle mani dei potenti gruppi economico-finanziari, per cui ognuno di voi ha ben poche possibilità di scrivere quello che vorrebbe. Non vi chiedo atti eroici, ma solo di tentare di far passare ogni giorno qualche notizia per aiutare il popolo italiano a capire i drammi che tanti popoli stanno vivendo.
Mi appello a voi giornalisti/e perché abbiate il coraggio di rompere l’omertà del silenzio mediatico che grava soprattutto sull’Africa. (Sono poche purtroppo le eccezioni in questo campo!)
È inaccettabile per me il silenzio sulla drammatica situazione nel Sud Sudan (il più giovane stato dell’Africa) ingarbugliato in una paurosa guerra civile che ha già causato almeno trecentomila morti e milioni di persone in fuga.
È inaccettabile il silenzio sul Sudan, retto da un regime dittatoriale in guerra contro il popolo sui monti del Kordofan, i Nuba, il popolo martire dell’Africa e contro le etnie del Darfur.
È inaccettabile il silenzio sulla Somalia in guerra civile da oltre trent’anni con milioni di rifugiati interni ed esterni.È inaccettabile il silenzio sull’Eritrea, retta da uno dei regimi più oppressivi al mondo, con centinaia di migliaia di giovani in fuga verso l’Europa.
È inaccettabile il silenzio sul Centrafrica che continua ad essere dilaniato da una guerra civile che non sembra finire mai. È inaccettabile il silenzio sulla grave situazione della zona saheliana dal Ciad al Mali dove i potenti gruppi jihadisti potrebbero costituirsi in un nuovo Califfato dell’Africa nera.
È inaccettabile il silenzio sulla situazione caotica in Libia dov’è in atto uno scontro di tutti contro tutti, causato da quella nostra maledetta guerra contro Gheddafi.
È inaccettabile il silenzio su quanto avviene nel cuore dell’Africa , soprattutto in Congo, da dove arrivano i nostri minerali più preziosi.È inaccettabile il silenzio su trenta milioni di persone a rischio fame in Etiopia, Somalia , Sud Sudan, nord del Kenya e attorno al Lago Ciad, la peggior crisi alimentare degli ultimi 50 anni secondo l’ONU.
È inaccettabile il silenzio sui cambiamenti climatici in Africa che rischia a fine secolo di avere tre quarti del suo territorio non abitabile.
È inaccettabile il silenzio sulla vendita italiana di armi pesanti e leggere a questi paesi che non fanno che incrementare guerre sempre più feroci da cui sono costretti a fuggire milioni di profughi. (Lo scorso anno l’Italia ha esportato armi per un valore di 14 miliardi di euro!).Non conoscendo tutto questo è chiaro che il popolo italiano non può capire perché così tanta gente stia fuggendo dalle loro terre rischiando la propria vita per arrivare da noi.
Questo crea la paranoia dell’“invasione”, furbescamente alimentata anche da partiti xenofobi.Questo forza i governi europei a tentare di bloccare i migranti provenienti dal continente nero con l’Africa Compact , contratti fatti con i governi africani per bloccare i migranti.Ma i disperati della storia nessuno li fermerà.
Questa non è una questione emergenziale, ma strutturale al sistema economico-finanziario. L’ONU si aspetta già entro il 2050 circa cinquanta milioni di profughi climatici solo dall’Africa. Ed ora i nostri politici gridano: «Aiutiamoli a casa loro», dopo che per secoli li abbiamo saccheggiati e continuiamo a farlo con una politica economica che va a beneficio delle nostre banche e delle nostre imprese, dall’ENI a Finmeccanica.
E così ci troviamo con un Mare Nostrum che è diventato Cimiterium Nostrum dove sono naufragati decine di migliaia di profughi e con loro sta naufragando anche l’Europa come patria dei diritti. Davanti a tutto questo non possiamo rimane in silenzio. (I nostri nipoti non diranno forse quello che noi oggi diciamo dei nazisti?).
Per questo vi prego di rompere questo silenzio- stampa sull’Africa, forzando i vostri media a parlarne. Per realizzare questo, non sarebbe possibile una lettera firmata da migliaia di voi da inviare alla Commissione di Sorveglianza della RAI e alla grandi testate nazionali? E se fosse proprio la Federazione Nazionale Stampa Italiana (FNSI) a fare questo gesto? Non potrebbe essere questo un’Africa Compact giornalistico, molto più utile al Continente che non i vari Trattati firmati dai governi per bloccare i migranti? Non possiamo rimanere in silenzio davanti a un’altra Shoah che si sta svolgendo sotto i nostri occhi. Diamoci tutti/e da fare perché si rompa questo maledetto silenzio sull’Africa.
 «I leader europei stanno cercando di distrarre l’opinione pubblica da quello che è il vero problema: la mancanza di canali sicuri e legali per le persone che vogliono raggiungere l’Europa».
«I leader europei stanno cercando di distrarre l’opinione pubblica da quello che è il vero problema: la mancanza di canali sicuri e legali per le persone che vogliono raggiungere l’Europa».
Internazionale online, 18 luglio 2017 (p.d.)
Tra un’ora, Stephane Broch, il vicecoordinatore delle operazioni di soccorso salirà sul ponte di comando della nave Aquarius con un binocolo e comincerà il primo turno di avvistamento. La luce è nitida, il mare leggermente increspato, ci aspettano tre giorni di bel tempo. Intanto la squadra di Sos Méditerranée è a prua: Rocco, Tanguy, Charlie sistemano i giubbotti di salvataggio arancioni dentro dei grossi sacchi di rafia bianca. Mentre Alain, Alessandro e Svenja gonfiano i gommoni. Bananas, li chiamano. Sono lunghi galleggianti arancioni che vengono lanciati in acqua se qualcuno finisce in mare. “Anche se abbiamo fatto decine, centinaia di soccorsi, ogni volta che saltiamo dentro un gommone per cominciare un’operazione ci prende paura. Nessun soccorso è uguale al precedente, ogni volta è diverso. La paura ci aiuta a tenere l’attenzione alta e a non fare sbagli”, spiega Rocco Aiello, uno dei soccorritori.
Sotto coperta Craig Spencer di Medici senza frontiere tiene una breve lezione per i giornalisti sulla rianimazione cardiopolmonare. “Ci succede così frequentemente che le persone che soccorriamo perdano coscienza che abbiamo deciso che tutti a bordo debbano saper fare la rianimazione, perché in questi casi il tempo è tutto: la tempestività è inversamente proporzionale alla mortalità”, spiega Spencer. Piegato su un manichino di gomma steso a terra, il medico americano mostra tutte le fasi del soccorso: “Dovete prima accertarvi che la persona non risponda agli stimoli sia verbali sia fisici e che la situazione non comporti pericolo. Poi dovete chiamare i medici con la radio di bordo. Urlate: "Medical emergency, medical emergency" e il punto della nave in cui vi trovate. Quindi dovete controllare il respiro della persona e in caso sia assente procedete con la manovra di rianimazione cardiopolmonare”. Cento pressioni al minuto, intense, alla base dello sterno, con entrambe le mani una sopra all’altra, ginocchia ben piantate per terra. “Per darvi il ritmo pensate alla canzone Stain’ alive dei Bee Gees, aiuta!”.
Un codice di condotta per le ong
“Quando arriveremo a 25 miglia dalle coste libiche, ridurremo la nostra velocità di crociera e cominceremo a pattugliare quella che viene chiamata in gergo Sar zone (area di ricerca e soccorso)”, afferma Hauke Mack, il coordinatore di Sos Méditerranée sull’Aquarius. È seduto al computer nella sua cabina e controlla le condizioni del tempo. Vive ad Amburgo e ha lavorato nel settore navale per tutta la vita, fino a quando ha letto sul giornale che Sos Méditerranée avrebbe cominciato a salvare i migranti nel Mediterraneo e ha deciso di mettere a disposizione del progetto le sue competenze. “Io mi sento europeo, anche se so di avere molte identità: sono tedesco, del nord della Germania. Sono molto critico verso l’Unione europea, ma penso che sia stata un grande passo in avanti per tutti, perché ha garantito soprattutto la pace. Questo le persone tendono a dimenticarselo”.
Come previsto dal vertice dei ministri dell’interno europei che si è svolto a Tallinn, il 18 luglio le organizzazioni non governative hanno ricevuto dal governo italiano un codice di condotta in undici punti, e sono state convocate al ministero dell’interno a Roma il 25 luglio per discutere delle nuove norme. Se non lo dovessero sottoscrivere, il governo potrebbe impedire loro di continuare a operare nel Mediterraneo centrale. Le nuove norme prevedono tra le altre cose che le ong non entrino nelle acque territoriali libiche, che non spengano mai i transponder delle navi e che facciano salire a bordo su richiesta delle autorità degli agenti della polizia giudiziaria contro il traffico di esseri umani.
“La maggior parte di queste norme sono inutili”, afferma Mack. “Perché sono quelle già previste dalla legge che rispettiamo: non entriamo nelle acque territoriali libiche, non spegniamo i transponder. Quello che facciamo nel Mediterraneo è conforme alla legge: soccorriamo imbarcazioni in difficoltà che è un obbligo per qualsiasi nave”. Tuttavia c’è un punto problematico nel codice di condotta, quello che prevede che la polizia salga a bordo delle navi umanitarie su richiesta delle autorità. In particolare per le grandi organizzazioni come Medici senza frontiere e Save the children questo punto potrebbe rappresentare un ostacolo: infatti, nello statuto di queste organizzazioni, c’è il divieto di cooperare con le forze armate in qualsiasi parte del mondo per garantire la neutralità degli spazi umanitari in qualunque tipo di situazione. “Rispettiamo tutte le norme internazionali in merito ai salvataggi in mare, il fatto di imporci un codice di condotta implica che noi stiamo facendo qualcosa di sbagliato”, afferma Marcella Kraay di Medici senza frontiere. “Quello che facciamo qui è salvare vite umane e sulle nostre imbarcazioni ospitiamo persone molto provate e vulnerabili che possono essere interrogate dalla polizia una volta arrivate in Italia, perché mentre sono sulla nave non rischiano di scappare”.
Secondo Marcella Kraay, i leader europei stanno cercando di distrarre l’opinione pubblica da quello che è il vero problema: la mancanza di canali sicuri e legali per le persone che vogliono raggiungere l’Europa. “Le ong in questo momento stanno mettendo in luce con le loro azioni che le istituzioni europee non si stanno prendendo responsabilità, non stanno facendo il loro dovere e per questo sono sotto attacco”. Per gli umanitari impegnati nei soccorsi è molto chiaro che il problema è il sistema che costringe le persone ad affrontare viaggi pericolosi attraverso il deserto e attraverso il mare per raggiungere un paese sicuro dove vivere. “Ci vorrebbe un codice di condotta per l’Europa, che permette ai suoi stati membri di non essere solidali”, afferma Mack.
“Le persone continueranno ad attraversare il Mediterraneo anche se le ong se ne andranno, come facevano già prima che noi arrivassimo”, assicura Mack. “Ho l’impressione che i leader europei vogliano solo chiudere gli occhi di fronte a questa tragedia, non gli conviene vedere quello che sta succedendo qui. Ma è un’illusione pensare che se le ong se ne andranno le persone smetteranno di mettersi su una barca”. Le persone che vengono soccorse spesso non sanno quanto sia grande il Mediterraneo, anche per questo accettano di salire su barche instabili, secondo il coordinatore di Sos Méditerranée. “Pensano che sia un fiume o un lago, perché molti di loro il mare non l’hanno mai visto”, conclude Mack.
Questo articolo fa parte di un diario che racconta la vita a bordo dell’Aquarius, una delle navi impegnate nel soccorso dei migranti nel Mediterraneo centrale.

Corriere della Sera
«L’ITALIA NON PUÒ DIVENTARE
LA DISCARICA DI TUTTA L’AFRICA
BLOCCHI LE NAVI ESTERE»
di Lorenzo Cremonesi
«Occorre assolutamente che i leader europei, in particolare di Francia, Germania e Italia, si riuniscano a Bruxelles per elaborare una politica comune di fronte al problema migranti. L’Italia non può accogliere le navi straniere colme di migranti, come del resto non può diventare la discarica delle masse di persone che arrivano dall’Africa e dal Medio Oriente mentre l’Europa non fa nulla per aiutarla».
È molto determinato Gilles Kepel mentre riflette sulle questioni poste dai massicci arrivi di migranti sulle nostre coste. Il celebre politologo francese, noto per i suoi studi sull’estremismo islamico, si occupa anche di questo tema in una serie di lezioni che sta tenendo all’Università di Lugano.
Centinaia e centinaia di migranti continuano ad arrivare sulle coste italiane. Nelle ultime ore sono approdate nei porti italiani anche navi battenti bandiera tedesca e britannica. Non crede che queste navi dovrebbero portare i migranti a casa loro?
«Credo che nei confronti della questione migranti l’Europa stia conducendo una politica assolutamente irresponsabile. Manca un coordinamento gestito da Bruxelles. L’Italia non può diventare uno spazio grigio dove arrivano i migranti senza alcun controllo e senza alcun coordinamento con gli altri partner di Bruxelles. Si rischia in questo modo di destabilizzare l’Italia in vista degli importanti appuntamenti elettorali dei prossimi mesi. E la questione migranti rischia di spostare il vostro elettorato verso le destre nazionaliste e il Movimento 5 Stelle. È tempo che le istituzioni europee smettano di disperdersi nei rivoli burocratici infiniti dei loro meccanismi interni e assumano finalmente le loro responsabilità nei confronti di questi giganteschi ed epocali movimenti di popolazioni che premono alle nostre coste meridionali. Il tema sarà sempre più esistenziale per l’unità europea. Occorre darci criteri di accoglienza e di divisioni dei compiti. Senza questo l’Italia diventerà sempre più una zona anarchica di accoglienza. La Germania continuerà a scegliere a suo piacimento gli elementi migliori tra i migranti. La Francia sempre più sarà costretta a ricevere i migranti che la Germania espelle. Mentre i Paesi dell’Est europeo continueranno a rifiutarli tout court».
DALL’UE VIA LIBERA AL CODICEPER LE ONG
IL VIMINALE: LINEA DURA CON CHI NON FIRMA
di Dino Martirano
ROMA L’Unione Europea dà il via libera al «Codice dicondotta per le Ong impegnate nelle operazioni salvataggio dei migranti inmare» che ora l’Italia è pronta a utilizzare per regolare il traffico dellenavi umanitarie nei nostri porti. Secondo il diritto internazionale, gli scaliitaliani non possono certo essere chiusi ma è chiaro che adesso, con il codicecondiviso in sede Ue e sottoscritto dalle organizzazioni umanitarie, leautorità portuali — su indicazione del ministero dell’Interno — potrebbero rivelarsimolto ma molto pignole con le Ong che dovessero rifiutare di firmare.
Il testo, corretto, ha eliminato i vocaboli «obbligo» e«divieto», posizionandosi su un più tenue «si impegna». La nuova formulazionesoddisfa comunque il ministro dell’Interno, Marco Minniti, che oggi farà ilpunto al Viminale per stabilire modalità e tempi del tavolo aperto con le Ong(già in settimana) attraverso la Guardia Costiera. A Bruxelles il via libera al«Codice» c’è da giovedì 13 ma è stato annunciato dal Viminale ieri al terminedi un fine settimana molto articolato sul fronte immigrazione. Infatti con inumeri di nuovo massicci degli sbarchi — e la rivolta dei cittadini e delsindaco di Castell’Umberto nel Messinese contro l’arrivo dei migranti — ilTimes di Londra ha dato ampio spazio a un meccanismo, già utilizzato nel 2011dal governo Berlusconi per ridistribuire i migranti in tutti i Paesi Ue,definendolo «l’opzione nucleare dell’Italia».
L’idea — spinta da tempo da Emma Bonino, dalla comunità diSant’Egidio e dal senatore Luigi Manconi — si aggancia alla direttiva Ue55/2001 che prevede la concessione ai migranti di documenti provvisori a scopoumanitario validi anche per varcare le frontiere Ue. Spiega Emma Bonino: «Laminaccia di bloccare i porti era inattuabile, come quella di espellere iclandestini. I visti temporanei sono un buon modo per affrontare la questioneperché non fanno pressione sui profughi ma sugli Stati membri».
Alla vigilia del vertice di Tallinn, il ministro Minniti haricevuto al Senato da Luigi Manconi un documento con i dettagli del «pianovisti» ma al Viminale la proposta non ha fatto breccia: perché per rilasciarequei visti umanitari serve la maggioranza qualificata del Consiglio Ue dei capidi Stato e di governo.
Manconi ricorda che nel 2011 il ministro dell’InternoRoberto Maroni, davanti al «niet» dell’Ue, forzò la mano:«Applicando l’articolo20 del Testo unico sull’Immigrazione concesse migliaia di permessi di soggiornotemporanei e marocchini e tunisini che in parte riuscirono a passare inFrancia». Maroni conferma: «Il sistema funzionò e potrebbe funzionare ancora maprima bisogna dichiarare lo stato di emergenza». È certo — dice il viceministrodegli Esteri Mario Giro citato dal Times , che nel governo è il piùpossibilista — che l’Italia avrà «un duro negoziato» con i partner Ue.
 L'interesse dell'Europa a utilizzare le persone che fuggono dai loro deserti è simmetrico rispetto all'interesse dei migranti di trovare un'occupazione. Ma per trovare la sintesi occorre un'Europa profondamente diversa dall'UE. il manifesto, 26 luglio 2017
L'interesse dell'Europa a utilizzare le persone che fuggono dai loro deserti è simmetrico rispetto all'interesse dei migranti di trovare un'occupazione. Ma per trovare la sintesi occorre un'Europa profondamente diversa dall'UE. il manifesto, 26 luglio 2017







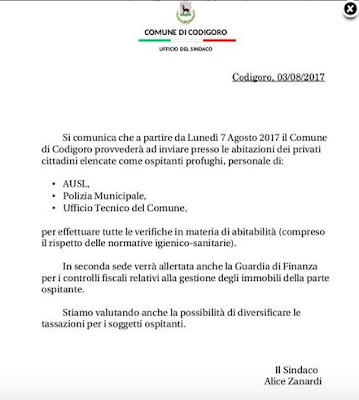










 Ancora ostacoli alle organizzazioni umanitarie che tentano di aiutare i fuggiaschi che tcercano rifugio in luoghi sicuri. Articolo di Carlo Lania e commento diLuigi Manconi.
Ancora ostacoli alle organizzazioni umanitarie che tentano di aiutare i fuggiaschi che tcercano rifugio in luoghi sicuri. Articolo di Carlo Lania e commento diLuigi Manconi. 

 Un resoconto sul rastrellamento degli immigrati "illegali'"nell’era Trump. Storie di ordinaria persecuzione quotidiana: ma la California non è d'accordo,
Un resoconto sul rastrellamento degli immigrati "illegali'"nell’era Trump. Storie di ordinaria persecuzione quotidiana: ma la California non è d'accordo, 


 Una forte invettiva contro i mille silenzi dei mass media sulla giungla di delitti che giorno dopo giorno vengono compiuti in Africa. I nostri posteri ci ricorderanno come noi oggi ricordiamo i nazisti?,
Una forte invettiva contro i mille silenzi dei mass media sulla giungla di delitti che giorno dopo giorno vengono compiuti in Africa. I nostri posteri ci ricorderanno come noi oggi ricordiamo i nazisti?, 
