 «L'allarme del politologo Colin Crouch autore del libro "Postdemocrazia" in cui teorizza il futuro delle democrazie avanzate: governi svuotati di potere e significato. Per evitare che la globalizzazione sia guidata da un'oligarchia delle multinazionali "serve più Europa e meno nazionalismo"». Intervista di Giuliano Balestreri. Huffington Post, 13 maggio 2016
«L'allarme del politologo Colin Crouch autore del libro "Postdemocrazia" in cui teorizza il futuro delle democrazie avanzate: governi svuotati di potere e significato. Per evitare che la globalizzazione sia guidata da un'oligarchia delle multinazionali "serve più Europa e meno nazionalismo"». Intervista di Giuliano Balestreri. Huffington Post, 13 maggio 2016
MILANO - Governi svuotati di potere e significato. La democrazia che cede il passo all'oligarchia delle multinazionali. Addio alle politiche social-democratiche che hanno fatto la storia dell'Europa per lasciar spazio al neo liberismo. E' l'epilogo temuto da Colin Crouch sociologo e politologo britannico celebre per aver coniato il termine "postdemocrazia" nell'omonimo libro in cui teorizza il futuro delle democrazie avanzate. In Italia per partecipare al Festival "Fare la pace" di Bergamo fino a 15 maggio, Crouch punta il dito con il Ttip, il trattato transatlantico di libero scambio tra Europa e Stati Uniti, che "servirebbe ad aumentare le tutele di consumatori, ma invece viene usato solo per ridurle". E critica l'Unione europea perché "ha dimenticato l'eredità delle Commissioni Delors e Prodi fondate sul compromesso tra liberismo e socialdemocrazia per interessarsi solo al liberismo. Siamo caduti in una trappola da cui non riusciamo a uscire".
Più che vittima di una trappola, il Vecchio continente sembra stretto tra due idee antitetiche di Europa. Non crede?
No, siamo davvero in trappola. Da un lato siamo consapevoli dei cambiamenti che porta la globalizzazione e delle necessità di avere un'Unione europea capace di affermarsi ai massimi livelli dove vengono prese le principali decisioni economiche; dall'altro abbiamo bisogno di una politica più vicina alla vita quotidiana. Bruxelles dovrebbe convivere con istituzioni vicine alle persone: le decisioni devono essere prese a livelli diversi a seconda degli argomenti. Il rischio che corriamo è quello di pensare che il nazionalismo rafforzi la democrazia.
Il referendum su Brexit, il prossimo 23 giugno, metterà alla prova le due idee di Europa.
L'appartenenza alla nazione rimane tra le poche identità, che legano la gente al mondo politico. E in un mondo pieno di rischi internazionali - dalla globalizzazione economica, che sembra minacciare il lavoro, all'immigrazione fino al terrorismo islamico - c'è la forte tentazione di vedere la nazione come una fortezza. Il referendum britannico darà ai cittadini la possibilità di concentrare tutte queste ansie su un bersaglio singolo: l'Unione europea. Una tentazione che si scontra con la paura di un futuro totalmente incerto, dicendo addio a tutti i nostri rapporti economici degli ultimi 40 anni. Sarà una battaglia tra due paure: quella di un mondo incontrollabile contro quella di un isolamento totale.
Come si sconfigge la paura?
Con un'Europa più intensa. Delors e Prodi lo avevano capito: bisogna legare in maniera indissolubile i livelli più alti a quelli più bassi. Bisogna riscoprire le politiche regionali, aumentando il loro peso. La Scozia è un caso emblematico: vogliono più autonomia a livello locale, ma sono molto legati all'Unione europea per mantenere un ruolo di peso a livello globale. L'Europa non è una tecnocrazia apolitica, ma rischia di diventarlo se ripensiamo rapidamente il ruolo delle istituzioni.
Gli anni dell'austerity hanno contribuito ad allontanare Bruxelles dai cittadini.
Sì, perché sono stati anni persi a consumare tutta l'energia nel tagliare la spesa e a fare attenzione ai bilanci. Invece, sarebbero serviti a fare altre cose.
Per esempio il Ttip?
Anche. Il Trattato transatlantico di libero scambio serve davvero, ma solo se ci permette di aumentare gli standard di sicurezza. Per il momento, invece, le discussioni vertono solo sul come ridurre gli standard: anche perché un mondo con standard di sicurezza più alti ad ogni livello sarebbe un mondo più caro. E gli americani non possono accettarlo. Però gli europei sbagliano a pensare di essere gli unici a garantire la piena tutela dei consumatori e dei cittadini. In alcuni campi è certamente vero, ma sul fronte bancario la realtà è diametralmente opposta: siamo noi che dovremmo imitare i loro standard. E comunque anche negli Stati Uniti crescono le resistenze con la diffidenza ad aprire il loro mercato agli europei.
A preoccupare i cittadini sono soprattutto le clausole Isds che permettono alle aziende di citare per danni gli Stati che con le loro norme mettano a repentaglio i loro profitti.
E' vero, sono la cosa più pericolosa del trattato. La clausola più antidemocratica. Certo oggi già esistono, ma gli Stati sono liberi di scegliere se riconoscere il diritto alle aziende o meno, con il Ttip diventerebbe invece una regola vincolante per tutti. Il meccanismo di citare in giudizio gli Stati che promulgassero leggi contrarie agli interessi delle aziende era nato per attirare risorse finanziarie nei paesi in via di sviluppo: le multinazionali chiedevano garanzie prima di investire negli Stati a rischio temendo che un cambio di repentino di governo le avrebbe danneggiate. Insomma, il principio era in qualche modo positivo, era un incentivo alla stabilità, ma lentamente il sistema di è esteso fino all'Europa. Basti pensare alla svedese Vattenfall che ha chiesto miliardi di danni alla Germania dopo la decisione - in seguito alla tragedia di Fukushima - chi chiudere le centrali nucleari. Il Ttip in questo senso sarebbe un disastro, il mercato entrerebbe direttamente nelle politiche sociali dei governi che non potrebbe più tornare indietro.
In questo modo il potere sarebbe trasferito alla multinazionali?
Sì, sarebbe il punto finale della post democrazia. Un mondo nel quale le istituzioni tradizionali continuano a esistere, ma si svuotano di significato e la politica non è più in grado di incidere. Per fortuna non siamo ancora a questo punto, ma la strada che abbiamo imboccato è proprio quella. E il Ttip darebbe un'accelerata in questa direzione.
Anche per questo le trattative per il Ttip stanno sollevando proteste in tutta Europa.
E' vero, le resistenze sono molte: i cittadini stanno prendendo coscienza di questa rischio, ma l'atteggiamento dei manifestanti è ambiguo, si uniscono le proteste di sinistre a quelle della destra nazionalista. Bisogna fare attenzione, perché la difesa delle democrazione non passa per più sovranità. I movimenti nazionalisti cavalcano solo i diasgi della popolazione, dalla paura dell'immigrazione alle paure per l'occupazione.
Come si fa?
I governi devono uscire dalla trappola dei debiti, insomma credo che serva una certa austerità, ma diversa da quella applicata in Europa. Serve un cambiamento di direzione delle politiche sociali che oggi hanno strutture non sono adatte: le pensioni sono troppo generose, mentre mancano le risorse per la formazione e l'istruzione. Abbiamo bisogno di un grande compromesso a livello europeo per incentivare i paesi a usare i soldi in modo migliore. Il caso della Grecia è emblematico: riceve critiche per come usa le sue finanze, ma non è chiaro quali siano le cose giuste da fare. Un tempo l'Europa mediava tra liberismo e democrazia sociale, ora la palla è in mano solo ai primi, senza alcun compromesso.
Renzi si scontra spesso con le politiche europee. Come lo giudica?
Ho casa in Umbria, ma non conosco abbastanza bene la sua politica, di certo vuole essere
il Tony Blair d'Italia solo che il suo governo arriva in un momento in cui non c'è molto spazio di manovra proprio per colpa dell'austerity. Per fare riforme profonde bisogna sempre poter offrire qualcosa di nuovo e allettante, non vedo cosa si possa fare in questo momento.
 Ecco un'intervista (e un libro) che dovrebbero essere letti da chiunque voglia comportarsi da cittadino democratico, impegnato a salvare la nostra democrazia dall'ulteriore decadenza nel referendum del prossimo ottobre.
Ecco un'intervista (e un libro) che dovrebbero essere letti da chiunque voglia comportarsi da cittadino democratico, impegnato a salvare la nostra democrazia dall'ulteriore decadenza nel referendum del prossimo ottobre.
Il Fatto Quotidiano, 13 maggio 2016 (p.d.)
A guardarlo, il libro del professor Settis, mette di buon umore. E non solo perché s'intitola Costituzione!, con quel punto esclamativo che sembra un’esortazione. Poi c’è il sottotitolo: “Perché attuarla è meglio che modificarla”. Dentro i contributi –raccolti e aggiornati –che negli anni sono apparsi sui giornali o pronunciati in eventi pubblici e che parlano di lavoro, salute, scuola, paesaggio: beni comuni e diritti a cui l’operare dello Stato dovrebbe orientarsi. Ma non accade, “perché i governi hanno smontato lo Stato”.
Professore, partiamo dal sottotitolo: attuarla.
Chi insiste nel ripetere che la Costituzione va cambiata sostenendo che la prima parte non si tocca, non dice mai cosa di quella prima parte è realmente attuato. L’articolo 32, sul diritto alla salute, è attuato o no? Da quando, con la riforma del Titolo V, il sistema sanitario è organizzato su base regionale, come risulta da un’inchiesta del Corriere, la vita media degli italiani sta calando. Mi piacerebbe che chi dice di voler cambiare la Carta, s’impegnasse anche ad applicare le molte parti rimaste inattuate.
I riformatori risponderebbero che il nuovo sistema corregge i danni del federalismo, facendo tornare molte materie alla competenza del legislatore nazionale.
Sulla riforma del titolo V del 2001 –di cui mi sono occupato in particolar modo per quanto attiene alla tutela del paesaggio –sono sempre stato critico. Questa parte del ddl Boschi – senza entrare nel merito di com’è fatta, cioè malissimo – ha una qualche ragione d’essere. L’attuazione dell’art. 32 non dipende solo dal federalismo. Il problema sono i continui tagli e l’imposizione di ticket che sembra no portarci lentamente verso un sistema di sanità privata. Mentre gli Usa di Obama cercano di imitare noi, noi cerchiamo di imitare Reagan.
Il premier l’ha messa sul personale: si vota o con lui o contro di lui.
Non bisogna cadere nella trappola del referendum-plebiscito. La vera ragione per cui essere contrari è che la riforma intacca un terzo del testo costituzionale, diminuendo il prestigio del presidente della Repubblica – attraverso un meccanismo di elezione ridicolo – e il peso del Parlamento. Con un Senato, non più eletto dal popolo, ridotto a un dopolavoro per sindaci e consiglieri regionali. Il principio della sovranità popolare viene indebolito. Non ho alcun dubbio che siamo solo all’inizio di un percorso...
Infatti lei parla di un “assalto alla Carta”, che parte ben prima del governo Renzi.
C’è una convergenza tra il famoso reportdi JP Morgan del 2013 che punta il dito contro le Costituzioni del Sud Europa “troppo influenzate da idee socialiste”e l’agire dei governi, in particolare mi riferisco al documento Letta: Renzi è stato più cauto. È il segno di una mentalità che si è fatta strada nei circoli della finanza internazionale e delle élite politiche europee, penso alla Commissione e alla Banca centrale, che vuole imporre un ultraliberismo che viene spacciato per nuovo. Ma a me risulta che il thatcherismo non sia proprio un modello nuovo.
Quando si occupa della riforma dell’articolo 81 – con l'introduzione del pareggio di Bilancio in Costituzione – parla di un precetto seguito dal governo Monti che la Carta nega: la priorità dell’economia sui diritti.
In quel momento anch’io ho sottovalutato l’impatto della riforma. Ma quella è stata una specie di prova generale della maggioranza delle larghe intese: un progetto molto chiaro del presidente Napolitano per modificare la Costituzione senza bisogno di un referendum. Il principio che sta dietro all’articolo 81 è lo stesso che alberga a Taranto, dove il diritto alla salute viene scambiato con il diritto al lavoro. Certi temi non si affrontano perché l’economia ne risente. Ma sono i cittadini a rimetterci. Farò un paragone che può sembrare improprio: perché sul caso Regeni l’Italia ha solo finto di fare la voce grossa? Perché dietro ci sono interessi economici. Questo per dire che i diritti di una persona o della persona vengono schiacciati in nome dell’economia che dovrebbe salvare il Paese, nonostante la lunga stagnazione e la disoccupazione giovanile al 38%.
In più punti del libro sottolinea la sospetta confusione, anche lessicale, della riforma: come se fosse scritta per non essere capita.
Lo sforzo che ho fatto in questo volume è stato articolare il ragionamento sulla riforma, affrontandone via via i temi nello specifico. Perciò ho inserito una corposa appendice con tutte le riforme costituzionali state fatte fino ad oggi, compresa l’ultima. L’articolo 70 – che prima contava 4 parole e ora 434 – è fatto per non essere capito, per confondere le idee e tenere i cittadini lontano dalla Costituzione. Dicono che il bicameralismo produce solo danni: avrebbero fatto miglior figura a cancellare il Senato. Non è vero, tra l’altro, che il bicameralismo è stato abolito. Per quanto riguarda la cosiddetta semplificazione, ci sono almeno 23 fattispecie di leggi che devono passare per il Senato. Ecco perché nella lettera dei costituzionalisti – 11 dei quali presidenti emeriti della Consulta – si dice chiaramente che la riforma non funzionerà. Succederà che si farà ancor più ricorso ai decreti legge del governo, delegittimando ulteriormente il Parlamento. Quindi l’esecutivo – per evitare che il Paese si fermi – diventerà ancora più potente perché, come si usa dire, “non c'è alternativa”.
Renzi ha parlato di “archeologi travestiti da costituzionalisti”. Forse pensava a lei...
Non desidero interloquire a questi livelli. Si deve parlare del merito della riforma, che è ciò che interessa ai cittadini. Sulla rottamazione mi permetto di osservare che Renzi ha fatto il patto del Nazareno con Berlusconi, che non è proprio un giovanotto. Come del resto Verdini. I vecchi vanno bene se sono amici suoi. Ma dal premier voglio sapere, punto per punto, come cambierà la nostra democrazia.
 «Una Costituzione che promette di non fare troppi danni solo a patto che una maggioranza specifica governi è una costituzione per il presente, non per il futuro, e quindi è improvvida».
«Una Costituzione che promette di non fare troppi danni solo a patto che una maggioranza specifica governi è una costituzione per il presente, non per il futuro, e quindi è improvvida».
Libertaegiustizia.it, 11 maggio 2016 (m.p.r.)
Il clima che i proponenti della riforma costituzionale, Renzi e Boschi, stanno premeditatamente creando ha davvero ben poco a che fare con la politica costituzionale. La Costituzione è diventata, a questo punto e per loro espresso proposito, un oggetto di contenzioso politico, proprio come un programma elettorale: di costituzionale non vi è nulla. Figuriamoci se questo fosse stato il clima dei Costituenti! Avremmo avuto la guerra civile non settant’anni di vita civile.
E fa davvero stupire il più sprovveduto osservatore leggere le opinioni di stimati articolisti, giornalisti, e intellettuali: tutti loro “bevono” (per usare un verbo che piaceva a Piero Gobetti) l’espediente retorico del plebiscito: non c’è alternativa. La catena di idee è questa: poiché non ci possiamo permettere, come Paese, di avere una crisi di governo, e siccome Renzi la scatenerebbe se perdesse il plebiscito, non abbiamo alternativa se non votare come lui vuole, anche perché non c’è altro politico disponibile in questo momento a parte Renzi: quindi turarsi il naso e votare. La nuova Costituzione è brutta, può essere pericolosa perché non ci tutela da cattive maggioranze, eppure per “spirito di responsabilità” la si deve votare. La responsabilità è invocata per l’oggi e verso l’oggi, non per e verso il paese.
La retorica del catastrofismo ha fatto breccia nel cervello degli intellettuali, che mostrano così la labilità della razionalità e dimostrano, se ce ne fosse ancora bisogno, che davvero nessuno può dirsi “intellettuale” in una democrazia, perché tutti lo sono poiché indistintamente di tutti sono queste emozioni così poco razionali.
Ma appunto per questo, appunto perché i sacerdoti del Sì non possono vantare, proprio come quelli del No, alcuna privilegiata saggezza, mettiamo sul tappeto le questioni reali implicate in questa battaglia sulla Costituzione: parliamo del carattere di questa nuova versione della Costituzione e degli effetti che può generare, soprattutto se accoppiata con l’Italicum. Dicevano i teorici e i politici settecenteschi che hanno teorizzato e/o scritto le costituzioni che queste devono essere scritte “per i demoni non per gli angeli”. E come per il ‘Peter sobrio’, che scrive le regole pensando a se stesso quando potrebbe essere ubriaco, queste carte di regole e di intenti servono proprio per esorcizzare e contenere il potere, in particolare quando e se tenuto da mani sconsiderate. Una Costituzione che promette di non fare troppi danni solo a patto che una maggioranza specifica governi è una costituzione per il presente, non per il futuro (o per un presente corto rispetto al futuro lungo, secondo cui dovrebbe essere pensata la vita di una Costituzione), e quindi è improvvida. E allora, come si può coerentemente e razionalmente sostenere che, sì, questo nuovo Senato è pasticciato, e forse necessiterà di ritocchi in corso d’opera, e però deve essere approvato? Perché, sapendo che ha questi problemi, non si è provveduto a superarli prima di giungere alla sua approvazione? Non è irrazionale questo comportamento?
La campagna referendaria che ci attende sarà in molta parte all’insegna dell’odio verso i sostenitori del No - l’unico modo per sfuggire alle obiezioni, per non rispondere nel merito, per non dar conto di questa irrazionalità. E’ a questo che ci si deve preparare - a un parlare senza dialogo e senza discussione; a un parlare su binari paralleli per convertire i propri e condannare al rogo mediatico gli altri. Alla fine, quale che sia l’esito, l’Italia sarà una società molto divisa. La Costituzione, la grammatica comune, sarà essa stessa la causa della divisione. Anche in questo vi è una sovrabbondanza di irrazionalità.

Ecco perché la magistratura (il potere giudiziario) ha non solo il diritto, ma il dovere di esprimersi sulle azioni del potere legislativo e di quello esecutivo. Ed ecco anche, in filigrana, perché a Matteo Renzi non è bastato assorbire il legislativo nell'esecutivo (il Parlamento nel Governo) ma vuole papparsi anche il giudiziario, cioè la Magistratura). Micromega, 11 maggio 2016
Proprio per evitare che la promessa costituzionale restasse un libro dei sogni e per impedire che il pendolo della storia tornasse indietro a causa delle pulsioni autoritarie della parte più retriva della classe dirigente e del ritardo culturale delle masse, i padri costituenti concepirono nella seconda parte della Costituzione una complessa architettura istituzionale di impianto antioligarchico basata sulla centralità del Parlamento e sul reciproco bilanciamento dei poteri".Il procuratore di Palermo dissente dal vicepresidente del Csm Legnini: "I magistrati possono partecipare al referendum".
"Se non capisci come funziona il gioco grande... sarai giocato". Il procuratore generale di Palermo Roberto Scarpinato, toga famosa per le sue indagini sulla mafia, è convinto che i magistrati "debbano" esprimersi sul referendum non solo perché "è un nostro diritto", ma per la futura valenza che la riforma comporta.
Il vice presidente del Csm Legnini (e altri con lui) dice che i magistrati non devono impegnarsi nella campagna referendaria perché finirebbero nella contesa politica. Che ne pensa?
Mi permetto di dissentire. Forse a tanti non è sufficientemente chiaro quale sia la reale posta in gioco che travalica di molto la mera contingenza politica. A mio parere siamo dinanzi a uno spartiacque storico tra un prima e un dopo nel modo di essere dello Stato, della società e dello stesso ruolo della magistratura. Nulla è destinato a essere come prima".
Cosa potrebbe cambiare nel futuro rispetto al passato?
A proposito del passato mi consenta di partire da una testimonianza personale. Tanti anni fa ho deciso di lasciare il mio lavoro di dirigente della Banca d'Italia e di entrare in magistratura perché ero innamorato della promessa-scommessa contenuta nella Costituzione del 1948 alla quale ho giurato fedeltà.
E quale sarebbe questa "promessa-scommessa?
Quella scritta nell'articolo 3 di "rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del paese". Era uno straordinario programma di lotta alle ingiustizie e un invito a innamorarsi del destino degli altri. La Repubblica si impegnava a porre fine a una secolare storia nazionale che Sciascia e Salvemini avevano definito "di servi e padroni" perché sino ad allora intessuta di disuguaglianze e sopraffazioni che avevano avuto il loro acme nel fascismo e nella disfatta della seconda guerra mondiale".
Sì, però l'attuale riforma costituzionale si occupa solo della seconda parte della Costituzione e lascia intatta la prima sui diritti. Cosa la turba lo stesso?
La seconda parte è strettamente funzionale alla prima.
E perché tutto questo coinvolgerebbe le toghe? Realizzare la promessa non era compito della politica?"All'interno di questo disegno veniva affidato alla magistratura il ruolo strategico di vigilare sulla lealtà costituzionale delle contingenti maggioranze politiche di governo.
Un'affermazione forte... Ma di quale vigilanza parla?"I giudici, tra più interpretazioni possibili della legge ordinaria, devono privilegiare quella conforme alla Costituzione e, se ciò non è possibile, devono "processare la legge", cioè sottoporla al vaglio della Consulta. La magistratura italiana quindi è una "magistratura costituzionale" e, in quanto tale, la sua fedeltà alla legge costituzionale è prioritaria rispetto a legge ordinaria. È una rivoluzione copernicana del rapporto tra politica e legge di tale portata che a tutt'oggi non è stata ancora metabolizzata da buona parte della classe politica che continua a lamentare che la magistratura intralcia la governabilità sovrapponendosi alla volontà del Parlamento.
Con la riforma Renzi questo equilibrio potrebbe saltare?
Alcune parti di questa riforma si iscrivono in un trend più complesso. Oggi tutto ciò rischia di restare solo una storia terminale della prima Repubblica, perché quello che Giovanni Falcone chiamava "il gioco grande", si è riavviato su basi completamente nuove. Alla fine del secolo scorso, a seguito di fenomeni di portata storica e mondiale, sono completamente mutati i rapporti di forza sociali macrosistemici che furono alla base del compromesso liberal-democratico trasfuso nella Costituzione del 1948. Lo scioglimento del coatto matrimonio di interessi tra liberismo e democrazia ha messo in libertà gli "animal spirits" del primo che ha individuato nelle Costituzioni post fasciste del centro Europa una camicia di forza di cui liberarsi.
Un attimo: cosa si sarebbe rimesso in moto?
Si è avviato un complesso e sofisticato processo di reingegnerizzazione oligarchica del potere che si declina a livello sovranazionale e nazionale lungo due direttrici. La prima è quella di sovrapporre i principi cardini del liberismo a quelli costituzionali trasfondendo i primi in trattati internazionali e trasferendoli poi nelle costituzioni nazionali. Esempio tipico è l'articolo 81 della Costituzione che imponendo l'obbligo del pareggio di bilancio impedisce il finanziamento in deficit dello Stato sociale e trasforma i diritti assoluti sanciti nella prima parte della Costituzione in diritti relativi, cioè subordinati a discrezionali politiche di bilancio imposte da organi sovranazionali spesso di tipo informale e privi di legittimazione democratica. La seconda direttrice consiste nel trasferimento dei centri decisionali strategici negli esecutivi nazionali incardinati ad esecutivi sovranazionali, declassando i Parlamenti a organi di ratifica delle decisioni governative e sganciandoli dai territori tramite la selezione del personale parlamentare per cooptazione elitaria grazie a leggi elettorali ad hoc. Il gioco dialettico tra maggioranza- minoranza viene disinnescato grazie a premi di maggioranza tali da condannare le forze di opposizione all'impotenza.
Questo è uno scenario politico. Perché ciò dovrebbe interessare la magistratura?
Se muta la Costituzione, cioè la Supernorma che condiziona tutte le altre, rischia di cambiare di riflesso anche la giurisdizione. La magistratura già oggi è sempre più spesso chiamata a farsi carico della cosiddetta legalità sostenibile, cioè della subordinazione dei diritti alle esigenze dei mercati, e quindi delle forze che governano i mercati. L'articolo 81 della Costituzione ha costituzionalizzato il principio della legalità sostenibile che si avvia a divenire una norma di sistema baricentrica del processo di ricostituzionalizzazione in corso. La conformazione culturale della magistratura al nuovo corso potrà essere agevolata dalla possibilità di minoranze, trasformate artificialmente in maggioranze grazie al combinato disposto dell'Italicum e di alcune delle nuove norme costituzionali, di selezionare i giudici della Consulta e la componente laica del Csm.
Cosa direbbe a un giovane magistrato oggi indeciso se impegnarsi nella campagna referendaria?
Che se non capisci come funziona il gioco grande, sarai giocato. Da amministratore di giustizia rischi di trasformarti inconsapevolmente in amministratore di ingiustizia.
«Il sindaco di Livorno, per fare chiarezza sul collasso della municipalizzata dei rifiuti, decide di portare i libri in tribunale. Poco dopo anche per lui scatta l’avviso di garanzia. Eppure qual è il compito dell’amministratore pubblico se non provare a risolvere i problemi della collettività?».
Lavoce.info, 10 maggio 2016 (m.p.r.)
La pessima prassi di nascondere i “piccoli” problemi…
Vita dura quella dell’amministratore della cosa pubblica. Ne sa qualcosa il sindaco di Livorno, che dopo aver cercato di fare chiarezza sul collasso di un’impresa pubblica (la municipalizzata dei rifiuti dello stesso comune, rovinata da anni di mala gestione) e dopo avere fatto un atto di estremo coraggio (portare i libri in tribunale) è rimasto coinvolto dallo scandalo che lui stesso aveva sollevato.
Vita dura davvero. E vale la pena di ricostruirne i passaggi.
Anno 2014. Dopo settanta anni di indiscussa amministrazione di sinistra (dal Pci al Pd, dal 1944 nessun sindaco livornese ha avuto un’estrazione diversa) viene eletto sindaco Filippo Nogarin, del Movimento 5 Stelle. Forse i livornesi si sono accorti che “qualcosa” non andava? Non lo so. Ma da allora - tra i tanti problemi sul tappeto - il neo sindaco si trova ad affrontare il tema della locale azienda dei rifiuti (Aamps), al 100 per cento del comune. E qui, le cose che non andavano erano tante.
È almeno dal 2010 che il margine operativo dell’impresa non è superiore agli ammortamenti: in cinque anni, oltre 7,3 milioni di perdite a livello di risultato operativo netto (i bilanci sono sul sito del comune). Tanto che nel 2013 una verifica da parte del ministero dell’Economia aveva denunciato una decina di “non conformità”, alcune decisamente gravissime. Come si legge, per esempio, nello stesso bilancio dell’impresa, “non puntuale riscossione della tariffa di igiene Ambientale; squilibrio tendenziale fra costi della produzione e ricavi; eccessivo ricorso all’indebitamento verso istituti bancari”.
Ciononostante, nella primavera 2014 gli amministratori chiudono “tranquillamente” il bilancio del 2013 facendo apparire utili minimi ma superiori allo zero e parlando più in generale di “un risultato positivo (…) che ci fa ben sperare per il futuro”. Decisione coraggiosa, di fronte di una relazione del collegio sindacale (l’organo di controllo) il quale concludeva, con insolita franchezza, che il “progetto di bilancio al 31/12/2013 non è stato redatto con chiarezza e non rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale, finanziaria e il
risultato economico di Aamps”.
… fin quando i problemi stessi non siano troppo grandi
Dopo qualche settimana si insedia la nuova amministrazione, che deve decidere cosa fare dei problemi che fino allora erano finiti sotto il tappeto. Il risultato è che il bilancio di fine 2014 fa segnare quasi 12 milioni di perdita, con debiti a breve verso le banche saliti da 4 a 12,5 milioni. Una situazione in gran parte dovuta alla necessità di accantonare somme ingenti per crediti vecchi ormai di fatto inesigibili: le tariffe “di igiene ambientale” che le precedenti amministrazioni mantenevano a bilancio quasi si trattasse di crediti di imminente incasso.
Anche questo è stato un bilancio molto sofferto, approvato a fine ottobre (cinque mesi oltre il normale), di nuovo con il parere negativo dei sindaci, che sollevano forti dubbi sulla “continuità aziendale”. A fine 2015 la nuova amministrazione deve quindi portare i libri in tribunale; preferisce tentare altre strade, ma – anche mancandole le risorse – il 25 febbraio 2016 viene presentata domanda di ammissione al concordato preventivo, ciò che il tribunale concede il 5 marzo.
Un concordato con poca concordia
Il concordato ha tante conseguenze. Citiamone due per tutte, giusto per chiarire i risvolti economici e politici della cosa. La prima è che l’impresa può sospendere il pagamento degli interessi alle banche. A cominciare dal Monte dei Paschi, che a quanto pare riceveva da questa fonte quasi un milione all’anno. La seconda conseguenza è che di fatto tutti i contratti dell’azienda vengono ora passati al setaccio, con prospettive tutte da verificare per artigiani e cooperative locali. E lo scontento monta su diversi fronti…
Purtroppo, nel gennaio di quest’anno la società (non ancora in concordato, ma sicuramente in situazione delicatissima) decide di stabilizzare una trentina di precari, assumendoli a tempo indeterminato. Atto opportuno? Sicuramente no. Atto dovuto? Forse. Ora, arriva l’avviso di garanzia, forse legittimo, per carità, ma almeno altrettanto paradossale. Il provvedimento finisce infatti per coinvolgere proprio la persona che questo bubbone lo ha fatto scoppiare. La polemica politica non mi interessa; se però il sindaco avesse continuato a nascondere le magagne sotto il tappeto, ora probabilmente staremmo parlando di altro.
Chiunque abbia un ruolo amministrativo e provi a prendersi responsabilità “vere” è avvisato. Il coraggio - almeno per ora - non paga. Ma, d’altra parte, se fai l’amministratore pubblico senza provare a risolvere i problemi della tua collettività, a cosa servi?

«» Ergo i magistrati, se vogliono, possono dire ciò che vogliono sul referendum sul quale si esprimeranno col voto. La Repubblica, (c.m.c.)
Caro direttore, alcune prese di posizione di magistrati sulla vicenda referendaria hanno dato l’avvio a un serrato dibattito, nel quale sono risuonati echi dell’annosa contrapposizione (c’è chi la chiama guerra) fra politica e magistratura. Per la verità, tranne pochi estemporanei pasdaran, nessuno fra gli esponenti politici intervenuti ha sostenuto che si debba vietare ai giudici di esprimere le proprie idee. Il richiamo, semmai, è alla categoria dell’”opportunità”: non è vietato esprimersi, ma è inopportuno, per esempio, che una corrente della magistratura si schieri apertamente per il “no” al referendum, o, peggio, che aderisca a questo o a quel comitato, ancorché animato da insigni esperti della materia.
L’opportunità sembra essere dunque l’ultima frontiera fra ciò che è consentito e non sarebbe illecito, ma, diciamo così, vivamente sconsigliato. La novità è che, di solito, l’opportunità viene invocata quando si verte in materia di valutazione strettamente politica, o per sottolineare aspetti “eccentrici” della vita privata dell’uomo pubblico, o per rimarcare condotte che potrebbero apparire pregiudizievoli all’immagine di questo o di quel magistrato, di questo o di quel politico.
Niente a che vedere con un referendum decisivo per il nostro destino comune di cittadini italiani: magistrati inclusi. Perché fra qualche mese andremo a votare per cambiare (o conservare) l’attuale Costituzione: ed è dunque sacrosanto che ciascuno esprima, attraverso il voto, il proprio gradimento o il proprio rifiuto. Ora, i magistrati, al pari dei professori, degli avvocati, dei tecnici, insomma, dispongono di un patrimonio di conoscenze specifiche che attribuisce alle loro prospettazioni un valore del tutto particolare.
E’, dunque, “opportuno” che facciano sentire la propria voce? Non sarebbe la prima volta. I giudici italiani furono attivi protagonisti nelle campagne referendarie del 2000 e del 2006, anche allora schierandosi. Affermarono, in passato, idee dissonanti con quelle delle maggioranze di centro-destra. Nessuno ritenne “inopportuni” i loro interventi. Oggi dall’interno della magistratura si levano voci dissonanti con l’attuale maggioranza di centro-sinistra. Perché dovrebbero essere giudicate “inopportune”? La sensazione è che non l’opinione del singolo, non l’adesione di una corrente a un comitato siano in discussione, ma la persistenza di una disallineamento fra politiche legislative e alcuni settori della magistratura.
Se così fosse, l’opportunità sarebbe invocata invano.Non solo e non tanto perché alla fine decideranno i cittadini - e non certo una “corporazione” che conta meno di diecimila individui - ma per il semplice motivo che una perfetta sintonia fra politiche legislative e valutazioni della magistratura non è ipotizzabile, a meno di non voler riesumare l’antica pretesa del giudice “bocca della legge”: utopia giacobina che appartiene a epoche remote. La ragione è ben nota agli addetti ai lavori: giudicare significa necessariamente interpretare le leggi. Non fosse così, non ci sarebbe bisogno di una Corte Costituzionale che è chiamata a pronunciarsi proprio su questo, sulla corrispondenza della legge in concreto ai principi della Carta.
Che fra politica e magistratura esista un fisiologico disallineamento risulta confermato, in Italia, da esempi storici: il governo piemontese postunitario adottò le leggi Pica per la repressione del brigantaggio per vincere le resistenze di una magistratura sì di formazione borbonica, ma “inquinata” dai principi iluministici della rivoluzione napoletana del ’99; il Fascismo fu indotto a istituire tribunali speciali perchè quelli ordinari, “inquinati” dal liberalismo giolittiano, apparivano troppo blandi nella repressione degli avversari politici. E i primi governi post-fascisti, analogamente, si trovarono a dover dialettizzare con una magistratura fortemente “inquinata” dall’eredità della dittatura.
In questo quadro storico e culturale, dunque, non c’è niente di inopportuno nello schierarsi per il “sì” o per il “no”, e la stessa magistratura è divisa, non è quel monolite granitico che alcuni rappresentano. Ma l’invocata categoria dell’opportunità suggerisce altre riflessioni. “Opportunità” è un termine scivoloso, inafferrabile. Delinea una zona grigia disancorata da riferimenti precisi e - direbbero i giuristi - tipizzati. Una valutazione rimessa al discernimento del singolo, e nello stesso tempo potenzialmente soggetta a intervento censorio di organi di vigilanza e controllo.
Il rischio è che, in assenza di contorni nettamente delineati, si tramuti in un’arma da brandire contro le voci dissenzienti in quanto tali. O che il timore di essere giudicati “inopportuni” induca all’autocensura e al silenzio. Si finirebbe così per preferire, a una leale battaglia di idee professate a viso aperto, il mormorio livoroso delle segrete stanze. Si finirebbe per preferire a uomini orgogliosi delle proprie idee il trafficare di soggetti che millantano di non possedere alcuna idea.
Qualche giorno fa il Tribunale di Roma si è aperto a una folla di ragazzi a cui, insieme ad artisti, scrittori, giornalisti, molti magistrati hanno cercato di spiegare il senso profondo di parole abusate come “legalità”. E’ stato un momento di grande apertura. Ai ragazzi si è spiegato quanto sia importante lo spirito critico, quanto sia decisivo lottare contro il pregiudizio. Noi che c’eravamo siamo stati “inopportuni”? Secondo alcuni sì. Ma sicuramente non siamo stati opportunisti.

Il Fatto Quotidiano, 9 maggio 2016 (p.d.)
Un tempo volevano andare tutti in Italia. Ora il sogno, qui, è Raqqa. Cinque anni, e in Siria, 500mila morti dopo, la Tunisia è il solo paese della primavera araba in cui la rivoluzione non è deragliata. Gli islamisti di Ennahda sono al governo insieme ai laici di Nidaa Tounes, e nonostante un vicino difficile come la Libia, nonostante l’attentato al museo del Bardo e poi quello di Sousse, un anno fa, con cui i jihadisti hanno colpito il turismo, la prima fonte di reddito del paese, crollato dell’85 percento, ogni angolo qui ha ancora intatto tutto il suo fascino. La Tunisia ti ricorda molto l’Europa, è vivace, libera: è tutta un caffè all'aperto, i tavolini affollati fino a tardi. Ed è vero. Ma perché sono tutti disoccupati, qui.
Bilal ha 31 anni e una laurea in ingegneria, ma fa la guida ai turisti. E ha deciso di unirsi ai 6mila tunisini che si sono arruolati nell’ISIS. “Perché in apparenza io e te siamo simili, la vita, qui, è una vita normale. Ma osservami bene: non ho che una copia cinese di quello che hai tu. I jeans, il giubbotto di pelle... Tutto finto. Non è pelle, è plastica. Sembriamo simili, ma io torno a casa stasera, a un’ora da qui, in un posto che non è la Tunisia che conosci tu, la Tunisia è una fogna in cui non ho l’elettricità, non ho l’acqua calda, ho solo un materasso, per terra e delle coperte, e perché neppure ho un lavoro: è finto anche questo: e non solo perché sono un ingegnere, ma perché con quello che guadagno mi pago a stento i mezzi per venire qui. Torno a casa, la sera, e mi sento uno zero”. La Tunisia, per quelli come Bilal, non è stabile: è immobile. “Non ho nessuna prospettiva. Nel resto del mondo sei giovane e sei pieno di energie, di progetti. Avviare un’impresa, iscriverti a un dottorato. Cambiare città. O anche solo un viaggio. Ma io? Posso solo tornare qui, domani, e vivere un altro giorno identico a questo”.
Eppure Bilal è uno di quelli che ha creduto nella rivoluzione. Uno di quelli che alle manifestazioni, cinque anni fa, è stato in prima fila. “Ma abbiamo sbagliato. Abbiamo pensato che il nemico fosse Ben Ali. E invece avevamo contro tutto il mondo, perché quando una manciata di miliardari possiede la stessa ricchezza di metà della popolazione del pianeta, non è questione di Ben Ali e dei conti svizzeri di sua moglie:è questione che tutti voi dovete rinunciare a qualcosa. Ma non l’avevamo capito. Non avevamo capito che la battaglia non si poteva vincere solo in Tunisia, perché non riguardava solo la Tunisia”. Uno dei suoi amici è già in Siria. E un altro, in Siria, è già morto. Non hai paura? “No, sono già un po' morto”.
Non è difficile, qui, incontrare ragazzi così. Né raro. Non però dove è istintivo cercarli: non a Kairouan, per esempio, quarto centro sacro per l’Islam dopo la Mecca, la Medina e Gerusalemme. Nel 2012, 10mila salafiti hanno marciato per le sue strade chiedendo l’introduzione della sharia: ma Kairouan rimane una piccola, incantevole città di luce e colori chiari, gli archi in pietra, le finestre blu. Le lanterne in ferro battuto. A Kairouan si viene a bere l’acqua che si dice arrivi dalla stessa fonte della Mecca, ma soprattutto, si viene a comprare tappeti. Gli adepti dell’ISIS non si trovano qui, a meditare sul Corano, ma nelle sterminate, improvvisate periferie di Tunisi come Ettadhamen, in mezzo a quel 90 percento di tunisini che possiede solo il 20 percento della ricchezza del paese – in mezzo a distese di case scalcinate e nient’altro, costruite così, una dopo l'altra, senza un progetto, senza infrastrutture, spazi senza luoghi, polvere d’estate e fango d’i nverno. “Tranquilla, è una zona sicura: perché non c’è niente da rubare”, mi hanno detto al Café De Paris, in centro. L’ecstasy locale si chiama Equanil: è un antidepressivo. Se hai vent’anni e sei tunisino, non ti fai per sballarti, ma per dimenticare.
La scintilla, in questi mesi, è Kasserine, al confine con l’Algeria. Uno di quei posti in cui ti sbagli, e scambi il mercato per una discarica: a Kasserine non si vendono neppure cose cinesi, solo cose usate, dove le madri vendono i pupazzi dei figli appena crescono. La Tunisia non è Europa, qui, è Africa. Il 21 gennaio, all’ennesima domanda di lavoro respinta, Ridha Yahyaoui, 28 anni, si è arrampicato su un traliccio dell’elettricità e si è ucciso. Si è fulminato. Da allora cammini, a Kasserine, a Sfax, a Sousse, ovunque, nella medina di Tunisi, tra i turisti, e all’improvviso, vedi un ragazzo in bilico su un cornicione: e tutti, sotto, che cercano di fermarlo. Se hai vent’anni e sei tunisino, o muori jihadista o muori suicida. “Non è una questione di povertà, però, ma più esattamente, di frustrazione”, dice Kais Zriba, 24 anni, giornalista di Inkifada, la testata che in queste ore sta scavando nei Panama Papers. “In Tunisia, e non solo, tutto viene ridotto a uno scontro tra laici e islamisti. Ma lo scontro è sociale e generazionale. Rispetto a cinque anni fa, certo, abbiamo molta più libertà: ma è solo libertà di espressione, perché non abbiamo alcun potere. Siamo tagliati fuori dal governo. Dalle decisioni. In realtà qui lo scontro è tra inclusi e esclusi”.
In Tunisia Beji Caid Essebsi, il presidente, ha 90 anni, metà della popolazione meno di trenta. Ed è vero che Ben Ali è stato spedito in esilio in Arabia Saudita, ma il processo per i 335 morti dei 28 giorni della rivoluzione si è concluso con una semplice condanna per omicidio colposo dei vertici delle forze di sicurezza, tutti già scarcerati.
Ora poi, è stata approvata la cosiddetta legge di riconciliazione economica: un’amnistia generale per tutti i responsabili di reati finanziari. “Che invece è la vera emergenza”, dice Kais Zriba, “perché qui tutto funziona attraverso mazzette, clientele, parentele: e quindi si arricchiscono solo i già ricchi. La crescita non è crescita del benessere, ma delle disuguaglianze. Il problema vero, in Tunisia, non è che laici e islamisti sono incompatibili, al contrario: è che sono alleati. Sono uguali”.
Secondo le stime, la metà dei miliziani dell’ISIS, in Libia, arriva dalla Tunisia. “Se volete sconfiggere l’ISIS, ha più senso investire in Tunisia che bombardare la Libia”. Dei tanti tunisini che vogliono unirsi all’ISIS, quello che più colpisce è l’assenza di qualsiasi riferimento all’Islam. Alla religione. L’ISIS, qui, è quello che per altri è la Germania: un’opportunità di lavoro. La Tunisia, colonia francese, rimane un paese sostanzialmente laico. “Siamo finiti nel mirino dell’ISIS proprio perché siamo la prova che l’Islam è un’altra cosa”, dice Imen Ben-Mohamed, 31 anni, deputata di an-Nahda. Un partito di “demo-musulmani”, nella sua definizione, “come un tempo, da voi, i democristiani. Siamo stati protagonisti della battaglia per la democrazia”, dice – suo padre è un rifugiato: era un oppositore di Ben Ali, e fu costretto all’esilio. I primi di marzo, jihadisti infiltrati dalla Libia hanno assaltato la città di frontiera di Ben Guerdane, probabilmente più per crearsi una sorta di retrovia che per fondare una nuova provincia del califfato. Almeno per ora. Negli scontri sono morti 12 poliziotti, 7 civili e 43 jihadisti. “Ma sono stati i tunisini stessi, non solo i militari, a combattere e respingerli. Per questo è importante investire nella Tunisia: perché possiamo essere di esempio”.
Fino a oggi, il sostegno internazionale è stato più morale che materiale: il premio Nobel alla società civile, al cosiddetto Quartetto, i sindacati che hanno mediato tra laici e islamisti. A ottobre l’Unione Europea, primo partner commercialedella Tunisia, ha avviato negoziati per un'area di libero scambio. Ma sono negoziati che durano anni: l'unica misura concreta, davanti all'ondata di suicidi, è stata l’esenzione dal dazio per l'importazione di altre 35mila tonnellate di olio d'oliva. In realtà, più per rimediare al calo della produzione italiana, che per aiutare la Tunisia. “Non è che non ci siano progetti e risorse”, dice Damiano Duchemin, cooperante del GVC di Bologna. “Solo che magari l’obiettivo di fondo è più contrastare il terrorismo e l’immigrazione. La Tunisia non interessa in sé”. E in effetti anche i reportage, i libri, non sono molti, la Tunisia non fa notizia. Non ha il petrolio: è la sua fortuna e la sua condanna.
Chiedi cosa è cambiato, rispetto a cinque anni fa, e nessuno ha dubbi: la libertà, ti rispondono. “Siamo liberi di dire che è una vita del cazzo”. Sidi Bouzid è a 200 chilometri da Tunisi, ed è la città in cui tutto è iniziato. La città in cui il 17 dicembre 2010 Mohamed Bouazizi, 26 anni, siè cosparso di benzina e ucciso dopo la confisca del carretto di frutta e verdura con cui tirava a campare. Lavorava da quando aveva 10 anni. Il suo suicidio ha travolto Ben Ali e l’intero mondo arabo, e oggi la strada principale, qui, ha il suo nome. Ma è la sola differenza. “Si pensa che sia tutta colpa degli attentati, della crisi del turismo. E io per primo sono stato licenziato: ma per me non è cambiato niente”, mi dice un ragazzo che chiamerò Bilal: perché come l’altro Bilal, ha deciso di andare in Siria. Lavorava a Djerba. Come cameriere. Ma il turismo, qui, anche a pieno regime, è low cost, pacchetti tutto incluso, “e i profitti vanno ai proprietari dei resort, agli operatori internazionali e i loro soci locali. Ti pagano 400 dinari al mese per dieci ore al giorno sette giorni su sette, 200 euro, e solo per la stagione. Sei un servo. Della Tunisia, della tua vita, conoscono solo l’aeroporto”. E non è solo il turismo, in realtà. Tutta l’economia, qui, è a bassa qualifica e basso salario, al servizio di altri paesi. Assemblaggio, call center. Chi non studia ha il doppio di probabilità di trovare lavoro rispetto a chi studia.
Poi cammini sulla sabbia, lungo il mare di Zarzis, e trovi scarpe. Scarpe, e relitti di barca. Mohsen Lihidheb, il postino, ha percorso questa costa in bici per vent’anni. Su, fino a Djerba, e ritorno, ogni giorno. 150 chilometri. Ora la sua casa è il Museo della Memoria del Mare. Scaffali di spazzole, accendini, fotografie, documenti. Una cassetta di bottiglie con dentro messaggi, torce, lampade, confezioni di cioccolato, di medicine, banconote della Libia, del Senegal, del Mali. E poi scarpe. Decine e decine di scarpe, la suola sottile, tenuta insieme con lo spago. Non c'è una targhetta, una data, una descrizione: niente. D’altra parte, cosa si potrebbe scriverci? Sono vite di cui non è rimasto neppure un numero. Mohsen ti dice solo: le ossa le ho sepolte.
Zarzis non è uno dei nomi sui giornali di questi giorni. Lesbos, Calais, Idomeni. Keleti. I punti di partenza e approdo cambiano di settimana in settimana. “E tutti pensano che al fondo, il problema sia la Siria. Ma non si fugge solo dalla guerra, si fugge anche dal resto”, dice Mohsen –dal mondo nascosto tra le statistiche, o forse, dalle statistiche: in Tunisia l’economia ha un tasso di crescita del 3,5 percento, ma la disoccupazione è raddoppiata. “I giornalisti vengono e ripartono. La notizia è altrove. Promettono tutti di scrivere, fare, cambiare, ma poi spariscono. La Tunisia non interessa". A Zarzis tornano solo le scarpe.

Il manifesto, 8 maggio 2016 (p.d.)
Quando si esalta un tiranno, magari per farci ricchi e convenienti affari, prima o poi va a finire male. Anzi malissimo. E’ capitato a Matteo Renzi con il generale presidente Al Sisi, ora capita a tutti i leader europei con il Sultano atlantico Erdogan che sta trasformando la Turchia in una buia prigione. Nascondendo il fatto che il presidente golpista egiziano aveva le mani sporche di sangue, il presidente del Consiglio italiano ha sdoganato Al Sisi per primo, la ha riempito di elogi pubblicamente, ha intessuto con lui una rapporto preferenziale perfino amicale.
Ora non sa che dire di fronte al fatto che quel regime depista e nasconde le prove sul delitto di Stato di Giulio Regeni, fa dire che quella del Cairo è su questo una «collaborazione inadeguata», mentre in Egitto infuriano repressione, sparizioni violente, arresti e condanne a morte. Tanto che è stato incarcerato anche Ahmed Abdallah, attivista dei diritti umani e consulente della famiglia Regeni.
Sul fronte turco, hai voglia a prendersela con le malefatte «ottomane» del presidente turco. Siamo noi che andiamo alla sua corte a prendere lezioni di umanità, democrazia e rispetto delle libertà. Così ha fatto Merkel che è corsa ad Ankara dopo avere accettato la messa sotto accusa in Germania del comico Jan Böhmermann che si era «permesso» una canzoncina satirica su Erdogan. Al quale abbiamo prima attribuito il compito, tramite la coalizione degli «Amici della Siria» di destabilizzare la Siria coinvolgendola direttamente nel sostegno in armi e addestramento a tutta la galassia degli insorti anche jihadisti, compresi Al Nusra (Al Qaeda) e Isis.
Operazione riuscita a metà – non completamente come in Libia – ma con la devastazione di un altro Stato in Medio Oriente, con costi umani e sociali da apocalisse. Poi, di fronte alla tragedia di decine di milioni di profughi in fuga da quella guerra che anche noi abbiamo attivato, riconosciamo sempre ad Erdogan con tanto di elargizione di ben 6 miliardi, il ruolo di salvatore dell’Europa perché si trasformerà per noi con abile maquillage in «posto sicuro» dove, a nostre spese, continuerà ad accogliere la marea di disperati. Tutto, insomma, purché non arrivino a casa nostra.
Nell’Unione europea che nessuno riconosce più e che, invece che madre – secondo l’auspicio di papa Francesco – sembra, attorno ad una moneta, una camera di tortura disseminata di ostacoli e muri. La vicenda è smaccatamente sotto gli occhi di tutti, al punto che emerge perfino la coda di paglia di Matteo Renzi che dichiara, tra un tweet e l’altro, di essere preoccupato per la bontà dell’accordo della Ue con Ankara. Ma quando l’ha sottoscritto ignorava forse quello che tutti sapevano?
E il Sultano turco che fa? A ventiquattrore dalla defenestrazione del «troppo filo-occidentale» premier Davutoglu, punta ad una nuova Costituzione più presidenziale e autoritaria. E, nello stesso giorno in cui i due giornalisti del quotidiano di opposizione Cumhuryet, il direttore Cam Dündar e il caporedattore Erdem Gül, vengono condannati a 5 anni di galera per violazione del segreto di Stato per avere documentato e denunciato traffici di armi con i jihadisti in Siria; e nelle stesse ore in cui davanti al tribunale di Istanbul proprio Dündar subisce un attentato a mano armata perché «traditore», ecco che Erdogan dichiara con durezza all’Europa che lui non cambia le leggi antiterrorismo. Le stesse che il Consiglio d’Europa accusa di essere lo strumento per «reprimere le attività della società civile, asfissiare il legittimo confronto politico e il giornalismo investigativo».
Perfino gli Stati uniti denunciano gli stessi argomenti . Mentre aumentano i processi per «insulto al presidente» e la Turchia ha il triste primato del maggior numero di giornalisti in carcere. E mentre i leader della sinistra kurda sono minacciati di morte e le città kurde sono investite da una violenza repressiva senza pari, bombardate e sotto coprifuoco, che qui da noi non fa nemmeno notizia.
Il grande scrittore Orhan Pamuk ha lanciato in questi giorni un doloroso quanto impotente grido d’allarme: «Salvate Istanbul, viviamo nella paura». Il fatto è che il Sultano, islamista moderato, è anche il baluardo sud dell’Alleanza atlantica che tace su ogni repressione dei diritti civili in Turchia. Se la Turchia fosse investita da una legittima rivolta democratica, L’Unione europea sarebbe persa.
Così Erdogan tiene in scacco le cancellerie del Vecchio continente. Si avvia infatti a gestire per noi in appalto in nuovi universi concentrazionari (cioè campi di concentramento) la disperazione dei profughi. Vale a dire la vergognosa arroganza della fortezza Europa. Davvero non c’è più bisogno che Ankara entri nell’Unione. È al nostro «livello», l’integrazione è realizzata: i veri turchi siamo noi.

Il manifesto, 8 maggio 2016 (p.d.)
La bella e partecipata manifestazione della coalizione Stop-Ttip di ieri a Roma è stata anzitutto un bel momento di democrazia in una vicenda, quella delle trattative sul Partenariato transatlantico per il commercio e gli investimenti, avvolte finora in un alone di riservatezza e opacità al dibattito pubblico. Se i documenti resi noti da Greenpeace Olanda – 13 dei 17 capitoli di testo «consolidato» – hanno contribuito a far circolare l’informazione su una trattativa che riguarda un’amplissima serie di materie rilevanti per l’economia, l’ambiente e la società, la manifestazione conclusa a piazza San Giovanni per opporsi al Ttip è, anzitutto, una richiesta di maggiore democrazia e trasparenza.
E, dunque, il contrario di quello che si capisce dai documenti che rappresentano lo stato della trattativa com’era a fine marzo. Su alcune materie come quelle ambientali, i negoziatori americani fanno più volte riferimento alla necessità di avere un parere dalle associazioni industriali, come quelle della chimica, tra le più interessate ad allentare le norme europee che sono ben più restrittive di quelle statunitensi. L’interesse dell’industria prima di tutto.
Il regolamento Reach, che come Greenpeace avremmo voluto ancora più severo, è stato più volte additato da parte americana come un inutile intralcio al commercio: in Europa le sostanze chimiche vietate sono oltre mille, negli Usa una manciata. L’obbligo di etichettatura per prodotti contenenti Ogm com’è noto è un altro esempio. Il premio Nobel per l’economia Joseph Stiglitz ha messo da tempo in evidenza come il Ttip sia un modo per scavalcare le tutele europee per tutelare invece gli interessi di alcuni settori specifici dell’economia statunitense. L’agrochimica certamente è tra queste.
Il Presidente francese Hollande e il Cancelliere austriaco Faymann hanno rotto il fronte attaccando il Ttip. Oggi il ministro delle politiche agricole Maurizio Martina ha ribadito che non si abbasseranno mai le tutele in campo agroalimentare. Sarebbe carino che oltre a queste rassicurazioni se ne trovasse traccia anche nei testi, mentre in 248 pagine, ad esempio, non si trova mai citato il principio di precauzione, principio basilare nella normativa europea.
Come Greenpeace non siamo contrari agli accordi commerciali, purché siano garantite certe condizioni. Se, ad esempio, si mettesse insieme la parte migliore della normativa statunitense – ad esempio sulle emissioni di mercurio dalle centrali a carbone, sulle emissioni delle auto, sui composti chimici nei giocattoli dei bambini – assieme alla parte migliore delle norme europee, il quadro del dibattito potrebbe cambiare. I testi del trattato mostrano, al contrario, che la spinta statunitense è tutta dalla parte opposta ed è molto determinata.
Ma, proprio in questi giorni, Hillary Clinton in corsa per le presidenziali, rispondendo per iscritto a un gruppo di sindacati e associazioni ambientaliste ha ribadito che «mi oppongo all’accordo sul Ttp (quello trans-pacifico, ndr), sia prima che dopo le elezioni». L’intero approccio degli Stati uniti agli accordi commerciali va ripensato, aggiunge la Clinton.
Credo che dovremmo dire la stessa cosa noi dal versante europeo. E, certo, concludere trattati commerciali con gli Usa mentre i principali candidati alla prossima presidenza li attaccano appare un tantino bizzarro.
Sarebbe ora di fermarsi e consentire un dibattito più ampio e partecipato su che tipo di regole vogliamo avere negli scambi commerciali con gli Usa, e che tipo di futuro desideriamo per la nostra società e la nostra economia. Ma non sembra che partecipazione e democrazia siano in cima alle priorità di chi spinge, come il governo Renzi, per il Ttip.

« Il manifesto, 6 maggio 2016 (c.m.c.)
La recente pubblicazione di alcuni documenti sui negoziati in corso sul Ttip effettuata da Greenpeace ha riportato sui media il trattato di libero commercio tra Usa ed Europa. Tranne in alcuni momenti – in Italia solo quando sembra poter diventare una discussione che riporta al cortile di casa – tutto quanto sta accadendo intorno al Ttip non trova granché spazio nella discussione pubblica e politica.
L’argomento, in effetti, non è dei più semplici perché la volontà dei negoziatori (in primo luogo gli statunitensi) è quella di regolare il commercio del mondo occidentale all’interno di standard che da quel momento in poi saranno da considerarsi universali. O almeno in grado di regolare i rapporti tra quasi tutti gli Stati tranne, dicono i maligni, Cina e Russia, escluse, guarda il caso, da tutto questo movimento internazionale desideroso di «liberalizzazioni». Ci sono molti aspetti, inoltre, da cui discendono dei «no» talmente forti al trattato da aver coinvolto centinaia di associazioni e organizzazioni in mobilitazioni che trovano sfogo nelle piazze di molti paesi.
In Italia sabato 7 maggio ci sarà una manifestazione nazionale e per capire tutte le ragioni dei «no» e i motivi delle campagna di «Stop Ttip» sabato, in occasione delle proteste, sul manifesto ci sarà un inserto ad hoc di otto pagine. Nel frattempo è bene segnalare la letteratura che esiste circa le argomentazioni contro «i metodi» con i quali il trattato si sta portando avanti, oltre che contro il trattato stesso (se mai arriverà a compimento). In Ttip – L’accordo di libero scambio transatlantico, quando lo conosci lo eviti (Derive e Approdi, 13 euro), Paolo Ferrero, Elena Mazzoni e Monica Di Sisto, affrontano tutto quanto riguarda le ricadute economiche, sociali e politiche del Ttip. Partendo proprio dalla domanda di partenza: qual è l’obiettivo dichiarato del Ttip?
Gli autori del volume spiegano che il fine è «abbattere le differenze di normative tra le parti, differenze che sono considerate barriere non tariffarie al commercio e agli investimenti: l’idea chiave è che, riducendo queste differenze di regolamentazione, il commercio e gli investimenti aumenteranno con conseguente crescita economica». La prima constatazione è la convenienza di un percorso simile: a chi porterà dei vantaggi? «Un percorso simile potrebbe sfociare in un’enorme ingerenza sulla capacità degli Stati di legiferare nell’interesse dei cittadini, perché il Trattato crea delle costrizioni internazionali che, in modo evidente, vanno a influire sull’autonomia normativa delle parti».
Su questo la posizione dell’Europa – che in realtà qualche dubbio lo ha – non ha alcun tentennamento, come dimostrato dalla Commissaria al Commercio Ue, Cecilia Malmstrom quando ha specificato che «i due contraenti si impegnano, con l’accordo in fase di negoziazione, a eliminare le normative che impediscono al mercato transatlantico di essere armonioso».
Al di là dell’ironia dell’utilizzo della parola «armonia» (usata da Pechino per indicare la necessità di una società sottoposta al volere del Partito comunista), le parole di Malmostrom indicano una chiara volontà dell’Ue di appoggiare i piani tanto degli Usa quanto delle multinazionali, in favore dell’abbassamento di standard di qualità che finiscono poi per ripercuotersi in molti settori delle nostre vite future. In ballo non c’è tanto e solo la sovranità di uno stato, quanto le conquiste fatte nel corso del tempo in tema di diritti ambientali, del lavoro, dell’alimentazione. E soprattutto c’è la volontà di negoziare – come dimostrato dai leaks resi pubblici da Greenpeace – senza che la società civile sappia di cosa si sta discutendo, salvo poi assistere alla farsa dell’eventuale ratifica dei parlamenti nazionali completamente esclusi del resto dalle trattative. Gli autori del volume, in ogni caso, vanno oltre.
Mettiamo, sembrano dire, che tutto questo insieme di elementi generali (compreso quello che riguarda la risoluzione delle controversie tra Stati e aziende) non sia sufficiente per un «no» energico al progetto di Ttip, vediamo allora cosa succede nell’ambito numerico, economico, puramente di guadagno. Se il Ttip, ad esempio, portasse all’azzeramento «delle tariffe doganali e dei contingenti tariffari, le esportazioni agroalimentari degli Usa verso l’Ue aumenterebbero di 5,5 miliardi di dollari rispetto all’anno di riferimento (2011), mentre i livelli di esportazioni europee verso gli Stati uniti crescerebbero di 0,8 miliardi».
Questo accade perché l’Ue «attualmente impone barriere tariffarie più alte sulle importazioni di quanto non facciano gli Usa», ma se «oltre ai dazi, si rimuovono dal commercio transatlantico alcune specifiche misure non tariffarie, la situazione è destinata a cambiare di molto».
Ovvero, carne, colture, frutta e verdura: sono questi «gli ambiti più interessati da misure non tariffarie restrittive, e rimuoverle si tradurrebbe in un aumento delle esportazioni degli Usa verso l’Europa di ulteriori 4,1 miliardi». La crescita di esportazioni complessive degli Usa diventerebbero quindi di quasi 10 miliardi di dollari. Per l’Europa la rimozione delle misure non tariffarie si tradurrebbe in un guadagno di 1,2 miliardi. E al di là di questo: chi quantificherà i danni per la salute?

Il Fatto Quotidiano, 5 maggio 2016 (p.d.)
I politici non hanno smesso di rubare, hanno solo smesso di vergognarsi”. L’ha detto Piercamillo Davigo in un’intervista al Corriere della Sera, ripetendo una frase che è stata un grande classico in tanti suoi interventi pubblici negli ultimi anni. Si sono indignati i politici, ma non i cittadini. E comunque la cronaca sembra dargli ragione.
In una settimana abbiamo dovuto raccontare ai lettori de ll’arresto del sindaco di Lodi Simone Uggetti (Pd) per turbativa d’asta; dell’arresto di Antonio Bonafede, consigliere comunale del Pd a Siracusa, mentre stava per imbarcarsi su traghetto con 20 chili di droga; dell’indagine per concorso esterno in associazione mafiosa a carico del consigliere regionale e presidente del Pd in Campania, Stefano Graziano; dell’incredibile vicenda del Consiglio regionale della Sardegna, dove in cella si sono incontrati il vicepresidente del Consiglio regionale Antonello Peru (Forza Italia), arrestato per una vicenda di presunti appalti truccati, e Giovanni Satta (centristi) che quando è stato fermato pertraffico internazionale di stupefacenti ancora non era consigliere regionale. Lo è diventato – da detenuto – dopo che a seguito di vari ricorsi, l’ufficio elettorale della Regione gli aveva assegnato il seggio.
La questione morale incombe, è un’emergenza ormai cronica. Abbiamo chiesto a Gustavo Zagrebelsky com’è possibile che quelle affermazioni di Enrico Berlinguer (“I partiti sono soprattutto macchine di potere e di clientela. Gestiscono interessi, i più disparati, i più contraddittori, talvolta anche loschi, comunque senza alcun rapporto con le esigenze e i bisogni umani emergenti, oppure distorcendoli, senza perseguire il bene comune”), 35 anni dopo suonino così attuali.
Dalla politica ci dicono che la responsabilità penale è personale, che bisogna essere garantisti: i corrotti sono casi isolati, cioè singole mele marce. Cosa ne pensa?
La responsabilità penale è personale, ma la corruzione non è semplice illegalità individuale. Coinvolge necessariamente più soggetti, come dice la parola: la corruzione implica una cooperazione. I giuristi parlano di reato plurisoggettivo. Per vivere deve necessariamente allargarsi: i corruttori sono indotti a estendere progressivamente il raggio della corruttela per ottenere coperture e per questo moltiplicano le complicità dei corrotti che, a loro volta, diventano corruttori. C’è una forza diffusiva che la semplice illegalità di per sé non possiede. La corruzione è un sistema, non è la somma di singole illegalità. Esempio: se un contribuente fa una dichiarazione fiscale falsa, siamo di fronte a un’illegalità, che si può colpire processando l’evasore. Ma se il contribuente si mette d’accordo con il suo consulente fiscale, che si mette a sua volta d’accordo con la Guardia di Finanza e con l’Agenzia delle Entrate, tutto questo crea un sistema diffuso di corruzione.
Come le associazioni criminali.
Infatti. A differenza dell’illegalità, la corruzione crea ordinamenti alternativi a quelli legali. Per questo, mi pare riduttivo parlare di “questione morale”: siamo di fronte a una “questione istituzionale”. La mafia, per esempio, è una istituzione con regole interne, autorità di governo, agenti esecutivi e perfino tribunali. C’è una legittimità mafiosa che si contrappone alla legittimità dello Stato. Bisogna partire dal presupposto che si tratta di conflitti tra ordinamenti. È illusorio pensare che si possa sconfiggere la corruzione esclusivamente con processi che necessariamente perseguono i singoli. Come se si volesse vincere una guerra eliminando, uno ad uno, i combattenti dell’al traparte, mentre i caduti sono sostituiti da nuove leve e i ranghi si rigenerano. Gli ordinamenti si sconfiggono con guerre d’altro tipo; innanzitutto stabilendo una linea di demarcazione netta, un fronte, tra chi sta di qua e chi di là, cioè combattendo la “zona grigia”di chi sta un po’di qua e un po’di là.
Però la selezione della classe dirigente è affidata, non da oggi, al diritto penale. Ma la verifica penale non ha questa finalità, né il giudice è un’autorità morale.
I giudici svolgono i loro compiti con riguardo a singoli fatti e singoli autori dei fatti. Il conflitto tra ordinamenti non può accontentarsi d’una delega ai giudici. Coloro che si richiamano non ipocritamente alla legalità devono innanzitutto selezionare una classe politica priva di commistioni con l’altro ordinamento, mettendo confini invalicabili tra vita e malavita. Questo non può farlo la magistratura. Soprattutto in un momento come questo in cui tutti gli indizi portano a dire che il mondo della politica è estesamente penetrato dalla corruzione: significa che tra questi due opposti ordinamenti oggi non c’è conflitto, ma connivenza. O, addirittura, che s’è creato un meta-ordinamento diffuso, basato sulla convivenza.
Quali sono, allora, i rimedi?
Non possono essere solo le armi giudiziarie. Che ci devono essere, ma non sono risolutive. Mi chiedo, poi, se esiste davvero la volontà di combatterla, la corruzione. Scoppia uno scandalo e qual è la reazione? Se pur non si accusa la “giustizia a orologeria”, si esprime “piena fiducia nella magistratura”; ci si trincera dietro al “fino alla condanna definitiva nessuno può considerarsi colpevole”; si ritorce l’accusa: anche voi avete i vostri corrotti. Tutto ciò mi pare dimostri una fondamentale ambiguità ai limiti dell’a cquiescenza. La delega ai giudici è uno sfuggire alle proprie responsabilità; la ritorsione dell’accusa significa considerare la corruzione non un problema di integrità di sistema ma un’occasione per una gara a chi è più o meno corrotto. Così, si finisce per adagiarsi. Il vecchio discorso “tutti colpevoli, nessun colpevole”significa “siamo tutti sulla stessa barca”. Per non affondare tutti insieme, dobbiamo darci una mano ed essere tolleranti, gli uni verso gli altri. Mi chiedo se i nostri politici che usano questi argomenti si rendano conto del senso di quello che dicono. Credo di no.
Nel 2014 su 1100 consiglieri regionali, 521 erano sotto inchiesta; per 300 era stato chiesto il giudizio per spese pazze con i fondi ai gruppi.
Spesso sono quisquilie, disgustose ma quisquilie per le quali ben venga la repressione penale. Più preoccupanti sono le reti di connivenze che fanno capo a faccendieri e lobbisti vari, massoneria affaristica, finanza laica e vaticana, giornalismo al soldo, ecc. Questa è la potentissima rete della corruzione che tocca interessi finanziari, industriali, della comunicazione, degli armamenti, nazionali e internazionali. Che cosa c’è dietro, per esempio, al fatto che in Parlamento non si è potuto discutere dell’acquisto degli F-35? In una parola, la corruzione alligna nelle oligarchie. Per combatterla davvero, ci vuole democrazia.
Vero, ma la riforma costituzionale non va in direzione opposta, garantendo immunità a politici regionali tutt’altro che insospettabili e promossi senatori?
Il Senato dei 100 è un pasticcio in sé e una catastrofe funzionale: altro che semplificazione. L’immunità parlamentare nella storia della Repubblica ha subìto un rovesciamento. In origine proteggeva la libertà della funzione parlamentare. Oggi, spesso serve a proteggere il parlamentare. Cioè: mentre una volta si era protetti perché ci si dava alla politica, oggi ci si dà alla politica perché si vuole essere protetti. Insomma, in diversi casi il titolo preferenziale per essere messo in lista è stato avere grane con la giustizia. Sarà così anche per i nuovi senatori?
Il presidente emerito Napolitano ha citato voi “professori del no” in un’intervista al Corriere: “Vedo tre diverse attitudini. Quella conservatrice: la Costituzione è intoccabile. Quella politica e strumentale: si colpisce la riforma per colpire Renzi. E quella dottrinaria ‘per fezionista’. Dubito che tutti i 56 costituzionalisti e giuristi che hanno firmato il manifesto contro siano d’accordo su come si sarebbe dovuta fare la riforma. Ma è una posizione insostenibile: perché il No comporterebbe la paralisi definitiva”. Vuole rispondere?
Vincenzo Cuoco – commentatore della rivoluzione napoletana del 1799 – diceva che le Costituzioni sono abiti che devono essere indossati da un corpo. Questo corpo è ciò che chiamiamo la Costituzione materiale, fatta di convinzioni politiche, tradizioni, comportamenti, rapporti e anche di corruzioni. Le costituzioni non sono belle o brutte in sé, ma sono adatte o inadatte al corpo che deve indossarle. Se il corpo è quello della statua modellaria di Prassitele – diceva Cuoco –la Costituzione indossata farà una bella figura. Ma se il corpo è deforme, l’abito servirà soltanto a coprire le deformità. Non si corregge il corpo con la veste. A differenza del presidente Napolitano, penso che, parlando di conservatori, perfezionisti e innovatori, si finisce per perdere di vista la vera posta in gioco: le degenerazioni della vita politica materiale, degenerazioni che non si combattono, ma si occultano soltanto mettendo loro sopra una veste nuova. Il cosiddetto “combinato disposto” della legge elettorale e della riforma costituzionale è per l’appunto questa veste nuova, sotto la quale si nascondono tendenze, da tempo in atto, a separare la politica dalla partecipazione dei cittadini e ad accentrarla in centri di potere sospesi per aria o appesi in alto. La chiamano democrazia perché ogni cinque anni ci faranno votare? Ma votare su che?
In verità lei una proposta di riforma l’ha formulata.
Sì. L’ho inviata alla ministra Boschi, come si era concordato. Ma è sparita. Anche il presidente Napolitano l’ha ricevuta, ma era assai diversa da quella ch’egli sosteneva e sostiene. Così è stato un buco nell’acqua. Solo mi dispiace che si dica che chi è contrario a questa riforma non ha saputo e non sa proporre nulla di alternativo. È vero il contrario. Per onore della verità.
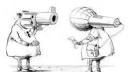
Il manifesto, 4 maggio 2016 (p.d.)
Ieri si celebrava la Giornata Mondiale per la Libertà di Stampa, occasione per buttare un occhio all’ultimo rapporto di Reporter Senza Frontiere. Pubblicato 10 giorni fa, il World Press Freedom Index regala all’Italia uno schiaffo in faccia: siamo messi peggio della Moldavia, scivolati in un anno dal 73° al 77° posto della classifica mondiale. In Europa facciamo meglio solo di Bulgaria, Grecia e Cipro.
Ai primi posti stanno i soliti noti: Finlandia, Olanda e Norvegia. In fondo Turkmenistan, Corea del Nord e Eritrea. Vanno male i paesi in conflitto, che si tratti di guerre civili come la siriana o la yemenita, in cui le informazioni si confondono con la propaganda, o di avanzate di gruppi terroristici, Boko Haram in Nigeria e al Shabaab in Somalia tra gli altri; e i governi che spiano imperterriti i propri cittadini, Russia e Stati Uniti.
E vanno male quelli che in questo periodo sono sotto i riflettori del Vecchio Continente: la Turchia del presidente-sultano Erdogan che tiene dietro le sbarre oltre 30 reporter (per lo più kurdi) e l’Egitto del golpista al-Sisi che mette a tacere le voci critiche con la consolidata pratica delle sparizioni forzate. Non a caso i redattori del quotidiano turco Cumhuriyet Dundar e Gul e il giornalista egiziano Shawkan (per la cui scarcerazione si è mossa anche la famiglia Regeni) sono tra i 9 reporter che ieri Amnesty International ha preso a modello delle abusi contro la stampa.
In generale, registra Rsf, la situazione peggiora ovunque: «Tutti gli indicatori della classifica mostrano un deterioramento – spiega il segretario generale Deloire – Molte autorità temono che il dibattito pubblico sia troppo aperto». Nel caso italiano, le ragioni dell’arretramento le spiega lo stesso Rsf: il caso Vatileaks e le conseguenze giudiziarie subite dai giornalisti Nuzzi ed Fittipaldi che hanno reso note informazioni nascoste dietro il portone di San Pietro.
Si potrebbe scorrere tutto l’indice, arrovellarsi per capire perché El Salvador e Burkina Faso occupano posizioni sicuramente più prestigiose (38° e 42° posto). Si potrebbe studiare il meccanismo dietro l’indice di Reporter Senza Frontiere, giudicato poco veritiero perché per l’80% fondato su percezioni soggettive più che su dati assoluti.
C’è del vero dietro il giudizio tranchant di alcuni media che nei giorni scorsi hanno pubblicato il rapporto. Si parte da un questionario compilato da associazioni e giornalisti chiamati a dare un punteggio da 1 a 10 su legislatura, autocensura, pluralismo, indipendenza, trasparenza e infrastrutture. I voti vengono poi calcolati sulla base di una particolare formula matematica. Poi si utilizzano dati assoluti: numero di giornalisti arrestati, minacciati, licenziati, uccisi. Valori che pesano meno dei giudizi personali, spesso prodotto del contesto nazionale.
In Italia, però, si potrebbe anche fare autocritica. E dirci che se siamo tra i paesi occidentali meno liberi in campo mediatico forse un motivo c’è. Da noi del resto la condizione di lavoro di migliaia di giornalisti è senza contratto, freelance che spesso freelance non sono perché lavorano nelle redazioni, siedono a fianco dei colleghi contrattualizzati, fanno lo stesso mestiere, a volte seguono un intero settore.
Sono tanti: secondo i dati 2014 dell’Lsdi, oltre il 62% dei giornalisti attivi sono autonomi, 31mila contro 18mila subordinati. Il restante 38%, da dipendente, può guadagnare 5 volte più di un freelance. Sono tanti e di tanti tipi: dai giovani disposti ad accettare retribuzioni basse o collaborazioni gratuite a chi ha esperienza di decenni ma si ritrova disoccupato per la chiusura del proprio giornale. Secondo la Federstampa, la gran parte dei precari (il 75%) non supera il traguardo dei 10mila euro l’anno. Di questi il 62% è sotto la soglia dei 5mila.
Forse scendiamo nella classifica perché è difficile parlare di informazione libera e indipendente quando chi lavora nelle redazioni – che siano quotidiani, tv, radio o agenzie web – è sottopagato e spogliato dei propri diritti. Quindi ricattabile. A uscirne malconcio è un intero sistema che si fonda su giornalisti che mettono insieme uno stipendio – o no – a seconda degli articoli pubblicati ogni mese. Ed è ovvio che di tempo per inchieste, per il mito del giornalismo investigativo, per chiedere diritti ne resta poco.
 «La democrazia negata si può restaurare proprio a colpi di democrazia: ovvero di informazione e di spazi di confronto. Come quello che si aprirà a Roma il 7 maggio.».
«La democrazia negata si può restaurare proprio a colpi di democrazia: ovvero di informazione e di spazi di confronto. Come quello che si aprirà a Roma il 7 maggio.».
LaRepubblica, 4 maggio 2016 (c.m.c.)
Il Ttip è nudo! Qualcuno è riuscito a pubblicare quasi tutte le carte di un trattato importante tra due continenti che pochi tecnocrati, con appoggi governativi, cercavano di nascondere nelle segrete stanze. Finalmente sappiamo di che stiamo parlando e la realtà è ben peggiore delle peggiori previsioni. Le turbolente vicende relative ai negoziati sul Ttip confermano alcuni segnali poco consolanti, ma ci danno anche qualche speranza.
Le brutte notizie, a dire il vero, già le conoscevamo:
1) I cittadini, a volte, devono difendersi dalle istituzioni: questo non era nell’idea di democrazia. Non era nei patti che una Commissione Europea di “nominati” si svincolasse dichiaratamente dalla volontà dei cittadini che eleggono il Parlamento Europeo, arrivando ad accettare modalità di negoziazione che ostacolano l’accesso dei parlamentari ai documenti. Così ci hanno pensato i cittadini, e nella fattispecie Greenpeace, a pubblicare il testo di quel trattato segreto. Non è così che dovrebbe funzionare.
2) L’arroganza del mercato e dei suoi alfieri si concentra su velocità e facilità degli scambi trascurando l’oggetto: armi, pane o informazioni, è uguale, purché sia tutto rapido e uniforme. Questo è di una stupidità straordinaria, è la vecchia metafora del treno che va sempre più veloce senza che i passeggeri possano sapere dove vanno e chi sta guidando, né chi li ha messi su quel treno. Con il Ttip questa logica ha raggiunto il suo massimo splendore: “armonizziamo” gli standard, ci dicono, così gli scambi aumenteranno, di ritmo e di numero.
“Abbassiamo le barriere non tariffarie” così facilitiamo il commercio tra Europa e Stati Uniti. Ma il commercio di cosa? Con quali benefici pratici per le comunità? Fa lo stesso: l’importante è che le merci corrano per il pianeta senza intralci che si chiamano “normative”. Che fastidio dover pianificare gli affari evitando di calpestare i diritti, di ammalare le persone e di inquinare l’universo.
3) L’intralcio principale è, in fin dei conti, il sistema democratico. Che prevede che i rappresentanti eletti dalle popolazioni coinvolte dicano la loro in situazioni come queste. Ma se si fa così non si va avanti, avranno pensato i tecnici ai quali è stato affidato (da chi?) il compito di scrivere il trattato. Invece la democrazia si costruisce poco alla volta, si riconsolida ad ogni passaggio. La democrazia europea tra mille difficoltà, ha costruito le normative che ora paiono d’intralcio alle multinazionali. Perché, come ci diceva il buon Pericle cinque secoli fa «il nostro governo favorisce i molti invece dei pochi: e per questo viene chiamato democrazia». Le multinazionali sono poche. I cittadini sono molti.E veniamo alle buone notizie.
1) Non è vero che gli interessi degli statunitensi sono diversi da quelli degli europei. Di più: non è vero che gli imprenditori, e in particolare quelli agricoli, degli Usa sono tutti di grande scala e dediti alle monoproduzione, mentre quelli europei sono tutti piccoli e multifunzionali. La differenza semmai sta nell’interesse alle esportazioni intercontinentali. Ma attenzione: quando si parla di cibo e di vino di qualità, si fanno affari oltreoceano anche restando piccoli; l’importante è mantenere alta la qualità. La quale è tutelata dalle normative- intralcio.
2) Lo stesso senso di condivisione pervade i consumatori, da entrambe le parti dell’oceano. Sembra proprio che, grazie a questo tentativo di patto scellerato, finalmente le popolazioni si riscoprono parte della medesima comunità di destino, parte di un sistema planetario che deve innanzitutto difendere la qualità della propria vita.
3) Infine la migliore di tutte: nonostante gli spudorati tentativi di tenere il dibattito il più lontano possibile non dico dalle piazze, ma addirittura dai Parlamenti legittimamente in carica, le parrocchie, le librerie, le università, le associazioni si son fatte sentire e stanno cambiando di fatto gli equilibri: per quanto ancora verranno ignorate?
La democrazia negata si può restaurare proprio a colpi di democrazia: ovvero di informazione e di spazi di confronto. Come quello che si aprirà a Roma il 7 maggio. Spero che sia una manifestazione che si realizzerà in una grande partecipazione dei cittadini italiani perché siamo tutti cittadini del mondo e gli “uomini di buona volontà”, quelli che lavorano per il bene comune, sono dappertutto, e parlano la stessa lingua.

greenMe.it, rilanciato da Comune-info, 03 maggio 2016 (p.d.)
Saber Hosseini è un maestro di scuola che vive in Afghanistan nella località di Bamyan. I bambini che vivono nelle aree più remote del Paese non hanno la possibilità di andare a scuola né di accedere alla cultura, all’istruzione o a una biblioteca.
Ecco allora che questo maestro che ha davvero a cuore i bambini ha deciso di raggiungere in bici le località più povere dell’Afghanistan per portare dei libri da leggere ai bambini. Durante la settimana il maestro lavora in una scuola mentre nel weekend raggiunge i bambini che non possono frequentarla per dare loro in prestito dei libri.
All’incontro successivo i bambini possono restituire i libri già letti e prenderne in prestito degli altri, In questo modo la cultura entra in circolazione gratuitamente tra i più poveri. L’impegno del maestro è ormai ben noto in Afghanistan e la sua iniziativa è molto apprezzata soprattutto da chi non avrebbe mai la possibilità di acquistare un libro.
Esistono diversi modi per mostrare solidarietà ai bambini e alle persone in difficoltà. Grazie alla sua iniziativa il maestro ha distribuito centinaia di libri per rendere felici i bambini e per fare in modo che potessero accedere alla lettura.
Non tutti purtroppo nel mondo hanno questa opportunità e dobbiamo ritenerci davvero fortunati nell’avere sempre a disposizione dei libri da prendere in prestito nelle biblioteche o da acquistare nelle librerie.
Il maestro ha scelto la bicicletta e i libri come un vero e proprio simbolo per dimostrare che possiamo sostituire la violenza con la cultura. La produzione di libri in Afghanistan è molto limitata dunque quelli distribuiti dal maestro di solito sono importati dall’Iran. Si tratta soprattutto di versioni semplificate delle opere di Victor Hugo, Jack London, Saint-Exupery e di poesie e racconti di scrittori iraniani.
Ogni volta che il maestro porta dei libri ai bambini cerca di parlare con loro e di proporre un argomento che può essere utile per la loro istruzione. Quando arriva nei villaggi trova sempre un gruppo di bambini pronto ad ascoltare una lettura o una piccola lezione.
Siamo davvero colpiti dall’impegno del maestro che gratuitamente porta cultura, libri e un raggio di speranza ai bambini che si trovano in difficoltà. Servirebbero più persone così anche in altre zone del mondo.
Guardate il video per approfondire la sua storia.

Comune-info, 3 maggio 2016 (p.d.)
Il Trattato di libero scambio transatlantico (Ttip) è stato uno dei temi centrali affrontati all’incontro di Hanover (Germania) del 25 aprile tra la Merkel, Obama, Hollande e Renzi. “Da un punto di vista europeo – ha detto Angela Merkel – il Ttip è assolutamente utile per far crescere la nostra economia. È un bene per quella tedesca e per tutta l’Europa. Dobbiamo far presto”. È questo il pensiero non solo di Merkel, ma anche di Obama e di Renzi, che vorrebbero che il Trattato fosse firmato entro l’estate.
Il Ttip è conosciuto come “il più grande trattato della storia”, perché se verrà approvato, legherà gli Usa e l’Unione europea coinvolgendo circa 820 milioni di persone e abbracciando un’area che produce circa il 45 per cento del Pil mondiale. E costituirebbe la più grande area mondiale di libero scambio. Le trattative per creare il Ttip sono partite in tutta segretezza nel luglio 2013 a Washington e sono condotte da pochi esperti della Commissione europea e del ministero del Commercio Usa: è un negoziato stipulato senza la partecipazione dei cittadini. È un vero e proprio golpe da parte dei poteri economico-finanziari che governano il mondo.
Infatti il Trattato indebolisce il “principio di precauzione” vigente in Europa , in relazione ai nuovi prodotti, elimina le sanzioni in caso di abusi relativi ai diritti sociali e ambientali e mira a una progressiva privatizzazione di tutti i servizi pubblici (il Ttip, infatti spiana la strada per l’altro trattato in arrivo, il Tisa – Accordo sul commercio dei servizi -, che vuole privatizzare tutti i servizi pubblici). Ancora più grave è il fatto che il Ttip introduca le corti arbitrali private per le dispute investitori-stati (il cosidetto Isds): un meccanismo che – seppure nelle correzioni addotte come compromesso al ribasso del gruppo socialista nel Parlamento Europeo – subordina tuttora i diritti umani alla prevalenza delle imprese e del mercato (Francesco Martone)”.
Il Ttip avrà inoltre pesanti ricadute sul mondo del lavoro aggirando le norme dei diritti dei lavoratori, svuotandone le normative per la loro protezione, ma anche ridimensionando il diritto di contrattazione collettiva. Il Trattato mina poi alla base il “principio di precauzione” aumentando i rischi per la salute alimentare. "Il Ttip – dice Susan George – è un assalto alla democrazia, alla classe lavoratrice, all’ambiente. L’unica risposta possibile dinanzi a questo attacco è alzarsi dal tavolo, chiudere le porte e lasciare la sedia vuota".
Infatti ci sono mobilitazioni contro il Ttip in tutta Europa e negli Usa: il 24 aprile ben novantamila persone sono scese in piazza ad Hanover. Sono molti i sindaci e i governatori di regioni che in Europa, come anche in Italia, hanno aderito alla campagna: "Fuori Ttip dalla mia città".

«». LaRepubblica, 1 maggio 2016 (c.m.c.)
La campagna elettorale per il referendum costituzionale, già cominciata da tempo, ha avuto una forte e prevedibile accelerazione dopo i risultati del referendum sulle trivelle. E dalle polemiche e dai conflitti di questi giorni già vengono indicazioni che consentono di avanzare ipotesi sui caratteri che assumerà la campagna elettorale e sugli effetti che via via si produrranno nel sistema politico-istituzionale.
Si deve partire da una constatazione. I referendum sono un gioco a somma zero, un sì contro un no, un vincitore e un vinto, e quindi il conflitto è nella loro stessa natura. Fatta questa ovvia constatazione, si tratta poi di stabilire per ciascun referendum come si strutturi concretamente il conflitto, con quali caratteristiche e intorno a che cosa. E, facendo questo, si scopre che i referendum possono incidere sul funzionamento del sistema politico al di là della conferma o dell’abrogazione di una legge. Più d’una volta, negli anni passati, si è ritenuto che un voto referendario potesse avere un effetto destabilizzante del sistema politico al punto tale che, pur di evitarlo, in alcuni casi si è preferito sciogliere le Camere.
Considerando le ultime vicende, i critici dell’utilità del voto sulle trivelle hanno insistito sul fatto che ben cinque dei sei quesiti predisposti dalle regioni avevano trovato una risposta positiva da parte del governo, sì che non valeva più la pena di andare a votare su un caso residuale. Valutazioni a parte su questo giudizio, questa vicenda mostra come una semplice richiesta referendaria possa modificare l’agenda politica, stabilire priorità. Inoltre, la mobilitazione sociale necessaria già al momento della raccolta delle firme può dare origine ad un vero e proprio movimento, a forme di intervento alle quali i cittadini ricorrono quando appaiono chiusi gli altri canali di partecipazione politica.
Questo sfaccettarsi delle funzioni del referendum diviene ancor più evidente se si considera l’imminente referendum costituzionale. All’abituale polarizzazione referendaria, infatti, si è questa volta aggiunta una chiara personalizzazione del voto perché, con l’annunciata decisione di dimettersi in caso di bocciatura della riforma, il presidente del Consiglio ha ormai trasformato l’occasione referendaria in un vero e proprio voto di fiducia.
Si può dire, ed è stato detto, che un governo, se attribuisce una particolare importanza ad alcuni suoi provvedimenti, ben può ritenere che la loro cancellazione impedisca la prosecuzione della sua azione, annunciando preventivamente ai cittadini questa sua intenzione. Ma questo referendum non riguarda l’indirizzo politico di maggioranza bensì, come è giusto dire, una massiccia riscrittura delle regole del gioco, con una modifica della forma di governo e del contesto democratico definito dalla Costituzione. Lo ha messo in evidenza efficacemente Romano Prodi, ricordando che «le riforme costituzionali debbono durare molto e non possono essere mirate solo all’interesse di chi possiede la maggioranza del momento».
Il riferimento ai soli interessi della maggioranza è, alla lettera, quello che si trova nelle pagine di Hans Kelsen dedicate alla virtù fondativa del «compromesso », dove si sottolinea che esso «fa parte della natura stessa della democrazia » e consiste, in primo luogo, nel risolvere «un conflitto mediante una norma che non è totalmente conforme agli interessi di una parte, né totalmente contraria agli interessi dell’altra». Chi ha memoria della nostra storia costituzionale, cosa ben diversa dai troppi richiami sgangherati ai lavori dell’Assemblea costituente fatti in questo periodo, ricorda che di un “compromesso costituzionale” si è molto parlato, anche con toni critici, ma in definitiva riconoscendo la saggezza politica dei costituenti che, attraverso un confronto serrato, erano giunti a sintesi assai elevate, garantendo l’alta qualità della Costituzione.
Si dice che bisogna discutere nel merito la riforma sottoposta al voto. Ma non vi è merito più importante e ineludibile della valutazione della logica che la ha guidata e di quale risultato, in termini di democrazia, sia stato raggiunto. È bene ricordare, allora, che nel corso dell’iter parlamentare, e in particolare in occasione delle audizioni di molti studiosi, proprio sul punto centrale della nuova disciplina del Senato vi erano state proposte assai circostanziate di modelli che avrebbero evitato non solo il pasticcio attuale, ma avrebbero consentito una soluzione davvero innovativa, con effetti di seria semplificazione e mantenimento di equilibri costituzionali che, soprattutto se si tiene conto dell’intreccio con la nuova legge elettorale, vengono invece pregiudicati. Il buon “compromesso democratico” è lontano, e di questo si dovrà discutere.
Ma il riferimento alla democrazia torna, in maniera ancor più impegnativa, quando si constata che siamo di fronte al passaggio da una democrazia rappresentativa ad una democrazia d’investitura, dunque ad un mutamento della forma di governo. Ancora una ineludibile questione di merito, se appena si considera che la sentenza della Corte costituzionale che ha cancellato il “Porcellum” è sostanzialmente fondata sulla constatazione che non veniva garantita proprio la rappresentanza dei cittadini. E questo non è tema che riguarda il passato, perché la Corte costituzionale dovrà occuparsi della legittimità dell’Italicum, contestata con argomenti che sottolineano come anche questa nuova legge elettorale sia viziata da un deficit di rappresentanza (e contro l’Italicum si stanno anche raccogliendo le firme per un referendum abrogativo).
Vero è che ad ottobre non si voterà sulla legge elettorale. Ma è evidente che la discussione investirà anche questo aspetto della strategia istituzionale del governo, come peraltro sta già avvenendo, perché la stessa riforma costituzionale evoca il tema del potere dei cittadini con le nuove norme sui referendum e sulla iniziativa legislativa popolare, in sé deboli e comunque inadeguate per costituire un contrappeso ad un accentramento del potere che mette la maggioranza nella condizione di poter vanificare le iniziative popolari (altra cosa è la democrazia partecipativa considerata anche nella dimensione digitale).
Giustificato con l’argomento della semplificazione delle procedure di decisione (realizzata invece in forme confuse e contraddittorie), il moto ascendente del potere, la sua concentrazione in poche mani pongono chiaramente una questione di democrazia, già evidente in alcune inquietanti prassi dell’attuale governo, o per meglio dire del presidente del Consiglio. Il giudizio degli elettori riguarderà inevitabilmente tutti questi aspetti della questione, che oggi si presenta con i tratti di una democrazia messa sotto tutela.
Diventa fondamentale, allora, il contesto nel quale si svolgerà la campagna elettorale. Uno storico come Emilio Gentile ha appena pubblicato un libro dal titolo “Il capo e la folla”, che riprende un tema trattato nel 1895 da Gustave Le Bon, analizzando “la psicologia delle folle”. La ricostruzione dei rapporti tra il leader e le masse, la personalizzazione del potere ci portano ai giorni nostri, che conoscono il pieno dispiegarsi di quella che Abramo Lincoln chiamò la “democrazia recitativa”. Varrà la pena di tornare su questo tema. Ma, considerando la campagna elettorale, bisognerà garantire subito che la “recita” non sia riservata ad un numero ristretto di personaggi. Questo chiama in causa particolarmente la televisione pubblica, ma implica una responsabilità dell’intero sistema informativo. Una questione di democrazia, che si aggiunge alle altre appena ricordate.

Articoli di Riccardo Chiari e Francesco Ditaranto
Il manifesto, 30aprile 2016
A PISA IL MANGANELLO DAY
di Riccardo Chiari
“Che strana questa brillante modernità renziana. Si parla tanto di internet e innovazione, poi si continua ad usare il vecchio manganello”. Il commento di Tommaso Fattori fotografa bene quanto accaduto per ore nel lungo viale che costeggia il Cnr, con le ripetute, violente cariche della celere ai danni di un corteo di protesta organizzato nell’Internet day. A Pisa era arrivata la ministra Giannini, ospite del Centro nazionale ricerche per una iniziativa in ricordo del primo collegamento internet partito qui trent’anni fa. Mentre Matteo Renzi, che pure era annunciato, era rimasto a Roma. In sua assenza, l’ospite d’onore della giornata è stato, appunto, il manganello.
Il corteo, autorizzato, era partito pochi minuti dopo le 10 da piazza XX Settembre. In testa gli studenti medi e universitari, e fra il migliaio abbondante di manifestanti il comitato locale “Vittime del salvabanche”, altri comitati cittadini come quello del popolare Quartiere Cep, delegati e simpatizzanti dei sindacati di base Usb e Cobas, e attivisti delle variegate realtà della sinistra pisana. “Vogliamo arrivare al Cnr – raccontavano i manifestanti – è un pezzo della nostra città e della nostra storia. Ci devono ascoltare”.In realtà tutta l’area intorno al Cnr era stata considerata come “zona rossa”, e naturalmente l’accesso al Centro era stato vietato a chiunque avesse, anche solo lontanamente, l’idea di contestare il governo. Intanto lungo il tragitto i manifestanti scandivano slogan ed esponevano striscioni, fra questi spiccava: “Non accettiamo che Renzi festeggi il paese dove 6 milioni di persone vivono nella povertà”.
Una volta arrivato alla rotonda fra via Luzzato e via Volpi, con alle spalle i giardini pubblici, il corteo è stato bloccato dalla celere in assetto antisommossa. “Andate ad arrestate il Pd campano – hanno reagito i manifestanti – non i lavoratori”. E dopo alcuni lanci di uova e ortaggi è bastato che un uomo si staccasse dal corteo, per spingere lo scudo di plexiglass di un agente, per far partire le prime cariche. Molto violente.
Grazie a internet, le immagini girate dagli smartphone dei manifestanti e dalle telecamere dei videoreporter sono andate in tempo reale in rete. Comprese quelle girate da un giovane videocronista del gruppo Espresso-Repubblica, manganellato al volto mentre stava riprendendo. “Sono state almeno tre cariche a freddo – riepilogava Sebastian Parenti del comitato Quartiere Cep a Rai News 24 – anche a gente anziana. Hanno colpito indistintamente tutti, mentre stavo alzando un ragazzo da terra mi sono venuti addosso in cinque e mi hanno trascinato via”.
Un altro manifestante segnalava l’assenza del presidente del consiglio: “Ha paura. Avrebbe dovuto essere qui in un evento che celebrava la rete, quando la rete è proprio il nemico giurato di Renzi, che scappa. Il ‘Ciaone’ degli esponenti del Pd lo rispediamo al mittente. Ciaone Renzi, che ormai non si presenta a interventi pubblici”. Nel mentre, con il corteo rimasto fermo nei giardini sempre fronteggiato da alcune decine di agenti, venivano curati alcuni ragazzi feriti alla testa dalle manganellate.
Nonostante il tentativo di accreditare ai manifestanti la responsabilità delle cariche, l’Associazione stampa toscana e il Gruppo cronisti toscani hanno denunciato: “Siamo consapevoli dei rischi, anche fisici, che si corrono seguendo gli avvenimenti di cronaca. Ma ci rivolgiamo anche alle forze dell’ordine, chiedendo quantomeno attenzione e tutela per chi si trova sul posto a svolgere la propria attività professionale”. Tira le somme Fattori, consigliere regionale di Toscana a Sinistra: “Dice Renzi che si tratta di scontri ‘incomprensibili’ e in effetti sono incomprensibili. Il fatto è che Renzi deve chiederne conto ai responsabili del disordine pubblico, dato che una ragione per manganellare i manifestanti proprio non c’era”.
NO AL CORTE DI LOTTA STUDENTESCA A MATERA
NEL GIORNO DELLA FESTA DEI LAVORATORI
di Francesco Ditaranto
Salvo ripensamenti dell’ultimo minuto, al momento improbabili, da parte delle autorità, il 1° maggio la città di Matera sarà teatro della sfilata di Lotta Studentesca, costola giovanile del movimento d’estrema destra Forza Nuova.
La notizia ha cominciato a circolare sui social network nei giorni scorsi, scatenando un’aspra polemica nella città lucana. In poche ore, è stata lanciata una petizione online per ottenere che la manifestazione fosse vietata. Per i cittadini che, a vario titolo, sotto l’insegna Matera Antifascista e non solo, stanno chiedendo di bloccare l’iniziativa, si tratta di un’intollerabile provocazione di matrice neo-fascista. Matera non è soltanto la capitale europea della cultura 2019, dunque una grandissima vetrina mediatica, ma rappresenta la prima testimonianza nel Mezzogiorno di sollevazione contro gli occupanti nazisti. Quella insurrezione, avvenuta il 21 settembre del ’43, valse alla città il conferimento della Medaglia d’Argento al Valore Militare. E come ogni anno, lo scorso 25 aprile, le autorità locali hanno ribadito quale fondamentale importanza abbia la Resistenza nella cultura democratica della città.
Eppure, nelle ore seguenti alla celebrazione ufficiale della Liberazione, si è consumato un corto circuito politico. La minoranza di centrosinistra ha presentato, in Consiglio Comunale, un ordine del giorno che stigmatizzava l’ipotesi di un corteo dell’estrema destra, e chiedeva al sindaco De Ruggieri di adoperarsi con le autorità competenti per scongiurare lo svolgimento di una manifestazione incompatibile con i valori della Festa dei Lavoratori. L’ordine del giorno, però, non è stato votato perché mancava il numero legale. Ma nella maggioranza (particolarmente composita per sensibilità e percorsi politici) c’è chi non ci sta.
I consiglieri che si richiamano a una tradizione di sinistra e sindacale, hanno ribadito nuovamente, nelle ultime ore, la necessità di dare priorità al valore del 1° maggio, quando in questione ci sono principi universalmente riconosciuti e costitutivi della democrazia repubblicana. Facile leggere, tra le righe, un invito, innanzitutto al sindaco, ad assumersi le sue responsabilità.
Dal primo cittadino, tuttavia, è giunta una risposta che appare vaga ai più, nella quale si conciliano i riferimenti all’importanza delle lotte dei lavoratori con quelli al diritto a manifestare come elemento imprescindibile della nostra Costituzione. Questo richiamo al diritto di esprimere le proprie opinioni, riferiscono quanti hanno partecipato giovedì a un sit-in sotto la Prefettura, ricevuti poi in delegazione proprio dal Prefetto, sarebbe all’origine della decisione di permettere lo svolgimento della sfilata, che si terrà abbastanza lontano dal centro città.
Antifascisti e sindacati celebreranno, invece, la Festa dei Lavoratori con un concerto in una piazza del centro storico. In un clima teso, questa mattina si dovrebbe tenere una seduta del Consiglio Comunale, che in molti sperano possa produrre, finalmente, una presa di posizione ufficiale alla vigilia della sfilata dell’estrema destra.
Riferimenti
Mario Scelba è stato Ministro dell'interno negli anni della più dura repressione delle lotte operaie e contadine. Una sintesi dell'attivita reazionaria ed anticostituzionali di Scelba è offerta da Wikipedia
 Esistono muri che non sono fatti di mattoni o filo spinato. «Berlino anticipa Londra: lavoratori dell’Ue discriminati».
Esistono muri che non sono fatti di mattoni o filo spinato. «Berlino anticipa Londra: lavoratori dell’Ue discriminati».
Il Fatto Quotidiano, 29 aprile 2016 (p.d.)
La porta aperta dalla trattativa tra Gran Bretagna e Unione Europea è stata imboccata per prima dalla Germania: i lavoratori comunitari, infatti, saranno discriminati rispetto ai colleghi tedeschi nell’accesso ai sussidi sociali. La ministro del Lavoro Andrea Nahles - che, per quanto vale, è socialdemocratica, il lato sinistro della Grande Coalizione - ha annunciato ieri che in tempi brevi porterà in Consiglio dei ministri una proposta sul tema: “Lo avevamo annunciato a dicembre”, ha spiegato, per colmare “le lacune interpretative” sull’accesso agli aiuti dello Stato nati dalla sentenza di una Corte sociale federale. I giudici, infatti, avevano stabilito che i cittadini dell’Unione che cercano lavoro in Germania possono accedere ai sussidi (ma non a quello di disoccupazione) dopo sei mesi di permanenza nel Paese: la sentenza aveva preoccupato assai le istituzioni locali, Comuni in testa, che temevano per la tenuta dei loro bilanci. Niente paura: interviene il governo, che fa pure un passo più in là.
In futuro, secondo il progetto del ministro Nahles, i cittadini comunitari saranno esclusi dalle prestazioni garantite dal cosiddetto pacchetto “Harz-IV”- le riforme del lavoro approvate dai governi Schroeder e Merkel - che include peraltro il sussidio di disoccupazione. Niente aiuti sociali poi (supporto per l’affitto, l’asilo dei figli e quant’altro) se non hanno un lavoro in Germania e non hanno maturato il diritto all’assicurazione sociale, che si acquisisce dopo 5 anni di lavoro senza aiuti dallo Stato. La cosa non è senza effetti in particolare nel sistema tedesco: il pacchetto di “aiuti” contenuto nel pacchetto Hartz, infatti, serve a controbilanciare gli effetti di una riforma del lavoro particolarmente penalizzante per i lavoratori.
Si rivolge, in particolare, ai cosiddetti mini-jobber, persone che pur lavorando - e costando quasi nulla in tasse alle imprese - non possono mettere in tasca 900 euro al mese: l’impresa può così abbassare il costo del lavoro, ma il dipendente rischia di fare la fame, soprattutto perché questo genere di mini-lavori sono spesso discontinui. E qui arrivano i sussidi: non solo quello di disoccupazione (equivalente alla nostra Naspi e che vale 391 euro al mese), a anche il sostegno alle spese di affitto, per i figli o i famliari a carico, eccetera fino a colmare la distanza col reddito considerato minimo (un po’meno di 1.500 euro). Può sembrare un’ottima cosa, ma questo sistema è in sostanza un enorme aiuto di Stato alle imprese (per abbassare il costo del lavoro) mascherato da welfare.
I benefici concessi ai lavoratori comunitari nel progetto Nahles, alla fine, sono condizionati a durata e resistenza nel mercato del lavoro tedesco e a una sorta di primo soccorso: un sostegno all’arrivo, che non potrà superare le quattro settimane, per coprire vitto e alloggio. Porte a perte per chi se ne vuole andare: un prestito per quelli che vogliono tornare nei Paesi d’origine.
La platea interessata non è affatto piccola. Secondo l’Agenzia federale del lavoro, riportava ieri l’A ns a, sono 440.000 i cittadini dell’Unione europea che ricevono al momento in Germania prestazioni sociali dallo Stato (su un totale di sei milioni di percettori): in numeri assoluti, il gruppo più esteso è costituito dai polacchi (92.000) seguiti da italiani (71.000), bulgari (70.000), rumeni (57.000) e greci (46.000). In termini percentuali, rispetto alle presenze in Germania, ai primi posti ci sono bulgari e rumeni.
L’idea del governo tedesco è di bloccare quei migranti interni all’Unione europea che si muovono - ha sostenuto la ministro tedesca - solo per beneficiare del welfare tedesco: questa pratica va fermata, disse, per salvare il sistema. Se il progetto è questo, però, si va parecchio più in là del tentativo di fermare “l’emigrazione del sussidio”e si introduce una discriminazione piena tra lavoratori tedeschi e lavoratori di altri stati Ue: il significato dell’Unione europea come viene raccontata - fratellanza, solidarietà, etc - corrisponde sempre meno al suo effettivo dispiegarsi nella vita dei suoi cittadini.
 «Gli attacchi ai giudici sono elementi costitutivi di una riscrittura della democrazia che vuole accentrare i poteri nell’esecutivo».
«Gli attacchi ai giudici sono elementi costitutivi di una riscrittura della democrazia che vuole accentrare i poteri nell’esecutivo».
Il Fatto Quotidiano, 27 aprile 2016 (p.d.)
Non c’è nulla di stupefacente nell’attacco che ancora una volta viene lanciato, dal governo e da un gran numero di politici, alla magistratura italiana e in particolare alle parole di Piercamillo Davigo. Né il nuovo presidente dell’Associazione nazionale magistrati dovrebbe preoccuparsene oltre misura: il suo compito è di rappresentare il potere giudiziario, quindi di dare a tale rappresentanza una voce, che per forza di cose non si esprime solo nelle sentenze.
Non c'è nulla di stupefacente perché l’invettiva del presidente del Consiglio contro “25 anni di autentica barbarie legata al giustizialismo”, così come l’appello dell’ex presidente Napolitano a una riforma delle intercettazioni e a una “cooperazione” tra giustizia e politica che metta fine a presenti e passati conflitti, non sono affermazioni che cadono dal cielo. Sono gli elementi costitutivi di una riscrittura della democrazia costituzionale che sta avvenendo in numerosi Stati dell’Unione europea, che in Italia è perseguita da decenni e che non si limita a circoscrivere e svuotare l’indipendenza del potere giudiziario. L’obiettivo che si persegue,in questi Stati e nelle stesse istituzioni europee, è di accentrare i poteri nell’esecutivo e di declassare ogni potere suscettibile di frenare l’estensione dell’autorità centrale. Di qui il depotenziamento più o meno subdolo dei poteri giudiziari, di quelli parlamentari, e al tempo stesso di una serie di organi intermedi: sindacati, partiti, organizzazioni imprenditoriali e professionali, enti locali sovracomunali come le province.
Giuseppe de Rita ha descritto molto bene quel che si vuole ottenere attraverso simili esautoramenti con leggi e riforme costituzionali: “I politici, che hanno voluto la disintermediazione, si trovano circondati, premuti, circuiti, qualche volta addirittura ricattati, da gruppetti (da ‘quartierini’) di un avventuroso lobbismo” (Corriere dellaSera, 14.4.16).Le istituzioni europee tendono a favorire quest’accentramento e questa disintermediazione anche a livello comunitario. Nella famosa lettera cheTrichet eDraghi spedirono al governo italiano nel 2011, non si esitò ad attribuire alla Bce un compito costituente che nessuno le ha mai conferito e si chiese proprio questo: una riforma costituzionale he iscrivesse il Fiscal Compact nella nostra Carta e “abolisse o fondesse alcuni strati amministrativi intermedi come le Province”.
Non a caso Jürgen Habermas denuncia il degrado democratico dell’Unione europea, dandogli il nome di “federalismo degli esecutivi”.
Parlare di conflitto giustizia-politica fa dunque tutt’uno con il referendum sulla riforma costituzionale, con la diminuita rappresentanza locale del futuro Senato e con la più generale offensiva contro gli organi intermedi della società. L’oscuro oggetto del disgusto provato da molti politici non è il conflitto, da abolire in nome della “cooperazione”, ma la dialettica stessa tra i poteri e la loro netta separazione. È il motivo per cui mi preoccuperei anch’io,come Davigo, se tale conflitto non esistesse. Non mi stupisce nemmeno che le sue parole siano manipolate e deturpate, in modo tale che i cittadini possano meglio confondersi quando lo sentono parlare e non comprendere i suoi argomenti. Si dice ad esempio che il presidente dell’Anm ha denunciato i politici corrotti per poi “frenare”e far marcia indietro: cosa palesemente falsa, perché ovviamente le sue parole erano rivolte ai “politici che rubano”. Se avesse voluto accusare tutti, anche i politici onesti,davvero non ci sarebbe più bisogno d’indagini e processi.
Indagini e processi sono utili proprio perché mostrano che esiste una differenza tra chi ruba e chi no. In un certo senso, si fa giustizia per proteggere l’innocenza. Idem per gli altri argomenti discussi in questi giorni:tra cui le intercettazioni e la presunzione di innocenza.
Intercettazioni. Dovrebbe essere noto a chi governa e a chi riforma la giustizia italiana che esiste una vasta giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo di Strasburgo in difesa della libertà di stampa, e che il giornalista ha il diritto di pubblicare notizie se le ritiene non solo penalmente, ma anche moralmente rilevanti. Il dibattito italiano è inoltre incredibilmente vecchio in materia. Si accusa continuamente il “circo mediatico-giudiziario", fingendo di ignorare fenomeni come quelli dei whistle blower (ostinatamente chiamati talpe o spie sui nostri giornali) o di Wikileaks. A ciò si aggiunga che in Italia già esistono norme sulla diffamazione e la violazione della privacy.
Presunzione d’innocenza.Viene continuamente e giustamente invocata, ma nell’esclusiva speranza che il politico condannato in primo grado sia prosciolto nel secondo o nel terzo, magari tramite la prescrizione. I tre gradi di giudizio sono un’anomalia tutta italiana, che naturalmente facilita le prescrizioni facili. Il politico condannato in primo grado dovrebbe lasciare le cariche che ricopre sin da quando è sospettato di non adempiere le funzioni pubbliche con disciplina e onore (art. 54 della Costituzione). Tantopiù deve farlo se condannato in primo grado.
Se così stanno le cose, sarebbe l’ora di rivolgere l’accusa di giustizialismo ad altri soggetti, sempre che si abbia a cuore l’uso della logica nell’informazione dei cittadini. I veri “giustizialisti” sono i politici specializzati nel lamentare il conflitto con la giustizia. Sono loro a far dipendere le proprie carriere, le proprie cariche, il proprio potere da tutti e tre i gradi di giudizio. Sono loro ad affidare ai magistrati e alle sentenze la selezione delle classi dirigenti. Non sarebbe male se ci spiegassero come mai, a questo punto, se ne dolgano tanto.

Il manifesto, 22 aprile 2016 (p.d.)
A proposito di referendum (e non solo). Dire partito democratico (o Pd) ormai suona come una contraddizione in termini. Lasciamo stare quello di domenica scorsa, boicottato dal presidente del Consiglio Matteo Renzi, e mettiamo tra parentesi anche quello sulle riforme costituzionali del prossimo ottobre imposto come una prova di forza che sa di deriva plebiscitaria. Torniamo invece su quello per l’acqua pubblica del 2011 votato da milioni di cittadini – il 57% degli aventi diritto al voto con il 95% schierato per la difesa dell’acqua bene comune – e stravolto l’altra sera con la votazione finale del ddl approvato alla Camera (243 i voti a favore, 129 i contrari e 2 gli astenuti, il prossimo passaggio sarà al Senato).
Durante la votazione, tutti i parlamentari del Movimento 5 Stelle – applauditi e sostenuti da Sinistra Italiana – hanno sventolato magliette e bandiere blu del referendum urlando contro i banchi della maggioranza. Dalle tribune, alcuni attivisti mescolati tra il pubblico hanno lanciato volantini e bandiere del Forum italiano dei movimenti per l’acqua pubblica. Caos democratico. Il parapiglia fuori programma, e il corpo a corpo tra penta stellati e alcuni commessi chiamati a riportare l’ordine in aula, hanno provocato la sospensione della seduta. «L’acqua secondo il Pd è chiaramente a gestione privata – hanno detto i deputati della Commissione ambiente M5S – è il solito teatrino del Pd che sosteneva di rispettare la volontà popolare e invece oggi ha calato la maschera». Per Sinistra Italiana, «la gestione dell’acqua deve essere pubblica come chiesto a gran voce da milioni di cittadini con il referendum del 2011. Solo il pubblico è in grado di mettere in atto quel processo virtuoso tra tariffe, spese di gestione e servizio». Sembra che sia andata diversamente.
Certe intemperanze poco rispettose del parlamento verranno presto sanzionate, se è vero che in seguito alla solidarietà espressa ieri da tutti i capigruppo ai commessi della Camera verrà convocato un ufficio di presidenza su iniziativa della presidente della Camera Laura Boldrini. Fioccheranno sanzioni, mentre ancora non è dato sapere come la politica reagirà – e se reagirà – al colpo di mano che con un bizantinismo da azzeccagarbugli, emendamento su emendamento, ha stravolto l’impianto di un disegno di legge che originariamente era stato pensato per rendere nuovamente pubblico il sistema idrico. Come da volontà popolare.
A una prima lettura, il ddl appena approvato introduce nuove norme che sembrano positive sulla gestione, la pianificazione e il finanziamento del servizio idrico interrato. Ma alcune differenze significative saltano all’occhio se confrontiamo il testo con la sua stesura originaria che sottolineava esplicitamente la totale ripubblicizzazione del servizio idrico. Il nuovo testo, invece, stabilisce che «il servizio idrico integrativo sia considerato un servizio pubblico locale di interesse economico generale assicurato alla collettività, che può essere affidato anche in via diretta a società interamente pubbliche in possesso dei requisiti prescritti dall’ordinamento europeo per la gestione in house, comunque partecipate da tutti gli enti locali ricadenti nell’Ato (Ambito territoriale ottimale)».
Dove sta il trucco? Nel testo iniziale l’affidamento della gestione in house era blindato con la parola «prioritariamente». La sua eliminazione non sarebbe un dettaglio di poco conto, anzi, secondo M5S e Si si tratta di un vero e proprio insulto alla democrazia. Le novità più rilevanti, insieme ad altre modifiche cesellate ad arte, infatti prefigurano nuovi scenari che si scontrano con la volontà del popolo italiano. Il servizio idrico smette di essere qualificato come un servizio pubblico che non avendo una rilevanza economica viene sottratto alla libera concorrenza: ci si potrà lucrare sopra. La gestione e l’erogazione del servizio possono essere nelle mani dello stesso soggetto (anche di società quotate in borsa), e fognature, acquedotti e impianti di depurazione non devono essere affidate necessariamente a organi di diritto pubblico. Sono state apportate modifiche anche sulle concessioni per uso differente da quello potabile: nel ddl originale potevano essere revocate anche prima della loro scadenza e assolutamente non più rinnovabili, mentre ora la materia verrà regolamentata da un decreto legislativo ancora tutto da scrivere entro il 2016.
Altre novità, invece, risultano meno sgradite. A tutti i cittadini, sulla carta, dovranno essere garantiti almeno 50 litri di acqua potabile al giorno (anche in caso di mancato pagamento delle bollette, che presto verranno conteggiate con nuovi contatori installati in ogni abitazione). Le bollette diventeranno più «trasparenti» (con parametri di qualità dell’acqua, conteggio delle perdite idriche e dati sugli investimenti negli acquedotti). Sull’acquisto di ogni bottiglia di acqua minerale sarà previsto il contributo di 1 centesimo per finanziare progetti di cooperazione per l’accesso all’acqua potabile. Niente di particolarmente grave per le intoccabili multinazionali dell’acqua: aumenteranno i prezzi.
 «Ri-Mediamo. La copertura informativa del referendum del 17 aprile è stata l’anticipazione del clima che a breve si scatenerà sul voto confermativo sulla (contro)riforma costituzionale».
«Ri-Mediamo. La copertura informativa del referendum del 17 aprile è stata l’anticipazione del clima che a breve si scatenerà sul voto confermativo sulla (contro)riforma costituzionale». Il manifesto,
20aprile 2016 (c.m.c.)
Allarme rosso per la democrazia dell’informazione. L’elettroregime di Matteo Renzi è persino più pesante di quello dell’allora premier Berlusconi – quasi da punteggio tennistico. I dati pubblicati dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (elaborati da Geca Italia) sulle presenze televisive di marzo sono impietosi e segnalano una bulimia mediatica senza precedenti.
Il vecchio duopolio Rai – Mediaset ormai è un coro ossessivo con un’unica nota.
Lo stesso Renzi si è lanciato nella serata di domenica in un’invettiva contro talk, facebook, twitter: «rei» di muovere delle critiche, come se anche l’articolo 21 della Costituzione fosse già stato abrogato. Eppure, proprio di tali strumenti si è giovato sempre con bulimia l’attuale presidente del consiglio per la sua affermazione. L’inquietante gravità della situazione meriterebbe tutt’altra reazione. E’ un antico vizietto, duro a morire. La sottovalutazione fu un peccato già grave a fronte di una società più strutturata e di un sistema mediale lento e meno esteso. Ora è un vero e proprio peccato mortale, visto che ciò che residua della sfera politica naviga nel flusso ininterrotto della comunicazione.
E non per caso il proprietario di facebook Mark Zuckerberg ha adombrato una sorta di «scesa in campo». Non solo. La «destra» culturale si sta riorganizzando, con Bolloré e il pur ammaccato – ma sempre vispo negli affari – uomo di Arcore. Le Monde è da un po’ che parla dei fenomeni in corso. La copertura informativa del referendum del 17 aprile è stata l’anticipazione del clima che a breve si scatenerà sul voto confermativo sulla (contro)riforma costituzionale.
Ecco, le parole a caldo del premier la sera di domenica 17 ci raccontano di quale miscela di demagogia e arroganza autoritaria sarà infarcita la campagna che ci attende.
E’ inderogabile, quindi, una campagna di chiarimento su quanto è stato deciso dalla maggioranza parlamentare, che ha scelto di ridimensionare fortemente il circuito democratico della decisione. Altro che riduzione della casta. Ma di tutto questo sarà possibile parlare in trasmissioni adeguatamente istruite e pubblicizzate (almeno come «Rischiatutto»), collocate in orari decenti? Tribune referendarie immaginate per il pubblico del «Commissario Montalbano», per capirci.
L’odierna routine va completamente ripensata.
Basti osservare collocazione nel palinsesto e conseguenti ascolti degli spazi offerti dalla Rai alle «trivelle». Tredici tribune ed altrettanti messaggi autogestiti, mai nelle fasce di buon ascolto, e quindi relegate ad audience inesorabilmente modeste: da 71mila utenti ad un «picco» quasi eccezionale di un milione e 200mila. Il problema va studiato e a questo dovrebbero dedicarsi l’Agcom e la commissione parlamentare di vigilanza.
Nell’ultima vicenda – sempre dai dati dell’Autorità – il tempo dedicato ai referendari è stato al di sotto di ogni sospetto, ma proprio l’Agcom non ha ritenuto di intervenire con i correttivi necessari. Tra l’altro, come ha sempre lucidamente sottolineato il centro di ascolto dei radicali, ore e minuti non vanno contati, bensì «pesati». Una diretta del Tg1 conta ben diversamente di una tribunetta inserita come riempitivo. E non è certo beneaugurante la risposta data dal presidente Cardani ad Alessandro Pace, che presiede il comitato per il no al referendum. Non basta. Buio totale avvolge la raccolta di firme su ulteriori quesiti (contro la legge elettorale e la «buona scuola», nonché le proposte sul lavoro).
Si avvicina un’altra notte della repubblica, in silenzio?
Le ragioni per le quali è infondata la richiesta di dichiarare illegittima la pubblicazione delle itercettazioni relative allo scandalo Tampa Rossa.
La Repubblica, 15 aprile 2016
FU PROPRIO questo giornale, subito accompagnato dall’attivismo della Rete e poi dal risveglio delle piazze, ad avviare nel 2010 la campagna “No bavaglio”, che impedì l’approvazione di una pessima legge sulle intercettazioni che avrebbe limitato gravemente la libertà d’informazione. Ma da allora in poi si è assistito ad uno stillicidio di polemiche e di proposte, quasi sempre insincere e strumentali, che andavano sostanzialmente nella stessa direzione. Si diceva che era necessario tutelare la privacy dei cittadini, perché le intercettazioni avevano fatto nascere una sorveglianza di massa. Tesi del tutto infondata, ma che cercava di offrire una giustificazione ad iniziative di una classe politica che voleva costruirsi una rete di protezione che la mettesse al riparo da una conoscenza diffusa di fatti che avrebbero messo in evidenza corruzione, conflitti d’interessi, evasione fiscale, prepotenze privatistiche. Erano i tempi in cui Berlusconi lanciava appelli che riprendevano l’invito attribuito a François Guizot, «Arricchitevi » senza farsi troppi scrupoli. Questa legittimazione anche di comportamenti illegali di massa, che ha molto pesato nel deperimento dell’etica civile, in realtà serviva a coprire la volontà di liberare l’esercizio del potere di governo da quella particolare e democratica forma di controllo resa possibile da una informazione puntuale che obbliga i soggetti pubblici a rendere immediatamente conto del loro operato.
Si faticava, e si fatica ancora, ad acquistare piena consapevolezza di un dato istituzionale che negli Stati Uniti è stato messo in evidenza fin dal 1964. In quell’anno la Corte Suprema, decidendo un caso che vedeva il New York Times accusato da una persona di averla diffamata, stabiliva il principio secondo il quale le “figure pubbliche” ricevono una tutela giuridica attenuata proprio perché i cittadini debbono poter esprimere in ogni momento il loro giudizio su di loro, disponendo di tutte le necessarie informazioni. Questo circolo virtuoso si ritrova oggi nei più diversi Paesi, ha dato origine a moltissime sentenze, e riguarda in particolare proprio situazioni di cui oggi in Italia si discute intensamente, chiedendosi se sia legittimo rendere pubbliche informazioni sulla vita privata che possono sconfinare nel pettegolezzo.
Per discutere con buona cognizione dei termini giuridici del problema, difficile come sempre accade quando si tratta di stabilire un punto d’equilibrio tra privacy e informazione, è necessario tener presenti alcuni specifici riferimenti. Il primo è rappresentato proprio dalla categoria delle figure pubbliche, che non comprende soltanto i politici, ma pure sportivi e persone del mondo dello spettacolo, e che si è venuta estendendo per effetto del dilatarsi del numero di persone che decidono appunto di “vivere in pubblico”. L’esposizione allo ”sguardo generale” non è il risultato di una imposizione, ma di una libera scelta della persona, che dev’essere consapevole del fatto che ciò produce conseguenze sull’intero sistema delle sue relazioni sociali. E la più rilevante di queste conseguenze è rappresentata proprio dal fatto che le figure pubbliche, come s’usa dire, hanno una più ridotta “aspettativa di privacy”.
Questo è il metro di giudizio al quale ricorrere quando si devono individuare i criteri per stabilire quali siano le informazioni personali legittimamente pubblicabili, provengano da intercettazioni telefoniche o da altre fonti. Criteri che, nel nostro sistema giuridico, hanno trovato una traduzione precisa nel modo in cui la questione è affrontata dall’articolo 6 del Codice di deontologia dell’attività giornalistica, che è un insieme di vere e proprie norme giuridiche, applicabili dai giudici civili, penali e amministrativi, e non solo da organi deontologici.
La norma è molto chiara. “La sfera privata delle persone note o che esercitano funzioni pubbliche deve essere rispettata se le informazioni o i dati non hanno alcun rilievo sul loro ruolo o sulla loro vita pubblica”. Ho sottolineato le parole “alcun rilievo” perché esse indicano una soglia particolarmente rigorosa e restrittiva per quanto riguarda l’individuazione dei casi in cui la pubblicazione di una informazione può essere ritenuta illegittima. Deve poi essere messo in evidenza il fatto che le parole adoperate in questo articolo - esercizio di “funzioni pubbliche” - corrispondono a quanto è scritto nell’articolo 54 della Costituzione, che impone a questi soggetti di comportarsi con “disciplina e onore”.
Siamo così di fronte all’attuazione di un criterio costituzionalmente rilevante. E, pur registrando il fatto che principi e regole costituzionali stanno conoscendo torsioni assai preoccupanti, sembra davvero difficile considerare prive di alcun rilievo le parole pubblicate in questi giorni, che connotano in modo del tutto disonorevole il modo in cui sono intese e praticate funzioni pubbliche, addirittura ministeriali, sì che appare del tutto arbitrario derubricarle a «pettegolezzo».
Poiché siamo in materia propriamente costituzionale, bisogna aggiungere un’altra riflessione. Si è messo in evidenza, non da oggi, che le nuove norme sulle intercettazioni sono previste in una delega al governo di cui è stata ripetutamente sottolineata la genericità, e quindi l’incostituzionalità, per la mancanza di quei precisi principi e criteri direttivi ai quali fa esplicito riferimento l’articolo 76 della Costituzione. Si deve aggiungere che intervenire su diritti fondamentali, in questo caso quello all’informazione, dovrebbe indurre a non espropriare il Parlamento di questa delicatissima funzione, che consente all’intera procedura legislativa d’essere pubblica e controllabile, mentre la delega la affida al chiuso di commissioni ministeriali. Si è detto, infine, con una delle tante giravolte politiche di questi tempi, che non si vuole toccare la disciplina delle intercettazioni. Tre ragioni che consigliano di stralciare dal disegno di legge in discussione al Senato una parte così difficile e controversa.
 « La Costituzione gli sopravvivrà, a lui come a noi tutti». Ecco le quattro spine mortali del fiore avvelenato che Renzi (e chi gli sta dietro) vuole imporre alla nostra Repubblica.
« La Costituzione gli sopravvivrà, a lui come a noi tutti». Ecco le quattro spine mortali del fiore avvelenato che Renzi (e chi gli sta dietro) vuole imporre alla nostra Repubblica.
Corriere della sera,
Chi l’avrebbe detto? Un Parlamento espresso con una legge elettorale (il Porcellum ) annullata poi dalla Consulta; sbucato dalle urne senza una maggioranza chiara, anzi con tre grandi minoranze (Pd, FI, 5 Stelle) armate l’una contro l’altra; lì per lì incapace perfino d’eleggere il capo dello Stato, tanto da confermare l’uscente (Napolitano), episodio senza precedenti, prima di eleggere Mattarella; ecco, quelle Camere impotenti timbrano la riforma più potente, consegnando agli italiani una Costituzione tutta nuova.
Sicché adesso tocca a noi, ci tocca la parola. Ma è una parola secca: sì o no, prendere o lasciare. Per non sprecare quel monosillabo dovremmo ragionarci sopra, dovremmo soppesare la riforma, senza furori ideologici, senza tifo di partito.Al referendum vince o perde l’Italia, non Matteo Renzi . La Costituzione gli sopravvivrà, a lui come a noi tutti. Dunque la scelta investe il nostro destino collettivo, non le fortune di un leader. E dietro l’angolo non c’è affatto il rischio d’un ducetto; semmai rischiamo un’altra Caporetto. Perché le istituzioni repubblicane, dopo settant’anni d’onorata carriera, hanno vari acciacchi sul groppone; la cura ri-costituente può guarirle, ma può altresì accopparle.
Sarebbe stato giusto concederci l’opportunità di rifiutare o d’approvare questa riforma per singoli capitoli, nei suoi diversi aspetti. Non è così, il nostro è un voto in blocco: se vuoi la rosa, devi prenderti le spine. Ciò tuttavia non cancella l’esigenza d’esaminare il testo «nel dettaglio», come auspica un folto gruppo di costituzionalisti su Federalismi.it .
Scorporando le questioni, magari in ultimo potremmo stilare una pagella, mettendo su ogni voce un segno meno o più. Se le promozioni superano le bocciature, voteremo sì; altrimenti bocceremo tutta la riforma. Se invece la somma è pari a zero, significa che non è cambiato nulla. In Italia succede di sovente.
Ma intanto ecco l’elenco degli esami. Primo: il potere. La riforma lo concentra, lo riunifica. Una sola Camera politica (l’altra è una suocera: elargisce consigli non richiesti). Un governo più stabile e più forte, senza la fossa dei leoni del Senato, che ha divorato Prodi e masticato tutti i suoi epigoni, nessuno escluso. E uno Stato solitario al centro della scena. Via le Province, pace all’anima loro. Via le Regioni, cui la riforma toglie di bocca il pasto servito nel 2001, sequestrandone funzioni e competenze: dal federalismo al solipsismo. Perciò il decisionista Carl Schmitt voterebbe questo testo, l’autonomista Carlo Cattaneo lo disapproverebbe. Voi da che parte state?
Secondo: l’efficienza. Una maggior concentrazione del potere dovrebbe assicurarla, però non è detto, dipende dalle complicazioni della semplificazione. L’ iter legis , per esempio: qui danno le carte soltanto i deputati, tuttavia il Senato può emendare, la Camera a sua volta può respingere a maggioranza semplice, ma talora a maggioranza assoluta. Mentre rimangono pur sempre 22 categorie di leggi bicamerali. Insomma, dalla teoria alla prassi il principio efficientista rischia di rivelarsi inefficiente. E voi, siete teorici o pragmatici?
Terzo: le garanzie. Nessuno dei 47 articoli nuovi di zecca spiega le attribuzioni dei garanti: la magistratura, la Consulta, il capo dello Stato. Ma sta di fatto che quest’ultimo dimagrisce quando mette pancia il presidente del Consiglio, giacché in una Costituzione tout se tient . Con un’unica Camera dominata da un unico partito (per effetto dell’Italicum ), addio ai governi del presidente, quali furono gli esecutivi Dini, Monti, Letta. Ma addio anche al potere di sciogliere anzitempo il Parlamento: di fatto, sarà il leader politico a decretare vita e morte della legislatura. E addio alla garanzia del bicameralismo paritario, che a suo tempo bloccò varie leggi ad personam cucinate da Berlusconi. In compenso la riforma pone un argine ai decreti del governo, promette lo statuto delle opposizioni, aggiunge il ricorso preventivo alla Consulta sulle leggi elettorali. Ma il compenso compensa lo scompenso?
Quarto: la partecipazione. Quali strumenti di decisione e di controllo restano in tasca ai cittadini? E quanto sarà facile tirarli fuori dalla tasca? Intanto aumenta la fatica di raccogliere le firme: da 50 a 150 mila per l’iniziativa legislativa popolare; da 500 a 800 mila per il referendum abrogativo, in cambio dell’abbassamento del quorum. Però i regolamenti parlamentari dovranno garantire tempi certi per i progetti popolari, però s’annunziano altre due tipologie di referendum (propositivo e d’indirizzo). Peccato che la volta scorsa ci sia toccato pazientare 22 anni (la legge sui referendum è del 1970). Dunque è questione d’ottimismo, di fiducia. E voi, siete ottimisti o pessimisti?
 La corruzione non è un dato esclusivo dell'Italia, ma «l’etica pubblica ha conosciuto dalle nostre parti un degrado che ha infettato il funzionamento dell’intero sistema, diventandone un dato strutturale.
La corruzione non è un dato esclusivo dell'Italia, ma «l’etica pubblica ha conosciuto dalle nostre parti un degrado che ha infettato il funzionamento dell’intero sistema, diventandone un dato strutturale.
Il manifesto, 12 aprile 2016
Ho letto le osservazioni
critiche di Alfio Mastropaolo riguardanti un mio articolo sulla corruzione e su esse, per motivi di chiarezza, vorrei rapidamente tornare.
Non ho sostenuto che l’Italia sia un caso «unico», quasi che altrove la corruzione fosse sconosciuta. Ho cercato di segnalare, anche con qualche rinvio a fatti accaduti in paesi a noi comparabili, come l’etica pubblica abbia conosciuto dalle nostre parti un degrado che ha infettato il funzionamento dell’intero sistema, diventandone un dato strutturale.
Oltre a molti libri «di battaglia», esiste da tempo una buona letteratura che, sia pure con accenti diversi, dà solide basi a questa constatazione, fornendo elementi precisi per spiegare una persistenza e una continuità nel tempo, incarnate talora addirittura dalle medesime persone, che hanno prodotto una proterva «controetica», esibita senza pudore anche in sedi governative e parlamentari (con quelle che sono state chiamate assoluzioni «sociologiche» dei corrotti).
Sono stati così generati non solo comportamenti amministrativi sempre più diffusi e addirittura interventi legislativi, ma un vero e proprio «indirizzo politico», che viene rivelato dalla continua cascata di documenti ufficiali che quantificano non solo singoli casi di corruzione, ma la corruzione strutturale di interi «comparti», dagli appalti pubblici alla sanità.
Tutto questo non ha corrispondenza in Francia, Germania, Regno Unito e in altri paesi che ci precedono nella graduatoria di Transparency International, che non sopravvaluto (non l’ho citata), ma che ha sicuramente qualche significato informativo.
Certo, tutto questo rimanda alle ragioni sociali del fenomeno, ha uno sfondo e un denominatore comuni da ritrovare nella esasperazione della logica del profitto e di una finanziarizzazione che davvero ha fatto del denaro la misura di tutte le cose. Ma, come si diceva un tempo, fatta questa constatazione occorre una «analisi differenziata». E questa ci farebbe scoprire, senza troppa fatica, che proprio i «riti di espiazione», ai quali Mastropaolo rimanda, rivelano situazioni assai diverse a seconda che riguardino casi individuali o interi ceti o strutture.
Non è che l’Italia li celebri in modo più vistoso. E’ proprio la loro dimensione sociale a rivelare una qualità assai diversa del fenomeno, dalla quale non si può prescindere se si vuole avviare una efficace strategia di contrasto.
Accentuando, per visibili ragioni polemiche, la portata della corruzione italiana, intendevo mettere l’accento su patologie istituzionali, non certificare la scomparsa delle persone oneste, o la totale perdita del senso dello Stato (anche se poi, quando si vuole ritrovarlo nelle istituzioni si finisce troppo spesso nel citare la Banca d’Italia). Non caso prendevo le mosse dalla «controsocietà degli onesti» di Italo Calvino.
Aggiungo che le concrete proposte di Mastropaolo sono tutte condivisibili, e su tutte in vari tempi mi sono espresso o direttamente impegnato. Non hanno dato finora frutti. E questo vuol dire che bisogna lavorare per una cultura che rimuova questo ostacolo.Il terreno è quello dell’etica civile. Se poi questo produce l’accusa di moralismo, che sia benvenuta.
Nell'icona una protesta contro la corruzione in Turchia
 «Ri-Mediamo. La copertura informativa del referendum del 17 aprile è stata l’anticipazione del clima che a breve si scatenerà sul voto confermativo sulla (contro)riforma costituzionale». Il manifesto, 20aprile 2016 (c.m.c.)
«Ri-Mediamo. La copertura informativa del referendum del 17 aprile è stata l’anticipazione del clima che a breve si scatenerà sul voto confermativo sulla (contro)riforma costituzionale». Il manifesto, 20aprile 2016 (c.m.c.)



 «Una Costituzione che promette di non fare troppi danni solo a patto che una maggioranza specifica governi è una costituzione per il presente, non per il futuro, e quindi è improvvida».
«Una Costituzione che promette di non fare troppi danni solo a patto che una maggioranza specifica governi è una costituzione per il presente, non per il futuro, e quindi è improvvida». 






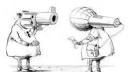
 «La democrazia negata si può restaurare proprio a colpi di democrazia: ovvero di informazione e di spazi di confronto. Come quello che si aprirà a Roma il 7 maggio.».
«La democrazia negata si può restaurare proprio a colpi di democrazia: ovvero di informazione e di spazi di confronto. Come quello che si aprirà a Roma il 7 maggio.». 






