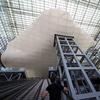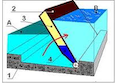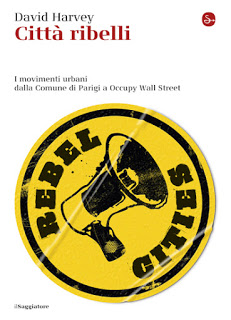«Flash mob di un gruppo di circa 150 persone residenti a Venezia che, con la maschera da Panda, hanno manifestato per la salvezza della città e criticando un Carnevale che, lamentano, è diventato solo una macchina spenna-turisti.». La Nuova Venezia, 17 febbraio 2017 (p.s.)
«Flash mob di un gruppo di circa 150 persone residenti a Venezia che, con la maschera da Panda, hanno manifestato per la salvezza della città e criticando un Carnevale che, lamentano, è diventato solo una macchina spenna-turisti.». La Nuova Venezia, 17 febbraio 2017 (p.s.)
I veneziani non vogliono essere una specie in via di estinzione come il panda gigante. Alla vigilia dell'avvio ufficiale del Carnevale, gli abitanti della città lagunare con un flash-mob dal titolo provocatorio «Un pesce di nome panda?» sul sagrato della Chiesa della Madonna della Salute hanno rivendicato il diritto di vivere, e non solo di lavorare, tra calli e campielli, senza subire il peso di un turismo sempre più soffocante.
Centocinquanta persone dai 3 ai 73 anni si sono improvvisate attori, vestiti da panda, per sottolineare, di fronte alla platea internazionale, il diritto economico a poter risiedere in città e a non vedere trasformato ogni palazzo in un nuovo albergo, ponendo fine all'esodo degli abitanti, quantificato in 2,6 al giorno.
Attualmente sono 54.600 i residenti nei sestieri (a fronte dei quasi 175 mila del 1951), mentre risultano 30 mila i pendolari che oggi giorno dalla terraferma giungono in centro storico per prestare la loro opera.
«Facciamo appello alla solidarietà del mondo intero, perché Venezia, con i suoi abitanti e la sua cultura unica, patrimonio dell'umanità - spiega Marco Gasparinetti, uno degli organizzatori dell'evento, promosso dall'associazione 'Veneziamiofuturo' - e non la proprietà privata di qualche lobby».
Un concetto che Gasparinetti chiarisce ulteriormente.«Quello che comincia domani non è più il nostro Carnevale: una macchina mangiasoldi per spennare i turisti undici mesi su dodici: il solo mese di tregua per noi è gennaio - conclude -. Per far girare la macchina mangiasoldi al massimo, bisogna svuotare Venezia dei suoi cittadini e la missione è quasi compiuta. Noi non ci stiamo, non intendiamo rassegnarci a fare le valigie».
 «L’intervento della tanto denigrata “burocrazia” della soprintendenza sta rendendo al futuro della città e al bene comune uno straordinario servizio». la Repubblica ed.Roma, 18 febbraio 2017 (c.m.c.)
«L’intervento della tanto denigrata “burocrazia” della soprintendenza sta rendendo al futuro della città e al bene comune uno straordinario servizio». la Repubblica ed.Roma, 18 febbraio 2017 (c.m.c.)
Dialogando amabilmente con Matteo Salvini, Maria Elena Boschi si era impegnata in diretta televisiva (a Porta a Porta, il 16 novembre scorso) a chiudere le soprintendenze («io sono d’accordo diminuiamo le soprintendenze, lo sta facendo il ministro Franceschini. Aboliamole, d’accordo») dopo la vittoria del Sì al referendum costituzionale. Sappiamo com’è finita: e, per ora, le soprintendenze ci sono ancora. E dunque le amministrazioni comunali non possono fare proprio quello che vogliono del territorio e del patrimonio culturale delle loro città.
È così che un paletto molto ingombrante, o addirittura esiziale, per la mega speculazione Parnasi è stato piantato proprio dagli uffici periferici del Ministero per i Beni Culturali. Il vincolo che ieri sera è stato firmato dalla soprintendente di Roma Margherita Eichberg non solo impedisce la distruzione dell’Ippodromo di Tor di Valle, tutelando un edificio importante (e, ironia della sorte, anche la memoria storica delle Olimpiadi romane del 1960), ma, bloccando praticamente i lavori in tutta la famosa particella 19, costringe la Conferenza dei servizi sullo Stadio a fermarsi.
E ora si aprono due possibilità. La prima è che tutto il progetto si fermi, e che gli attori internazionali di questa speculazione migrino altrove, secondo le logiche rapaci della creazione del denaro dal cemento. La seconda è che invece si sia disposti a rivedere, correggere, riscrivere il progetto, sostituendo un vero parco all’attuale colata di cemento. Mille ragioni — dall’assetto idrogeologico di Tor di Valle al sistema dei trasporti — renderebbero preferibile la prima, più radicale soluzione: ma in ogni caso l’intervento della tanto denigrata “burocrazia” della soprintendenza sta rendendo al futuro della città e al bene comune uno straordinario servizio.
È impossibile non rilevare la singolarità della situazione. Pochi giorni fa, la magistratura ha sequestrato il cantiere di un villaggio turistico che massacrava il meraviglioso paesaggio e il patrimonio archeologico di Punta Scifo, in Calabria, motivando quell’atto anche con «l’inerzia della Pubblica amministrazione nelle sue varie articolazioni [soprintendenza compresa] coinvolte nell’iter autorizzatorio, che. .. non ha mai inteso compiere le dovute verifiche ed eventualmente esercitare il potere-dovere di autotutela».
In questo caso calabrese la soprintendenza è venuta completamente meno ai suoi doveri, mentre il Movimento 5 Stelle è stato invece determinante nel sostegno ai comitati civici che si battino da tempo contro quel cemento. A Roma, invece, abbiamo la situazione esattamente opposta: la soprintendenza fa coraggiosamente la sua parte (rispettando in toto il parere radicale del comitato tecnico scientifico, e non curandosi delle superiori indicazioni che consigliavano una linea morbida da ‘pecora morta’), e mette le mani in un fuoco incandescente, proprio mentre la giunta 5 Stelle sembrava apprestarsi a varcare la linea d’ombra del cemento.
È questa la contraddizione che sta infiammando in queste ore la base del Movimento, non dimentica che una delle famose 5 stelle rappresenta proprio l’ambiente.
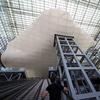 «La relazione del procuratore regionale Cabras : "Riscontrati fenomeni corruttivi e mala gestione della cosa pubblica. Metropolitana, 230 milioni assolutamente ingiustificati". Nel 2016 condanne per oltre 35 milioni». la Repubblica, ed Roma, 17 febbraio 2017 (p.s.)
«La relazione del procuratore regionale Cabras : "Riscontrati fenomeni corruttivi e mala gestione della cosa pubblica. Metropolitana, 230 milioni assolutamente ingiustificati". Nel 2016 condanne per oltre 35 milioni». la Repubblica, ed Roma, 17 febbraio 2017 (p.s.)
«Un'istruttoria assai rilevante e complessa è stata originata da alcune segnalazioni relative alla eccessiva lievitazione dei costi di progettazione, direzione artistica ed esecuzione dei lavori del Nuovo centro congressi dell'Eur».
Così il procuratore regionale presso la sezione giurisdizionale per il Lazio della Corte dei Conti, Donata Cabras, ha bacchettato lo spropositato proliferare dei costi della celebre Nuvola, leggendo la sua relazione durante l'inaugurazione dell'anno giudiziario 2017. «La procura - ha continuato Cabras - ha individuato un danno alle pubbliche finanze pari a oltre 5 milioni di euro corrispondente al totale degli indebiti pagamenti effettuati nei confronti del progettista e alle società riferibili allo stesso professionista».
Ma il caso dell'opera dell'archistar Massimiliano Fuksas (che attraverso i suoi legali ribadisce la conformità dei pagamenti ricevuti ai contratti, all'attività svolta e ai parametri normativi) non è il solo a essere finito nel mirino dei giudici contabili. Critica anche la gestione della costruzione della linea C della metropolitana di Roma i cui costi, ha spiegato Cabras, sono aumentati in modo esponenziale: «Per una sola fattispecie riscontrata nelle nostre indagini ci sono 230 milioni assolutamente ingiustificati».
Nella sua relazione, Cabras ha sottolineato che «la lievitazione esponenziale del prezzo contrattuale è avvenuta attraverso il ricorso sistematico all'iscrizione di riserve che, a breve distanza di tempo dall'avvio dei lavori per la realizzazione delle opere, ha raggiunto cifre esorbitanti». Cabras ha evidenziato che i 230 milioni si riferiscono a una sola delle fattispecie e, quindi, la somma di questi costi potrebbe essere superiore. «Alcune indagini in proposito hanno riguardato l'affidamento dell'appalto con il sistema del contraente generale in cui si è assistito alla lievitazione esponenziale del prezzo contrattuale», ha concluso.
In generale, secondo il magistrato, «il 2016, come già gli esercizi precedenti, è stato caratterizzato dal moltiplicarsi dei fenomeni corruttivi e di mala gestio della cosa pubblica». Cabras ha precisato che «nel corso dell'anno una particolare attenzione è stata riservata ai casi di assenteismo o di indebito riconoscimento di benefici retributivi o di carriera, che hanno riguardato funzionari e dipendenti pubblici». Ci sono state poi «numerose istruttorie a carico di soggetti che hanno illecitamente utilizzato finanziamenti e contribuzioni pubbliche, cui è conseguita la chiamata in giudizio per avere distolto le somme erogate dal fine al quale erano normativamente destinate». Inoltre, «i magistrati dell'ufficio sono stati costantemente impegnati nelle indagini relative a fattispecie di danno derivanti dalla violazione delle disposizioni che regolano la materia dei lavori pubblici».
«Il sistema dei rapporti illeciti si è sostanziato in attività di tipo corruttivo e collusivo nell'assoggettamento della funzione pubblica rivestita al servizio dei privati», ha spiegato poi Cabras, parlando in particolare del sistema criminale denominato "Mafia Capitale" che ha arrecato diversi danni patrimoniali allo Stato: «Un primo danno per 9 milioni di euro per la lesione del principio delle norme a tutela della concorrenza con riflessi in termini di maggiore costo per l'amministrazione», a cui si vanno ad aggiungere un danno dello stesso importo per il disservizio dell'azione amministrativa, uno da oltre 1 milione e 800mila euro come conseguenza diretta delle indagini, più un altro ancora da 1 milione di euro per la maggiore spesa e i costi per il personale per le ore di straordinario.
Infine, Cabras segnala la «grande indignazione» suscitata dalla «vicenda di assoluta attualità sulla la gestione dei profughi e delle somme destinate ai migranti. Il giudizio già pervenuto a sentenza ha riguardato le sovraffatturazioni e la distrazione dei fondi veicolati, illecitamente utilizzati per remunerare prestazioni di diversa natura e finalità».
Prima dell'intervento del procuratore regionale, era stata la presidente della sezione, Piera Maggi, a prendere la parola per relazionare sull'attività svolta nel 2016. «Sono state emesse condanne per danni per oltre 35 milioni di euro per le sole fattispecie verificatesi nel Lazio - ha detto Maggi - ma si deve ritenere che tale cifra costituisca solo la punta dell'iceberg del pregiudizio derivante dalla mala gestio, se si considerano le ipotesi di carenza di giurisdizione, di colpa non grave, di mancato e insoddisfacente raggiungimento della prova, delle ipotesi che sfuggono per mancanza di notitia damni specifica e concreta, di problemi procedurali, di prescrizione o di particolare astuzia degli artefici nell'occultare le fattispecie dannose. Tanto dà misura dell'enorme pregiudizio che l'erario subisce».
«Articoli di Mauro Favale, Ignazio Marino, Antonello Sotgia e Enzo Scandurra da la Repubblica e il manifesto 16 e 17 febbraio 2017 (c.m.c.)
la Repubblica
STADIO, A RISCHIO LE OPERE PUBBLICHE
di Mauro Favale
Sullo stadio della Roma a Tor di Valle, «non c’è alcun accordo », sostiene Virginia Raggi. C’è però una «delicata trattativa », per la quale la sindaca di Roma mantiene «il massimo riserbo ». E non solo «per evitare strumentalizzazioni », come lei stessa scrive sul blog di Beppe Grillo.
La prima cittadina, in questo momento, non può dire che al tavolo con la Roma e il costruttore Luca Parnasi, il tema della discussione non sono solo le cubature del “business park” da ridurre (forse del 20%, c’è chi dice meno) e le torri di Daniel Libeskind da abbassare. Quello che la sindaca non dice è che la trattativa verte anche sulle opere pubbliche che Ignazio Marino e il suo assessore all’Urbanistica Giovanni Caudo vollero inserire nella delibera che, a fine 2014, assegnò lo standard di “interesse pubblico” al progetto dell’arena a Tor di Valle.
Quattro prescrizioni che la Roma si impegnò a realizzare per agevolare soprattutto la mobilità in quella zona, pena l’annullamento dell’interesse pubblico del progetto. Che, ricorda oggi Caudo, «sta proprio nelle opere esterne e non certo nello stadio ». Si va dal potenziamento del trasporto pubblico su ferro al ponte pedonale verso la stazione ferroviaria di Magliana, all’adeguamento della via del Mare fino allo svincolo con il Grande raccordo anulare passando per alcuni interventi per limitare il rischio idrogeologico che insiste su Tor di Valle e per un nuovo ponte sul Tevere che collegherà l’area all’autostrada Roma-Fiumicino. Un’opera, quest’ultima, che sul totale pesa per quasi 94 milioni di euro e che, secondo indiscrezioni dell’ultima ora, potrebbe essere l’infrastruttura destinata a saltare. O a essere modificata.
Con effetti pesanti non solo sulla circolazione in quella zona durante le partite casalinghe della squadra giallorossa, quanto sull’intera tenuta del progetto. Il perché lo ricorda proprio Caudo: «Se anche solo una di queste opere contenute nella delibera del 2014 venisse meno si ricomincia tutto da capo».
Di più: l’ex assessore aggiunge che finora è stato raccontato lo stallo tra un ex assessore (Paolo Berdini) «che voleva tagliare le dita agli speculatori e i palazzinari che volevano portare avanti il progetto». Per Caudo, invece, il discorso è diverso: «La stasi si è creata tra un ex assessore che non ha compreso a pieno la nostra delibera e la Roma che non vuole ricominciare da capo l’iter del progetto».
Dopo le dimissioni di Berdini, due giorni fa, l’accordo sembra essere più vicino. Anche se vanno ancora individuati gli strumenti tecnici per il via libera al progetto. La Regione ieri ha fatto filtrare la sua posizione: «Siamo in attesa degli atti ufficiali da parte del Comune alla ripresa della Conferenza dei servizi, il 3 marzo». Per quella data il Comune dovrebbe approvare, prima in giunta e poi in Aula, la variante al Piano regolatore, correggendo quella bocciatura “con prescrizioni” inviata in Regione a inizio febbraio. Intanto c’è da completare la convenzione urbanistica con la Roma, all’interno della quale trasferire tutte le disposizioni del progetto, opere pubbliche comprese.
«Leggo che a scriverla è il privato — attacca Caudo — ma mi pare assurdo che i grandi paladini della trasparenza e della lotta al cemento lascino scrivere il contratto alla Roma». E aggiunge: «Al di là del gioco dei “cubi”, se venisse tagliata anche solo un’opera pubblica, si fa un favore al privato che all’inizio voleva costruire solo lo stadio. Se finirà così, l’obiettivo di massimizzare i profitti verrà raggiunto proprio grazie agli “anti-cemento”».
la Repubblica
GUAI A TRADIRE IL PATTO CON I COSTRUTTORI
L’intervento.la lettera dell'ex-Sindaco Ignazio Marino
Caro direttore, il dibattito intorno allo Stadio della Roma ha prodotto un fiume di parole confuse, per cui è necessario ripartire dai fatti.
La delibera della mia Giunta, votata in Assemblea Capitolina il 22 dicembre 2014, dichiarò il pubblico interesse all’opera, condizionandolo, ovviamente, non allo stadio privato, sul quale legittimamente la società sportiva conta per accrescere la propria competitività, ma alle opere connesse all’impianto sportivo e utili alla qualità della vita delle romane e dei romani.
In particolare venne previsto: 1. il potenziamento del trasporto pubblico su ferro a servizio dell’area di Tor di Valle e della città, con frequenza di 16 treni l’ora nelle fasce di punta e un nuovo ponte pedonale verso la stazione FL1 di Magliana (costo a carico del privato: 58 milioni di euro); 2. l’adeguamento di via Ostiense/via del Mare, di cui si parla da decenni, fino allo svincolo con il Grande Raccordo Anulare (costo a carico del privato: 38,6 milioni di euro); 3. il collegamento con l’autostrada Roma Fiumicino attraverso un nuovo ponte sul Tevere (costo a carico del privato: 93,7 milioni di euro); 4. l’intervento di mitigazione del rischio idraulico e di messa in sicurezza dell’area (costo a carico del privato: 10 milioni di euro).
Se verrà a mancare anche una sola di queste opere di interesse pubblico la delibera recita testuale: “(...) il mancato rispetto delle su esposte condizioni necessarie, anche solo di una, comporta decadenza ex tunc del pubblico interesse qui dichiarato e dei presupposti per il rilascio degli atti di assenso di Roma Capitale e della Regione Lazio, risoluzione della convenzione, con conseguente caducazione dei titoli e assensi che dovessero essere stati medio tempore rilasciati”. In sostanza, se si cancellano le opere pubbliche esterne allo stadio, viene meno il pubblico interesse e si deve riscrivere una nuova delibera. È questo lo stallo in cui si è impantanato lo stadio.
A Roma non c’è uno scontro tra voraci palazzinari e quelli che invece vogliono tagliare le unghie alla speculazione immobiliare. Sembra esserci più che altro un gioco, tra chi non vuole, avendo sbagliato percorso, perdere la faccia e chi, il proponente privato, chiede semplicemente certezze.
Molti commentatori pur ammettendo di non aver letto le carte hanno gridato alla speculazione. Bisogna giudicare il progetto nel suo insieme, comprese le torri di Daniel Libenskid, che hanno una forza non solo architettonica, ma saranno in grado di attrarre grandi gruppi internazionali, creando migliaia di posti di lavoro e sostenibilità economica al progetto.
Si è lanciato l’allarme per le inondazioni cui sarebbe sottoposta l’area dello stadio ma anche qui le carte dicono una cosa diversa. Il rischio esondazione c’è ed è reale, ma interessa una porzione di città esterna all’area di Tor di Valle che è già oggi abitata da moltissimi cittadini, quella del quartiere di Decima. Nessuno si era occupato di loro e il fatto che il progetto dello stadio approvato dalla mia Giunta preveda, ancora una volta a carico del privato, la messa in sicurezza del fosso rendendo più sicura la vita di quei cittadini, è un fatto, ma lo si omette.
Si preferisce invece l’immagine del conflitto tra buoni e cattivi, per alimentare i discorsi vuoti di chi, forse, non si sente in grado di entrare nel merito del progetto.
L’amministrazione Raggi ha davanti un bivio: o porta avanti il progetto originario con il massimo rigore e serietà nel presidiare il pubblico interesse preteso dalla mia Giunta o, se decide di cambiarlo, deve illustrare quali sono gli ulteriori vantaggi pubblici e concreti per la vita dei cittadini del nuovo indirizzo.
il manifesto
L’URBANISTICA DIVENTA CONTRATTATA , AL SERVIZIO DI INTERESSI PRIVATI
di Antonello Sotgia
«Stadio della Roma. Si sta ribaltando il concetto di "rispetto": le regole fissate a giochi fatti »
Daniel Libeskind, l’architetto polacco-americano chiamato a rimpolpare con tanto «altro» lo stadio della Roma di Tor di Valle, presentando i suoi tre grattacieli gettati nell’ansa del Tevere ha dichiarato d’aver preso, disegnando i suoi blocchi dorati squadrati, quale riferimento formale l’opera di Giovan Battista Piranesi. Ma i suoi sgraziati monoliti, a differenza della sublime solidità costruttiva propria alle opere d’invenzione dell’architetto veneto, non hanno resistito molto.
Tagliuzzando spazi tra un piano e l’altro, abbassando di qualche metro l’altezza fissata a 200 metri, cucendo e scucendo metri tra corridoi e pianerottoli, la giunta Raggi, ha scelto non di rigettare quel progetto, ma di cucinare con i resti. Sembra essere riuscita a mettere insieme quella manciata di superficie che consente adesso di affermare a Luigi Di Maio: «È tutta un’altra cosa, siamo di fronte ad un progetto sostenibile e rispettoso dei valori del Movimento 5 Stelle».
Una volta erano le città a richiedere e ottenere per loro rispetto, che attraverso le regole dell’urbanistica veniva riportato a chi la città abita. È stato proprio rispettandosi e riconoscendosi l’un l’altro come abitante, ritrovarsi sotto il medesimo cielo, a fare della città la costruzione collettiva per eccellenza. Da quest’atto deriva l’abitare. Anche quando assume la forma del conflitto. A questo serviva l’urbanistica. A far sì che gli interessi dei pochi non prevaricassero su quello dei molti. Questo, nei casi in cui ci si è riusciti, è la massima forma di rispetto possibile. Ora è il contrario. Le «regole» si fissano dopo aver sistemato il progetto. Una volta ascoltato e autorizzato senza battere ciglio quello che i proponenti vogliono fare.
L’urbanistica contrattata, che trova in Roma la sua indiscussa capitale e che è stata tenuta a balia dal disinvolto Piano regolatore veltroniano, con lo stadio conosce ora una nuova disciplina: il rispetto del proponente. Nel caso del cosiddetto stadio della Roma è difficile individuare il proponente in una sola figura. È la società sportiva, o questa è solo il veicolo necessario a far partire l’operazione immobiliare che poco ha a che fare con lo sport?
È il tycoon americano suo presidente, o questo è solo l’imprenditore che ha come obiettivo esclusivamente d’incrementare il patrimonio della società di cui è il maggiore azionista e poi magari venderla impreziosita di un «titolo edilizio» stimato ben oltre il valore attuale della società? È quel costruttore che si fa chiamare ora «sviluppatore», o questo è solo il suo ultimo disperato tentativo di poter salvare quel che resta del suo patrimonio tentando di coinvolgere la banca, vero padrone del suo asset societario, costruendole, con questo progetto e la sua futura gestione, l’acquisizione infinita di plusvalenze basate sulla estensione coatta del debito a tutti i soggetti interessati e allentare così (forse) il pesante peso debitorio?
Per questo proponenti e amministratori, anche se sembrano essersi accordati tra loro e trovata un’intesa, hanno ancora il problema di trovare una legittimazione al loro operato. Hanno bisogno dell’urbanistica che, cancellata, si ripresenta chiedendo di sottoporre quelle carte ad un voto del consiglio comunale dove il sistema bancario e i proponenti non saranno presenti. Sarà presente chi dovrà alzare la mano per autorizzare il tutto. E alzando la mano sarà costretto a far vedere la sua faccia.
il manifesto
L’URBANISTICA CONTRATTATA E L'ULTIMA TROVATA
di Enzo Scandurra
Il grande progetto Tor di Valle (che con lo stadio ha poco o niente a che vedere e, per favore, diciamocelo) cambierà Roma?
Roma sarà più moderna? Somiglierà di più a Milano e alle altre grandi città globali, come Londra, Barcellona, Dubai?
Al termine di una visita turistica ai Fori, a piazza Navona, a piazza Campo de’ Fiori, ci sarà la gita fuori porta a Tor di Valle per ammirare i grattacieli che si specchiano sul Tevere? E i borgatari di Ponte di Nona, di Tor Bella Monaca, del Laurentino saliranno sui torpedoni turistici per andare ad ammirare quel pezzo della loro città per scoprire bellezze a loro sconosciute, così da dire, al termine della gita: sono orgoglioso di vivere in questa città?
Non so se corrisponde a verità, ma ho letto che nella miracolosa sforbiciata destinata a ridurre la colata di cemento, c’è anche una riduzione dei posti del nuovo stadio: da 60 mila a 52 mila! Se è così, dentro l’amministrazione Raggi ci deve essere qualche mago che conosce cose sconosciute a tutti, ovvero che quegli 8 mila tifosi erano fasulli e tanto valeva tenerne conto. O forse a dimostrare che lo stadio, in quel faraonico progetto, da soggetto è diventato una variabile dipendente.
Tutto questo passa, nella testa di chi difende questo progetto, come modernizzazione, innovazione, stare al passo con i tempi, che poi sono i tempi di un capitalismo trasformatosi in pensiero comune, diffuso, molecolare: l’ideologia neoliberista che azzera la storia come inutile fardello.
E l’urbanistica? Di chi è la città, avrebbe detto Lefebvre?
Povera disciplina che pure in passato ha avuto qualche momento di sussulto, qualche bella stagione (chi si ricorda più di nomi di Olivetti, La Pira, Doglio, Sullo?). Ora a questa parola è stato aggiunto il qualificativo di contrattata, un po’ come è avvenuto alla democrazia che qualcuno vuole partecipata, perché a chiamarla semplicemente democrazia si rischia di non dire niente, semplice banalità, vecchio arnese arrugginito dal tempo.
Contrattata da chi? E con chi? Non certo con gli abitanti della città né col popolo delle periferie né con tutte quelle associazioni che quotidianamente si impegnano, e si battono, per avere una città semplicemente più decente. Contrattata con i soliti noti: quei poteri forti che a Roma, dai tempi di Pasolini, si chiamano impropriamente costruttori e che la bonaria ironia dei romani ha ribattezzato come palazzinari. I famosi palazzinari con al seguito banche creditrici e investitori hanno sempre segnato il destino di questa città.
È l’ultima scoperta del M5S; perché loro non sapevano, ai tempi della competizione elettorale per eleggere il sindaco, che a Roma di re non ce ne sono stati solo sette, ma che quella dinastia ha continuato a tenere botta. Così cacciato Berdini che, a detta di Raggi, parlava troppo e faceva niente, adesso sarà lei, la sindaca Raggi, improvvisata urbanista, a contrattarli, assicurandoci che non ci sarà una nuova colata di cemento. Su Tor di Valle pioverà manna dal cielo e Roma riprenderà a splendere più bella che pria.
È giorno di lutto per questa città, per i suoi abitanti e anche per quei tifosi che allo stadio certo ci tengono ma non a qualsiasi costo; anche loro vorrebbero una città più decente. Da domani ri-inizieremo a parlare di buche, di autobus che si fermano per la strada, di dove deve andare quella misteriosa metropolitana che sembra essersi persa nel sottosuolo romano, di tavolini selvaggi nel centro, e magari, perché no, di quegli insignificanti territori che si chiamano periferie abitati da cittadini che si chiamano tali solo il giorno delle elezioni.
E di Tor Bella Monaca, di Corviale, del Laurentino, che ne facciamo? Ora lo sappiamo: potremmo costruire altrettanti stadi così da riqualificare quei luoghi miserabili e diseredati con tanti grattacieli, magari ecologici, magari un po’ storti come si addice ai tempi moderni.

. T. Montanari, la Repubblica, F.Q., il Fatto Quotidiano, 16 febbraio 2017 (p.d.)
la Repubblica
LA LEZIONE DEL PARTENONE:
C'E' CHI DICE NO
di Tomaso Montanari
Ieri le agenzie hanno battuto una notizia che riconcilia con l’umanità: la Grecia ha detto no alla Gucci, che aveva chiesto di realizzare, e filmare, una sfilata di moda sull’Acropoli. Il particolare che rende clamorosa questa notizia è che la Gucci aveva offerto in tutto 56 milioni di euro (tra affitto e diritti televisivi). Come ogni fiorentino immediatamente comprende, questa notizia ci riguarda: anzi, parla di noi. Non solo perché la Gucci è fiorentina: ma perché è fiorentinissima, purtoppo, la mentalità che ha indotto la griffe ad avanzare quella richiesta. E allora leggiamo le motivazioni di quel no. La Commissione Archeologica greca cui spettava la decisione ha scritto che: "Il valore e il carattere dell’Acropoli è incompatibile con un evento di questo tipo". E il direttore del Museo dell’Acropoli Dimitris Pantermalis ha aggiunto: "Non abbiamo bisogno di pubblicità. Il simbolismo del monumento sarebbe svilito usandolo solo come ‘sfondo’ per una sfilata di moda".
Su un giornale di ispirazione moderata - Kathimerini, che esce in inglese con l’edizione internazionale dell’Herald Tribune - il poeta Pantelis Boukalas ha commentato la decisione con parole altissime. Parole che, lette da questa Firenze, fanno sanguinare il cuore: "Il Partenone è parte del patrimonio culturale dell’umanità non solo perché è bello, ma perché è un luminoso simbolo di democrazia. L’ultimo tentativo di umiliarlo è stata una richiesta della casa di moda Gucci di tenere una sfilata di moda sull’Acropoli, usandolo come sfondo. L’argomento a favore sarebbe che ciò promuoverebbe la libertà dell’espressione artistica e l’innovazione creativa. Questa artificiosa giustificazione non riesce a spiegare perché la libertà artistica dovrebbe passare attraverso la sottomissione di uno dei più grandi simboli dell’umanità a interessi commerciali. Il valore simbolico del Partenone è stato minacciato anche quando è stato recentemente chiuso al pubblico in occasione della visita del presidente americano Barack Obama, ma il danno sarebbe esponenzialmente più grande se il monumento fosse usato come fondale di un evento commerciale. L’argomento che esso beneficerebbe dell’enorme compenso o della pubblicità dell’evento è solo il travestimento di un cinismo abbietto».
Insomma: c’è chi dice no. Ed è commovente che questo ‘no’ venga da Atene, culla di ogni idea di democrazia. Da un’Atene in tali condizioni economiche da rendere ancora più ammirevole la dignità di questo no. E la “nuova Atene” (così si alludeva alla Firenze del Magnifico)? La nostra povera Atene è già in vendita da un pezzo, e per cifre incredibilmente ridicole, al confronto con i 56 milioni inutilmente offerti dalla Gucci. Non solo Matteo Renzi, Dario Nardella o Eike Schmidt, ma temo molti fiorentini, non riescono a pensare Ponte Vecchio, a Santa Maria Novella o a Palazzo Pitti come ad un patrimonio dell’umanità che non può essere sottomesso a interessi commerciali senza svilirlo, e, in ultima analisi, eroderlo irreparabilmente.
Ma non è mai troppo tardi per invertire la rotta.
il Fatto Quotidiano online
AGRIGENTO, DOPO IL NO
DI ATENE AI SOLDI DI GUCCI
IL SINDACO PROPONE LA
VALLE DEI TEMPLI
Atene non vuole i milioni di Gucci? E allora si fa avanti Agrigento. Nei giorni scorsi il Consiglio archeologico centrale greco (Kas) ha rifiutato un sostanzioso contributo economico offerto dalla casa di moda per poter organizzare a giugno una sfilata sull’Acropoli che sovrasta la capitale. Così Calogero Firetto, sindaco della città siciliana, ha pensato di candidare la Valle dei Templi, che nulla ha da invidiare alle bellezze della penisola ellenica. “Eventi riservati a pochi ospiti sono oggetto di un regolamento del Parco archeologico della Valle dei Templi - ha spiegato il primo cittadino all’
Adnkronos - e, in linea con le norme nazionali, sono stabiliti canoni e diritti di immagine“. Agrigento ha già ospitato molti eventi importanti come il Google Camp, ora potrebbe essere la volta della passerella dello storico marchio italiano comprato dai francesi di Kering.
“Penso che la Valle dei Templi, scelta per altri eventi privati di carattere internazionale, possa essere uno scenario anche più suggestivo dal punto di vista della qualità dell’immagine e della resa pubblicitaria”, ha aggiunto Firetto, sottolineando come l’area archeologica, che vanta una serie di templi dorici del periodo ellenico, abbia appena vinto il Premio nazionale del Paesaggio e sia candidata per l’Italia allo stesso premio del Consiglio d’Europa. “Per Agrigento e per Gucci sarebbe un’opportunità: il reciproco vantaggio è abbastanza ovvio - ha detto il sindaco - inoltre la casa di moda potrebbe rispettare la sua volontà di realizzare una sfilata tra i templi greci, in un luogo che è patrimonio dell’Umanità dichiarato dall’Unesco“.
“Concedere l’uso dell’Acropoli sarebbe stata un’umiliazione“, si legge in un editoriale pubblicato dal quotidiano greco ekathimerini. Firetto invece sostiene che “l’orgoglio verso il nostro passato si esprime ogni giorno in un paesaggio vivo e non imbalsamato, pronto ad accogliere tutto ciò che esprime la cultura contemporanea ad alti livelli, in Italia e nel mondo”. L’archeologia ad Agrigento “non è statica, ma pulsa di vita - ha concluso Firetto - attraverso la creatività di uomini e donne, che nell’arte, nella poesia, nella letteratura, nella scienza, nelle attività produttive, con un carattere fortemente innovativo e nel rispetto dei luoghi, riescono a legare magicamente classicità e contemporaneità”. Ora resta solo da attendere la risposta di Gucci.
 Stadi di Roma e di Firenze, Tav Val di Susa, Ponte sullo Stretto: «mega progetti presentati come la panacea di tutti mali, unica prospettiva per il rilancio dell’economia, l’immagine e il futuro di un territorio. Bisognerebbe invece partire dalla manutenzione come bisogno primario per aprirsi a piani, anche ambiziosi, ma sostenibili». il manifesto, 15 febbraio 2017 (c.m.c.)
Stadi di Roma e di Firenze, Tav Val di Susa, Ponte sullo Stretto: «mega progetti presentati come la panacea di tutti mali, unica prospettiva per il rilancio dell’economia, l’immagine e il futuro di un territorio. Bisognerebbe invece partire dalla manutenzione come bisogno primario per aprirsi a piani, anche ambiziosi, ma sostenibili». il manifesto, 15 febbraio 2017 (c.m.c.)
L’esito del duro scontro acceso intorno alla questione del nuovo stadio a Roma, e magari le dimissioni del prestigioso assessore Berdini, non riguarda solo la capitale. È una battaglia che ha un valore simbolico per tutto il nostro paese.
È da almeno vent’anni che si discute animatamente e si lotta duramente in alcuni casi (come per il Tav in Val Susa) sulle grandi opere prospettate di volta in volta come la panacea di tutti mali, unica prospettiva per il rilancio dell’economia, l’immagine e il futuro di un determinato territorio. Purtroppo, bisogna dire che la resistenza dei movimenti ambientalisti e di una parte della sinistra (a cui negli ultimi anni si era aggiunto il M5S) non è stata finora sufficiente a bloccare questa hybris che si manifesta con più forza nei momenti di crisi economica come quello che stiamo attraversando.
Poco prima di perdere il Referendum l’ex premier ha tirato nuovamente in ballo il Ponte sullo Stretto come prospettiva realistica con cui rilanciare quest’area del nostro Sud che presenta altissimi tassi di inoccupazione giovanile ed una fuga da questo territorio che ormai è diventato un esodo. Ci piaccia o no, le Grandi Opere esercitano un fascino sulla gran parte della popolazione perché il modello di sviluppo che abbiamo visto ed interiorizzato è questo e non riusciamo a immaginarne un altro.
Uno dei migliori contributi che ci ha dato Serge Latouche, soprattutto nei suoi primi scritti, è stato appunto questo: non usciamo da questa crisi, ambientale e sociale, se non cambiamo immaginario, se non la smettiamo di ridurre tutto il mondo a merce, un paesaggio o un bosco. Che non significa abbracciare tout court una nuova religione della “decrescita”, ma essere capaci di creare posti di lavoro, di autorealizzazione, spazi vivibili e progetti/visioni del futuro entusiasmanti, senza continuare a massacrare di cemento il nostro paese. E questo vale ovviamente anche per la capitale.
Lo si può fare recuperando il già costruito e magari abbandonato, come giustamente ci ricordava Piero Bevilacqua rispetto al caso dello stadio Flaminio, lo si può fare utilizzando nuove tecnologie, dando spazio agli artisti di ogni ordine e grado.
È questo lo snodo fondamentale per costruire una alternativa a questo sistema, altrimenti non importa chi ci governa perché la forza degli interessi in gioco unendosi a questa subalternità culturale, a questa mancanza di fantasia, sarà sempre vincente. Come spesso viene ricordato la Politica come la Fisica non sopporta il “vuoto”, e quando si crea c’è sempre qualcuno o qualcosa pronto a riempirlo. E questo è vero anche per il territorio, non nel senso dello spazio vuoto, ma del vuoto culturale che lascia un territorio senza prospettive.
A Saline Joniche in provincia di Reggio Calabria venne inaugurata nel 1975 la Liquichimica, una fabbrica che doveva produrre dal petrolio proteine per l’alimentazione animale. Assunse 500 addetti, gli fece fare sei mesi di formazione con soldi pubblici, ma non un solo giorno di lavoro. Il prezzo del petrolio era salito alle stelle rendendo non competitive queste “Bioproteine” rispetto alla soia statunitense. I cinquecento andarono tutti in cassa integrazione e in queste condizioni sono andati in pensione.
Per quaranta anni si è lasciato senza manutenzione, in uno stato di penoso abbandono l’ampio spazio occupato da questo stabilimento – comprese le mega piscine per decantazione – che sorge sul mare in uno dei posti più belli della costa jonica calabrese. Ma, nel 2014 una impresa multinazionale svizzera presentò un progetto per costruire una mega centrale a carbone. Riuscì a coinvolgere (corrompere) una parte degli amministratori locali, ma non la popolazione che insorse e costrinse enti locali e governo regionale a bloccare questo folle progetto. State sicuri che se verrà lasciata ancora nell’abbandono altri progetti folli vedranno la luce e qualcuno alla fine la spunterà.
La scommessa è questa: partire dalla manutenzione come bisogno primario per aprirsi a progetti, anche ambiziosi, ma sostenibili sul piano ambientale e sociale capaci di mobilitare energie per un orizzonte comune su cui puntare.

la Repubblica economia finanza, 15 febbraio 2017 (p.s.)
La storia e la cultura non hanno prezzo. E Atene, al settimo anno di una crisi economica che si è mangiata il 25% del Pil, dice no ai soldi offerti dalla Gucci per consentire una sfilata di moda di un quarto d'ora sull'Acropoli.
La richiesta della casa di moda è arrivata nei giorni scorsi sul tavolo della Commissione archeologica della Grecia (Kas) con un'offerta - immaginavano gli estensori - difficile da rifiutare, visto lo stato di salute delle casse elleniche: un milione per l'affitto della "roccia sacra" per uno show di 900 secondi da tenere proprio di fronte al Partenone, riferisce la stampa ellenica. Più 55 milioni per i diritti a girare e promuovere in giro per il mondo il filmato della passerella. Anche se di soldi, dice la società fiorentina, non si era ancora parlato in questa fase dell'operazione.
La risposta del Kas è stata però categorica. «Il valore e il carattere dell'Acropoli è incompatibile con un evento di questo tipo». Punto. «Non abbiamo bisogno di pubblicità - ha rincarato la dose Dimitris Pantermalis, direttore dello splendido Museo dove sono ospitati i resti del fregio del tempio antico e le Cariatidi -. Il simbolismo del monumento sarebbe svilito usandolo solo come "sfondo" per una sfilata di moda».
Poveri sì, insomma, ma non abbastanza da mettere in vendita l'anima del paese. La Gucci aveva avanzato la sua richiesta ricordando come nel 1951 i marmi e le colonne del Partenone avessero fatto da palcoscenico a una sfilata di Christian Dior. Altri tempi però, la Commissione, irremovibile, ha detto no mentre il marchio della Doppia G ha confermato di avere avuto un incontro con l’autorità ellenica per presentare un progetto di collaborazione culturale a lungo termine e raccogliere l’opinione dell’autorità stessa, ma che nessuna offerta economica è mai stata formulata.
«Concedere l'uso dell'Acropoli sarebbe stata un'umiliazione» ha commentato in un editoriale il quotidiano Kathimerini. I marmi dell'Acropoli sono stati sfruttati in passato per gli spot della Coca-Cola, di Lufthansa e Verizon (che ha trasformato le colonne in cabine telefoniche) e come set per un servizio fotografico di Jennifer Lopez non autorizzato dal Kas. Ma la storia (e la dignità) della Grecia non sono in vendita. Nemmeno oggi che lo Stato è quasi in bancarotta.
«Vertice della svolta sul nuovo stadio con il direttore della As Roma e il costruttore Parnasi. L'assessore all'Urbanistica Berdini dà le dimissioni "irrevocabili"». il manifesto, 15 febbraio 2016 (p.d.)
Lo sguardo ineffabile delle radio dei tifosi giallorossi saluta l’accordo sullo stadio tra giunta capitolina e As Roma. Non c’è ancora un via libera ufficiale alla cittadella che sorgerà a Tor di Valle col viatico del nuovo impianto, ma poco ci manca. Tanto che dopo giorni di attesa, l’assessore all’urbanistica Paolo Berdini annuncia le sue «dimissioni irrevocabili». «Mentre le periferie sprofondano in un degrado senza fine e aumenta l’emergenza abitativa, l’unica preoccupazione sembra essere lo Stadio della Roma», è il grido di dolore dell’ormai ex assessore.
Alla riunione della svolta c’è il primo in grado della Roma in Italia, il direttore generale Mauro Baldissoni. Con lui arriva il costruttore Luca Parnasi. Si apprende che la società calcistica aveva chiesto la presenza della sindaca. Lei però non si presenta. Per l’amministrazione capitolina ci sono il vicesindaco Luca Bergamo, il presidente del consiglio comunale Marcello De Vito, il capogruppo Paolo Ferrara e la presidente della commissione Urbanistica di Roma Donatella Iorio, che smentisce di essere candidata a sostituire Berdini in assessorato. Dalla composizione si capisce che l’incontro è più politico che tecnico. L’ultimo di questo genere si era tenuto proprio nella sede dell’ assessorato all’urbanistica quando il padrone di casa era in pieni poteri. Questa volta ci si vede in Campidoglio. Ma colui che ha definito il progetto «la più imponente speculazione immobiliare del momento in Europa» che richiederebbe «la più grande variante urbanistica ad hoc mai approvata a Roma», non è della partita. Senza l’assessore ancora formalmente in carica (seppure «con riserva») si discute di 974 mila metri cubi di cemento che comprendono solo per un 14% lo stadio vero e proprio. Il resto contiene le tre torri disegnate dallo studio Libeskind, un albergo e centri commerciali. E poi c’è da parlare di opere infrastrutturali come ponti e uno svincolo. Berdini chiedeva appunto di tornare nell’ambito del Piano regolatore di Roma, secondo cui andrebbe costruito lo stadio e poco più.
Ai primi di febbraio, il Campidoglio aveva ufficialmente chiesto la modifica del progetto per alcune carenze. La posizione di Berdini, favorevole a un drastico taglio di cubature, si scontrava ormai da settimane con quella dell’ala dialogante del M5S, che sarebbe capeggiata dall’assessore allo sport Daniele Frongia, pronta a chiudere un accordo con una diminuzione delle cubature attorno al 20%, magari tagliando in altezza qualche edificio.
Ballano 600mila metri cubi di cemento, insomma. E dietro quelle cubature si agitano gli spettri della tradizionale speculazione edilizia assieme ai giochi fantasmagorici della finanza, con Unicredit a tenere i cordoni della borsa. Così, quando Luca Bergamo esce dalla riunione annunciando con soddisfazione che si è aperto un nuovo corso, si capisce che la fronda pro-stadio ha preso il sopravvento. «Vorrei ringraziare la Roma per aver risposto alle nostre sollecitazioni nella riunione della scorsa settimana presentandoci oggi una revisione del progetto che ha dei caratteri fortemente innovativi – dice Bergamo – I tavoli tecnici sono ancora al lavoro, faremo una valutazione di questa importante novità e ci siamo dati appuntamento alla prossima settimana». Se riusciranno a rispettare i tempi, cioè si avrà un primo via libera entro il 3 marzo? «È ovvio», risponde sicuro il vicesindaco. A chi gli chiede maggiori dettagli, come quello – decisivo per capire di che compromesso si tratta – circa l’esistenza di una variante urbanistica che passerà in consiglio, Bergamo risponde: «Di tutti questi elementi parleremo una volta completata questa primissima fase».
Anche Baldissoni si sbilancia: «Noi abbiamo sempre detto che vogliamo fare questo progetto insieme alla città. Abbiamo cercato di intercettare quali sono le esigenze e visioni della nuova giunta. Continuiamo a lavorare insieme, nel rispetto dei tempi e della sostenibilità del progetto stesso». Si vedrà se adesso quella parte di base grillina che nei giorni scorsi ha contestato il progetto, o almeno ha chiesto che la decisione venisse decisa mediante votazione online sul sito di Grillo, accetterà i termini dell’accordo.
Tutto mentre la cottura a fuoco lento di Berdini è proseguita fino a ieri pomeriggio, con la sindaca che non voleva farne una vittima e puntava a sfiancarlo. L’ultima trovata degli avvocati passati alla politica che costituiscono l’ossatura della giunta (ci si faccia caso, hanno l’abitudine di appigliarsi al cavillo e alle procedure) si chiamava «due diligence», sorta controllo degli atti finora portati avanti dall’urbanista. Solo che stavolta Berdini sbatte la porta: «Era mia intenzione servire la città mettendo a disposizione competenze e idee. Prendo atto che sono venute a mancare tutte le condizioni per poter proseguire il mio lavoro». Il consigliere pentastellato Pietro Calabrese lo accusa: «Se alle parole non corrispondono i fatti è normale che le strade a un certo punto si dividano». Raggi è gelida: «Prendiamo atto che l’assessore preferisce continuare a fare polemiche piuttosto che lavorare. Noi andiamo avanti». L’ex assessore torna al suo lavoro di urbanista, spiegando dove secondo lui la giunta ha mancato: «Dovevamo riportare la città nella piena legalità e trasparenza delle decisioni urbanistiche, invece si continua sulla strada dell’urbanistica contrattata, che come è noto, ha provocato immensi danni a Roma».

Ogni periodo della vita delle città nel capitalismo ha l'evento che traina la devastazione della città. Nei nostri anni tocca agli stadi. Anche a Firenze. Chi organizzerà un giro d'Italia? il Fatto Quotidiano, blog "Alle porte coi sassi", 14 febbraio 2017
Un nuovo stadio. E a fianco una Cittadella Viola che fa gonfiare volumetrie e proventi. Metri cubi da costruire in project financing nei pressi dell’aeroporto in espansione (quello di Carrai e Eurnekian) che, a sua volta, scalza una vecchia lottizzazione oggi in mano alla Unipol. In un clima di land grabbing all’argentina. Tutto, o quasi, fuori dalla pianificazione generale.
Vediamo meglio.Un nuovo stadio. E a fianco una Cittadella Viola che fa gonfiare volumetrie e proventi. Metri cubi da costruire in project financing nei pressi dell’aeroporto in espansione (quello di Carrai e Eurnekian) che, a sua volta, scalza una vecchia lottizzazione oggi in mano alla Unipol. In un clima di land grabbing all’argentina. Tutto, o quasi, fuori dalla pianificazione generale.
Vediamo meglio.
Il nuovo stadio è una trottola che gira tra cantieri e progetti evanescenti alla periferia occidentale del capoluogo toscano. Nel 2008 si diceva della sua costruzione nel “parco di Castello”, ottanta ettari di verde quale compensazione al progettato milione e 200.000 metri cubi di nuove costruzioni, allora intestato a Ligresti. Lo stesso parco che così, senza giri di parole, il sindaco Domenici chiosava: «mi fa cacare da sempre». Traduzione: in quell’area (paludosa) non ci vuole andare nessuno. Cosa di meglio allora di uno stadio con una corona di edifici speculativi? Spunta l’idea della Cittadella Viola: parcheggi, centro commerciale, hotel, museo dello sport. Più un parco a tema, tutto con firma d’autore. Un’altra nuvola di Fuksas.
Con la Magistratura in azione a Castello, sul progetto dello stadio è reputato opportuno mettere la sordina. Ma solo per poco.
La giunta Renzi, in Palazzo Vecchio dal 2009, non rinuncia ai metri cubi dello stadio e del suo corredo, che, nelle parole del sindaco, continua a rappresentare una «ghiotta opportunità per il territorio». Lo stesso sindaco che abbagliò l’Italia con un PRG “a volumi zero”, nei quali volumi zero, a mo’ di magico cilindro, si nascondeva (anche) la «Disneyland del calcio» di Della Valle, patròn viola.
La trottola continua a girare. Il Piano Strutturale Comunale (PS) arranca nel cartografarne i movimenti, registrati ex post da una variante (2012) al vecchio, ma vigente, PRG. Anziché dettare regole certe, il successivo Regolamento Urbanistico Comunale (2014) conterrà indicazioni flessibili alle occasioni di mercato, che si susseguono.
Quando si staglia sulla scena, nitido, il “pasticciaccio brutto” del nuovo aeroporto di Firenze, la limitrofa lottizzazione di Castello – quella di Ligresti, poi Unipol – è in parte sacrificata all’aviazione. Saltano metri cubi ed ettari edificabili. (Oggi, dalla stampa trapela che ai bolognesi di via Stalingrado, proprietari dei futuri volumi, potrebbe succedere Eurnekian, imprenditore dei due mondi. Che, in tal modo, sbancherebbe.)
La progettata pista dell’aeroporto richiede spazio: lo stadio deve spostarsi. Si pensa subito alla vicina area della Mercafir (cfr. variante al PRG 2012). Colpito dal giro di trottola, il Mercato Ortofrutticolo relegato dalla variante in un cantuccio dello stesso comparto, ora schizza a ovest, fuori dalle previsioni di PS e RU: la scelta oscilla tra Quaracchi e l’Osmannoro, poi – per ristabilire un opportuno equilibrio con quanto tolto – si orienta su Castello. Tutto a spese del pubblico, mentre il Comune, nel bilancio preventivo appena approvato, elemosina spiccioli con la vendita di ville rinascimentali e case popolari. Si dice che (in cambio dell’area Mercafir, tutta intera) Della Valle paghi il terreno del nuovo mercato ortofrutticolo.
Nel marzo 2016 Nardella, da Londra, parlava di un «investimento privato di interesse pubblico» ancora comprensivo di cittadella. A fine dicembre il progetto della Fiorentina Calcio ne ridimensiona i volumi accessori. La Cittadella viola, ancorché ridotta, non perde il carattere di core business, come avvertono anche i tifosi.
Se il quadro resta quello descritto, Firenze avrà uno stadio «modello Bordeaux», un potente edificio alto circa 40 metri, visivamente interposto tra le ville medicee di collina e la cupola del Duomo. Per conferire conformità urbanistica al progetto, è allo studio una variante al Piano Strutturale. Prima lo stadio, poi l’urbanistica. Come a Roma.
Utilizzare i meccanismi della rendita immobiliare per ricavarne le risorse necessarie per il miglioramento della città è un errore, che provoca gravi distorsioni alle regole e gli effetti del governo del territorio. la Repubblica, 14 febbraio 2017
QUANDO si ascoltano Alessandro Di Battista, Luigi Di Maio e Virginia Raggi promettere che, sì, lo stadio della Roma si farà, viene da pensare che ci sia una maledetta linea d’ombra, nella vita pubblica italiana. Quella linea è l’elezione a una carica pubblica.Quando la varca, il cittadino subisce una mutazione radicale nel linguaggio, nell’etica, nella scala delle priorità. Perfino nella logica. Non è più un cittadino, ormai: diventa il pezzo di un potere immutabilmente uguale a se stesso, chiunque lo incarni.
La città (non solo Roma) si è disfatta, è diventata invivibile, a tratti mostruosa, perché si è smesso di pensarla e di disegnarla. Si è rotto il legame tra la comunità degli uomini e la città materiale: la prima ha cessato di immaginare e modellare la seconda. Il taglio delle finanze locali, l’ignoranza e la corruzione delle classi dirigenti hanno delegato a pochi grumi di interesse privato (palazzinari e banche, in sostanza) lo sviluppo delle città, secondo questa logica perversa: “io amministratore permetto a te speculatore di prenderti un pezzo di spazio pubblico, se in cambio mi fai quei servizi, quelle urbanizzazioni, quelle infrastrutture necessarie alla comunità che io non ho i soldi per fare, né la voglia di pensare”. È la fine dell’urbanistica, e dunque la fine della città pubblica. Questa abdicazione è stata compiuta indifferentemente da destra e da sinistra.
Un simbolo di questa continuità perfetta è stata la figura di Maurizio Lupi: assessore allo Sviluppo del territorio, edilizia privata e arredo urbano del Comune di Milano nella giunta di Gabriele Albertini e poi ministro delle Infrastrutture dei governi Letta e Renzi. La linea Lupi è quella della Legge Obiettivo di Berlusconi del 2001: che resuscita, peggiorata, nello Sblocca Italia di Renzi (e Lupi, appunto) nel 2014. Il motto delle due leggi era lo stesso: “padroni in casa propria”. Parole che volevano solleticare i cittadini, ma che di fatto descrivevano perfettamente le figure di amministratori che si sentono padroni del territorio solo per svenderlo ad interessi particolari. Un pensiero unico che tende ad inghiottire tutti: basti pensare ad Enrico Rossi, che mentre si candida a guidare il Pd e il Paese con idee socialiste, impone ai cittadini della Maremma un’autostrada che essi non vogliono.
Ora è il turno dei 5 Stelle. In campagna elettorale il loro slogan (sommario, ma efficace) era: riprendiamoci il governo della città. Non come 5 stelle, come cittadini. Ed è su questo che hanno avuto il voto di moltissimi romani di sinistra. La prima cosa che i vincitori avrebbero dovuto fare una volta entrati in Campidoglio era dunque ritirare la delibera 132/2014: quella con cui la giunta Marino aveva stabilito che il progetto dello stadio — un progetto della Roma (la società, non la città), che prevede un milione di metri cubi di cemento con destinazione prevalente a uffici per ospitare multinazionali e attività commerciali — fosse “di pubblico interesse”.
Era una battaglia difficile, ovviamente: una battaglia che si poteva vincere solo spiegando molto chiaramente agli elettori la situazione, chiedendo pubblicamente l’appoggio dei romani contro chi minacciava — e minaccia — di mettere in ginocchio la città attraverso cause miliardarie. D’altra parte, tutti sappiamo che per invertire la rotta pluridecennale della privatizzazione delle città occorre una clamorosa rottura della continuità: una rottura che affermi il primato della politica e del bene comune sugli affari e sugli interessi privati. Ma è successo tutto il contrario: e ora ci si viene a dire che lo stadio si farà, vedremo con quante torri e quanta speculazione attorno.
I 5 Stelle vengono quotidianamente passati al microscopio da chi si aspetta (o magari si augura) di poterli dichiarare uguali a tutti gli altri nella corruzione. Ma quello che sta emergendo è qualcosa di diverso, forse di peggiore. E cioè che essi rischiano di essere uguali agli altri nella subalternità allo stato delle cose: in un difetto, e non già in un eccesso, di radicalità. Perché chiunque varca quella famosa linea d’ombra senza una visione, senza un progetto, senza sapere quale città e quale politica vuole, non riuscirà a cambiare niente. Anzi, ne sarà inesorabilmente cambiato.

Un progetto obsoleto ma una Grande Opera produttrice di giganteschi investimenti pubblici e generatrice di ingenti arricchimenti privati, ostacolata da un’intelligente e tenace opposizione popolare
Le “grandi opere” inutili e/o dannose non sono una prerogativa italiana, come sanno coloro che a livello europeo si occupano di questa problematica di vaste dimensioni. Dappertutto questi grandi progetti che implicano un oneroso investimento pubblico provocano ingenti danni non solo ambientali ma anche sociali ed economici alle comunità.
Il progetto
Secondo un progetto che risale al lontano 1994, la principale stazione ferroviaria di Stoccarda, situata in centro-città, con 17 binari e una frequenza di 50 treni all`ora, sta per essere sotterrata. Il grande cantiere, aperto nel febbraio 2010, è ormai esteso a tutta la città e devasta da anni ampi spazi cittadini : si scavano tunnel per circa 60 km per far passare solo 8 binari sui quali dovrebbero transitare 32 treni all`ora.
L’argomento ufficiale del necessario potenziamento del nodo ferroviario è dunque obsoleto, come si può evincere anche dalla nuova stazione centrale di Vienna, attiva dal 2015 e simile nelle sue dimensioni, con un traffico inferiore del 30% rispetto a quanto previsto anche per la nuova stazione di Stoccarda. Quali sarebbero allora i benefici di questa grande opera, i cui costi sono balzati dagli iniziali 2 miliardi di euro a 4,5 nel 2011, a 6,5 nel 2013 e nel 2016 a oltre 10 miliardi di euro? Si presume inoltre che con la nuova linea ferroviaria prevista sulla tratta Wendlingen - Ulm i costi lieviteranno a ben 14,6 miliardi di euro complessive. (Queste cifre sono infine da paragonare con la somma erogata alle Ferrovie tedesche per l’intera rete nazionale: 1,2 mrd.di euro.)
Oltre ai lauti profitti per le ditte di costruzione, ci si aspetta così anche per città e regione un lucrativo sviluppo urbano ed economico, last but not least sulle superfici liberate dagli attuali binari (circa 100 ettari). Ma anche qui i calcoli sono alquanto vaghi e la Corte dei conti ha ammonito contro aumenti e ritardi a seguito di una pianificazione solo approssimativa.
Richiesto dalle Ferrovie S.p.A. come “controllo” dello stato dei lavori (la cui fine si è posticipato ormai al 2021/22), il più recente rapporto (2016) della multinazionale KPMG, che fornisce servizi professionali alle grandi imprese nel mondo, si basa solo su informazioni interne e conferma più o meno le aspettative del committente pur rivelando tra le righe molte lacune su una serie di gravi mancanze tecniche. Oltre al fatto che non è di dominio pubblico.
La resistenza
L`intero progetto è stato osteggiato attivamente dal 2009 fino al 2011 da decine di migliaia di cittadini, sostenuti all`inizio dalle organizzazioni di tutela ambientale del Bund e dal partito dei Verdi. Nel 2011, i Verdi sono entrati in coalizione con la Spd (dal 2016 la coalizione è con la Cdu) al governo del Land Baden-Württemberg oltre a quello della città di Stoccarda, e da allora essi hanno virato su una posizione consenziente: “costruttiva, ma critica”.
Anche sull’onda dell`esito “favorevole” al finanziamento regionale, espresso in un referendum regionale nel novembre 2011, che - pur senza raggiungere il quorum necessario - ha fatto crollare parte della resistenza attiva. Ciò nonostante permane un’opposizione di base molto decisa al progetto “Stuttgart 21” che ha elaborato un progetto alternativo per una “svolta” (Umkehr 21/K21) mantenendo alta l`attenzione in città, nella speranza che “Stuttgart 21” non venga portato a termine nel modo previsto alla luce delle tante questioni ancora aperte. Dal 17 luglio 2010 il nucleo duro di resistenti (circa 300 persone, in maggioranza donne) tiene aperto 24 ore su 24, giorno e notte, davanti alla stazione centrale la “Mahnwache”, un posto di monito, di protesta permanente dove chiunque può trovare materiali e informazioni sullo stato delle cose.
Ogni lunedì (ininterrottamente dal 26 ottobre 2010!) questo gruppo di irriducibili organizza un raduno serale con qualche oratore nella centrale Schlossplatz che poi raggiunge in corteo la stazione centrale (alla 357a manifestazione dello scorso 6 febbraio hanno partecipato anche testimoni contro le grandi opere a Firenze e Venezia).
Con il gruppo di lavoro nominato “Stuttgart 21 è ovunque” si è potuto constatare che in ogni paese, e nello spazio pubblico sempre più privatizzato, le grandi opere non corrispondono alle esigenze concrete dei cittadini o del territorio ma piuttosto alle aspettative di alto profitto dei capitali, aspettative difficilmente raggiungibili altrove nella fase dell`odierno capitalismo. Lottare contro questi mostri (per lo più di cemento) significa quindi anche lottare per un futuro sostenibile per tutti.
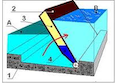
La stampa più attenta denuncia i mille pasticci del MOdulo Elettromeccanico Sperimentale, che dovrebbe "salvare" Venezia e la sua laguna. Tutto vero: ma tutti trascurano il rischio più devastante: la risonanza fisica. Ce lo racconta un esperto
Gli ormai frequenti episodi di inconvenienti che si stanno constatando nella fase di realizzazione del Mose rappresentano incidenti di percorso che possono impressionare una opinione pubblica o istituzionale volutamente poco informata ed affascinata da inediti o presunti scoop giornalistici. Una sequenza di notizie che giustamente vengono messe in evidenza da una buona stampa che segnala scenari critici di una attività di cantiere in essere la cui tipologia di incidente può essere ricondotta a correzioni più o meno prevedibili e costose, ma che comunque non scalfiscono l’iter che continuerà a svolgersi con la prosecuzione e conclusione dell’opera.
Sta succedendo, e succederà in seguito, con o senza notizie giornalistiche, azioni della magistratura o controlli amministrativi, quanto era desumibile da tutte quelle critiche scientificamente fondate ed inascoltate esposte fin dal momento del concepimento del Mose (critiche di tipo progettuale, ambientale, procedurale, di cantierizzazione e di gestione) contenute ricordiamo soprattutto nei voti del Consiglio Superiore dei LL.PP (1982 e 1990), nella valutazione negativa di impatto ambientale (1998) e nella forte presa di posizione del Comune di Venezia nel 2006 che questa opera non solo avversava, ma dimostrando tecnicamente i suoi difetti proponeva soluzioni alternative meno impattanti, più funzionali, meno costose, più consapevoli dell’eustatismo in corso e più rispondenti al rispetto di quell’equilibrio idrogeologico ed eco sistemico che gli indirizzi della legislazione speciale indicano.
E va tenuto presente che contemporaneamente a queste connotazioni tecnico-scientifiche cresceva quella vasta area di opinione e di mobilitazione popolare contraria a tale opera che ha conosciuto alti momenti di tensione con occupazioni delle aree di cantiere del Mose, della sede del MAV (Magistrato alle Acque di Venezia), della sala del Consiglio Comunale, delle sede del CVN (Consorzio Venezia Nuova) provocando processi contro i manifestanti con pesanti capi di imputazione. E lo slogan che doveva rivelarsi profetico attribuito al Mose era “ Opera inutile e dannosa utile solo per chi la fa “.
Non c’è da meravigliarsi quindi di cosa ci si può aspettare da una opera di questo tipo, di dimensioni inusitatamente maggiori di quanto avrebbero potuto essere, basata su tecnologie obsolete, concepita con una inutile e pericolosa complessità che ne comprometterà l’efficacia, e con grossi difetti di comportamento dinamico, che ne potranno determinare la perdita di funzionalità operativa. La sua architettura di sistema comporta l’esistenza di una enorme quantità di elementi “ semplici “ interconnessi funzionalmente e soggetti a critiche condizioni ambientali che, nel loro insieme, costituiscono un sistema estremamente complesso, che dovrà operare in situazioni ambientali difficili od estreme, la cui affidabilità necessariamente costituirà un problema nella sua lunga vita operativa e che richiederà una manutenzione continua e costosa. Basti sapere che per garantire la corretta operatività ci sono circa 3000 (tremila) componenti e sottosistemi di comando, controllo, sicurezza e monitoraggio collegati funzionalmente tra loro.
Rimanendo nella logica progettuale del Mose, prescindendo ma confermando che il riconoscimento di quella aprioristica errata impostazione progettuale di carattere idraulico di non voler ridurre permanentemente gli attuali scambi mare-laguna avrebbe impedito la nascita di una simile opera ,si sta assistendo a numerose criticità (paratoie che non si alzano, materiale delle cerniere, detritti nelle sedi di alloggiamento, subsidenza, altezze d’onda che allagano i tunnel, basi di fondazione collassate durante lo zavorramento, ossidazioni delle cerniere/connettori ecc.) che sarebbero tutte meritevoli di approfondimento tecnico che però non è possibile verificare stante la pratica sempre seguita dal CVN e dal MAV di non rendere noti i dati utilizzati durante i lavori di tutti gli elaborati di progetto, con le procedure di analisi, di calcolo, di sicurezza, di collaudo, di certificazione dei materiali ecc, . Sul tema della informazione/trasparenza poi va segnalato che da ormai parecchi anni il Comune di Venezia per precisa volontà politica non si è più dotato di quella struttura della legge speciale deputata a poter fornire alla cittadinanza ogni informazione legata alla salvaguardia ed in particolare a tutto quanto può ruotare attorno al sistema Mose.
Praticamente ancora oggi non è dato conoscere se il progetto esecutivo ha confermato i dimensionamenti del progetto definitivo oppure ci sono state modifiche e di quale entità si tratta; non c’è evidenza delle prove sul modello utilizzate per la progettazione delle paratoie delle tre bocche di porto e di come è stato valutato l’effetto scala ; non sono disponibili i dati del nuovo rapporto meteo che tenga conto della presenza delle lunate aggiunte successivamente al periodo in cui fu redatto il rapporto meteo per il progetto definitivo; non sono noti i criteri di manovra che dovrebbero portare alla decisione di chiusura delle bocche; non si conoscono i costi e le disponibilità finanziarie per la manutenzione e la gestione dell’opera e tanto altro ancora.
Però tutte queste “attenzioni“, questo dilagare di notizie, allarmismi, considerazioni ,smentite,reportage, dichiarazioni, improvvisi interessi sull’andamento dei cantieri del Mose non mettono mai in discussione l’opera, perché alla fine tutto ciò sarà inghiottito e metabolizzato nel proseguimento del Mose.
Si sfugge volutamente da un nodo strutturale che contraddistingue questa opera: affrontare nella sua giusta dimensione quel fenomeno della instabilità dinamica, estrema conseguenza della risonanza, delle paratoie del Mose. Perché esiste uno studio della società francese Principia commissionato a suo tempo dal Comune di Venezia che ha evidenziato un comportamento di instabilità dinamica della paratoia del Mose che ne impedisce una modellazione numerica ed un dimensionamento affidabile.
Con lo studio di Principia le Autorità competenti sono di fronte alla responsabilità di far continuare l’esecuzione di un’opera la cui funzionalità viene messa in discussione da autorevoli considerazioni tecnico-scientifiche mai smentite.
A fronte di tale studio che viene intenzionalmente omesso dal dibattito nazionale ed internazionale o male interpretato per incompetenza o convenienza si chiede ormai da troppo tempo un approfondimento della materia, quale quella della instabilità dinamica, estrema conseguenza della risonanza sub armonica, il cui riscontro, se esiste come evidenziato dallo studio di Principia nel caso della paratoia del Mose, inficerebbe un’opera interamente finanziata con risorse pubbliche il cui costo di realizzazione sfiora i 6.000 milioni di euro unitamente agli esorbitanti costi di manutenzione e gestione. Praticamente potrà accadere che le paratoie oscillano con ampi angoli facendo entrare acqua in laguna vanificando così l’effetto diga al contenimento della marea.
Se a tutt’oggi questo approfondimento non lo si vuole fare, confronto /verifica che si è insistito doversi fare con tecnici specializzati nella “modulazione numerica di sistemi marini complessi che interagiscono tra loro in moto ondoso “, viene da chiedersi, pensando positivo, se i nuovi gestori del Mose (in primis commissari del CVN e Presidente ex MAV) sono in grado di garantire la discontinuità del tanto vituperato sistema Mose.
Armando Danella 11 febbraio 2017
 «Una profetica riflessione del cardinale sulla metropoli, tratta dall’Opera Omnia (3° tomo) in uscita a 90 anni dalla nascita». Il Sole24ore, 12 febbraio 2017 (m.c.g.)
«Una profetica riflessione del cardinale sulla metropoli, tratta dall’Opera Omnia (3° tomo) in uscita a 90 anni dalla nascita». Il Sole24ore, 12 febbraio 2017 (m.c.g.)
Mai come in questo tempo stiamo sperimentando, più ancora che la forza, la debolezza delle nostre città. Eventi drammatici che hanno toccato altre metropoli, il riproporsi recente di oscure minacce e più in generale la complessità dei processi in atto nei grandi agglomerati urbani sembrano indurre a un senso di sgomento di fronte alla difficoltà di reggere alle sfide che pone la grande città.
Eppure la città è un patrimonio dell’umanità. Essa è stata creata e sussiste per tenere al riparo la pienezza di umanità da due pericoli contrari e dissolutivi: quello del nomadismo, cioè della desituazione che disperde l’uomo, togliendogli un centro di identità; e quello della chiusura nel clan che lo identifica ma lo isterilisce dentro le pareti del noto. La città è invece luogo di una identità che si ricostruisce continuamente a partire dal nuovo, dal diverso, e la sua natura incarna il coordinamento delle due tensioni che arricchiscono e rallegrano la vita dell’uomo: la fatica dell’apertura e la dolcezza del riconoscimento. Ambrogio le caratterizzava secondo la nota formula: «cercare sempre il nuovo e custodire ciò che si è conseguito».
Noi avvertiamo la fatica di costruire la città del nostro tempo come un luogo insieme protettivo e aperto, come una specie di Gerusalemme celeste dalle molte porte (Apocalisse 21,12-13). Per queste porte infatti entrano e sono entrate tante differenze disorientanti. E vi sono entrate ancor prima di quelle che noi comunemente definiamo con il prefisso di extra e a cui tendiamo ad attribuire mali che sono più radicalmente epocali e culturali.
È stata infatti la società complessa a sancire la fine della unità di un costume comune e identificante. È stata la frammentazione ad essa congenita che ha polverizzato quella che prima era un’unica identità nei tanti sottoinsiemi della società, i quali aspirano ciascuno a regole particolari e diverse. Sicché l’apertura della città rischia oggi di spersonalizzarla e ogni soggetto che vi entra si sente isolato; e, d’altro canto, l’identità si rifugia, quasi per paura, nei tanti gruppi amicali paralleli che rivendicano proprie regole particolari. Così l’apertura, disarticolandosi, non arricchisce più l’identità e l’identità, parcellizzandosi, non dà senso a tutta la città.
Eppure la città conserva un ruolo visibile di manifestazione dell’umano, se è vero che diventa luogo simbolico privilegiato dove si scarica il conflitto; una cassa di sfogo di scontri ideologici e perfino di disagi comuni. Ed essa ne paga forti tributi di insicurezza e perfino di sangue. E così può nascere uno spirito di fuga dalla città, verso zone limitrofe protette, verso zone franche, per avere i vantaggi della città come luogo di scambi fruttuosi e l’eliminazione degli svantaggi di un contatto relazionale ingombrante.
È allora la città destinata a disperdersi in un nuovo feudalesimo, compensato magari dalle impersonali relazioni mediatiche? È destinata a diventare un accostamento posticcio tra una city, identificata dal censo e dagli affari, e molte diversità a cui si concede di accamparsi in luoghi privilegiati o degradati, a seconda dei casi? E però se l’antidoto alla città difficile diventa una piccola città monolitica assediata dalle mille città diverse, la città perde il suo ruolo di identità-apertura e si originerà una faglia di insicurezza che metterà a repentaglio gli insiemi. È questa, in realtà, una delle caratteristiche e uno dei limiti d’una oligarchia, non d’una democrazia, stando a Platone: «uno Stato oligarchico è non unico, ma doppio: uno dei poveri e uno dei ricchi, sussistenti entrambi nello stesso territorio, in perenne conflitto tra di loro».
Si evidenzia perciò, oggi come non mai, la difficoltà della gestione della città e del suo governo politico, e può nascere la tentazione di gestire la città limitandosi a tenere separate le parti che in essa convivono mediante una specie di paratie tecniche. Ma così la città muore e soprattutto muore il suo compito di custode della pienezza dell’umano, per cui essa era nata.
Invece, proprio in forza della sua complessità localizzata, la città permette tutta una serie di relazioni condotte sotto lo sguardo e a misura di sguardo, e quindi esposte al ravvicinato controllo etico, e consente all’uomo di affinare tutte le sue capacità. Essa è infatti sempre meno un territorio con caratteristiche peculiari, e sempre più un mini- Stato dove si agitano tutti i problemi dell'umano. È perciò palestra di costruzione politica generale ed esaltazione della politica come attività etica architettonica. E in più ha dalla sua il vantaggio di una tradizione di identità propria.
Ce l’ha in particolare Milano – e le è comunemente riconosciuta – nel ruolo del lavoro e dell’organizzazione amministrativa e di servizi, di un raccordo tra religione e strutture formative e caritatevoli, che la rendono luogo facilmente riconoscibile da chi vi sopraggiunge. Ma se si perdono le radici culturali di questa identità e si cerca solo di mantenerne vivi i vantaggi tecnici, si finisce col perdere l’anima della identità e, alla lunga, anche i suoi vantaggi.
Milano non può, nel nome dell’identità, perdere la sua vocazione all’apertura, perché proprio questa è iscritta nella sua identità, cioè la capacità di integrare il nuovo e il diverso.
L’accoglienza, come categoria generale, non è per la milanesità solo un affare di buon cuore e di buon sentimento, ma uno stile organizzato di integrazione che rifugge dalla miscela di principi retorici e di accomodamenti furbi, e si alimenta soprattutto ad una testimonianza fattiva. Per questo sono lieto che sia possibile, in collaborazione anche col comune, offrire alla città una Casa della carità che risponda alle intenzioni di un generoso benefattore milanese e rimanga come segno di accoglienza verso i più sprovveduti. (...)
La paura urbana si può vincere con un soprassalto di partecipazione cordiale, non di chiusure paurose; con un ritorno ad occupare attivamente il proprio territorio e ad occuparsi di esso; con un controllo sociale più serrato sugli spazi territoriali e ideali, non con la fuga e la recriminazione. Chi si isola è destinato a fuggire all’infinito, perché troverà sempre un qualche disturbo che gli fa eludere il problema della relazione: commune conversationis officium, dice Ambrogio: «comune è il dovere di intrattenere relazioni».
 «Appunti di psicopatologia urbanistica, autovalori dominanti ed ecologia della mente in memoriam Fiorentino Sullo». ilgiornaledell'Architettura, 8 febbraio 2017 (m.c.g.)
«Appunti di psicopatologia urbanistica, autovalori dominanti ed ecologia della mente in memoriam Fiorentino Sullo». ilgiornaledell'Architettura, 8 febbraio 2017 (m.c.g.)
Economia – dal greco οἶκος (oikos), “casa” inteso anche come “beni di famiglia”, e νόμος (nomos), “norma” o “legge” – si intende sia l’organizzazione dell’utilizzo di risorse scarse (limitate o finite) quando attuata al fine di soddisfare al meglio bisogni individuali o collettivi
(wikipedia, ad vocem)
Le funzioni amministrative sono esercitate in maniera semplificata, prioritariamente mediante l’adozione di atti negoziali in luogo di atti autoritativi
(Maurizio Lupi)
Lupi per agnelli
Milano si conferma anche oggi, nel bene e nel male come la capitale della ricerca avanzata del post: dimenticate subito le utopie moderniste di progresso civile e culturale, dopo l’apparentemente innocuo camouflage postmoderno con bricolage di capitelli, piramidi e colonne che nascondeva il disimpegno etico del nuovo che avanza, ora è la volta del postumano….. Alla (fanta)urbanistica futurista dell’assessore Carlo Masseroli, dove la fiducia nelle sorti progressive veniva sostituita dalla fiducia nella buona sorte (e lui, ingegnere dei sistemi, che aveva promesso di ritornare ai suoi amati diagrammi di flusso ora è catapultato a dirigere Milanosesto Spa per lo sviluppo delle aree ex Falck), al decesarismo democratico che ha inabissato la giunta Pisapia e spento per sempre l’alba arancione di Milano (ma a volte ritornano e, promoveatur ut amoveatur, Ada Lucia De Cesaris rispunta come grand commis nominata dal Ministero dell’economia a propria rappresentante nel Cda di Arexpo).
Tutti ancora al capezzale della suburbanistica del giorno dopo, o fast post, inauguratasi con Expo e ora con Arexpo. Oggi, dulcis in fundo, anche con Pierfrancesco Maran (preconizziamo per lui un futuro di ministro alle infrastrutture….) nel solco della continuità corrono i cavalieri, destri e sinistri, dell’apocalisse urbanistica contrattata di rito ambrosiano sempre a cavallo dei lupi affamati di suolo. Siamo giunti finalmente alla post-urbanistica, proporre e veicolare archifiction, inoculando nell’immaginario sociale la falsa immagine di un ritorno al futuro, ma quando il futuro ormai non c’è più.
Come si può capire fino in fondo questa rivoluzione copernicana dell’urbanistica meneghina? Riassume il meglio delle due posizioni: quella di un mondo che non sarà mai e quella di un mondo che quando si manifesta ha già superato l’orizzonte degli eventi e si ritrae in se stesso annichilendosi e trasformandosi in un buco nero che, come l’Expobuco, si è dimostrato capace d’inghiottire sogni e risorse degli italiani, non meno avido di alcune nostre storiche e ora non più prestigiose banche.
È il salto definitivo e irreversibile nella
fiction finanziario-architettonica. Come è possibile che tutto accada in una democrazia ormai matura e forse avanzata? Basta deformare l’orizzonte epistemologico che vuole definire il progetto come un processo lineare continuo che parte da un punto (il cosiddetto prima) e arriva a un altro (il cosiddetto dopo), fino a far coincidere i due punti temporali in uno solo, tecnicamente chiamato scenario. Anche costruire non sarà più necessario… La smaterializzazione del progetto comporta la sua scomposizione in quanti fotonici, che per essere liberi di viaggiare alla velocità della luce, si distaccano da tutto quanto viene definito convenzionalmente come iter e legittimazione sociale di un progetto, per entrare nel nuovo ambito dell’aleatorietà determinata ai fini della grancassa della psicopropaganda virale del Ministero della Verità & Marketing. Le soluzioni sono aleatorie e discrezionali ma rimandano a quantità incognite, di autovalori dominanti che snaturano il carattere “pubblico” e la trasparenza del mercato, negoziati in modo opaco e indiretto per poi essere rapidamente cartolarizzati e avviati al consumo.
Come si traduce tutto ciò in burocratese urbanistico? La parola magica è Accordo di programma. Come ha scritto Maria Cristina Gibelli(1) :«è a Milano che ha fatto i primi passi una deregolazione urbanistica che ha poi trovato una configurazione organica con la LR 12/2005 sul Governo del Territorio e i suoi molteplici, e sempre peggiorativi, emendamenti successivi. È a Milano e hinterland che si stanno cogliendo i frutti avvelenati, in termini di coesione sociale, vivibilità, ma anche competitività, di quella stagione». Proprio su questo Accordo di programma degli ex scali Fs (1,25 milioni di mq che possono valere sino a ******) si è arenata la giunta Pisapia.
Ed è lo stesso Accordo, con qualche intervento di chirurgia estetica e social, che la giunta Sala si appresta a convalidare entro maggio con lo stesso spirito e gli stessi cosmetici principi con cui la giunta Pisapia ha poi ratificato il Piano di Governo del Territorio Masseroli-Moratti. La natura dello scambio segue la classica equazione asimmetrica dell’incremento di valore della speculazione fondiaria: ossia, prendo un’area a valore nullo o addirittura negativo, come in questo caso, e attraverso una trasformazione che è innanzitutto linguistica (la promessa di un cambio di destinazione d’uso), la rendo produttrice d’immaginario, di futuro.
Ora bisogna però stabilire se nella promessa di questo futuro la città assume il carattere di feticcio della merce, ossia, parafrasando Arjun Appadurai, tenda esclusivamente «a mascherare i rapporti sociali che rendono possibile la sua appropriazione a scopo di profitto da parte del capitale» (Scommettere sulle parole. Il cedimento del linguaggio nell’epoca della finanza derivata, Milano 2016, p. 17).
Architettura quindi non più come disvelamento, come invenzione critica, come nuova utopia del possibile, frammento di verità, progetto di emancipazione culturale e sociale, ma come tragica maschera che nasconda le contraddizioni e la falsa coscienza dei rapporti in atto, supina ai dettami imperanti dello spirito dell’incertezza. Architettura come formalizzazione, astrazione e commercializzazione del meccanismo del rischio stesso. Allora niente di meglio che l’immarcescibile visione del paradiso che, come ci ha spiegato Marcel Proust, è solo quello che abbiamo perduto. Come tutte le visioni beatifiche, sono misteri che oltrepassano la capacità di rappresentazione sensibile e la comprensione razionale. E allora avanti ancora con quell’ormai trita, frusta e paradossale menata improponibile della città giardino universale dove tutti non fanno altro che passeggiare ridenti e giulivi, innaffiano le piante sui terrazzi rigogliosi dove fioriscono orchidee perenni, vanno in bicicletta e portano a spasso cani…
Così si compie il miracolo della trasformazione di un reietto terzo paesaggio postindustriale “scalo ferroviario obsoleto da bonificare”, un Vicolo Corto pieno di problemi logistici, infrastrutturali e costi di bonifiche ambientali, a un meraviglioso “Central Park” (Public Garden non si usa più…) che rimanda alla favolosa casella del Parco della Vittoria del Monopoli, su cui tutti vogliono mettere le mani. Al subentrato “Central Park” vengono poi attribuiti dei volumi virtuali trasformati immediatamente in denaro sonante per i fortunati proprietari delle aree medesime, al di là che poi le suddette volumetrie vengano prima o poi realizzate.
La società titolare delle aree (Ferrovie dello Stato, che ha appena acquisito la linea 5 della metropolitana, e spinge da tempo anche per rilevare la maggioranza in Trenord al posto della Regione…), acquisiti i diritti “rapinati” con le equivoche pratiche di sdemanializzazione alla Giulio Tremonti, una volta firmato l’Accordo di programma li iscrive a bilancio ed è così ora pronta a quotarsi in borsa per poi essere privatizzata dagli speculatori finanziari. La polpetta indigesta viene poi condita in salsa social e adeguatamente lubrificata dalla politica compiacente, dall’establishment di programmatori e facilitatori, espertoni meglio se professori specialisti in supercazzole tecnichesi e storytelling a lieto fine, stampa compiacente, menestrelli e azzeccagarbugli specializzati nel paralogismo politico.
Dispiace vedere sempre in prima linea rettori e direttori di dipartimenti universitari e politecnici (di per sé enti terzi e non fiancheggiatori conto terzi… spesso chiamati sempre in camera caritatis, quando l’operazione è riuscita e il paziente è morto), pronti a correre al capezzale di una politica sputtanata per spendere le ultime briciole di dignità rimasta a fare da stampella alle strampalate e raffazzonate speculazioni territoriali che servono a colmare i buchi di bilancio di altrettante e spregiudicate gestioni finanziarie di enti pubblici e parapubblici come Fiera, Aler, ospedali, ecc., a cui si aggiungono, come contorno, il circo barnum dei visionari zelanti architetti con incarichi diretti o pseudodiretti, sempre compiacenti nell’offrire i propri servigi, ansiosi di lasciare il segno in ogni angolo della città, rigorosamente bipartisan, assunti in pianta stabile a tutto regime per la clonazione indefinita dello status quo e delle sue best practices, con sprofluvio di kermesse, articoli, forum e seminari, senza dimenticare spruzzate quanto basta di proteste e opposizioni antagoniste tanto per far credere che la democrazia sia ancora viva. Ma Milano non era la capitale dell’intellighentia critica? «Lotus International» ha dedicato un Forum e il numero Meteo Milano al dibattito in corso.
Un film già visto con la Fiera delle vanità, i grandi quartieri di lusso, gli Ospedali riuniti, l’Expoballa, Cascina Merlata… Ora è il turno degli scali ferroviari che, però – e questa è forse la maggiore difficoltà -, sono incuneati nel tessuto del cuore di Milano e lambiscono la città storica e i quartieri che ne costituiscono l’ossatura identitaria e il patrimonio genetico. Un’operazione a cuore aperto, irreversibile, che rischia di sfigurare per sempre ciò che è sopravvissuto dell’identità di Milano.
Anche per questo, tra i più di trecento architetti e firmatari dell’appello (rassegna stampa, elenco firmatari e interventi nel sito scaliferroviarimilano.blogspot.it) è nata l’idea di costituirsi nell’associazione “Città bene comune”, per affermare il primato della cittadinanza attiva, ben consapevoli che non saranno i tecnici, i regolamenti, le dispute di diritto, il finto teatrino della politica a salvarci ma solo la vera politica con la P maiuscola, ovvero quella che, come diceva Aristotele, significa amministrazione della polis per il bene di tutti: la determinazione di uno spazio pubblico al quale tutti i cittadini partecipano.
Débat public alla milanese…
Salzwasser in der Tennishalle! Ja, das ist ärgerlich, aber nasse Füße sind noch lang nicht das Ende der Welt(H. M. Enzensberger, Der untergang der Titanic, 1929)
Nella palude conformista milanese qualcosa non ha funzionato. Il dubbio si è fatto sospetto, a cui son seguiti la paura, lo sconforto e il tormento di un’angoscia ricorrente. Gli spettri dell’omologazione globale, i mostri come il quartiere fantasma griffato Daniel Libeskind di condomini sghimbesci abitato solo da dj tatuati con la Porsche, le Costa Concordia arenate di Zaha Hadid in piazza Giulio Cesare, i grattacieli mignon di City Life, la turbina a vento di Cesar Pelli sono ormai tra noi! Questi fantasmi si aggirano cupi e minacciosi nel salotto buono, turbando le coscienze dei milanesi che hanno sviluppato ormai una punta di diffidenza bipartisan, nonostante tutti gli sforzi della politica di sedarli e gli imbonitori che vendono lambrusco spacciandolo per champagne.
Alla luce di queste non esaltanti esperienze, risulta oltremodo patetico il tentativo di far passare per débat public quello che invece è astuta opera di disinformazione politica e di creazione del consenso. Meccanismo ormai rodato, per quelle operazioni di mattone deluxe certo più alla portata del fiato corto e delle idee stantie della politica contemporanea che dell’urbanistica avveduta e previdente e della pianificazione strategica lungimirante. Una politica che di moderato ha spesso solo la cultura e la fiducia nell’intelligenza critica.
Nonostante tutto e forse anche meno male, non sono bastate certo le cure e visioni dei cinque architetti-scenografi chiamati al capezzale per tessere gli scenarios e stimolare l’appetito degli investitori a sedare la diffidenza dei milanesi. Questo l’obiettivo della tre giorni di workshop milanese organizzata a fine dicembre 2016 da FS in “collaborazione” con il Comune. Dopo il lungo battage del «Corriere della Sera» sulle neoallucinazioni forestali del transgenico e sempre più green Stefano Boeri (il cosiddetto Fiume verde, il Pratone…), FS ha chiamato lo stesso Boeri (Studio SBA) e il “secchione” Cino Zucchi (CZA, che forse si poteva risparmiare la pagliacciata…), oltre a Benedetta Tagliabue (EMBT), all’olandese Francine Marie Jeanne Houben (Mecanoo) e al cinese Ma Yansong (MAD Architects). In attesa, come recitava il comunicato stampa, «del supporto di un advisor tecnico internazionale, le idee dei cittadini saranno trasformate in elaborati e modelli. Le cinque visioni possibili verranno presentate al Comune di Milano nel marzo 2017. L’Amministrazione comunale deciderà successivamente come gestire il processo di trasformazione urbana. Farini, Porta Romana, Porta Genova, Greco-Breda, Lambrate, Rogoredo, San Cristoforo sono i sette scali ferroviari milanesi inseriti nel progetto di riqualificazione, per una superficie complessiva di un milione e 250mila metri quadrati».
La musica è sempre la stessa… nonostante il Gran Ballo Excelsior di politici locali e nazionali, la variegata fauna di biodiversità architettonica presentata, l’ottimo catering, il parterre prestigioso e gli special guests a stuzzicare l’atmosfera festosa e arguta da Festival della mente, oggi di gran moda, la partecipazione prefestiva alla tre giorni in massa di architetti affamati di crediti formativi e di pressoché tutto il Comune di Milano in licenza studio. Oggi finalmente un pionieristico studio (A. Casavola, Perché comprare Parco della Vittoria conviene? Modellizzazione e studio sugli autovalori dominanti del gioco del Monopoli, s.d. Università della Calabria), ha messo a disposizione una tabella dei valori fondiari che ci consente di capire le ragioni profonde di tanto agitarsi: «Abbiamo quindi in questa tabella dei fattori che ci permettono di determinare la convenienza relativa di un appezzamento rispetto agli altri, tenendo unicamente conto della rendita che essi sono in grado di garantire.
In questa modellizzazione notiamo che l’elemento che continua a rimanere per rendita asintotica e massimale più conveniente è Parco della Vittoria, sebbene non sia il più frequente: questo primato spetta infatti (tra gli appezzamenti che danno rendita) a Corso Raffaello». L’autore subito ammonisce sull’esagerato ottimismo che potrebbe derivare dalla sensazionale scoperta: «Si noti infine la logica e attesa altissima frequenza della prigione, dovuta all’uso della regola del doppio sei».
Per questa urbanistica contrattata di rito ambrosiano è sempre buono il momento di proclamare che due più due fa cinque, e farcelo credere. Era inevitabile che prima o poi succedesse, era nella logica stessa delle premesse su cui si basa. La visione del mondo che la informa nega, tacitamente, non solo la validità dell’esperienza democratica ma l’esistenza stessa di una realtà esterna all’infuori di essa stessa.
In questa strategia della distensione e della creazione del consenso, la narrazione verde assume i toni di un astuto camouflage, che serve a nascondere i veri problemi di una programmazione che si è allineata alle prospettive di rischio e di performance sul brevissimo termine, e a quei calcoli che appartengono più alle prospettive monopoliste e di dumping finanziario tardocapitalista in una prospettiva di mercato viziato e drogato che alle logiche di promozione e sviluppo di una città, di un distretto territoriale. L’ormai inflazionata sussidiarietà, di per sé non un male, cercava di rimodulare il controllo dei rapporti stato-individuo sulla scala territoriale. Ha praticamente fallito, in quanto, a parte nicchie ecologiche particolari non fa altro che amplificare e duplicare difetti già immanenti alla scala del potere centrale, per di più appesantite dalle consuete dinamiche socioantropologiche.
La distribuzione di poteri e poltrone in una prospettiva socio-territoriale ancora più angusta non ha fatto altro che annichilire le responsabilità e la capacità decisoria intorno ad argomenti di generale interesse nazionale. Un altro effetto perverso è stato quello di prosciugare e smontare quelle sacche di sapere professionale e di buona pratica amministrativa che resistevano nella macchina comunale per affrontare le sfide strategiche e di larga scala, oggi rese ancor più critiche dalla questione irrisolta della “regione metropolitana”.
In altri casi, la gestione “dal basso”, come spesso è avvenuto per i beni culturali, è riconosciuta come un micidiale boomerang compromissorio, dove la mancanza di una chiara distinzione tra ciò che è di natura intrinseca bene pubblico e ciò che è privato, a causa di una legislazione incoerente e carente sul fronte delle garanzie di legittimità e per interpretazioni viziate per conflitto d’interessi, in mancanza di una legislazione aggiornata ma soprattutto efficace, ha spesso generato, nei casi non giudiziari, equivoci e proliferazione di contenziosi.
Il carattere di contratto negoziale tra attori, assunto nella quasi totalità dei casi, ha naturalmente bisogno di un quadro legislativo raffinato e di controlli efficaci e tempestivi per garantire trasparenza, equità e legalità (favorire, non garantire a tutti i costi il negoziato). E non è detto che basti, ossia è condizione necessaria ma non sufficiente, perché è indispensabile che tutto avvenga in un quadro sociale che attui il pieno rispetto di un corretto e fisiologico esercizio delle virtù democratiche.
Per questo, e per la persistente consapevolezza di una cronica incapacità di attuare un indispensabile aggiornamento senza derogare dai principi cardine della Carta costituzionale, il rapporto società-politica deve essere inquadrato anche nei termini di una “revisione” dei principi del contratto di gestione amministrativa che regolano anche il rapporto della gestione dei beni comuni, che s’intrecciano con un diritto privato oggi sempre più aggressivo e prevalente.
Questa materia “sensibile” ha avuto finora scarso ascolto dalla politica in termini legislativi, e ha spesso costretto all’uso del referendum, ma ha costituito un fertile terreno di confronto tra “beniculturalisti” e “benicomunisti”, costituzionalisti, ambientalisti ed ecologisti. E ora, per la prima volta, ha destato anche una folta rappresentanza di architetti, urbanisti, intellettuali e cittadini attivi, una società civile milanese trasversale, transgenerazionale e bipartisan, che al grido di “Città bene comune” ha trovato una naturale, inedita convergenza “politica” di obiettivi, cercando nuovi strumenti e spazi per opporsi, resistere e denunciare rischi e limiti di una situazione che si è protratta per troppo tempo e i cui guasti non siamo in grado di prevedere fino in fondo.
(1)Gibelli M. C. (2016), “Milano: da metropoli fordista a Meccadel real estate”, in Meridiana, n. 85
I tre firmatari di questo documento hanno colto l’occasione dell’ampio dibattito provocato dalla querelle relativa allo stadio della Roma per affrontare un argomenti di portata più vasta. Lo pubblichiamo nella speranza che sia utile a sviluppare un dibattito sul modo migliore per combattere il modello neoliberistico di governo del territorio
NOI URBANISTI CI IMPEGNIAMO…
Quanto sta accadendo a Roma - il caso della realizzazione del nuovo stadio – evidenzia in modo eclatante come l’urbanistica sia ormai relegata, dall’ideologia neoliberista dominante da tempo, a un ruolo subalterno e quindi miseramente perdente, rispetto alla centralità che un tempo possedeva nella progettualità riformista.
Basti pensare ad Adriano Olivetti presidente dell’Istituto Nazionale di Urbanistica, a Carlo Doglio che sperimenta in prima persona in Sicilia la ‘pianificazione della libertà’, alle conquiste sociali degli anni ’60 e ’70 in tema di standard collettivi, alla lunga marcia per separare diritto di proprietà e diritto di edificazione, al dibattito sul ruolo dell’urbanistica e della pianificazione del territorio rispetto ai mezzi e ai fini della programmazione economica, alla più recente acquisizione di come le scelte urbanistiche debbano necessariamente far propri i limiti ambientali del contesto in cui intervengono.
Di questa nobile tradizione disciplinare oggi restano soltanto poche tracce nei generosi quanto politicamente marginali appelli lanciati in rete da gruppi di intellettuali sempre più minoritari.
Ciò chiama in causa i partiti e i “movimenti”, che hanno allegramente ridotto, quando non liquidato, le questioni urbanistiche dai propri programmi, ma anche l’intera comunità degli urbanisti, troppo spesso proni a legittimare questa deriva e a rovesciare il loro ruolo a facilitatori degli interessi immobiliari.
Al centro della questione – emblematico il caso di Roma - l’interpretazione di ciò che è “pubblico interesse”. Lo stadio, se visto dal punto di vista della tradizione romana panem et circenses, potrebbe essere considerato opera di pubblico interesse, e in quanto tale è previsto dalla legge 147/2013. Ciò che viene legittimato dal Comune di Roma con la delibera 132/2014 è invece la qualifica di "pubblico interesse" per un progetto che comprende un milione di metri cubi con destinazione prevalente a uffici per ospitare multinazionali e attività commerciali, secondo il progetto presentato dai proprietari/costruttori, alla realizzazione del quale viene subordinata la costruzione compensatoria di alcune opere pubbliche per la città.
L’interpretazione del “pubblico interesse” vede quindi il “pubblico” affidato agli “interessi” finanziari dei proprietari fondiari, dei costruttori, delle banche creditrici, pronti a mettere in campo tutte le relazioni e i poteri di cui dispongono per assicurarsi la legittimazione “pubblica” dei loro profitti. E’ un copione che tende a ripetersi in molti luoghi, indipendentemente da chi governa le città e le regioni. Pratiche in controtendenza, da parte di singoli assessori, sono estremamente faticose e non riescono comunque a cambiare il contesto delle decisioni, rispetto alle quali prevalgono le mediazioni dei sindaci, dei presidenti e dei consiglieri eletti. Né il tentativo generoso di limitare i danni, con un corpo a corpo negoziale sui singoli progetti, riesce a restituire priorità effettiva agli interessi collettivi nelle trasformazioni della città e del territorio.
L’abbandono di ogni prospettiva seriamente riformatrice in materia di governo del territorio da parte delle maggioranze elette che governano le nostre città e i nostri territori contribuisce a rendere ancora più esasperata la disuguaglianza tra chi riesce tuttora a privatizzare i benefici delle decisioni pubbliche e chi – il popolo delle periferie -, assiste impotente a trasformazioni che non modificano affatto le sue condizioni di indigenza, privazione e marginalità. Una città può accrescere la propria ricchezza contemporaneamente al crescere della povertà e miseria di gran parte dei suoi abitanti.
Le politiche europee da un lato costringono le amministrazioni a svolgere un puro ruolo di ragioneria contabile, privatizzando anche le aziende municipalizzate sane e tagliando le spese per i servizi collettivi, esito di tante lotte e conquiste sociali, dall’altro sostengono la ricerca verso obiettivi effimeri come le smart city, l’uso di tecnologie che deresponsabilizzano gli abitanti, la ricerca di “successo” competitivo, piegando a ciò la stessa ricerca universitaria.
Mentre masse di cittadini già impoveriti vedono peggiorare le loro condizioni di vita giorno dopo giorno, tutti (o quasi) i governi locali subiscono il fascino delle grandi opere e dei grandi eventi, cavalli di troia per speculazioni, tangenti e scambi di favori proposti come ricetta magica.
Anna Marson, Enzo Scandurra, Edoardo Salzano
P.S
Questo articolo è stato ripreso dai siti Officina dei saperi e Società dei territoriliste/i, dove si possono inviare adesioni
 «La città deve tornare a essere un motore dell'immaginario, capace di essere ospitale, di generare narrazioni, di mettere in moto emozioni e sorprese. E di educare alla vita e alla bellezza civile».
«La città deve tornare a essere un motore dell'immaginario, capace di essere ospitale, di generare narrazioni, di mettere in moto emozioni e sorprese. E di educare alla vita e alla bellezza civile».
casadellacultura, città bene comune, 10 febbraio 2017 (c.m.c.)
L'ultimo libro di Giancarlo Consonni - Urbanità e bellezza. Una crisi di civiltà (Solfanelli, 2016) - è semplicemente Bello. Proprio così: con la "B" maiuscola. È infatti uno di quei rari saggi che riesce a prendere fiato rispetto al parapiglia di un dibattito urbanistico spesso schiacciato sui temi della rendita e della fiscalità urbana piuttosto che sull'arte di costruire le città, o su quello o quell'altro caso di speculazione, o - come si dice oggi - di sviluppo 'smart'.
Consonni - intrecciando i mille rivoli di una cultura personale che prima di essere urbanistica è umanistica - riesce a vedere con il necessario distacco quel che sta accadendo nel dibattito sulla città e il territorio e soprattutto riesce a farci comprendere bene quanto l'idea stessa di città si sia erosa e modificata nel tempo a furia di maltrattamenti lessicali e manomissioni di senso. Questo al punto che oggi fatichiamo a vedere, a sentire, a immaginare un futuro per quella che è una delle più grandi invenzioni dell'umanità.
Sento per l'autore di questo "libriccino" - così lo definisce lo stesso Consonni nella premessa - un sentimento di vera gratitudine. Ho respirato qualcosa di nuovo leggendo quelle pagine dense di pathos e non solo di logos. In esse ho colto una critica non ideologica a ciò che succede al governo del territorio. Ho visto dove si sono ammalorate le basi del pensiero urbanistico. E ho capito. Perché questo "libriccino" ti apre gli occhi, spostando il tuo sguardo fuori dalla rissa in cui perennemente ci troviamo, per appoggiarlo sulle cose veramente importanti, quelle che fondano (e dovrebbero continuare a fondare) sia l'idea di città sia l'idea di progetto della città.
Non si può che concordare con l'autore sulla necessità di interrompere quella follia che vuole la città e la metropoli come una sola grande occasione di profitto. Questo è terribilmente svilente non solo della bellezza dei luoghi urbani ma anche e soprattutto dell'idea di cittadinanza e dell'idea stessa di città. Idee che nel nostro Bel Paese si sono formate attraverso i secoli divenendo parte del nostro carattere, del nostro pensare e agire quotidiano, del nostro sguardo, persino quando chiudiamo gli occhi.
Il problema - perché esiste effettivamente un problema - è che oggi si sta eccessivamente imponendo, a forza di proclami e false verità, un'idea di città di plastica, tutta costruita attorno alla parola magica "metropolitana". Consonni vi si sofferma, la studia, ci ragiona con maestria e leggerezza e alla fine ne deduce che non possiamo rinunciare alle chiavi basilari di ciò che è veramente la città, ad alcuni suoi caratteri essenziali come quello dell'urbanità e quello della bellezza.
Diversamente ci "sembra" di essere in una città, ma invero siamo in una sorta di set cinematografico alla "Truman Show", in un penoso spettacolo in cui ogni cosa è messa lì per soddisfare le mire di guadagno di alcuni, i soliti che mirano ad accaparrarsi la rendita, quelli della finanza, del fondo immobiliare xy, della catena commerciale zk. E loro - questo è chiaro - hanno più bisogno di consumatori che non di cittadini.
Tra le strade e le piazze di questo tipo di città non sono benvenuti coloro che vogliono semplicemente passeggiare e - consapevolmente o inconsapevolmente - praticare un'esperienza emotiva e sensoriale complessa. Sono ammessi solo clienti a consumazione obbligatoria. E la bellezza allora sbiadisce, ma soprattutto evapora la nostra capacità di coglierla, di essere fieri e consapevoli che questa esiste davvero ed è l'anima delle nostre città, quelle europee ma soprattutto quelle italiane. Finiamo così per infischiarcene: un delitto di cui non possiamo essere complici. «La città - sostiene al contrario Consonni - deve tornare a essere un motore dell'immaginario, capace di essere ospitale, di generare narrazioni, di mettere in moto emozioni e sorprese. E di educare alla vita e alla bellezza civile».
Se la nostra identità non si intreccia con l'urbanità - che per Consonni significa bellezza d'insieme, ma anche affabilità, educazione allo stare insieme di architetture e persone e molte altre cose ancora - salta per aria quella convivenza civile fatta di relazioni di prossimità, di desiderio di prendersi cura dei luoghi, di sentimento di cittadinanza. Va cioè in crisi ciò che alla fine fa la città. Dalla capacità di tenuta dei sottili fili che ancora ci annodano a quel che rimane della bellezza d'insieme e dell'urbanità che, nonostante tutto, continua a caratterizzare molti dei nostri tessuti urbani, misureremo il nostro amore per la città.
Consonni non teme di lanciare un appello alle classi dirigenti del Paese, agli architetti e agli urbanisti, invitandoli, responsabilmente, a non spezzare quei fili, già così lisi. In caso contrario, verrebbe definitivamente meno il senso di appartenenza alla città (in quanto idea, luogo e casa) e soprattutto svanirebbe quell'obbligo implicito di legittimarsi attraverso la "bellezza civile". Se ciò accadrà, se si proseguirà sulla strada che da anni abbiamo purtroppo imboccato, «si sbriciolerà - secondo Consonni - uno degli argini che tiene insieme il mondo e ne limita la bruttezza».
Per concludere, questo "libriccino" giallo non è solo bello: è uno slancio poetico (perché è di poesia che abbiamo bisogno per ragionare e vedere al futuro). È cioè qualcosa che ci ricorda con sentimento che «la bellezza è un dono. Una felicità momentanea che, più che appagarci, ci interpella». Allora chiediamoci cosa può fare ognuno di noi per tener vive le tante bellezze delle nostre città e dei nostri paesaggi: di ciò siamo tutti responsabili.
Un bel passo verso l'apartheid sociale: i poveri (profughi e migranti, mendicanti, straccioni, ubriachi senza portafoglio, "indecorosi") possono essere trattati come i forsennati delle tifoserie sportive. Articoli di Nicoletta Cottone, Adriana Pollice, Mariolina Iossa, da Il Sole24ore, il manifesto, corriere della sera, 11 febbraio 2017
Il Sole24ore
MINNITI: «DASPO URBANO
PER CHI VIOLA LE REGOLE DEI TERRITORI»
di Nicoletta Cottone
«Non ci sono nuovi reati né aggravanti di pena ma misure come la possibilità di applicare in modo più ampio quello che si applica nelle manifestazioni sportive: davanti a reiterate violenze sportive c'è il daspo, di fronte a reiterati elementi di violazione di alcune regole sul controllo del territorio le autorità possono proporre il divieto di frequentare il territorio in cui sono state violate le regole». Lo ha detto il ministro Marco Minniti illustrando il decreto sicurezza approvato in cdm. Sulla sicurezza delle città oggi «abbiamo preso decisioni di un certo rilievo», ha sottolineato il premier Paolo Gentiloni, dopo il consiglio dei ministri, spiegando che il provvedimento sulla sicurezza è stato preso d’intesa con l’Anci.
Rafforzati i poteri di ordinanza dei sindaci
Il decreto mira a realizzare un modello trasversale e integrato tra i diversi livelli di governo mediante la sottoscrizione di appositi accordi tra Stato e Regioni e l’introduzione di patti con gli enti locali. Il ministro Minniti ha ricordato che «la sicurezza urbana va intesa come un grande bene pubblico. La vivibilità, il decoro urbano e il contrasto alle illegalità sono elementi che riguardo il bene pubblico». E ha spiegato che il decreto «prevede il rafforzamento dei poteri di ordinanza dei sindaci: avranno potere autonomi e la possibilità di patti tra territori e ministero degli Interni che prima non avevano una cornice legislativa». Previste uove modalità di prevenzione e di contrasto all’insorgere di fenomeni di illegalità quali, ad esempio, lo spaccio di stupefacenti, lo sfruttamento della prostituzione, il commercio abusivo e l’illecita occupazione di aree pubbliche.
Più servizi di controllo sul territorio
Il decreto prevede forme di cooperazione rafforzata tra i prefetti e i Comuni con l’obiettivo di incrementare i servizi di controllo del territorio e promuovere la sua valorizzazione. Il nuovo decreto «è stato ampiamente discusso, meditato, voluto» dall'Anci e dalla conferenza delle Regioni con l'idea di «un grande patto strategico di alleanza tra Stato e poteri locali». In Italia, ha detto il ministro, il modello sicurezza funziona, «non c’è emergenza ma bisogna stabilire che se il centro è modello nazionale si può pensare ad un modello che guardi meglio il territorio da Bolzano a da Agrigento».
Per i vandali obbligo di ripulitura dei luoghi
Con il decreto legge scatterà per i vandali l’obbligo di ripulitura e ripristino dei luoghi danneggiati, con obbligo di sostenere le spese o rimborsarle. Prevista anche una prestazione di lavoro non retribuita in favore della collettività per un tempo non superiore alla durata della pena sospesa. L’articolo 639 del codice penale già prevede che chi deturpa o imbratta cose altrui sia punito, con la multa fino a euro 103. Se il fatto è commesso su beni immobili o su mezzi di trasporto pubblici o privati, si applica la pena della reclusione da uno a sei mesi o della multa da 300 a 1.000 euro. Se il fatto è commesso su cose di interesse storico o artistico, si applica la pena della reclusione da tre mesi a un anno e della multa da 1.000 a 3.000 euro.
Nei casi di recidiva per le ipotesi di cui al secondo comma si applica la pena della reclusione da tre mesi a due anni e della multa fino a 10.000 euro.
Condanna a pulire per chi sporca la città
Nel decreto sulla sicurezza urbana c’è una «norma che prevede la pulizia e il ripristino per violazioni al decoro urbano. Il giudice, cioè, se qualcuno sporca, può condannarlo a ripristinare quello che ha sporcato: è una sfida di civiltà», ha detto il ministro Minniti.
Divieto di frequentare esercizi pubblici e aree urbane
Arriva anche la possibilità di imporre il divieto di frequentazione di determinati pubblici esercizi e aree urbane ai soggetti condannati per reati di particolare allarme sociale.
Misure per prevenire l’occupazione di immobili
Il provvedimento prevede anche misure per prevenire l’occupazione arbitrarie di immobili. Compito del prefetto impartire prescrizioni per prevenire il pericolo di turbative per l’ordine e la sicurezza pubblica e per assicurare il concorso della forza pubblica all’esecuzione di provvedimenti dell’autorità giudiziaria . (N.Co.)
il manifesto
STRETTA SULLASICUREZZA,
PIÙ POTERI AI SINDACI.
OK AL DASPO URBANO
di Adriana Pollice
Il decreto legge. Previste «misure amministrative: non ci sono nuovi reati né aggravanti di pena»Approvato ieri in Consiglio dei ministri anche il decreto legge «Misure sulla sicurezza urbana» (a firma Marco Minniti e Andrea Orlando) che dà ai sindaci più poteri in materia. La misura mostra la nuova strategia messa in campo dal ministro dell’Interno: «In Italia il modello Sicurezza funziona – ha spiegato -, non c’è emergenza ma bisogna stabilire che se il centro è modello nazionale si può pensare a un modello che guardi meglio il territorio da Bolzano ad Agrigento».
Decoro urbano, spaccio, prostituzione, commercio abusivo, occupazione di aree pubbliche, sono i punti intorno a cui ruotano gli articoli. Per i sindaci ci sarà maggiore autonomia e un rafforzamento del potere di ordinanza, forme di cooperazione maggiori tra i prefetti e i comuni, la possibilità di patti tra territori e ministero degli Interni. Il contenuto del decreto, ha spiegato Minniti, «è stato discusso, meditato, voluto dall’Anci e dalla Conferenza delle regioni con l’idea di un grande patto strategico di alleanza tra stato e poteri locali».
I comuni continuano a sopportare tagli, al Sud la disoccupazione aumenta, il governo dà più poteri in tema di sicurezza. Minniti si affretta a sottolineare che non si tratta di avere sindaci sceriffi «ma di cooperazione tra territorio e stato. Il decreto legge prevede misure di carattere amministrativo: non ci sono nuovi reati e non ci sono aggravanti di pena».
Nel dettaglio, però, il decreto legge stabilisce ad esempio multe tra 300 e 900 euro ma anche il daspo da determinate aree (non superiore a 48 ore ma può essere reiterato) per chi ha una condanna confermata in appello, ma anche per chi compie atti lesivi del decoro urbano, della libera accessibilità e fruizione a infrastrutture del trasporto pubblico, per chi violi i divieti di stazionamento o di occupazione di spazi o assuma alcol e droghe, eserciti la prostituzione «con modalità ostentate». Allontanamento anche per chi svolge commercio abusivo e accattonaggio. Per i «vandali» scatterà l’obbligo di ripulitura e ripristino dei luoghi danneggiati, con obbligo di sostenere le spese o rimborsarle.
Chi viola le ordinanze del sindaco su vendita e somministrazione di alcolici può subire una sospensione dell’attività, per gli ambulanti sono previsti sequestro di merci e attrezzature più la confisca amministrativa. A chi è stato condannato per spaccio, anche senza sentenza passato in giudicato, può essere vietato da uno a 5 anni lo stazionamento nelle vicinanze di locali.
Con una condanna definitiva possono scattare varie sanzioni: l’obbligo di presentarsi almeno due volte a settimana alla polizia o ai carabinieri; rientrare a casa entro una determinata ora e di non uscirne prima di un’ora prefissata; divieto di allontanarsi dal comune di residenza; obbligo di comparire in un comando di polizia negli orari di entrata e uscita dalle scuole. Si tratta di disposizioni previste dai quattordici anni in su. Le multe vanno dai 10 ai 40 mila euro.
È affidato al prefetto il compito di eseguire i provvedimenti del giudice su «occupazioni arbitrarie di immobili» per prevenire il pericolo di possibili turbative per l’ordine e la sicurezza pubblica».
corriere della sera
SICUREZZA, PIÙ POTERI AI SINDACI
UN«DASPO URBANO» CONTRO I VANDALI
di Mariolina Iossa
«Sì al decreto legge. Migranti, accelera l’iter per rimpatri e richieste d’asilo. Possibile un divieto di 12 mesi che può salire fino a cinque anni per chi spaccia nei locali».
Più poteri ai sindaci per la sicurezza delle città. Il consiglio dei ministri di ieri, su proposta del ministro dell’Interno Marco Minniti, ha approvato un decreto che realizza un patto tra prefetto e sindaci per dare loro più strumenti, come i poteri di ordinanza.
In particolare è previsto che chi deturpa zone di pregio delle città non potrà più frequentarle per un periodo di 12 mesi. Un provvedimento simile al «Daspo» in vigore oggi negli stadi. Ma prima di arrivare a questo vengono introdotte sanzioni amministrative da 300 a 900 euro con l’allontanamento fino a 48 ore per chi lede il decoro urbano o la libera accessibilità o la fruizione di infrastrutture, luoghi di pregio artistico, storico e turistico, anche abusando di alcolici o droghe, esercitando la prostituzione «in modo ostentato», facendo commercio abusivo o accattonaggio molesto.
Il Daspo urbano interviene quando tali lesioni siano ripetute. Il periodo di allontanamento è di 12 mesi mentre diventa più lungo, da uno a 5 anni, per chi spaccia droga nelle discoteche e locali di intrattenimento. Al giudice invece la possibilità di disporre il ripristino o la ripulitura dei luoghi pubblici (o il risarcimento), per chi deturpa o imbratta beni immobili o mezzi di trasporto pubblici o privati. «Non diventiamo come il sindaco di New York ma almeno abbiamo una norma che ci dà poteri concreti» commenta con soddisfazione il sindaco di Bari Antonio Decaro, presidente dell’Anci, l’associazione dei Comuni.
Su rifugiati e immigrazione clandestina, il governo ha esaminato anche un altro decreto del ministro Minniti. Si prevede la riduzione dei tempi per ottenere lo status di rifugiato, attualmente di due anni, l’accelerazione dei rimpatri per chi non è in regola, il raddoppio dei fondi per i rimpatri volontari, la sostituzione dei Cie con i Cpr, centri permanenti per il rimpatrio, che dovranno essere al massimo uno per Regione e non potranno accogliere più di 1.600 persone. Infine, sì ai lavori socialmente utili non retribuiti per favorire l’integrazione. Il ministro della Giustizia Andrea Orlando ha anche annunciato l’istituzione in 14 tribunali di sezioni specializzate sull’immigrazione.
Un disegno di legge delega della ministra Roberta Pinotti riorganizzerà le Forze Armate. Riguarderà i vertici del ministero e le relative strutture e il modello operativo. Due gli obiettivi: ridurre le risorse umane e finanziarie senza incidere sulle capacità operative e risparmiare. E integrare le varie componenti, eliminando duplicazioni, riducendo i livelli gerarchici e semplificando le procedure.
Diventa «universale», aperto a tutti i giovani che potranno anche andare all’estero e ridotto a 25 ore settimanali con programmazione triennale. Si potrà svolgere in vari settori, dall’assistenza alla protezione civile, dall’ambiente alla riquali-ficazione urbana, dal patrimo-nio artistico e culturale allo sport, all’agricoltura.
«Il mio consiglio a tutti sarebbe di uscire quanto più possibile e occuparsi della disuguaglianza sociale e del degrado ambientale perché questi sono temi sempre più lungimiranti. La gente deve diventare attiva, uscire, muoversi». comune-info - newsletter, 7 febbraio 2017 (m.p.r.)
I movimenti ribelli nelle aree urbane si sviluppano molto lentamente. Non si può cambiare l’intera città dall’oggi al domani. Lo dimostra la storia dei movimenti, dalla Comune di Parigi fino allo sciopero generale della città di Seattle 1919 o Buenos Aires 2001. Intanto, oggi in tante città l’organizzazione dei tassisti o dei lavoratori delle consegne comincia a preoccupare perché le città dipendono da quei settori. La lotta contro l’incredibile disuguaglianze esistente e per un diverso modo di vivere passa anche da questi nuovi movimenti. Una lunga conversazione con David Harvey - rilanciata da Z Net Italy -, sulle città ribelli, i beni comuni, l’urbanizzazione, la disneyficazione delle città, le organizzazioni di quartiere… Secondo Harvey è tempo di “uscire, muoversi, è un periodo cruciale…”
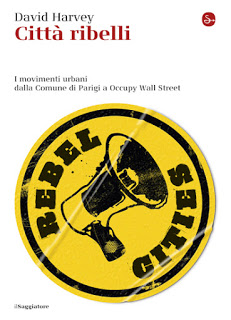
Inizi il tuo libro Rebel Cities: From the Right to the City to the Urban Revolution [Città ribelli: dal diritto alla città alla rivoluzione urbana] descrivendo la tua esperienza a Parigi negli anni ’70: «Alti edifici giganti, autostrade, edilizia popolare senz’anima e mercificazione monopolizzata nelle strade che minacciano di inghiottire la vecchia Parigi … Parigi dagli anni ’60 in poi è stata chiaramente nel mezzo di una crisi esistenziale». Nel 1967 Henry Lefebvre scrisse il suo fondamentale saggio “Del diritto alla città”. Puoi parlarci di quel periodo e dell’impulso a scrivere Rebel Cities?
Nel mondo gli anni ’60 sono spesso considerati, storicamente, un periodo di crisi urbana. Negli Stati Uniti, ad esempio, gli anni ’60 furono un’epoca in cui molte città centrali finirono in fiamme. Ci furono rivolte e semi-rivoluzioni in città come Los Angeles, Detroit e naturalmente dopo l’assassinio del dottor Martin Luther King nel 1968 … più di 120 città statunitensi subirono disordini e azioni di rivolta minori e grandi. Cito questo negli Stati Uniti perché ciò che in effetti stava accadendo era che la città veniva modernizzata. Era modernizzata intorno all’automobile; era modernizzata intorno alle periferie. A quel punto la Città Vecchia, o quello che era stato il centro politico, economico e culturale della città in tutti gli anni ’40 e ’50 era lasciata alle spalle. Ricorda, quelle tendenze avevano luogo in tutto il mondo capitalista avanzato. Dunque non si trattava solo degli Stati Uniti. Ci furono gravi problemi in Gran Bretagna e in Francia dove un vecchio stile di vita veniva smantellato, uno stile di vita di cui penso nessuno dovrebbe avere nostalgia, ma tale stile di vita era cacciato e sostituito da un nuovo stile di vita basato sulla mercificazione, sulla proprietà, sulla speculazione immobiliare, sulla costruzione di autostrade, sull’automobile, sulle periferie e con tutti questi cambiamenti abbiamo visto un’accresciuta disuguaglianza e disordini sociali.
Secondo dove ci si trovava all’epoca c’erano disuguaglianze strettamente di classe o erano disuguaglianze di classe concentrate su specifici gruppi di minoranza. Ad esempio, ovviamente negli Stati Uniti si trattava della comunità afroamericana residente nei quartieri poveri che aveva pochissimo in termini di opportunità di occupazione o di risorse. Così gli anni ’60 furono definiti in termini di crisi urbana. Se si torna indietro e si guarda a tutte le commissioni che dagli anni ’60 stava esaminando che cosa fare riguardo alla crisi urbana, ci furono programmi governativi messi in atto dalla Gran Bretagna alla Francia, e anche negli Stati Uniti. Analogamente tutti tentavano di affrontare tale “crisi urbana”.
Ho considerato questo un argomento affascinante di studio e un’esperienza traumatica da vivere. Sai, questi paesi che stavano diventando sempre più ricchi stavano lasciando indietro persone che erano rinchiuse in ghetti urbanizzati e trattate da esseri umani inesistenti. La crisi degli anni ’60 fu una crisi cruciale e penso che Lefebvre l’abbia compresa molto bene. Egli riteneva che le persone nelle aree urbane dovessero aver voce nel decidere come dovevano essere quelle aree, e quale processo di urbanizzazione dovesse aver luogo. Al tempo stesso quelli che si opponevano volevano invertire l’onda delle speculazioni immobiliari che stava cominciando a travolgere le aree urbane di tutti paesi capitalisti industrializzati.
Tu scrivi: “La domanda riguardo a che tipo di città vogliamo non può essere separata dalla domanda circa che genere di persone vogliamo essere, quali tipi di relazioni sociali ricerchiamo, quali relazioni con la natura apprezziamo, quale stile di vita desideriamo o quali valori estetici coltiviamo”. Citi anche la Comune di Parigi come evento storico per analizzare e forse aiutarci a concettualizzare come potrebbe essere il “diritto alla città”. Ci sono altri esempi storici sui quali dovremmo riflettere?
Quale tipo di città desideriamo costruire dovrebbe riflettere i nostri desideri e bisogni personali. Il nostro ambiente sociale, culturale, economico, politico e urbano è molto importante. Come sviluppiamo questi atteggiamenti e tendenze? Questo è importante. Dunque, vivendo in una città come New York ci si deve muovere attraverso la città, spostarsi e trattare con altre persone in un modo molto specifico. Come tutti sanno, gli abitanti di New York tendono a essere freddi e sbrigativi tra di loro. Ciò non significa che non si aiutino a vicenda, ma al fine di far fronte alla velocità quotidiana delle cose, e alla grande quantità di persone nelle strade e nelle metropolitane, si deve affrontare la città in un determinato modo. Allo stesso modo, vivendo in una comunità chiusa dei sobborghi conduce a determinati modi di pensare riguardo a che cosa dovrebbe consistere la vita quotidiana. E queste cose evolvono in atteggiamenti politici differenti, che spesso includono mantenere certe comunità chiuse ed esclusive, al costo di ciò che avviene nella periferia. Creiamo questi atteggiamenti e ambienti politici.
Le reazioni rivoluzionarie all’ambiente urbano hanno molti precedenti storici. A Parigi nel 1871 c’era un tipo di atteggiamento per cui la gente voleva un tipo diverso di urbanizzazione; voleva che vi vivesse un tipo diverso di persone; era una reazione allo sviluppo dell’alta società, speculativo consumistico che stava avendo luogo all’epoca. Dunque ci fu una rivolta che chiedeva generi diversi di relazioni: relazioni sociali, relazioni di genere e relazioni di classe. In conseguenza se si vuole costruire una città in cui le donne si sentano a loro agio, ad esempio, si costruisce una città molto diversa da quelle che normalmente abbiamo. Tutte queste questioni sono legate alla domanda riguardante in quale genere di città vogliamo vivere. Non possiamo separarla dal tipo di persone che vogliamo essere; quale tipo di relazioni di genere, quale tipo di relazioni di classe, e simili. Per me il progetto di costruire la città in un modo diverso, con una filosofia diversa, con scopi diversi, è un’idea molto importante. Occasionalmente tale idea è stata raccolta da movimenti rivoluzionari, come la Comune di Parigi. E ci sono molti altri esempi che potremmo citare, come lo Sciopero Generale di Seattle circa nel 1919. L’intera città fu presa dalla gente ed essa cominciò a costruire strutture comunitarie.
A Buenos Aires queste stesse cose stavano accadendo nel 2001. A El Alto, 2003, c’è stato un altro tipo di esplosione. In Francia, abbiamo visto le aree suburbane dissolversi in rivolte e movimenti rivoluzionari negli ultimi 20-30 anni. In Gran Bretagna abbiamo visto questo genere di sommosse e rivolte di tanto in tanto, che sono realmente una protesta contro il modo in cui si vive la vita quotidiana. Per essere chiari, i movimenti rivoluzionari nelle aree urbane si sviluppano molto lentamente. Non si può cambiare l’intera città dall’oggi al domani. Quella che vediamo, tuttavia, è una trasformazione nello stile dell’urbanizzazione nel periodo neoliberista. Prima, diciamo a metà degli anni ’70, l’urbanizzazione era caratterizzata da proteste; c’era molta segregazione; e la risposta a molte di tali proteste è stata, in effetti, la riprogettazione della città coerentemente con i principi neoliberisti di autosufficienza, di assunzione di responsabilità di sé stessi, di competizione, di frammentazione della città in comunità chiuse e spazi privilegiati.
Così, per me la riprogettazione della città è un progetto di lungo termine. Per fortuna le persone sono costrette a immaginare qualche forma di trasformazione rivoluzionaria, che si verifica in un particolare momento del tempo, come a Buenos Aires nel 2001, quanto ci sono stati movimenti che hanno guidato la presa delle fabbriche e hanno tenuto assemblee. Sono stati in grado di imporre, in molti modi, come la città andava organizzata e hanno cominciato a porre domande serie: chi vogliamo essere? Come dovremmo relazionarci con la natura? Quale tipo di urbanizzazione vogliamo?
Puoi parlarci di alcuni di questi termini? Ad esempio, puoi discutere della sub-urbanizzazione come conseguenza di “un modo di assorbire il surplus di prodotto e in tal modo risolvere il problema dell’assorbimento del surplus di capitale?” In altri termini, perché le nostre città sono state svuotate in questo modo particolare? Questa questione è particolarmente preveggente per i nostri ascoltatori locali nella regione dell’industria manifatturiera in crisi, che è stata completamente devastata negli ultimi 30-40 anni.
Di nuovo, questo è processo lungo, che si trascina. Fammi tornare agli anni ’30 e alla Grande Depressione. Poniamo la domanda: Come siamo usciti dalla Grande Depressione? E quale era il problema durante la Grande Depressione? Uno dei grandi problemi durante la Grande Depressione era un mercato debole. La capacità produttiva c’era. Ma non c’erano flussi di reddito da sfruttare, per dir così. Dunque c’era un surplus di capitale in giro senza un possibile impiego. Ora, in tutti gli anni ’30 ci furono tentativi frenetici di trovare un modo per spendere quel surplus di capitale. Ci furono cose come il “Programma di opere pubbliche” di Roosevelt. Sai, costruire autostrade e roba del genere. Cioè impiegare il surplus di capitale e il surplus di lavoro in giro all’epoca.
Negli anni ’30 non fu trovata alcuna soluzione reale, fino a quando non arrivò la seconda guerra mondiale. A quel punto tutto il surplus fu immediatamente assorbito dallo sforzo bellico: produrre munizioni e via dicendo. Molti si arruolarono nell’esercito; una quantità di manodopera fu assorbita in quel modo. Dunque la seconda guerra mondiale, apparentemente, risolse il problema della Grande Depressione. A quel punto sorse la domanda del dopo 1945: che cosa sarebbe successo una volta finita la guerra? Che cosa sarebbe successo a tutto quel capitale extra? Beh, a quel punto si ebbe la sub-urbanizzazione degli Stati Uniti. In effetti la costruzione delle periferie, a quel punto era la costruzione di periferie ricche, divenne il modo in cui fu impiegato il capitale in surplus. Prima fu costruito il sistema autostradale; a quel punto tutti dovevano avere un’automobile; poi l’abitazione suburbana divenne una specie di “castello” per la popolazione della classe lavoratrice. Tutto questo ebbe luogo abbandonando le comunità impoverite dei quartieri poveri. Questo fu lo schema dell’urbanizzazione che ebbe luogo negli anni ’50 e ’60.
I surplus, che il capitale produce sempre, funzionano così: i capitalisti cominciano la giornata con una certa quantità di denaro. A sera finiscono con più soldi. Sorge la domanda: che cosa fanno i capitalisti con i loro soldi alla fine della giornata? Beh, devono trovare qualche posto in cui investirli: espansione. I capitalisti hanno sempre questo problema: dove stanno l’espansione e le occasioni di fare più soldi? Una delle grandi occasioni di espansione dopo la seconda guerra mondiale fu l’urbanizzazione. C’erano altre occasioni, quali il complesso industriale-militare, e così via. Ma fu principalmente mediante la sub-urbanizzazione che i surplus furono assorbiti. Ora, questo creò molti problemi, quali la crisi urbana dei tardi anni ’60. A quel punto hai una situazione in cui il capitale torna di fatto nelle città centrali e successivamente rioccupa i quartieri poveri. A quel punto inverte lo schema. Così un numero sempre maggiore di comunità impoverite è cacciato nella periferia, mentre la popolazione ricca ritorna nel centro della città.
Ad esempio nella New York di intorno al 1970 si poteva ottenere una casa nel centro di Manhattan quasi per nulla, perché c’era un enorme surplus di proprietà; nessuno voleva vivere in città. Ma ciò è completamente cambiato: la città è diventata il centro del consumismo e della finanza. Come hai citato, costa tanto un tetto per la tua auto quanto un tetto per una persona. Questa è la trasformazione che si è verificata. In breve, questo processo di urbanizzazione ha luogo in tutti gli anni ’40 estendendosi agli anni ’70. Dopo gli anni ’70 il centro della città diventa estremamente ricco. Di fatto, Manhattan passò dall’essere un luogo accessibile negli anni ’70 a diventare una vasta comunità chiusa negli anni 2000 riservata agli estremamente ricchi e potenti. Nel frattempo gli impoveriti, spesso comunità minoritarie, sono cacciate nella periferia della città. O, nel caso di New York, la gente è fuggita in cittadine del nord dello stato di New York o in Pennsylvania.
Questo schema generale di urbanizzazione ha a che fare con questa domanda di dove si trovano occasioni redditizie di investire il capitale. Come abbiamo visto nel corso degli anni, le occasioni redditizie sono scarseggiate negli ultimi quindici anni, o giù di lì. In tale periodo un’enorme quantità di denaro è stata riversata nel mercato residenziale, nella costruzione di case e in tutto il resto. Poi abbiamo visto quello che è successo nell’autunno del 2008 con lo scoppio della bolla immobiliare. Dunque si deve guardare all’urbanizzazione come a un prodotto della ricerca di modi con cui assorbire la produttività e la produzione accresciute di una società capitalista molto dinamica che deve crescere a un tasso del 3% di crescita composta se vuole sopravvivere. Questa è la domanda per me: come assorbiremo questa crescita composta del 3% nei prossimi anni in modo da evitare i dilemmi urbanizzazione/sub-urbanizzazione del passato? È interessante concettualizzare come potrebbe andare.
Tu parli della distribuzione geografica delle crisi economiche. Cioè come le crisi economiche si diffondono da una parte del globo all’altra. Citi anche il fatto che la gente non avrebbe dovuto essere sorpresa dal crollo economico del 2008. Ad esempio oggi abbiamo la crisi economica della zona UE e del Nord America, e tuttavia tu citi l’esplosione della crescita del PIL in Turchia e in varie parte dell’Asia, particolarmente in Cina. Ma citi anche un grande paradosso: in Cina, anche se è stato attraversato un enorme processo di urbanizzazione negli ultimi venti anni, quegli stessi processi industriali che hanno prodotto grandi profitti hanno cacciato milioni di cinesi e distrutto l’ambiente naturale. Contemporaneamente intere città rimangono totalmente vuote, poiché solo una piccola percentuale della popolazione cinese può permettersi tali lussi e abitazioni.
Beh, la Cina sta ripetendo il modo in cui gli Stati Uniti uscirono dalla Grande Depressione: mediante la sub-urbanizzazione dopo la seconda guerra mondiale. Penso che i cinesi, quando si trovarono posti di fronte alla domanda su che cosa dovevano fare, particolarmente in un declino economico globale e alla luce dei fiacchi risultati economici di circa il 2007-2008, decisero che sarebbero usciti dalle loro difficoltà economiche mediante programmi urbanistici e infrastrutturali: ferrovie ad alta velocità, autostrade, grattacieli e così via. Quelli divennero i mezzi attraverso i quali fu assorbito il surplus di capitale. Naturalmente tutti quelli che fornivano la Cina di materie prime se la passarono molto bene, poiché la domanda cinese era molto elevata.
La Cina assorbe metà dell’offerta mondiale di acciaio. Così se si produce minerale di ferro o di altri metalli, come fa l’Australia, allora naturalmente l’Australia se la passa molto bene perché non ha subito una gran crisi negli ultimi sette anni. I cinesi hanno, in effetti, preso una pagina dal libro della storia economica degli Stati Uniti replicando il programma di sviluppo economico post 1945 degli Stati Uniti. In poche parole, la Cina ha immaginato di potersi salvare con lo stesso tipo di strategia e di evitare la stagnazione o il declino economico. Sai, gli Stati Uniti e l’Europa sono impantanati in una crescita molto bassa, rispetto ai cinesi che hanno goduto tassi di crescita molto rapidi. Ma, di nuovo, si tratta di assorbire il surplus di capitale in modi che siano produttivi. Quella è la domanda; lo dico con speranza, perché non sappiamo se il boom cinese finirà a gambe all’aria.
Se il boom cinese andrà a rotoli, come i mercati immobiliare e finanziario negli Usa nel 2008, allora il capitalismo globale si troverà in guai seri. Oggi i cinesi stanno cercando di limitare il loro tasso di crescita. Così, invece di mirare a un tasso di crescita del 10 per cento del PIL, stanno puntando a una crescita del 7-8 per cento nei prossimi anni. Cercheranno di darsi una calmata. Voglio dire, via!, i cinesi hanno più di quattro città vuote. Riesci a crederlo? Città completamente vuote. Cosa succederà nei prossimi anni? Queste città diventeranno aree urbane produttive? Resteranno semplicemente lì a marcire? Nel qual caso andrebbe perso un mucchio di denaro e una grande depressione colpirebbe anche la Cina. In tal caso sarebbero prese alcune decisioni politiche molto sgradevoli, e certamente potremmo aspettarci agitazioni sociali tra la classe lavoratrice e tra i poveri cinesi.
Il mondo appare molto diverso secondo qual è la parte del mondo in cui si vive. Ad esempio, sono appena stato a Istanbul, Turchia: ci sono gru edili dappertutto. La Turchia sta crescendo a un ritmo del 7 per cento l’anno, dunque oggi (2013) è un luogo molto dinamico. Quando sei in Turchia è davvero difficile immaginare che il resto del mondo sia in crisi. Poi ho fatto un volo di due ore e mezza fino ad Atene, Grecia; non occorre che vi dica cosa succede là. La Grecia è come entrare in una zona disastrata dove tutto si è fermato. Tutti i negozi sono chiusi e non ci sono cantieri in corso in nessun luogo della città. Abbiamo qui due città distanti seicento miglia l’una dall’altra e tuttavia sono due luoghi totalmente differenti. Questo è ciò che ci si aspetterebbe di vedere nell’economia globale: alcuni luoghi prosperano, altri vanno in bancarotta. C’è sempre uno sviluppo disuguale delle crisi economiche. Per me questa è una storia molto affascinante da raccontare.
Nel capitolo due, Le radici urbane della crisi, discuti del collegamento tra la crisi economica e gli Stati Uniti, la proprietà e i diritti individuali di proprietà, che sono entrambi componenti ideologici importanti del Sogno Americano ma anche ti affretti a segnalare che tali valori culturali diventano molto rilevanti quando sussidiati da politiche statali. Puoi spiegare tali politiche?
Beh, se risali agli anni ’30 scoprirai che meno del 40 per cento degli statunitensi era proprietario della sua casa. Così circa il 60 per cento della popolazione degli Stati Uniti viveva in affitto. Era particolarmente così nel caso della classe inferiore, o della classe media. Normalmente vivevano in affitto. Ora queste popolazioni erano piuttosto irrequiete. Così era sorta l’idea di renderle filocapitaliste e a favore del sistema aprendo loro la possibilità di divenire proprietari. Così c’è stata una quantità di sostegno statale per quelle che chiamavano istituzioni di depositi e prestiti, che erano separate dalle banche. Erano luoghi in cui la gente depositava i propri risparmi e tali risparmi erano utilizzati per promuovere la proprietà per popolazioni a basso reddito. La stessa cosa valeva per la Building Society britannica. Negli anni ’80 si avvia tale tendenza con la classe imprenditoriale che si chiedeva come rendere la popolazione a basso reddito meno insofferente. C’era una magnifica frase che la classe imprenditoriale era solita utilizzare: “I proprietari di case non scioperano”.
Ricorda, ci si doveva indebitare per diventare proprietari. Questo è il meccanismo di controllo. In generale questo sistema era molto debole in tutti gli anni ’20 e fino agli anni ’30, quando il governo statunitense e le classi imprenditoriali decisero di rafforzarlo. Tanto per cominciare, quando sottoscrivevi un mutuo negli anni ’20 potevi solitamente ottenerlo solo per circa tre anni, poi avresti dovuto rinnovarlo o rinegoziarlo. Poi, negli anni ’30, le banche crearono i mutui trentennali. Ma per ottenere tali mutui essi dovevano essere garantiti in qualche modo. Così ciò portò alla creazione di istituzioni statali che avrebbero garantito i mutui. Ciò condusse all’Amministrazione Federale degli Alloggi. Contemporaneamente le banche avevano necessità di trasferire i mutui a qualcun altro, così crearono questa organizzazione chiamata Fanny May.
Per tutto quel periodo organizzazioni statali furono usate per incoraggiare e garantire la proprietà della casa, particolarmente a favore delle classi inferiori, il che naturalmente scoraggiò tali persone dallo scioperare e dallo sgarrare. Ora sono indebitate. Quelle istituzioni decollarono realmente dopo la seconda guerra mondiale. In quel periodo c’era una quantità di propaganda riguardo al “Sogno Americano” e a che cosa significava essere statunitensi. Entrò in gioco la deduzione fiscale dei mutui che consentiva di dedurre gli interessi sul mutuo. Ricorda, questo è un grande sussidio alla proprietà della casa. C’erano sussidi statali alla proprietà della casa; c’erano istituzioni statali che promuovevano la proprietà. Così tutto questo diventa cruciale quando collegato alla Legge GI, che diede diritti privilegiati di proprietà della casa e incentivi ai soldati reduci dalla seconda guerra mondiale. Ci fu un’incredibile spinta da parte dell’apparato statale a incoraggiare e garantire la proprietà della casa.
Ricorda, tutto questo stava accadendo nel contesto della sub-urbanizzazione. Quelle istituzioni divennero molto cruciali per il mercato immobiliare e naturalmente continuano a esistere. Tutti parlavano di come Fanny May e la nuova, Freddy Mac, erano gestite dal governo e tuttavia parzialmente di proprietà privata. Nel tempo, in essenza, sono divenute nazionalizzate. Così nel tempo il governo ha promosso la proprietà della casa e ha avuto un ruolo enorme nel creare questi mutui sub-prime. Ciò è stato fatto durante l’amministrazione Clinton, a partire dal 1995, mentre tentavano di promuovere la proprietà della casa tra le popolazioni minoritarie degli Stati Uniti. Lo sviluppo della “crisi dei sub-prime” è stato in larga misura collegato sia a ciò che stava facendo il settore privato, sia anche a ciò che le politiche governative garantivano.
Per me questo è un aspetto cruciale della vita statunitense, in cui si passa dal 60 per cento della popolazione in affitto al punto più alto del 2007-2008 in cui più del 70 per cento della popolazione diventa proprietario di casa. Questo, naturalmente, crea un genere diverso di atmosfera politica; un’atmosfera politica in cui la difesa dei diritti di proprietà e dei valori della proprietà diventa molto importante. Poi hai i movimenti di quartiere in cui la gente cerca di tenere certe persone fuori dal quartiere perchè le percepisce come causa della riduzione del valore della proprietà. Hai un genere diverso di politica perché la casa diventa una forma di risparmio per le famiglie della classe media e di quella lavoratrice. Naturalmente la gente attinge a quel risparmio per rifinanziare la propria casa.
C’è stata una quantità di rifinanziamenti in corso durante il boom della proprietà negli USA. Molte persone hanno approfittato degli alti prezzi delle case. Questa promozione della proprietà della casa è ora trattata come se fosse un antico sogno di quelli che vivono negli Stati Uniti. Tuttavia, di certo, c’è sempre stata questa specie di idea negli Stati Uniti presso le popolazioni dei lavoratori immigrati, che se ottieni un pezzo di terra, ci fai crescere qualcosa, e così via, potresti alla fine avere una vita piacevole. Sì, questo faceva parte del sogno degli immigrati. Ma questo è stato trasformato in proprietà suburbana, che non riguarda l’avere mucche e polli in cortile; riguarda avere tutto attorno a te simboli del consumismo.
Parliamo di queste tendenze in un ambito ideologico. Affermi che dovremmo andare oltre Marx. Tuttavia insisti che dovremmo utilizzare le sue intuizioni più preveggenti. Come possiamo andare oltre Marx? Che cosa intendi, esattamente?
Ora, il motivo per cui Marx è importante in tutto questo è che Marx ebbe un’acuta comprensione di come funziona l’accumulazione capitalista. Egli comprese che questa perpetua macchina di crescita contiene molte contraddizioni interne. Ad esempio, una delle contraddizioni di fondo di cui parla Marx è tra il valore d’uso e il valore di scambio. Puoi constatare molto chiaramente come questo abbia operato nella situazione degli alloggi. Qual è il valore d’uso di una casa? Beh, è una forma di rifugio, uno spazio di vita privata, dove uno può farsi una vita di famiglia. Possiamo elencare altri valori d’uso della casa, ma la casa ha anche un valore di scambio. Ricorda, quando affitti la casa, stai semplicemente affittando la casa per quel che serve. Ma quando acquisti la casa, a quel punto consideri la casa come una forma di risparmio, e dopo un po’ usi la casa come una forma di speculazione.
In conseguenza i prezzi delle case cominciano a salire. Così, in tale contesto, il valore di scambio comincia a dominare il valore d’uso della casa. Il rapporto tra valore di scambio e valore d’uso comincia a sfuggire di mano. Quindi, quando il mercato immobiliare crolla, improvvisamente cinque milioni di persone perdono la casa e il valore d’uso scompare. Marx parla di questa contraddizione ed è una contraddizione importante. Dobbiamo porre la domanda: che cosa dovremmo fare a proposito degli alloggi? Che cosa dovremmo fare riguardo all’assistenza sanitaria? Che cosa stiamo facendo riguardo all’istruzione? Non dovremmo promuovere il valore d’uso dell’istruzione? O dovremmo promuovere il valore di scambio di queste cose? Perché le necessità della vita dovrebbero essere distribuite attraverso il sistema del valore di scambio? Ovviamente dovremmo rigettare il sistema del valore di scambio che è preda dell’attività speculativa, dello sciacallaggio, e di fatto perturba i modi in cui possiamo acquistare prodotti e servizi necessari. Questo era il genere di contraddizioni di cui Marx era consapevole.
Nel terzo capitolo, La creazione dei beni comuni urbani, tu riconcettualizzi come potrebbero essere i “beni comuni” nel prossimo secolo. Prosegui facendo riferimento al lavoro di Tony Negri e Michael Hardt in tutto il libro. Ho intervistato Michael Hardt in passato e ho trovato molto del suo lavoro molto acuto e molto interessante. Come tutti voi citate nel vostro lavoro: dobbiamo cominciare a concepire come trasferire, promuovere, sviluppare e utilizzare i beni comuni. Ciò comprende anche effetti culturali: immagini, significati, simboli, eccetera. Prosegui citando il lavoro di Murray Bookchin: idee di ordine, processi, gerarchie sociali e così via diventano molto importanti quando si tenta di ideare alternative. Anche Christian Parenti ha recentemente scritto un testo notevole a proposito dello stato e dell’ambiente. Quali sono alcune delle tue idee su come potremmo riconcettualizzare i beni comuni?
Beh, la concezione dei beni comuni, da quel che ho visto e letto, è di dimensioni piuttosto ridotte. Così una quantità di scritti sui beni comuni si è occupata dei beni comuni a livello micro. Non sto dicendo che ci sia qualcosa di sbagliato in ciò; avere un orto comunitario nel tuo quartiere è una bella cosa. Tuttavia mi pare che dobbiamo cominciare a interessarci e a parlare di temi di vasta portata riguardo ai beni comuni, quali l’habitat di un’intera bio-regione. Ad esempio, come cominciamo a concepire come dovrebbe essere la sostenibilità nell’intero nord-est degli Stati Uniti? Come gestiamo cose come le risorse idriche a livello nazionale? E globalmente? Le risorse idriche dovrebbero essere considerate una risorsa di proprietà comune, ma spesso ci sono richieste di acqua pulita in conflitto tra loro: urbanizzazione, agricoltura industriale e ogni sorta di altre tutele dell’habitat e cose simili.
Mi fa piacere che tu abbia citato il saggio di Christian Parenti, perché il cambiamento climatico dovrebbe farci riconcepire i beni comuni globali. Come gestire questo problema? E come possiamo gestire questi temi nel futuro? È fuori questione che abbiamo bisogno di meccanismi di imposizione tra stati nazione al fine di combattere queste tendenze e prevenire minacce future. Che cosa succede ai trattati internazionali se i governi vanno a pezzi? Chi impedirà ad altri stati di immettere anidride carbonica nell’atmosfera? Lo si può fare indicendo assemblee collettive o quel che passa il convento. I confronti riguardo a se trasformare un pezzo di terra in un orto comunitario non combatteranno i problemi che affrontiamo come specie. Dobbiamo concepire i beni comuni come esistenti su una scala diversa. Sono interessato alla dimensione metropolitana-regionale. Come si organizza la gente in tali regioni per difendere i diritti della proprietà comune su scale diverse? Beh, questo livello di potenziale organizzativo non si realizzerà attraverso assemblee o altre forme di organizzazione che la gente utilizza oggi. Il problema è inventarsi un modo democratico di rispondere alle opinioni di vasti strati della popolazione in tutto il pianeta al fine di amministrare i diritti alle risorse di proprietà comune. Ciò includerebbe cose come qualità dell’aria e dell’acqua nell’intera regione. Includerebbe anche la sostenibilità bioregionale.
Queste cose non si realizzano mediante assemblee e solo perché c’è chi inventa qualche grande piano a livello locale, ciò non significa che tale piano funzioni a livello regionale o su scala globale. Così, mi piacerebbe introdurre il concetto di “scale” differenti di organizzazione nel nostro confronto collettivo sullo sviluppo, la sostenibilità e l’urbanizzazione. Dobbiamo sviluppare organizzazioni, meccanismi, vocabolari e apparati capaci di far fronte a questi problemi su scala globale. Non credo ci dia alcun vantaggio il discutere dei “beni comuni” se non siamo specifici riguardo alla scala di cui stiamo discutendo. Parliamo del mondo? In tal caso dobbiamo parlare dell’apparato statale e delle sue funzioni, particolarmente a livello bio-regionale e globale.
Pare che le sole persone disposte a considerare questi temi su scala globale siano gli scienziati del clima, gli oceanografi, i biologi, gli ecologisti, con pochissimi intellettuali, per non parlare di attivisti o della più vasta popolazione in generale che discutono dell’ambiente naturale globale. Alcuni scienziati suggeriscono che entro il 2048 quasi tutti i grandi pesci saranno estinti. Al minimo gli scienziati ci dicono di aspettarsi un aumento di due gradi Celsius della temperatura del globo entro la fine del secolo. Queste predizioni sono inquietanti, a dir poco. Anche se possiamo organizzarci efficacemente, diciamo, a livello bio-regionale, che cosa succede se altre regioni si rifiutano? Non avremo bisogno di un apparato globale per chiamare le nazioni a rispondere? A me questo sembra uno dei problemi più grandi del nostro tempo.
Beh, ci sono alcuni modi in cui una prassi può diventare egemone: uno è mediante coercizione, cosa che nessuno di noi vuole ma che può ben essere una necessità. Poi c’è il consenso, che è quello che vediamo in queste conferenze sul cambiamento climatico ma, come vediamo, anche questo non funziona. Il terzo è quello che potremmo chiamare “mediante esempio”. È per questo che penso che una regione come la Cascadia sia così interessante, tra i motivi che hai citato, perché la Cascadia mette in atto alcune politiche molto, molto progressiste. Ad esempio, la California lo ha fatto riguardo a numerosi aspetti della legislazione ambientale. Su scala locale la California ha cominciato a imporre cose come il chilometraggio o la capacità del serbatoio obbligatori per le auto, e questo è un piccolo esempio.
In modo interessante, può anche essere dimostrato che non si finirà a pezzi, economicamente, se gli stati attueranno tali misure. Oggi non accade nulla di tutto ciò. Penso che guidare mediante l’esempio possa essere molto significativo. È più facile conquistare consenso quando si offrono esempi alla gente di come questo funzionerebbe. Ad esempio, l’abbiamo visto a livello urbano con città come Curitiba, Brasile, che è piuttosto nota per il suo progetto ambientale. In altre parole, molte delle cose che si fanno a Curitiba sono ora attuate in tutto il mondo in vari contesti urbani. Penso che avremo una combinazione di operare mediante esempio, consenso e coercizione. La mia speranza sarebbe che potessimo principalmente utilizzare esempi del mondo reale; poi è più facile raggiungere il consenso; ed è piuttosto difficile muoversi in direzione della coercizione. Comunque questa è solo la mia speranza. Non necessariamente le cose andranno così.
Nel capitolo quattro, L’arte della rendita, citi che a un certo punto “le università delle arti erano fucine di dibattito, ma la loro successiva pacificazione e professionalizzazione hanno gravemente ridotto la politica agitativa”. Puoi parlare del carattere speciale della produzione e riproduzione culturale? Inoltre, puoi articolare questo concetto di “rendita di monopolio”? Come è stato aiutato questo processo da quella che chiami “imprenditorialità urbana”? Chiami questi processi la “disneyficazione” della società e della cultura. Che cos’è il capitalismo simbolico collettivo?
Il mio interesse a questo deriva da una contraddizione molto semplice. Si suppone che viviamo sotto il capitalismo e si suppone che il capitalismo sia competitivo cosicché ci si aspetterebbe che i capitalisti e gli imprenditori apprezzino la competizione. Beh, emerge che i capitalisti fanno tutto quel che possono per evitare la competizione. Amano i monopoli. Così ogni volta che possono cercano di creare un prodotto che sia monopolizzabile, che, in altre parole, sia “unico”. Ad esempio prendete il logo della Nike, che è un esempio perfetto di capitalisti che incassano un prezzo di monopolio da un simbolo particolare perché c’è tutto quel bagaglio culturale collegato a ciò che quel logo significa, a ciò per cui sta, e a come le persone vi interagiscono. Una scarpa identica, che costa molto meno, può essere venduta a un prezzo molto inferiore perché semplicemente non ha quel logo. Così il prezzo di monopolio è tremendamente importante. Troverete molti casi in cui è una componente cruciale di come funzionano i mercati.
Nello stesso capitolo cito il commercio del vino, che mi intriga parecchio. Si cerca di ricavare una rendita monopolistica perché questo vigneto ha un suolo particolare, o questa vigna ha una collocazione geografica speciale. Perciò crea un unico vino “vintage” che ha un sapore migliore di ogni altro al mondo; solo che non è così. C’è un grande interesse a cercare di acquisire una rendita monopolistica assicurandosi che il proprio prodotto sia commercializzato come unico e molto, molto speciale. Poi, a livello locale, città cercano di darsi un “marchio”. C’è ora un’intera storia, in particolare riguardante gli ultimi 30-40 anni, in cui città si sono date un marchio e hanno tentato di vendere un pezzo della loro storia. Qual è l’immagine di una città? È attraente per i turisti? Va di moda? La città si promuoverà commercialmente.
Si troveranno città che hanno alte reputazioni, come Barcellona, Spagna, o New York City. Uno dei modi in cui si può vantare l’unicità di una città consiste nel promuovere qualcosa riguardo alla storia della città che sia molto specifico, perché non si può fruire del parallelo storico altrove. Così, per esempio, si va ad Atene per via dell’Acropoli, o si va a Roma per le antiche rovine. Così si comincia a promuovere commercialmente la storia di una città come unica e redditizia. D’altro canto, se non si ha una storia particolare, semplicemente se ne inventa una. C’è una quantità di città che si sono inventate storie nel mondo di oggi. Allora si dice alla gente che la cultura del luogo è molto speciale. Sai, cose come stili alimentari unici, o danze uniche diventano molto importanti. Si deve promuovere la “vita di strada” come unica; non esiste nessun altro luogo così, e tutto quel genere di roba.
La commercializzazione degli aspetti culturali e storici di una città è oggi una componente cruciale del processo economico. Alcune città semplicemente s’inventano una cultura unica. Ad esempio alcuni città utilizzeranno “architettura firmata”. Ad esempio non molti conoscevano la città di Bilbao, in Spagna, prima che il Museo Guggenheim diventasse il posto alla moda di un particolare marchio di architettura. Passando oltre possiamo considerare Sidney, Australia, e la sua Sala dell’Opera, che è la prima cosa che le persone riconoscono quando vedono una fotografia della città, e possiamo vedere quanto importante sia diventato ciò. Così l’architettura stessa diviene preda della commercializzazione e del marchio di una città. Sai, persino le scene della pittura e della musica diventano aspetti considerevoli di cultura da poi promuovere e vendere; città come Austin, Texas, diventano “scene della musica”. Poi ci sono luoghi come Nashville, e così via. Così le città cominciano a usare la produzione culturale come modo per promuoversi come uniche e speciali. Naturalmente il problema al riguardo è che molta della cultura è facilissima da replicare. L’unicità comincia a sparire. A quel punto abbiamo quella che chiamo la “disneyficazione” della società.
In Europa, ad esempio, anche se molte città hanno un passato storico-culturale serio, ogni cosa diventa “disneyficata”. Alcuni, io per esempio, finiscono estremamente disgustati da questo. È ancora un’altra “disneyficazione” della storia dell’Europa e io semplicemente non voglio più essere seccato da questo. Questa è la contraddizione: si promuove commercialmente una città come unica e tuttavia, mediante la promozione, la città diventa replicabile. In realtà i simulacri della storia diventano importanti tanto quanto la storia stessa. C’è una tensione in giro in cerca di rendite monopolistiche, conquistandole per un po’ e poi perdendole a favore dei simulacri. Questo diviene significativo. Oggi questo crea anche una situazione in cui i produttori di cultura diventano tremendamente importanti. Sono andato a vivere a Baltimora nel 1969 e vi erano circa tre musei. Oggi ci sono più di trenta musei a Baltimora! Questo diventa il modo in cui si commercializza la città. Tuttavia se ogni città ha trenta musei allora ci si può scordare di godere di un vantaggio monopolistico. Allora davvero non conta dove mi trovo; se a Baltimora, Pittsburgh o Detroit. Tutto diventa un’esperienza replicabile. Cominciano a perdere il loro potere monopolistico.
Nel capitolo cinque, Riprendersi la città per la lotta anticapitalista, tu scrivi: “Due questioni derivano dai movimenti politici a base urbana: 1) La città, o sistema di città, è uno spazio meramente passivo o una rete preesistente? 2) Le proteste politiche spesso misurano il loro successo in termini di capacità di disarticolazione delle economie urbane”. Puoi spiegare tali disarticolazioni? Come pensi che i dimostranti nella società odierna possano disarticolare più efficacemente le economie urbane?
L’uragano Sandy ha realmente disarticolato le vite dei residenti nella città di New York. Dunque non vedo perché movimenti sociali organizzati non potrebbero disarticolare la vita consueta in grandi città e perciò causare danni agli interessi della classe dominante. Abbiamo visto molti esempi storici di questo. Ad esempio negli anni ’60 i disturbi che si sono verificati in molte città degli Stati Uniti hanno causato grandi problemi alle aziende. Le classi politiche ed economiche sono state rapide nel reagire a causa del livello di disarticolazione e distruzione. Cito nel libro le dimostrazioni dei lavoratori immigrati nella primavera del 2006. Le dimostrazioni furono una reazione al tentativo del Congresso di criminalizzare gli immigrati illegali. Successivamente la gente si mobilitò in luoghi quali Los Angeles e Chicago, e inceppò considerevolmente l’economia cittadina.
Si potrebbe prendere l’idea di uno sciopero, solitamente mirato contro una particolare azienda o organizzazione, e tradurre quelle tattiche e strategie nei centri cittadini. Così invece di scioperare contro una particolare impresa o società la gente indirizzerebbe le sue azioni nei confronti di intere aree urbane. Allora ci sono eventi come la Comune di Parigi o lo sciopero generale di Seattle del 1919 o la rivolta Cordobazo in Argentina, circa 1969. Non occorre che sia un movimento rivoluzionario da un giorno all’altro. Queste cose possono aver luogo gradualmente mediante riforme.
La redazione partecipativa del bilancio è attualmente attuata a Porto Alegre, Brasile, dove il Partito dei Lavoratori ha sviluppato un sistema attraverso il quale popolazione e assemblee locali decidono per che cosa devono essere spese le loro imposte. Dunque tengono assemblee popolari e così via, che decidono come utilizzare fondi e servizi pubblici. Di nuovo, ecco una riforma democratica che inizialmente è stata avviata a Porto Alegre ma che da allora è stata fatta circolare in città europee. È una magnifica idea. Coinvolge il pubblico e mantiene le persone coinvolte nel processo. Democratizza il processo decisionale in tutta la società. Queste decisioni non sono più prese da consigli comunali, burocrati o dietro porte chiuse. Oggi questi dibattiti sono accessibili alla partecipazione del pubblico. Da un lato ci sono interventi molto rapidi sotto forma di scioperi e interferenze. Dall’altro c’è un processo lento di riforme che ha luogo attraverso assemblee democratiche e così via.
Nel corso degli anni ho collaborato con persone che operano nel settore sindacale, con persone disoccupate e che operano nell’ambito di quella che è comunemente chiamata l’”economia sommersa”. Cosa più importante, sono interessato a organizzare quelli che lavorano nelle industrie dei servizi, o negli ipermercati tipo Applebee’s o Best Buy. Nel capitolo cinque tu scrivi: “Nella tradizione marxista le lotte urbane sono spesso ignorate o scartate in quanto prive di potenziale o significato rivoluzionario. Quando una lotta a livello cittadino acquista, in effetti, uno status di icona rivoluzionaria, come accadde durante la Comune di Parigi nel 1871, si afferma, prima da parte di Marx e poi con maggiore enfasi da parte di Lenin, trattarsi di una rivolta proletaria, piuttosto che un movimento rivoluzionario molto più complicato animato tanto dal desiderio di riprendersi la città stessa dall’appropriazione borghese, quanto dalla desiderata liberazione dei lavoratori dai calvari dell’oppressione di classe nel luogo di lavoro. Considero d’importanza simbolica che i primi due atti della Comune di Parigi siano stati l’abolizione del lavoro notturno nei forni, una questione sindacale, e l’imposizione di una moratoria degli affitti, una questione urbana”. Puoi parlare del privilegio riservato agli operai dell’industria nell’ideologia marxista?
C’è una lunga storia di ciò. La tendenza nei circoli marxisti, e non solo nei circoli marxisti ma nella sinistra in generale, consiste nel privilegiare i lavoratori dell’industria. Questa idea di una lotta di avanguardia che conduce a una nuova società è in circolazione da un certo tempo. Tuttavia, quella che è affascinante è l’assenza di alternative a questa visione, o almeno di varianti del suo intento e proposito. Naturalmente molto di questo proviene dal volume I del Capitale di Marx che enfatizza il lavoratore di fabbrica. Questa idea che il partito d’avanguardia dei lavoratori ci porterà nella nuova Terra Promessa dell’anticapitalismo, chiamiamola una società “comunista” è stata persistente per più un centinaio d’anni. Ho sempre sentito che si trattava di una concezione troppo limitata di chi è il proletariato e di chi è l’”avanguardia”. Inoltre io sono sempre stato interessato alle dinamiche della lotta di classe e ai loro rapporti con i movimenti sociali urbani. Chiaramente per me i movimenti sociali urbani sono molto più complicati. Coprono tutto lo spazio dalle organizzazioni borghesi di quartiere, impegnate in politiche di esclusione, a una lotta di affittuari contro padroni di casa a causa di pratiche sfruttatrici. Quando si guarda alla vasta gamma di movimenti sociali urbani se ne trovano alcuni anticapitalisti e altri che sono l’opposto. Ma farei la stessa osservazione riguardo ad alcune forme tradizionali di organizzazione sindacale. Ad esempio ci sono alcuni sindacati che considerano l’attività di organizzazione come un modo per privilegiare i lavoratori privilegiati della società. Naturalmente questa idea non mi piace. Poi ci sono altri che stanno creando un mondo più giusto e più equo.
Penso ci sia una varietà uguale di distinzioni nell’ambito delle forme di organizzazione dei lavoratori dell’industria. Di fatto le forme di organizzazione dei lavoratori dell’industria a volte, poiché si occupano di gruppi speciali e di interessi speciali, sono reattive alla politica generale più di quanto ci si aspetti. È a questo riguardo che io accolgo le forme di organizzazione di Antonio Gramsci. Egli era molto interessato ai consigli di fabbrica. Egli seguiva, in effetti, la linea marxista che l’organizzazione di fabbrica è cruciale nella lotta. Ma poi egli spingeva le persone anche a organizzarsi in ambito di quartiere. In quel modo, nel pensiero di Gramsci, potevano avere un quadro migliore di com’è l’intera classe lavoratrice, non solo quelli che sono organizzati in fabbriche e via dicendo. Includendo persone come i disoccupati, i lavoratori temporanei e tutte le persone che hai citato in precedenza che non erano occupate in posti di lavoro tradizionali del settore industriale. Così Gramsci proponeva che questi due tipi di metodi di organizzazione politica dovrebbe essere interconnessi al fine di rappresentare realmente il proletariato.
In essenza, il mio pensiero riflette Gramsci sotto questo aspetto. Come cominciamo a occuparci di tutti i lavoratori in una città? Chi lo fa? I sindacati tradizionali tendono a non farlo. Mentre ci sono movimenti in seno al movimento sindacale che stanno attuando tali pratiche organizzative. Ad esempio i Trade Union Councils in Gran Bretagna o i Labor Councils negli Stati Uniti che entrambi cercano di organizzare in qualche misura fuori dall’ambito dell’organizzazione sindacale tradizionale. Ora, quelle correnti del movimento sindacale non sono state dotate di potere. Dobbiamo ideare nuove forme di organizzazione che colgano il lato progressista di ciò che accade nei movimenti sociali urbani e lo unisca a quel che resta del modello sindacale tradizione del settore industriale. Dobbiamo riconoscere che molti lavoratori che operano nell’economia statunitense non potrebbero organizzarsi ufficialmente in un sindacato date le attuali leggi sul lavoro. Dunque abbiamo bisogno di una forma diversa di organizzazione, esterna al modello sindacale tradizionale.
C’è un’organizzazione a New York, che in realtà è nazionale ma è molto forte a New York, chiamata Domestic Workers Organization [Organizzazione dei lavoratori domestici]. È molto difficile sindacalizzare i lavoratori domestici. Ma hanno un’organizzazione basata su diritti e continuano a organizzarsi e a battersi. Siamo onesti: se sei un immigrato clandestino negli Stati Uniti, sei trattato in modi deplorevoli. Perciò organizzare gruppi come i tassisti o i lavoratori dei ristoranti conduce a quello che è chiamato un Congresso dei Lavoratori. Stanno cercando di mettere insieme tutte queste forme di organizzazione. Sai, anche Richard Trumka [leader sindacale, già presidente dell’AFL-CIO], si è presentato a una di queste conferenze nazionali e ha detto ai lavoratori che il movimento sindacale tradizionale al minimo desidererebbe avere un rapporto con loro.
In breve, io penso che oggi ci sia un movimento in crescita che riconosce l’importanza di tutti i tipi diversi di lavoro che esistono nell’ambiente urbano. Ho accolto la domanda postami da molti membri di sindacato: “Perché non sindacalizziamo l’intera dannata città?” Sono già attivi movimenti per organizzare i tassisti, ma perché non i lavoratori delle consegne? È una vasta manodopera e la città dipende assolutamente da questi settori del lavoro per mantenere normalmente funzionante la sua attività economica. E se questi gruppi si unissero e cominciassero a rivendicare un tipo diverso di politica nelle città? E se avessero voce in capitolo sul modo in fondi e risorse sono utilizzati? Ci sono modi per contrastare l’incredibile disuguaglianza esistente a New York? Voglio dire: i dati delle entrate fiscali dell’anno scorso hanno mostrato che l’un per cento al vertice a New York guadagna 3,57 milioni di dollari a testa, in confronto con il 50 per cento della popolazione che cerca di tirare avanti con meno di 30.000 dollari. È una delle città più disuguali del mondo. Dunque che cosa possiamo fare al riguardo? Come possiamo organizzarci per cambiare questa disuguaglianza?
Per me dovremmo abbandonare questa idea che l’operaio di fabbrica è l’avanguardia del proletariato e cominciare a immaginare come nuova avanguardia quelli che sono impegnati nella produzione e riproduzione della vita urbana. Vi sarebbero inclusi lavoratori domestici, tassisti, addetti alle consegne e molti altri della classe povera e di quella lavoratrice. Penso che possiamo costruire movimenti politici che operino in modi totalmente diversi rispetto al passato. Possiamo vederlo in città di tutto il mondo, dalla città boliviane a Buenos Aires. Mettendo insieme il lavoro di attivisti urbani con quelli che lavorano nelle fabbriche cominciamo a sviluppare un elemento completamente differente di agitazione politica.
Puoi parlare di alcune di tali città, come El Alto, in Bolivia? Inoltre, nel 2011 ero a Madison, Wisconsin, nel 2011 nel corso delle proteste sindacali e devo dire che è stato interessante e assolutamente frustrante vivere le dinamiche interne del movimento sindacale, e come interagisce con i cittadini e i lavoratori non iscritti al sindacato. Purtroppo il movimento sindacale reprime il dissenso e la resistenza seri. Anche se molti lavoratori a Madison sono sindacalizzati, quelli che fisicamente avevano occupato l’edificio del Campidoglio e avevano avviato l’occupazione erano lavoratori non sindacalizzati. Poi sono arrivati i grandi sindacati e hanno immediatamente reindirizzato i discorsi al voto sulla revoca del governatore Scott Walker. Indiscutibilmente, col senno di poi, il voto per la revoca del governatore Walker è stato un disastro politico. Che cosa ne pensi?
I sindacati hanno attraversato un brutto periodo. Non sono molto progressisti, specialmente negli Stati Uniti. Nel complesso sono d’accordo su quanto citi. Il motivo per cui ho citato Trumka era perché io penso che Trumka e molti di quelli all’interno del movimento sindacale organizzato capiscono che non possono più fare da soli; hanno bisogno dell’aiuto dell’intera forza lavoro, sindacalizzata o no. Questa è sempre stata la sfida nell’organizzare: quanto sostegno vogliamo da queste vaste entità? E quanto di ciò che stanno facendo è frutto di un vero senso di solidarietà? Quanto è per profitto personale? La mia esperienza a Baltimora, che copre campagne per il salario minimo, rispecchia in una certa misura la tua esperienza. I sindacati erano in generale ostili a tali campagne e non hanno contribuito, parlando in generale. Tuttavia abbiamo ricevuto in effetti molto aiuto da sindacati locali.
Così, di nuovo, dobbiamo separare tali due entità. Sezioni locali hanno effettivamente contribuito alle campagne. Indubbiamente il movimento è stato molto, molto conservatore negli Stati Uniti; in molti modi, particolarmente negli ultimi circa cinquant’anni, siamo stati privi di un movimento serio del lavoro organizzato. E ci sono problemi simili anche nei sindacati britannici. Per essere giusti, l’impressione che io ricavo da parte della dirigenza locale di New York è che capiscono che non possono più comandare. Dubito che tu affermi che non dovremmo organizzarci nei sindacati, e di chiunque lo dica dovremmo essere diffidenti, ma credimi: sono ben consapevole dei limiti dei sindacati moderni.
In effetti ho saputo molto di quanto mi racconti da amici che partecipavano agli eventi di Madison, Wisconsin. Sai, ho letto tutto quanto ho potuto riguardo a El Alto, Bolivia, e quelle che per me sono realmente affascinanti sono le forme di organizzazione che vi hanno luogo. C’è una componente sindacale, con un forte sindacato degli insegnanti che apre la via. Ma ci sono anche molti ex membri del sindacato che lavoravano nelle miniere di stagno ma sono finiti disoccupati a causa della ristrutturazione neoliberista degli anni ’80. Quelle persone sono finite a vivere in questa città di El Alto e c’è una tradizione politica attivista di socialismo. Nel movimento sindacale cui appartenevano erano principalmente trotzkisti, il che è significativo. Tuttavia le organizzazioni più importanti erano le organizzazioni di quartiere. Inoltre c’era un’assemblea omnicomprensiva di organizzazioni di quartiere chiamata la Federazione delle Organizzazioni di Quartiere.
Ad esempio c’erano organizzazioni di venditori di strada, che abbiamo anche a New York, oltre a quelle degli addetti ai trasporti. Questi gruppi diversi si incontravano regolarmente. La dinamica interessante di queste organizzazioni è che non la vedono tutte allo stesso modo su ogni singolo tema. Voglio dire: che senso ha partecipare a una riunione in cui tutti sono d’accordo? Dovevano partecipare alle riunioni per assicurarsi che i loro interessi non fossero traditi. È questo quello che succede quando ci sono dibattiti vivaci e confronti politici: il progresso. Dunque l’attivismo delle federazioni di quartiere era il prodotto di metodi di organizzazione molto competitivi. Poi, quando la polizia e l’esercito hanno cominciato ad assassinare persone nelle strade, c’è stata un’immediata dimostrazione di solidarietà tra i gruppi che si organizzavano nella città. Hanno chiuso la città e bloccato le strade.
In conseguenza la popolazione di La Paz, Bolivia, non è stata in grado di ricevere merci e servizi perché tre delle vie principali passavano direttamente attraverso El Alto, che era chiusa da queste organizzazioni. Lo hanno fatto di nuovo nel 2003 e il risultato è stato che il presidente è stato cacciato. Poi, nel 2005, è stato cacciato il presidente successivo. Alla fine hanno avuto Evo Morales. Tutti questi elementi si sono uniti e hanno organizzato efficacemente i poveri e la classe lavoratrice in Bolivia. È da qui che ho tratto il titolo del mio libro Città ribelli. Del tutto letteralmente, El Alto è diventata una città rivoluzionaria nel giro di pochi anni. Le forme di organizzazione in Bolivia sono affascinanti da studiare e da osservare. Non sto dicendo che questo è “il modello” che tutti dovrebbero copiare, ma è un buon esempio da osservare e studiare.
Verso la fine del tuo libro citi un film che è caro al mio cuore, Sale della terra, un film che ho visto per la prima volta da matricola all’università. Il mio insegnante, il dottor Kim Scipes, teneva un corso sulla diversità razziale ed etnica alla Purdue North Central University, dove ho visto il film. Era materiale prescritto da vedere per il corso. Nel far riferimento al film nel tuo libro tu scrivi: “Solo quando unità e parità sono costruite con tutte le forze dei lavoratori saremo in grado di vincere. Il pericolo che questo messaggio ha rappresentato per il capitalismo è misurato dal fatto che questo è il solo film statunitense del quale è stata sistematicamente vietata per molti anni, per motivi politici, la diffusione su reti commerciali”. Puoi parlare del motivo per il quale questo film è importante? Che cosa può insegnarci riguardo alla lotta?
Beh, ho visto il film ormai un certo tempo fa. È stato un po’ in passato e non riesco a ricordare esattamente quando. Ma, come te, ho sempre fatto tesoro del suo ricordo. Così mentre ero seduto a scrivere questo libro sono tornato a vederlo. Naturalmente l’ho rivisto un paio di altre volte. Penso sia una storia molto umana. Ma questa è una magnifica storia di una miniera di zinco, che è basata su una situazione reale, scritta da persone messe al bando da Hollywood per le loro tendenze comuniste. È un grande film in cui classe, razza e genere si uniscono tutte a formare una grande storia e narrazione.
C’è un momento nel film che è un po’ buffo: gli uomini non possono più attuare picchetti a causa della legge Taft-Hartley, così sono le donne ad assumersi il compito di picchettare perché non c’è nulla che vieti loro di partecipare alle proteste. Allora gli uomini devono farsi carico dei lavori di casa. Curiosamente gli uomini cominciano rapidamente a capire perché le donne chiedano dal padrone acqua corrente e altre cose che renderebbero molto più facile la vita quotidiana. Velocemente, naturalmente, gli uomini scoprono quanto sia difficile stare in casa tutto il giorno. Sintetizza il tipo di questioni di genere che sono importanti oggi. Si occupa della solidarietà oltre le divisioni etniche, il che è cruciale. Il film compie un gran lavoro di evidenziazione di tutto questo in un modo molto non didattico. Ho sempre amato molto quel film così ho pensato che fosse appropriato che lo riproponessi nel contesto di ‘Città Ribelli’.
Qualche consiglio di saluto per quelli che ascoltano o leggono questa intervista?
Purtroppo io non sono un organizzatore; sono uno che scrive dei limiti del capitale e di come potremmo muoverci nel concepire visioni alternative della società. Ho ricavato una gran quantità di forza, motivazione e idee intellettuali da quelli che sono concretamente impegnati quotidianamente nella lotta. Partecipo e contribuisco, se posso. Dunque il mio consiglio a tutti sarebbe di uscire quanto più possibile e occuparsi della disuguaglianza sociale e del degrado ambientale perché questi sono temi sempre più lungimiranti. La gente deve diventare attiva, uscire, muoversi. È un periodo cruciale. Sai, la massiccia ricchezza e il capitale non hanno avuto sinora il minimo ripensamento. Dobbiamo dare una grande spinta se vogliamo vedere qualcosa di diverso nella nostra società. Dobbiamo creare meccanismi e forme di organizzazione che riflettano i bisogni e le volontà della società nel suo complesso, non solo quelli di una classe oligarchica privilegiata di individui.
Riferimenti
Vedi su eddyburg la recensione di Benedetto Vecchi e l'articolo di David Harvey, entrambi da il manifesto del 12 settembre 2013, e la nostra postilla (e.s.)
 «Questione romana. Il virus del trasformismo sembra aver contagiato i grillini».il manifesto, 10 febbraio 2017 (c.m.c.)
«Questione romana. Il virus del trasformismo sembra aver contagiato i grillini».il manifesto, 10 febbraio 2017 (c.m.c.)
L’imprudenza di Paolo Berdini non può trasformarsi in un viatico per l’approvazione dello Stadio. Il progetto che va sotto il nome Stadio della Roma è forse la più grossa speculazione fondiaria tentata a Roma dopo l’Unità d’Italia.
Un milione di metri cubi a Tor di Valle, in una fragile ansa del Tevere non lontana dall’Eur, località difficilmente accessibile, servita solo dalla Roma-Lido, la peggiore ferrovia d’Italia. Un milione di metri cubi equivale a dieci volte il volume dell’Hilton, l’albergo su Monte Mario della Società generale immobiliare contro il quale, a metà degli anni Cinquanta, si mobilitò l’Espresso (che aveva pochi mesi di vita). «Capitale corrotta, nazione infetta» è il titolo dell’articolo di Manlio Cancogni che dette il via a una memorabile campagna giornalistica, politica e morale, contro il malgoverno urbanistico. All’Espresso si affiancò Il Mondo dove scriveva Antonio Cederna che nell’occasione coniò l’hilton, unità di misura della speculazione edilizia: un hilton = centomila metri cubi.
Del milione di metri cubi previsti a Tor di Valle, lo stadio e le altre funzioni connesse alle attività sportive formano solo un segmento, meno del venti per cento, di un complesso immobiliare che comprende tre grattacieli alti più di duecento metri e altri edifici destinati ad attività direzionali, ricettive e commerciali senza rapporti con lo stadio, ma destinati a compensare il costo delle infrastrutture dichiarate necessarie per la funzionalità dell’insieme. Una specie di piccola Eur dove il piano regolatore prevede impianti sportivi con modeste cubature. Tutto ciò sarebbe consentito non da una legge sugli stadi, di cui ogni tanto si sente parlare, legge che non esiste, ma grazie a una norma inserita forzosamente e all’ultimo momento nella legge di stabilità del 2014 nell’ambito del tradizionale maxiemendamento e quindi approvato solo per volontà del governo con voto di fiducia.
E contro tutto ciò si sono energicamente battuti, durante l’amministrazione Marino, che aveva insensatamente deliberato l’interesse pubblico del progetto, il gruppo consiliare M5S e l’allora consigliera Virginia Raggi. Che non hanno cambiato idea in campagna elettorale. Per questa ragione, chi scrive questa nota non è stato il solo a votare per Virginia Raggi al ballottaggio per il sindaco nelle scorse elezioni amministrative, e ha votato Raggi soprattutto perché la determinazione contro lo stadio e la speculazione edilizia in generale era rafforzata dalla candidatura di Paolo Berdini ad assessore all’urbanistica, sicuro presidio contro il malaffare.
Tutto ciò sembra che non conti più nulla, più della coerenza e del rispetto per gli impegni presi (che pure furono rispettati a proposito delle Olimpiadi) contano il consenso di Totti e dei tifosi che un tempo l’Uisp (Unione italiana sport popolari) chiamava gli sportivi con il culo (nel senso che fanno sport stando seduti). Non conta nulla non sapere che fine fanno lo stadio Olimpico e il vecchio stadio Flaminio ormai vergognosamente abbandonato. Per non dire della difficoltà a negare lo stesso trattamento a una eventuale richiesta della Lazio o di altre società sportive. Contro lo stadio sono rimasti alcune associazioni ambientaliste, il benemerito comitato «Salviamo Tor di Valle» dal cemento e pochi altri.
Questo modo di fare politica si chiama trasformismo. Fu definita così la pratica politica sostenuta dal presidente del Consiglio Agostino De Pretis che, in un famoso discorso a Stradella nel 1882, si rivolse agli esponenti della destra affinché si trasformassero e diventassero progressisti. Da allora, il trasformismo, da De Pretis a Mussolini a Matteo Renzi al M5S, è diventata la più funesta malattia non solo della sinistra ma di tutta la politica italiana.
 «Berdini è – e resta – un punto di riferimento per chiunque pensa che il male delle nostre città sia che abbiamo troppo, e non troppo poco, cemento». la Repubblica, Blog art.9 Tomaso Montanari, 9 febbraio 2017 (c.m.c.)
«Berdini è – e resta – un punto di riferimento per chiunque pensa che il male delle nostre città sia che abbiamo troppo, e non troppo poco, cemento». la Repubblica, Blog art.9 Tomaso Montanari, 9 febbraio 2017 (c.m.c.)
Paolo Berdini è stato terribilmente ingenuo: si sa, «i figli delle tenebre sono più scaltri dei figli della luce» (Luca, 18, 6). Ma difficilmente chi è stato polizzato a sua insaputa può rimproverare qualcosa ad uno che a sua insaputa è stato intervistato.
L'iperpersonalizzazione della politica italiana (e in particolare delle figure dei sindaci-capi, con la loro elezione plebiscitaristica) fa sì che il problema sembri quello della lealtà dell'assessore al sindaco. No: il problema vero è la fedeltà della giunta al programma e ai cittadini. Anzi, al bene comune.
Ora, non c'è alcun dubbio che Berdini è – e resta – un punto di riferimento per chiunque pensa che il male delle nostre città sia che abbiamo troppo, e non troppo poco, cemento. Una delle famose 5 stelle rappresenta l'ambiente: se salta Berdini, è evidente che la giunta diventa a 4 stelle.
Allora, se Berdini deve saltare, deve saltare semmai sullo Stadio. Se la Raggi dovesse cedere all'eterno potere dei palazzinari e ai tweet del Pup(olist)one, se ci si dovesse rassegnare al fatto che a Roma il sistema dei signori del cemento vige non solo con la destra e la sinistra, ma anche con gli antisistema: beh, in quel caso Paolo Berdini non avrebbe un solo motivo per restare.
Ma non ora. Non perché ha detto ciò che – a torto o a ragione – dicono, con dispiacere e angoscia, moltissimi cittadini italiani, moltissimi militanti e moltissimi eletti del Movimento 5 Stelle.
La Nuova Sardegna, 9 febbraio 2017
Emergenza cultura è un collettivo di sostenitori della tutela dei beni culturali, in sintonia con l'art.9 della Costituzione, punti di vista alternativi alla riforma Franceschini. Nel sito omonimo interessanti documenti. Coordinamento affidato a una ventina di rappresentanti del variegato schieramento impegnato su questi temi, tra gli altri Vittorio Emiliani, Rita Paris, Vezio De Lucia, Tomaso Montanari, Maria Pia Guermandi.
Emergenza cultura ha pubblicato, in due puntate, un
dossier da brivido sulla Sardegna nel pantano della riforma. La dimostrazione che le riforme non sempre portano fortuna, specie nelle realtà di cui si trascurano la storia e la geografia.
Non convince la strategia del ministro: tutto in subordine alle super-collezioni e ai poli museali - nello sfondo l'incremento dei flussi di visitatori in aree urbane dense. Svantaggiosa per la Sardegna con la sua compagine di piccoli musei (spesso senza guida) impossibilitati a fare da traino alle iniziative delle soprintendenze depotenziate dagli accorpamenti tuttologici (erano quattro nell'isola e oggi sono due). Da un po' nel mirino di chi non ne sopporta l'autonomia di giudizio, e ha immaginato di sottometterle al controllo prefettizio (la sfortunata legge Madia). D'altra parte l'antipatia di Renzi verso i soprintendenti è nota. E infatti, al netto della noiosa retorica sul "Paese più bello del mondo", la riforma ministeriale (a costo quasi zero) non amplierà il grado di protezione dei beni elencati dalle due leggi del 1939, e sulla ambiguità della cosiddetta valorizzazione ci sarà da discutere.
E in Sardegna andrà peggio. Il patrimonio dell'isola è disperso nelle campagne, pericolosamente lontano dagli occhi e raggiungibile a fatica. I beni archeologici per essere rinvenuti/rilevati/protetti/visitati, necessitano di personale e forme organizzative adeguate al numero dei beni, alla difficoltà di raggiungerli, per cui servirebbero almeno efficienti mezzi di trasporto scandalosamente indisponibili.
Per memoria: i nuraghi sono quasi novemila, a cui si somma una miriade di antichi manufatti, chissà quanti sottoterra. Il patrimonio di beni architettonici con il corredo di apparati mobili è altrettanto vasto (in ogni piccolo comune c'è almeno una chiesa preziosa con dipinti e sculture). Il paesaggio vincolato, sul quale il Mibact ha competenza, è di grande estensione e valore, ed è minacciato da vecchi e nuovi aggressori come gli speculatori dell'energia.
Sono solo 400 i dipendenti Mibact tra Sassari, Cagliari e le sedi operative. Con clamorosi deficit. Basta l'esempio della Soprintendenza del Nord Sardegna: due tecnici laureati più uno part-time. Con queste poche risorse umane, spesso eccellenti, e con la cronica insufficienza di finanziamenti, la partita è persa in partenza. Il Polo Museale sardo invece di trainare le soprintendenze, sarà una scatola vuota affidata a pochi custodi "infelicissimi". Perché nessun museo ha senso senza un direttore, uno storico- conservatore, progetti didattici. Per contro, nel caos protratto, si rischia di perdere collaudate esperienze di integrazione, come quelle tra attività di scavo, restauro, esposizione di reperti, formazione. Una deriva deprimente che riguarda altri istituti come gli archivi statali, agibili grazie alla generosità di chi ci lavora.
C'è poi la questione dei compiti primari delle soprintendenze nella tutela del paesaggio, dei tempi stabiliti per esprimere pareri sugli atti trasmessi da Regione/enti delegati. Una marea di pratiche a cui si deve fare fronte con un pugno di funzionari sui quali incombe lo smacco (e non solo) del silenzio assenso. Dovrebbe sopperire il recente provvedimento del governo Gentiloni sulla semplificazione dei procedimenti di autorizzazione paesaggistica. Ma c'è chi teme i risvolti pratici. E che questi modi sommari per rimediare all'inefficienza dello Stato, non preannuncino il disarmo delle istituzioni a presidio dei nostri beni culturali. In questo brutto clima - "la tutela contro lo sviluppo" - sta la diffidenza verso la linea scrupolosa del soprintendente del Sud Sardegna Fausto Martino sul caso Eurallamina.

«Su 229 siti naturali riconosciuti dall’Unesco come eredità naturale dell’umanità, 145 luoghi, il 63%, sono stati danneggiati dall’impronta umana negli ultimi 20 anni». Altreconomia, 7 febbraio 2017, con postilla (c.m.c.)
Secondo una ricerca australiana pubblicata a inizio febbraio, il 63% dei Natural World Heritage Sites sono stati danneggiati da attività umane negli ultimi vent’anni. Il 91% di questi sono foreste e l’Asia è il continente più colpito. Intervista al responsabile dello studio «Che cosa fareste se il governo italiano buttasse giù il Colosseo per fare degli appartamenti?».
James Allan è il responsabile del team di ricercatori provenienti dalle università del Queensland in Australia e dalla North British Columbia: insieme alle associazioni Wildlife Conservation Society (Wcs) e all’Unione internazionale per la conservazione della natura (Iucne) ha pubblicato sulla rivista Biological Conservation, a inizio febbraio 2017, uno studio sull’espansione delle attività umane nei luoghi protetti dall’Unesco come patrimonio naturale dell’umanità. «I Natural World Heritage Sites -spiega- vanno considerati alla stregua dei grandi patrimoni culturali del Pianeta».
Il Parco di Yellowstone negli Usa, il Parco Nazionale del drago di Komodo in Indonesia, il Parco e Santuario Nazionale di Manas in India e anche il Chitwan National Park in Nepal, l’Area di Conservazione del Pantanal in Brasile o il Parco Nazionale delle Serengeti in Tanzania sono alcuni tra i siti naturali protetti dalla convenzione internazionale siglata 45 anni fa da più di 190 Paesi.
Su 229 siti naturali riconosciuti dall’Unesco come eredità naturale dell’umanità, 145 luoghi, il 63%, sono stati danneggiati dall’impronta umana negli ultimi 20 anni. Ogni sito ha perso mediamente dal 10 al 20% di superficie protetta dal 2000 ad oggi. «I danni sono causati maggiormente dalla agricoltura espansiva, dall’aumento della densità di popolazione, dall’aumento dei pascoli per l’allevamento all’interno dei confini protetti ed infine, certamente, dall’aumento delle infrastrutture», spiega James Allan ad Altreconomia.
Il 91% dei luoghi “colpiti” sono foreste, con l’Asia che spicca tra i continenti più colpiti, registrando in 16 anni un aumento di interventi umani nelle aree protette di quasi il 10%. Nel Santuario naturale del Manas l’impatto dell’uomo è passato dal 11,8% nel 1993 al 17% nel 2009, aumentando di più del 5%. Se consideriamo il consumo di foresta, il Parco internazionale della pace Waterton-Glacier in Canada è al primo posto con 540,7 chilometri quadrati in meno in 11 anni. Il Parco Nazionale del Grand Canyon (Usa) ha registrato una perdita di quasi il 10% con 38,2 chilometri quadrati sottratti e la Riserva della Biosfera del Rio Plátano (Honduras) ha perduto 365 chilometri quadrati in un decennio. Anche per il più famoso tra i parchi, il Parco di Yellowstone sono 217 i chilometri quadrati persi in una decina di anni.

Per quanto riguarda l’Europa, la ricerca ha ottenuto risultati parziali perché -come spiega Allan- «i siti sono stati molto modificati nel passato e adesso risultano già alterati». Rimane da considerare che «la pressione del turismo e il cambiamento climatico continuano oggi a minacciarli, ma nella ricerca non siamo riusciti a quantificare questi fenomeni perché i metodi per la raccolta dei dati devono essere globalmente uguali per poterli comparare tra loro».
«Le perdite -continua Allan- stanno aumentando. Portando problemi e gravi conseguenze ai Paesi, che avranno danni sia ambientali sia di prestigio culturale. Anche gli abitanti subiranno impatti, in particolare le comunità locali che vivono nei pressi dei siti». Una volta danneggiato, un luogo lo “è per sempre”, afferma Allan-. «Un sito naturale porta opportunità di crescita e turismo sostenibile per il Paese, che in questo modo andranno persi».
Davanti a questa situazione si aprono due scenari. Il primo è continuare senza intervenire: «I siti verranno danneggiati e compromessi, diventeranno sempre più piccoli e il loro valore andrà perso» spiega il ricercatore. Ma c’è un secondo scenario: «Agiamo immediatamente. Impieghiamo questo studio per richiamare alla lotta per i nostri patrimoni. Non lasciamoli costruire in un sito naturale. Se prendiamo una forte posizione possiamo salvare i nostri patrimoni naturali».
Il team di ricercatori lancia un appello all’Unesco con la speranza che la loro ricerca sia riconosciuta e inserita ufficialmente nel sistema di monitoraggio. «I satelliti per il rilevamento e la mappatura non mentono e ci mostrano una rappresentazione onesta di che cosa stia accadendo nei siti». La responsabilità, però, rimane in capo ai singoli Stati perché malgrado la Convenzione del 1972 che impegna gli stati a preservare il patrimonio naturale, l’Unesco «è solo una piattaforma» per coordinare le attività. «Il concetto di patrimonio mondiale è grande, ma abbiamo bisogno dei Paesi per farlo rispettare».
postilla
Nell'articolo vi si accenna, ma è utile precisare che l'Unesco, come tutte le agenzie dell'ONU, è un ente i cui organi decisionali sono costituiti dai rappresentanti dei governi nazionali. E' quindi estremamente difficile che l'Unesco si esprima contro la volontà dei governi (soprattutto di quelli che più contribuiscono al finanziamento dell'agenzia) . Per di più le raccomandazione dell'Unesco non prevedono alcuna sanzione nel caso che i governi le disattendano. Dire che è uno strumento assolutamente inefficace è dire molto poco.
«"Il mondo al tempo dei quanti” di Agostinelli e Rizzuto affronta il nodo cruciale del rapporto tra scienza, economia e politica. Tentando di rispondere a una domanda: è possibile, e in che modo, democratizzare oggi tecnica e capitalismo?». Sbilanciamoci.info, newsletter n 503, 7 febbraio 2017
Mario Agostinelli e Debora Rizzuto, Il mondo al tempo dei quanti. Perché il futuro non è più quello di una volta, Mimesis Edizioni, 2017, pp. 274, € 22.00
Trent’anni di ideologia neoliberista&ordoliberale e di utopie solo tecnologiche dovrebbero averci portato alla consapevolezza di essere a un bivio: decidere se proseguire sul piano inclinato deterministico del tecno-capitalismo e lentamente implodere (o peggio, esplodere); o provare a invertire la rotta o almeno deviarla, riprendendo i comandi della nave – o dell’aereo, secondo la metafora di Zygmunt Bauman, morto nelle scorse settimane, quando scriveva: «I passeggeri dell’aereo ‘capitalismo leggero’ scoprono con orrore che la cabina di pilotaggio è vuota e che non c’è verso di estrarre dalla misteriosa scatola con l’etichetta ‘pilota automatico’ alcuna informazione su dove si stia andando». In realtà, all’orrore ci stiamo abituando, posto che dopo dieci anni di crisi siamo ancora nella palude dell’austerità europea e alla deregolamentazione (e non alla ferrea ri-regolamentazione) dei mercati finanziari (Trump); e che l’unica reazione sembra essere quella di cercare l’uomo forte o il populista o il leader carismatico e visionario, barattando ancora una volta, come scriveva Freud, la possibilità di felicità per un po’ di sicurezza.
Dunque, il problema vero di questi ultimi decenni è quello del rapporto tra democrazia ed economia&tecnica. Un rapporto che è sempre più un conflitto (una guerra, secondo i francesi Dardot e Laval), ma che il tecno-capitalismo sa tenere ben nascosto sotto le forme apparentemente libertarie dell’individualismo neoliberista, della rete come libera e democratica, del tecno-entusiasmo come immaginario collettivo dominante. Per cui, direbbe il ‘pessimismo della ragione’, ci stiamo lentamente abituando al disastro, senza neppure più l’orrore di Bauman, e per di più rimettendo nella cabina di comando i nuovi uomini forti – che però non portano visioni nuove ma alla democratura secondo Pedrag Matvejevic (anche lui scomparso da poco), o alla non-più-democrazia secondo noi.
E allora, posto che tecnica e capitalismo sono strutturalmente a-democratici e quindi programmaticamente o tendenzialmente anti-democratici, ogni riflessione su tecnico-scienza e capitalismo è benvenuta, soprattutto se dichiara da subito – come fanno Mario Agostinelli e Debora Rizzuto in questo loro Il mondo al tempo dei quanti (Mimesis Edizioni) – che «la comprensione e la gestione democratica e consapevole della scienza e della tecnologia devono essere la nuova frontiera della politica» (lasciando così spazio all’ottimismo della volontà); una democrazia «che non si può consumare alla velocità della luce» perché è una «prospettiva che necessita di un tempo umano e che non può essere predeterminata dall’accanimento dei tecnocrati». I due autori vengono dal mondo della scienza (cui Agostinelli ha aggiunto una lunga, intensa militanza sindacale, la partecipazione al Forum sociale mondiale e la presidenza dell’associazione Energiafelice) e provano allora a invitarci a modificare il nostro approccio, a pensare diversamente la scienza (che è cosa diversa dalla tecnica, anche se spesso amano con-fondersi tra loro), e la politica.
Partendo da un’idea di fondo: «questa crisi non può essere affrontata con gli strumenti e le ricette che ci hanno portato allo smarrimento attuale, con il fallimento o addirittura il dissolvimento dell’apparato culturale e istituzionale che ha fornito all’intero pianeta il mito dello sviluppo quantitativo come criterio salvifico e inderogabile per l’avvenire delle nuove generazioni. (…) Dallo schianto in corso sembra essersi invece preservata la scienza, anche perché ha cominciato a considerare la realtà e il mondo naturale in totale discontinuità rispetto al passato e alle regole che ancora apprendiamo a scuola. Era già accaduto, da Aristotele a Copernico e Newton che bisognasse riconnettere l’interpretazione del mondo a nuove visioni… Ciò non è invece ancora accaduto dopo la rivoluzione che relatività e quantistica hanno introdotto nella concezione dello spazio e del tempo…». Una nuova discontinuità di cui invece occorre prendere atto per agire conseguentemente. Che è cosa ovviamente diversa dall’immaginare gli scienziati come aspiranti redentori dell’umanità (ne aveva scritto, criticamente, Hans Magnus Enzensberger nel 2001), ma «il bisogno che le prove fornite dalle nuove teorie interpretative della realtà correggano pregiudizi e convinzioni che resistono in una società poco informata e che le politiche attuali continuano a incorporare nel processo decisionale. (…) Suggeriamo il metodo scientifico più aggiornato alla definizione e comprensione dei problemi sociali e di fornire per questa via strumenti di previsione economica meno labili, un facilitatore di decisioni alla politica e un metodo di rafforzamento del processo di partecipazione democratica».
Tornando a ripensare a quella natura reale che invece tecnica e capitalismo, tra new economy e realtà virtuale, ci hanno fatto dimenticare per oltre quarant’anni – analogamente al concetto di limite – e che presenta oggi il conto di un riscaldamento globale che molti (Trump, di nuovo) ancora negano. Non solo: «Nel quadro attuale, il prevalere della tecnocrazia nel controllo e nell’assegnazione dei tempi – di lavoro, di consumo, di riposo, di riproduzione, di ozio – accresce la disuguaglianza sociale, mentre la velocità imposta ai processi di produzione e di consumo demolisce i cicli naturali e intacca irreversibilmente la qualità della vita. In un frangente simile, una politica che ha passato la mano, prova a persuaderci di vivere in un eterno presente, che distoglie dal riprogrammare il futuro, indebolisce il ricorso alla memoria, disconnette la società dalle urgenze e dalle leggi che implacabilmente regolano la biosfera e le probabilità di riproduzione». Dobbiamo allora re-impadronirci del tempo. E soprattutto tornare a considerare la natura (l’ambiente) come entità che non possiamo più considerare come miniera da sfruttare – deterministicamente e a piacimento – perché considerata come illimitata dalla tecnica e dal capitalismo e dalle loro pedagogie. Il mondo naturale, ricordano Agostinelli e Rizzuto, ha invece una sua autonomia, delle ciclicità necessarie. E va conservato, per noi e per le generazioni future.
Il saggio è ampio e affronta molti temi all’ordine del giorno, dal potere degli algoritmi alla disoccupazione tecnologica, dall’energia al movimentismo sociale. Ma spazia anche in campi inconsueti, ad esempio la relazione tra arte e scienza. Le conclusioni sono nette. Il primo passo da compiere è quello di rivalutare la polis, «riconsegnando quindi alla politica e a un patto di democrazia sociale, il governo del cambio di fase». Il secondo «sta invece nel tematizzare e risolvere le attuali fratture ecologiche e sociali con una chiave di interpretazione, anche teorica, in continuo aggiornamento e in opposizione alla resa mistificatoria di un certo nuovismo usato al posto del cambiamento necessario». Mentre il terzo punto sarebbe una diffusione maggiore del pensiero scientifico, che «ridiscuta, potenzi e riaggiorni il metodo della rappresentanza e valorizzi (…) un apporto critico dal basso».
Ma allora, che fare? – nella classica domanda leniniana, ma anche tolstoiana. Lo riassumiamo, necessariamente per punti: cambiare l’immaginario politico; vincere la sfida climatica; cambiare il modello energetico; riappropriarci del tempo e ridurre gli orari di lavoro; mettere le briglie alla velocità; regolamentare la finanza. Su tutto c’è il tentativo – che condividiamo – di dare una risposta appunto alla questione di partenza: comedemocratizzare tecnica e capitalismo (ammesso che sia possibile), due sistemi che si credono (o che sono già oggi, se già vincono gli algoritmi e il machine learning) autopoietici e autoreferenziali; che sono forme di vita più che forme economiche e tecniche (cioè, mezzi). Complicando così ulteriormente la questione. E la sua soluzione.

La forte probabilità di una conclusione catastrofica dell'affare MoSE era stata denunciata da tempo, ma nessuno ha voluto procedere a un confronto serio, delle numerose analisi compiute in più momenti e più sedi. Ed è stato costantemente ignorato il rischio più grave: la "risonanza", un fenomeno che fece crollare ponti. Torneremo sull'argomento. L'Espresso, 5 febbraio 2017
«Le dighe mobili per la difesa della città lagunare somigliano sempre di più a un rottame: l'Espresso anticipa la perizia commissionata dal Ministero delle Infrastrutture. Il documento rivela il pericolo di cedimenti strutturali per la corrosione e per l'uso di acciaio diverso da quelli dei test»
Non serve essere ingegneri. Non serve nemmeno avere giocato al Meccano da bambini per capire l’effetto devastante di un documento intitolato “possibili criticità metallurgiche per le cerniere del Mose”. Sono nove pagine firmate da Gian Mario Paolucci, già docente di Metallurgia all’università di Padova. Il rapporto è stato commissionato dal provveditorato alle opere pubbliche di Venezia, braccio operativo del Ministero delle infrastrutture. L’Espresso è in grado di anticipare i contenuti di un testo che rivela nero su bianco per la prima volta i vizi strutturali delle dighe mobili contro l’acqua alta a Venezia.
I problemi visti finora nelle sperimentazioni, dalla paratoia che non si alza alla proliferazione dei “peoci” (cozze, in veneziano) e parassiti vari sul Mose, sono folklore. Un folklore molto caro, perché richiede extracosti nella manutenzione di un’opera che già in fase di realizzazione ha fatto spendere allo Stato 5,5 miliardi di euro rispetto agli 1,6 miliardi previsti. Ma le criticità denunciate da Paolucci vanno molto oltre l’aspetto finanziario.
La corrosione elettrochimica dell’ambiente marino, come altri tecnici avevano annotato durante i tre decenni dalla prima inaugurazione del prototipo in pompa magna a Riva degli Schiavoni (1988), sta già imponendo un dazio pesantissimo e forse irreparabile sulle parti metalliche saldate ai cassoni in cemento alle quattro bocche di porto della laguna. Le cerniere del Mose, il meccanismo che collega la barriera mobile alla base in cemento, sono ad altissimo rischio (probabilità dal 66 al 99 per cento) di essere già inutilizzabili. Ripescarle per sostituirle o ripararle è di fatto impossibile. In ogni caso, sarebbe costosissimo.
Qualche passo scelto del documento?
«C’è la seria probabilità che la corrosione provochi danni strutturali e dunque il cedimento della paratoia». «Abbiamo l’assoluta convinzione che la protezione offerta dalla vernice non sia totale». La mazzata finale sull’opera da 5,5 miliardi di euro, che il ministro Graziano Delrio vuole inaugurare a giugno del 2018, arriva a pagina cinque.
«Il connettore femmina, dal quale dipende il funzionamento delle barriere mobili, costituisce l’anello debole dell’apparato a causa di un mancato controllo ispettivo per la sua intera vita di 100 anni, a meno di una laboriosa e costosa manutenzione straordinaria. Inoltre, la necessità di effettuare tale manutenzione verrebbe segnalata da malfunzionamenti causati da danni ormai avvenuti e talvolta irreparabili. Cioè, quando è troppo tardi. In questo caso, l’unica cosa da fare è sperare che i danni che certamente si saranno verificati sui connettori femmina di Lido, San Nicolò, Malamocco, Chioggia, siano contenuti».
La parola speranza ricorre un’altra volta nel documento. È una parola meravigliosa in molti contesti, ma poco rassicurante se applicata a un’opera di ingegneria idraulica concepita per proteggere una città patrimonio dell’umanità, non per minacciarla e neppure per distribuire mazzette gonfiando costi, com’è accaduto. E a proposito di preventivi gonfiati, il rapporto del professor Paolucci fa scattare più di un allarme. Durante la fase di sperimentazione, i componenti delle cerniere erano fabbricati con materiali di qualità migliore rispetto a quelli impiegati nella produzione di serie.
Il perno di rotazione sottoposto ai test di laboratorio, per esempio, era fatto di ottimo acciaio prodotto dalla Valbruna di Vicenza e lavorato dalla Focs Ciscato di Velo d’Astico. Invece i perni di serie da installare nelle quattro bocche di porto provengono da impianti dell’Europa dell’Est e presentano una lega diversa da quella del prototipo.
Acciaio depotenziato? La risposta spetta ai tre commissari governativi (Luigi Magistro, Francesco Ossola, Giuseppe Fiengo) in carica da due anni alla guida del Consorzio Venezia Nuova (Cvn), dopo la tabula rasa decisa dal governo sul tavolino di imprese private che si sono spartite i fondi della legge speciale con un uso sistematico di corruzione.
Il processo penale ha stroncato la carriera politica del forzista Giancarlo Galan, governatore regionale per 15 anni e poi ministro, del potente ex assessore Renato Chisso, in un primo tempo confermato da Luca Zaia, e ha coinvolto personaggi del calibro di Altero Matteoli, senatore che ha guidato i ministeri dell’ambiente e delle Infrastrutture, e dell’ex sindaco Paolo Orsoni, accusato di finanziamento illecito e non di corruzione come gli altri.
Guadagnare sott’acqua
La perizia del professor Paolucci è stata ordinata da quello che una volta si chiamava Magistrato alle Acque (Mav), in onore della tradizione antica della Serenissima. Il governo di Matteo Renzi lo ha derubricato a provveditorato alle opere pubbliche dopo lo scandalo delle tangenti del Mose, in onore della tradizione moderna per cui se si cambia nome a un problema il problema è risolto.
I lavori sulle cerniere del Mose sono stati affidati dal Cvn alla Fip di Selvazzano (Padova). L’impresa appartiene al gruppo Mantovani della famiglia Chiarotto, principale azionista del gruppo di aziende riunite nel Consorzio, presieduto da Giovanni Mazzacurati. La realizzazione delle cerniere è stata affidata alla Fip senza gara superando dubbi e critiche di alcuni tecnici che propendevano per le cerniere fuse, più resistenti e durature, invece delle cerniere saldate prodotte dalla Fip. Alcuni tecnici che avevano espresso critiche sono stati allontanati sotto la gestione Mav di Patrizio Cuccioletta, poi accusato di corruzione.
Fino al blitz della Procura, il braccio operativo della Mantovani su incarico del patriarca Romeo Chiarotto è stato Pier Luigi Baita. L’ingegnere veneziano, collaborando con i magistrati dopo l’arresto, ha consentito di scuotere un sistema di potere messo in piedi durante la Prima Repubblica, circa un quarto di secolo prima, e rimasto intatto sotto i governi di qualsiasi orientamento.
Oggi Baita è stato messo da parte e i Chiarotto lo hanno sostituito con l’ex questore Carmine Damiano nel tentativo di scaricare la presunta mela marcia e continuare a fatturare con il Mose. L’affare delle dighe mobili ha trasformato la Mantovani in un gruppo di prima grandezza a livello nazionale, anche se non sempre è andata bene fuori dal Veneto, come si è visto nell’inchiesta sulla piastra per l’Expo 2015 che ha coinvolto l’impresa padovana.
Ma il Mose vale molto di più dell’Expo. Rende in termini di forniture per la costruzione e continua a rendere una volta inaugurato, perché promette altri guadagni con la gestione e la manutenzione, in una banda di oscillazione ancora indefinita tra i 50 e gli 80 milioni di euro all’anno. Nelle previsioni iniziali dovevano essere 20 milioni di euro.
I tre commissari del Consorzio hanno sempre detto che la gestione non andrà in automatico ai costruttori. Di fatto, nel breve termine e con i pasticci tecnici già in corso, non ci sono alternative. E bisogna ricordare che un’altra importante mossa strategica dei commissari governativi, cioè il congelamento dei profitti alle imprese del Cvn in attesa delle decisioni della giustizia, è stata vanificata da una sentenza dell’immancabile Tar del Lazio.
Insomma, se il Mose funziona, bene. Se non funziona, meglio perché ci sarà più manutenzione da fare. Resta sempre più attuale la frase-simbolo coniata dallo spirito brillante di Baita. «Il bello del Mose è che i lavori si fanno sott’acqua». Certo, se non funziona affatto o produce danni al delicatissimo sistema lagunare invece di tutelarlo, la questione diventa imbarazzante. La bella opacità dei lavori rischia di trasformarsi in incubo.
Connettore malafemmina
La perizia Paolucci è scritta in modo da essere comprensibile a chiunque e forse proprio la semplicità delle osservazioni è l’accusa più pesante: se un profano può capire il problema, come mai i superesperti non lo hanno capito prima? Ma vediamo di che si tratta.
Il Mose è formato da tre parti principali: i cassoni di ancoraggio in cemento, sprofondati già da mesi alle bocche di porto, le cerniere e le barriere mobili, pronte a sollevarsi per sbarrare la strada all’acqua alta. Per proteggere la struttura dalla micidiale corrosione sottomarina ci sono due sistemi: la verniciatura e la protezione catodica. La verniciatura è soggetta a degrado, scheggiature e danni causati da sabbia e detriti che già si sono verificati. La protezione catodica si realizza attraverso un contatto elettrico con anodi di zinco che si corrodono al posto del ferro e periodicamente vanno sostituiti.
Le cerniere, la parte più delicata, sono dotate di un connettore maschio e di un connettore femmina, due giocattolini da 10 e 26 tonnellate rispettivamente. Il primo è applicato alla barriera e il secondo al cassone. «Paratoia e connettore maschio possono essere riparati e riverniciati con conseguenze solo finanziarie. Il vero problema è il connettore femmina che dovrebbe durare 100 anni senza subire alcuna manutenzione», dice la perizia. Purtroppo, i connettori femmine sono stati tutti inseriti nei cassoni ma «a eccezione di quelli di Treporti, non sono protetti catodicamente perché mancano le relative paratoie dove alloggiano gli anodi di zinco». Il monitoraggio, peraltro, non è stato realizzato neanche a Treporti, dove sono state applicate le paratoie. Nessuno sa se la protezione sia attiva almeno lì.
L’esposizione del connettore femmina («anello debole dell’apparato») alla corrosione a Lido, Malamocco e Chioggia è dovuta ai gravi ritardi nella posa delle barriere che dovevano essere inserite con la nave jack-up, costruita da Comar (Mantovani, Condotte, Fincosit) su progetto Tecnital-Fincosit. Monumento allo spreco da 50 milioni di euro, il jack-up non è mai stato collaudato e giace alla fonda all’Arsenale mentre le dighe vengono applicate con metodi più vecchi, e più lenti.
Processo verso la prescrizione
Oltre a Galan, Baita, Mazzacurati, Orsoni, l’inchiesta penale ha colpito anche il reparto tecnico del ministero delle Infrastrutture, chiamato a vigilare e non soltanto a distribuire incarichi di collaudo per milioni di euro a professionisti e dirigenti statali. I predecessori dell’attuale magistrato alle acque, Roberto Linetti, entrato in carica lo scorso novembre, sono finiti tutti sotto processo. Patrizio Cuccioletta ha patteggiato una condanna a due anni e la Corte dei conti gli ha appena chiesto 2,7 milioni di danno erariale oltre ai 750 mila euro già versati al tribunale penale. Un altro Magistrato alle acque, Maria Giovanna Piva, è ancora a giudizio.
A parte i circa quaranta patteggiamenti, il giudizio contabile potrebbe essere presto tutto quanto rimane della maxi-inchiesta sul Mose e sui manager del Consorzio che sono costati 32 milioni di euro negli anni dal 2005 al 2013. Il record è di 3,2 milioni di emolumenti e lo ha stabilito Mazzacurati nel 2009 cumulando le cariche di presidente e di direttore generale. I tre commissari in carica oggi guadagnano 700 mila euro all’anno in totale.
Il processo penale di primo grado per chi non ha patteggiato potrebbe concludersi in tempi brevi, forse nelle prossime settimane. Ma in appello, a partire dal settembre 2017, scatterà la prescrizione. Fra i salvati, ci saranno Baita, Claudia Minutillo, prima segretaria di Galan e poi manager di Adria infrastrutture (gruppo Chiarotto), e lo stesso Mazzacurati, che non è mai stato nemmeno rinviato a giudizio. L’ex presidente del Consorzio, trasferitosi in California, a quasi 85 anni non sarà in grado di partecipare al dibattimento nemmeno come testimone, essendo colpito da una grave forma di demenza secondo il medico legale Carlo Schenardi. È la conclusione tragica di un’epopea che è nata e rimane sotto una cattiva stella.