 «Campidoglio. Dopo un ricovero per un malore, Raggi incontra i proponenti a Palazzo Senatorio per l’intesa: dimezzate le cubature della cittadella» È davvero un miglioramento? il manifesto, 25 febbraio 2017, con postilla
«Campidoglio. Dopo un ricovero per un malore, Raggi incontra i proponenti a Palazzo Senatorio per l’intesa: dimezzate le cubature della cittadella» È davvero un miglioramento? il manifesto, 25 febbraio 2017, con postilla

 «Più cemento, meno centro è l’era della post-metropoli. Gli ultimi studi e un convegno internazionale“ Oltre la metropoli”rilanciano il tema dei nuovi assetti urbanistici». la repubblica, 7 marzo 2017 (c.m.c.)
«Più cemento, meno centro è l’era della post-metropoli. Gli ultimi studi e un convegno internazionale“ Oltre la metropoli”rilanciano il tema dei nuovi assetti urbanistici». la repubblica, 7 marzo 2017 (c.m.c.)
L’urbanizzazione del pianeta procede e avanza a ritmo incessante. Un’immagine satellitare che abbraccia l’intero globo e che registra l’intensità delle luci accese documenta quanta superficie terrestre occupi l’espansione urbana. Un tappeto luminoso si distende fra la California e la penisola della Kamchatka, con isole nette e nebulose sfumate, copre l’India, molta Cina, l’Africa meridionale e le coste sudamericane. Ma sono città tutti gli spazi dai quali provengono i bagliori?
La domanda rimbalza da anni nel settore degli studi urbani e interpella architetti e urbanisti, sociologi, geografi ed economisti. E l’abituale identificazione fra l’urbano e la città vacilla, fino a cadere fiaccata: possono diffondersi nel territorio case, anche palazzi, centri commerciali e centri logistici, stabilimenti industriali e paradisi del divertimento, possono distribuirsi (quando va bene) infrastrutture, strade e linee ferroviarie. Ma non è detto che questo faccia città — e città distinta nettamente dalla non-città.
Il fenomeno va avanti da qualche decennio. Ma faticano le sistemazioni teoriche e, soprattutto, è incerto come si possa fronteggiare un processo che genera affanno, spreco, alimenta individualismi e solitudine. Insorge l’espressione post- metropoli, coniata dal geografo Edward Soja, scomparso nel 2015. Un analista coinvolto su questo fronte d’indagine è il sociologo Neil Brenner, docente ad Harvard, fra i più innovativi e anche radicali analisti delle trasformazioni urbane, alle quali oppone l’idea che «un’altra urbanizzazione è possibile, alternativa a quella imposta dall’ideologia neoliberista». Di Brenner, che spesso si richiama alla Scuola di Francoforte, è uscita in Italia una raccolta di saggi ( Stato, spazio, urbanizzazione, introduzione di Teresa Pullano, Guerini associati, pagg. 190, euro 18,50) e Brenner stesso è atteso a un convegno domani a Roma.
Brenner punta a dimostrare come l’urbanizzazione investa l’intero globo e sia figlia di un capitalismo fortemente finanziarizzato. Ma non basta ad attestarlo la migrazione di popolazione verso i centri urbani, che una stima Onu colloca oltre il 75 del totale nel 2050. No, insiste Brenner, a parte l’attendibilità dei dati, occorre cambiare prospettiva «perché è la città che è esplosa. Ed è anzi azzardato parlare di città riferendosi a quelle forme di urbanizzazione che un po’ si concentrano, un po’ si diradano, si spalmano in maniera non pianificata o secondo logiche economiche, tutte private, ma che non è più possibile ripartire fra urbano, rurale e persino periferico».
Centro e periferia, per esempio, è una coppia di concetti che perde peso. Questa urbanizzazione avviene mescolando funzioni diverse «residenziali, ma non solo, ci sono reti infrastrutturali e di trasporto, stabilimenti industriali inquinanti, discariche», spiega Brenner. «Non esiste un modello unico», aggiunge il sociologo, «la mia intenzione è di provocare una riflessione generale su quali forme assume l’urbanizzazione planetaria».
E in Italia? Alessandro Balducci, urbanista del Politecnico di Milano, per un anno assessore nella giunta Pisapia, ha avviato una ricerca insieme ad altre università (Piemonte orientale, Iuav di Venezia, Firenze, La Sapienza a Roma, Alghero, Federico II di Napoli, Palermo). Ne è nato un Atlante (www.postmetropoli.it) che mostra come, in maniera differente che altrove e con marcate diversità al suo interno, anche in Italia si assiste a un’espansione dell’urbano che non fa città (già dagli anni Novanta si parla di “città diffusa”, grazie agli studi di Francesco Indovina e Bernardo Secchi). «È però preoccupante», lamenta Balducci, «che una delle forme di governo più recenti di queste realtà, le aree metropolitane, sia completamente inadeguata. Pensiamo nel XXI secolo di governare con strumenti del XX secolo entro confini del XIX».
Ma quali indicazioni fornisce l’Atlante? «Una condizione post- metropolitana caratterizza le regioni che hanno conosciuto una fase metropolitana in passato », spiega Balducci. «Penso a Milano e, in misura diversa, a Napoli. Qui l’urbanizzazione non si dirada a mano a mano che si esce dal centro e anche dalla periferia novecentesca, andando verso i nuovi insediamenti. Proliferano nuove centralità in luoghi periferici, e la popolazione è anziana, si riducono i componenti del nucleo familiare e c’è un forte incremento di immigrati, tutti fenomeni che fino a ieri avevano caratterizzato solo le aree centrali dei contesti metropolitani».
Diversa è la situazione in Veneto o in Toscana, dove, sostiene Balducci, «non c’è mai stata una fase metropolitana e prevale una forma “polinucleare”». Il Veneto è uno dei primi laboratori della “città diffusa”, con una crescita dissennata dell’edificato che ha saturato molti spazi, ora intasati di capannoni vuoti. Qui, ma anche in Toscana, le urbanizzazioni «attraversano i confini delle vecchie province», dice Balducci, «e non sono né Firenze né Venezia il fulcro intorno al quale ruotano le dinamiche territoriali».
Altra storia ancora è quella di Roma, messa a fuoco in un volume di saggi curato da Carlo Cellamare, docente alla Sapienza ( Fuori raccordo, Donzelli, pagg. 357, euro 34) che applica alla capitale il tema della post-metropoli. Una capitale in cui intorno al Grande raccordo anulare, il Sacro Gra indagato da Niccolò Bassetti e portato al cinema da Gianfranco Rosi, è cresciuta un’urbanizzazione che conta un milione di abitanti.
All’inverso di Milano o di Napoli, più ci si allontana dal centro più i nuovi insediamenti si diradano fino a toccare densità talmente basse da non essere più pertinenti a una dimensione di città. Una densità che non consente un decente livello dei servizi, in particolare del trasporto pubblico. Fallimentare è stato il tentativo di costruire nuovi centri direzionali. Mentre, ricorda Giovanni Caudo, urbanista di Roma 3 ed ex assessore con Marino, «in tutti i comuni della provincia di Roma e in quelle di Viterbo, Terni e L’Aquila, si sono trasferiti centinaia di migliaia di romani, creando un insediamento fatto di cerchi concentrici, attraversati da un pendolarismo quotidiano».
Non c’è città meno città di Roma, dove più di un terzo delle persone vive in una sommatoria di brandelli. E dove si registra un’altra delle condizioni analizzate da Brenner: l’aumento del disagio e delle diseguaglianze che producono conflitti e, appunto, insiste il sociologo, «la richiesta di un “diritto alla città” — una città come spazio comune, prodotta e condivisa da tutti, tendenzialmente più egualitaria e democratica. Per questo penso che il progetto di subordinare l’assetto urbano a una logica di puro profitto è sempre controverso e contraddittorio e incontra una crescente resistenza ».
Il Convegno“Oltre la metropoli” s’intitola il convegno di domani ( Aula Magna di Roma Tre, ore 9.30) al quale partecipa Neil Brenner.
 «Siamo una cittadina di provincia, con reati in calo e criminalità sotto controllo. Cosa dovrebbero fare allora a Milano o Torino: mettere un fossato con le mitragliatrici?”». La Stampa online, 4 marzo 2017 (p.s.)
«Siamo una cittadina di provincia, con reati in calo e criminalità sotto controllo. Cosa dovrebbero fare allora a Milano o Torino: mettere un fossato con le mitragliatrici?”». La Stampa online, 4 marzo 2017 (p.s.)
Un quartiere-bunker a due passi dal centro storico: è il villaggio “Borgo San Martino”, a Treviso, difeso da un muro alto quasi tre metri. Una zona esclusiva e inaccessibile, dove abitano prevalentemente liberi professionisti: un progetto che sarebbe stato un orgoglio all’epoca del sindaco-sceriffo Gentilini.
Per ora ci sono 21 case, ma solo una è ancora acquistabile. Ai nastri di partenza un ampliamento con altre sette villette a due piani, nell’ambito di una lottizzazione che arriverà a 50 edifici complessivi. Il costo non è proibitivo: per 150 metri quadrati si parte da 320 mila euro, per giungere fino a 410 mila. Da non sottovalutare le spese di gestione, comprese quelle per la piscina comune. Per ora, niente guardie giurate, ma video-sorveglianza per ogni singolo alloggio: quando il compendio immobiliare sarà concluso, si pensa ad una figura ibrida tra portiere e vigilante.
Il fortino è però finito nel mirino di Italia Nostra, che ha accusato il Comune di aver autorizzato una costruzione che non rispetta la normativa urbanistica. «Il Veneto è la terra delle deroghe e delle proroghe - ha ricordato il presidente provinciale dell’associazione ambientalista Romeo Scarpa -, quindi nessuno stupore particolare. Inoltre, vanno stigmatizzate queste iniziative che si basano sul livello di percezione della sicurezza, non su quella reale. Siamo una cittadina di provincia, con reati in calo e criminalità sotto controllo. Cosa dovrebbero fare allora a Milano o Torino: mettere un fossato con le mitragliatrici?».
«Sicuramente la nostra idea non è quella di quartieri ‘fortificati’ o ‘murati’, Treviso è una città sicura e di certo non ha bisogno di ‘alzare barriere’ - gli ha fatto eco il sindaco Giovanni Manildo -. Rispettiamo e promuoviamo il diritto di ciascuno alla protezione e alla privacy. In realtà, la ditta aveva fatto una richiesta di poter realizzare una protezione acustica, una barriera antirumore, per la quale avevamo rilasciato le autorizzazioni del caso. Chiederemo che intervenga per rendere più verde la struttura».
Alla società che ha ideato il villaggio blindato si fregano le mani per l’eco che la polemica sta garantendo: «I telefoni squillano in continuazione - conferma il titolare Remo Berno, emigrante italo-australiano - e la richiesta è pressante. C’è desiderio di privacy e i nostri residence la garantiscono. Il polverone sollevato a Treviso è strumentale: c’è un villaggio gemello a Castelfranco Veneto, ma lì nessuno dice nulla. E nemmeno a Jesolo, dove queste lottizzazioni impenetrabili sono presenti da tempo. Ad Arese esistono addirittura dagli anni Settanta».
«La sicurezza è intesa a 360° - fa sapere una giovane mamma che abita nel “Borgo”-: vicini di casa selezionati, un clima famigliare, bimbi che possono giocare negli spazi comuni senza il rischio di venire investiti dalle auto. Circa i malintenzionati, sono disincentivati dalla presenza della barriera perimetrale».
Quello di San Martino non è l’unico muro invalicabile: a fianco c’è quello della casa di riposo e pochi passi più in là quello del carcere. Da lì, però, i malfattori vorrebbero andarsene più che cercare di entrare.
«Palestina. L’albergo voluto dall’artista denuncia una barriera ormai dimenticata dalla comunità internazionale. Tra gli strumenti dell’occupazione israeliana c’è la distruzione dell’economia palestinese».il manifesto, 5 marzo 2017 (c.m.c.)
Una signora porta una pianta, suo marito saluta cordialmente il manager dell’hotel, Wassim Salsaa, che dispensa il benvenuto agli invitati che accedono al “The Walled Off Hotel”, l’hotel dello street artist britannico Banksy. Tutti sorridono lasciandosi alle spalle i lastroni di cemento armato, decorati con slogan politici, manifesti, imprecazioni e frasi di speranza, che compongono questa sezione del Muro israeliano che circonda Betlemme.
Proprio all’ingresso, una nicchia ricorda Lord Balfour mentre nel 1917 promette la Palestina al popolo ebraico. Nella hall di stile vario, con alle pareti riproduzioni e originali di opere di Banksy, tra le decine di persone presenti gira una domanda: mescolato tra di noi c’è anche il famoso graffitaro? La lente di ingrandimento è su un paio di uomini, alti e con uno spiccato accento british. Ma il mistero resterà irrisolto per tutta la sera. Banksy sa custodire il suo anonimato e i suoi collaboratori palestinesi hanno lavorato per oltre un anno all’hotel lontano dagli occhi dei media.
Al secondo piano, in una sala ampia e ben illuminata, sono esposti i lavori di pittori palestinesi: Tayseer Barakat, Khaled Hourani, Slyman Mansour e altri ancora. Alcuni di loro sono giù nella hall. Poi comincia un breve intrattenimento artistico, utile a spiegare il “The Walled off Hotel”. Ad un certo punto, su di uno schermo, appare Elton John live da Los Angeles. Wassim Salsaa sostiene che il cantante britannico si esibisce anche in onore di questo piccolo albergo in Palestina. Scattano gli applausi.
Eppure le attrazioni della serata restano la stanza decorata dallo stesso Banksy e il murales che ritrae un palestinese e un poliziotto israeliano che si prendono a cuscinate. Si provano sentimenti contrastanti girando per questo hotel che, come ha ripetuto Wassim Salsaa in questi giorni, «ha la vista più brutta del mondo». Come dargli torto. I lastroni del Muro sono a pochi metri dalle finestre del “The Walled Off Hotel”.
Inevitabile porsi degli interrogativi. Questo albergo è una iniziativa artistica o commerciale? Ha un significato politico o è figlio di quella superficialità occidentale che sempre più spesso avvolge la questione palestinese? È una denuncia sincera della barriera israeliana o proprio quei lastroni di cemento finiscono per renderlo trendy?
Probabilmente è tutto questo e anche altro, con gli amministratori palestinesi che appaiono un po’ meno interessati ai contenuti rispetto allo stesso Banksy che a Betlemme ha donato la sua guerrilla art per condannare l’orrore del Muro.
Lo street artist un paio d’anni fa è stato anche a Gaza, per lasciare i suoi graffiti sui ruderi delle case abbattute dai raid israeliani. E non passa inosservato, accanto all’hotel, il negozio dove è possibile acquistare magliette, poster, souvenir con le immagini dei lavori del graffitaro iconoclasta. Si dice che l’hotel voglia favorire il dialogo fra israeliani e palestinesi e riportare i riflettori su Betlemme, la città della Natività che, soffocata dal Muro, non riesce a sfruttare il suo potenziale turistico e le capacità dei suoi noti artigiani del legno d’olivo.
Sarebbe già tanto se riuscisse a persuadere i giornalisti italiani a non definire il Muro che divide Betlemme da Gerusalemme e dalle campagne circostanti, sempre e soltanto come una «barriera anti-terroristi» e a considerare quanta terra questa “opera” ha sottratto alla Cisgiordania per annetterla di fatto a Israele e i danni che ha causato a decine di migliaia di palestinesi, specie gli agricoltori, spesso riducendoli alla fame.
Gli abitanti di Betlemme non hanno un giudizio unico del “The Walled Off Hotel”. Molti lo apprezzano, altri alzano le spalle, altri ancora lo ignorano. A Banksy comunque tutti i palestinesi dovranno dire grazie per aver riportato attenzione sul Muro.
Quei 700 km di cemento e reticolati che dal 2002, come un serpente, si incuneano nella Cisgiordania restano per i palestinesi il jidar al fasl al unsuri, il muro della separazione razziale. Ormai non se ne parla più, non fanno più notizia le manifestazioni settimanali che a Bi’lin e in altri villaggi contro quel mostro di cemento. Negli anni passati, oltre a Banksy, altri artisti, come Roger Waters dei Pink Floyd, hanno denunciato il Muro. Poi più nulla o quasi.
Ed è caduto nell’oblio il parere emesso il 9 luglio 2004 dalla Corte Internazionale di Giustizia dell’Aia: «L’edificazione del Muro che Israele, potenza occupante, è in procinto di costruire nel territorio palestinese occupato, ivi compreso l’interno e intorno a Gerusalemme Est, e il regime che gli è associato, sono contrari al diritto internazionale». Nel 2017 un piccolo hotel e un artista di strada riaprono il caso.
 «Denuncia di 40 tra economisti, docenti esperti della materia per chiedere una profonda revisione dei metodi con cui in Italia si pianificano gli investimenti pubblici». Il Fatto Quotidiano, 5 marzo 2017 (c.m.c.)
«Denuncia di 40 tra economisti, docenti esperti della materia per chiedere una profonda revisione dei metodi con cui in Italia si pianificano gli investimenti pubblici». Il Fatto Quotidiano, 5 marzo 2017 (c.m.c.)
È in corso un grande rilancio politico delle “Grandi Opere”. I denari pubblici in gioco sono moltissimi, paria circa 70 miliardi. Una cifra enorme se si pensa agli stretti vincoli di bilancio e tutti concentrati su un numero limitato di grandi interventi, a cui si sommano le risorse dei Contratti di Programma con Fsi e Anas.
Il costo complessivo dei soli interventi ferroviari ammonta a quasi 26 miliardi di euro (Allegato al Def 2016), equivalente a oltre un terzo di quello complessivo di tutte le opere “strategiche”. Esistono in ambito internazionale consolidate regole di valutazione economico-finanziaria, ma in Italia sono state finora ignorate. Per nessuna delle opere sopra citate c’è stata una valida analisi, pubblicamente disponibile al momento della decisione, che ne dimostrasse l’utilità sociale. Solo per alcune (il Brennero ad esempio), sono stati pubblicati documenti, peraltro oggetto di critiche metodologiche, solo dopo che la decisione era stata presa. Lo stesso vale per grandi progetti stradali, come la Pedemontana veneta, quella lombarda, e la Livorno-Civitavecchia.
L’entità dei costi previsti impone che le grandi opere passino al vaglio di pubbliche ed approfondite analisi costi-benefici da parte di valutatori “terzi” rispetto ai committenti, per evitare scelte economicamente non giustificabili, dettate da considerazioni elettorali di breve respiro (nella migliore delle ipotesi). Purtroppo esempi di progetti infelici non mancano, dagli 800 milioni già inutilmente spesi per la stazione dell’Alta velocità di Firenze che non si farà ai quasi 8 miliardi spesi per l’Av Torino-Milano, scarsamente utilizzata rispetto alla capacità, e con costi stimati tripli rispetto ad analoghe linee francesi.
Analisi indipendenti evidenziano come due progetti – la nuova linea Torino-Lione e la linea Alta capacità/Alta velocità Napoli-Bari – mostrino flussi di traffico, attuali e prospettici, così modesti da poter escludere che sia opportuno realizzarli nella forma prevista. Perla Milano-Padova le ricadute positive saranno quelle dell’aumento di capacità complessiva che si potrebbe però ottenere con interventi assai meno onerosi e impattanti, mentre trascurabile appare il beneficio della velocizzazione del traffico diretto tra Milano e Venezia.
Per quanto riguarda il Terzo Valico Milano-Genova un’analisi costi-benefici, ancorché sommaria ha dato anch’essa risultati negativi. Per tutte queste opere le previsioni di traffico sembrano essere irrealistiche, come è evidente sia dal confronto storico dei flussi reali sia dalla stima, implicitamente assunta nelle analisi, di un forte aumento della domanda a seguito della disponibilità dell’opera. Queste assumono poi tariffe d’uso invariate rispetto a quelle attuali, quindi implicitamente che l’intero costo di investimento sia a carico dell’erario.
Se è vero che la decisione finale sulle opere pubbliche deve rimanere politica, essa non può prescindere dai risultati di analisi rigorose, trasparenti e comparative, né ignorare studi e valutazioni effettuate da esperti indipendenti e deve anche aprirsi a un confronto con tutte le parti interessate.
La corruzione è deprecabile, ma un danno più grave può essere inflitto alla collettività dal dedicare enormi risorse all’esecuzione di strade, linee ferroviarie o ponti non giustificati dai benefici del traffico, destinato a una crescita comunque modesta per ragioni economiche e demografiche. Forse per la percezione della necessità di un cambiamento, è stata recentemente creata nel ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti una struttura tecnica che dovrà valutare gli investimenti pubblici secondo regole precise e rendendo trasparenti e meno discrezionali le scelte politiche.
L’iniziativa del ministro Graziano Delrio è lodevole e necessaria, e deve ricevere il massimo supporto da parte di chi ha a cuore la cultura della valutazione e della trasparenza nelle scelte. Ma non si può fare a meno di notare che emergono forti ombre sul ruolo reale di questa struttura, se guardiamo alle contemporanee dichiarazioni della politica che certo non favoriscono valutazioni neutrali.
Da un lato si susseguono infatti dichiarazioni politiche in favore di “Grandi Opere” mai seriamente valutate (opera “strategica” o che “crea 100.000 posti di lavoro”, ecc.), dall’altro lato molte scelte vengono dichiarate “irreversibili” a causa dell’esistenza di forti penali in caso di mancata realizzazione. Ma queste penali furono spesso stabilite su contratti affidati senza gara, con patti evidentemente lesivi dell’interesse pubblico.
Prescindendo dalla consistenza giuridica di queste penali (il governo Prodi cancellò quei contratti, quello Berlusconi poi li ri-convalidò), è pur possibile valutare in modo rigoroso quali opere converrebbe alla collettività portare comunque a termine e quali sarebbero invece da cancellare o ridimensionare pur in presenza di penali (anche in funzione del loro stato di avanzamento: alcune sono appena iniziate).
C’è dunque il rischio che la costituzione di un organismo apposito, così innovativo nei principi, copra il perpetuarsi di scelte non validate, sotto le fortissime pressioni da parte delle lobby interessate ai lavori, ma indifferenti all’utilità dell’opera. Auspichiamo che il ministro mostri nei fatti la proclamata volontà di cambiamento.
 Ampia rassegna di ricerche e articoli, prevalentemente statunitensi, sul ruolo delle città, della rendita immobiliare e delle politiche urbane nel capitalismo dei nostri anni. Intervento introduttivo al seminario "Le piattaforme delcapitale", Milano, 3-4 marzo. EuroNomade, 3 marzo 2017
Ampia rassegna di ricerche e articoli, prevalentemente statunitensi, sul ruolo delle città, della rendita immobiliare e delle politiche urbane nel capitalismo dei nostri anni. Intervento introduttivo al seminario "Le piattaforme delcapitale", Milano, 3-4 marzo. EuroNomade, 3 marzo 2017
Vorrei partire da un libro di recente uscita intitolato The Complacent Class: The Self-Defeating Quest for the American Dream (New York, 2017) scritto da Tyler Cowen, un economista mainstream di orientamento conservatore (nel libro simpatizza apertamente con l’amministrazione Reagan degli anni Ottanta), noto per animare uno dei blog di economia più letti negli Stati Uniti. Nel libro l’autore sostiene che la società statunitense, e in particolare il suo ceto medio, ha perduto il dinamismo e la smania per il cambiamento (la restlessness) che la ha animata fin dalla fondazione della nazione americana.
Gli statunitensi non si muovono più come un tempo da uno stato all’altro in cerca di migliori opportunità di realizzazione personale, come hanno fatto fino agli anni Settanta del Novecento, a differenza degli europei visceralmente legati alla propria città natale; non cambiano lavoro come un tempo e hanno smarrito lo spirito imprenditoriale che li caratterizzava: a dispetto della retorica sul tema, il numero di imprese start-up – fa notare Cowen – è in costante diminuzione negli Stati Uniti, perfino nel decantato tech sector, il settore tecnologico che ha fatto parlare del tech boom 2.0 negli anni successivi alla “grande recessione”, dal 2010 a oggi.
L’autore manca di offrire un’analisi di perché ciò sia avvenuto. Il suo saggio, in linea con la tradizionale vena moraleggiante degli economisti conservatori, non offre soluzioni di public policy ai problemi di immobilità sociale che mette in evidenza, ma finisce per l’appunto con lanciare una strigliata morale alla nazione americana, colpevole di crogiolarsi in un apparente benessere dove in realtà sotto le ceneri covano sentimenti di frustrazione e risentimento sociale portati alla luce dall’elezione di Donald Trump.
In un articolo apparso in The Atlantic nel novembre 2015 (in era pre-Trump dunque) intitolato “Why the Economic Fates of America’s Cities Diverged” (Perché i destini delle città americane hanno iniziato a divergere) Phillip Longmann ha offerto un’accurata riflessione sulle cause dei crescenti divari regionali, in termini di distribuzione della ricchezza e del reddito, negli Stati Uniti: secondo lui, tali divari sono da attribuire alla mancanza di una politica di riequilibrio territoriale come quella che aveva orientato la politica economica federale nei decenni post-bellici, nell’era pre-neoliberale. I divari regionali sono ben evidenziati dai differenziali nei prezzi delle case tra le varie città.
L’elite di città che si sono poste alla testa del technology boom post-recessione hanno visto un’impennata dei prezzi (San Francisco, New York, Boston, Washington, Seattle, in parte Chicago e Los Angeles), mentre quelle che sono rimaste ai margini o del tutto escluse da tale fenomeno (ossia la stragrande maggioranza dei centri urbani americani) hanno avuto mercati immobiliari stagnanti. Queste ultime oggi attirano coloro che non possono più permettersi di vivere nelle città investite dal boom tecnologico. Per la prima volta – Longmann fa notare – gli americani si muovono non più alla ricerca di migliori opportunità di lavoro (cioè di più elevati salari) ma di un luogo più a buon mercato, con più bassi costi della vita, anche se ciò comporta mettere da parte le proprie aspirazioni di mobilità sociale.
Tale fenomeno riflette la dinamica ben illustrata da Michael Hardt e Antonio Negri in Commonwealth: i real estate values, ossia i prezzi immobiliari, sono direttamente proporzionali all’attrattività dei luoghi, in termini di esternalità positive (concentrazione di imprese e università innovative, governi dinamici, servizi efficienti etc.) come le chiamano gli economisti. È quel che abbiamo sotto gli occhi anche qui a Milano, la città italiana dove si osserva meglio il fenomeno della gentrification: l’ad di Starbucks ne ha tessuto nei giorni scorsi le lodi come “città modello”, nel motivare la scelta di aprire la prima sede in Italia della famosa catena di caffetterie.
In queste città d’elite si concentrano le imprese tecnologiche start-up, le comunità di pratiche innovative (i cosiddetti “imprenditori urbani” di nuova generazione: dai citymakers ai fablab), oltreché i servizi rari per le imprese, come avevano mostrato i primi analisti delle città globali già negli anni Novanta (da Saskia Sassen a Peter Taylor).
Nel resto dei centri urbani, si tira avanti, si raccolgono le briciole, covando quella “politica del risentimento” che vediamo esemplificata nell’esplosione del fenomeno del nazional-populismo nelle sue diverse manifestazioni: dai 5 Stelle a Brexit e a Trump. Alcuni teorici della sinistra, come Jodi Dean, autrice di The Communist Horizon, giungono a sostenere l’idea che la sinistra debba smettere di guardare alle grandi città trendy, dove la politica alternativa si è ridotta a pratiche fondamentalmente borghesi come la cura degli orti urbani e la filosofia del cibo a km zero, e debba concentrarsi invece sui piccoli centri, quelli rimasti ai margini dello sviluppo economico, dove appunto si alimenta il rancore sociale.
Ma a livello politico è realistica l’indicazione di Dean? Sempre a proposito degli Stati Uniti c’è un bel libro della politologa Katherine Cramer The Politics of Resentment: Rural Consciousness in Wisconsin and the Rise of Scott Walker (Chicago, 2016) che esplora la cultura del risentimento sociale nelle aree rurali e suburbane del Wisconsin, alla base dell’ascesa del governatore ultra conservatore Scott Walker, dove i repubblicani hanno tradizionalmente una presenza egemonica. È realistico pensare che la sinistra ricominci da questi territori? La spettacolare Women’s March del gennaio scorso ha in realtà mostrato la potenza delle città per quella che Andy Merrifield ha chiamato “politics of encounter”, la crowd politics, la politica della moltitudine diciamo noi che ha avuto nel 2011 il suo momento più alto e che la marcia delle donne ha riportato all’attualità.
Detto questo, vorrei tornare sul punto principale: perché una ristretta elite di città e grandi centri urbani svolge tale ruolo di catalizzatore del progetto di “imprenditorializzazione della società e del sé”, già intuito da Michel Foucault, rappresentato dal fenomeno del tech boom di imprese start-up di cui si diceva e dal connesso fenomeno della sharing economy ufficiale per cui tutti diventiamo un po’ imprenditori di noi stessi (anche se non lo siamo ufficialmente)?
Certamente esistono i fattori immateriali di cui si diceva prima: l’attrattività della location, per dirla in breve. Ma se vogliamo sfuggire a un’analisi meramente socio-culturale del fenomeno, vale a dire basata sui comportamenti e sulle preferenze individuali del consumatore o del lavoratore, che si avvita su se stessa e alla fine asseconda la politica neoliberale dominante, come quella offerta da Richard Florida nel famoso The Rise of the Creative Class (secondo il quale la classe creativa sceglie di vivere nei centri urbani più tolleranti e culturalmente predisposti verso minoranze, talenti e tecnologia), allora dobbiamo volgere il nostro sguardo per l’appunto al platform capitalism di cui si parla nel convegno.
Come ha ben illustrato Nick Srniceck nel suo libro recente sul tema (Cambridge, 2016), il movente essenziale delle imprese capitalistiche di piattaforma è la raccolta di ingenti masse di dati. Le grandi città e aree metropolitane, e in particolare i centri urbani divenuti egemoni nell’immaginario collettivo, funzionano da “laboratori viventi” (living labs) per le imprese chiave della nostra economia: per “i nuovi profeti del capitale”, come li ha chiamati Nicole Aschoff, che parlano da filantropi mentre fanno affari nel nome del “bene comune”.
Per questa ragione, Microsoft e Google approdano nelle favelas di Rio de Janeiro, affermando di voler far emergere il talento imprenditoriale oggi soffocato dalla povertà, distribuendo smartphone agli abitanti e digitalizzando la vita urbana. Per la stessa ragione, Amazon oggi utilizza Seattle per testare i gusti dei consumatori in previsione di una sua esplorazione di nuovi sbocchi di mercato, nel campo del cibo e dell’abbigliamento. Ma lo stesso fanno le imprese start-up.
Ne ho avuto conferma recentemente intervistando il rappresentante italiano di un’impresa start-up francese operante nel campo della mobilità urbana, impegnata ormai da vari anni nell’internet of things, ossia nel rendere connessi gli oggetti alle persone per monitorare i loro spostamenti e le loro forme di vita: «non ci interessano i piccoli centri, ci interessano le grandi città, le metropoli affollate di persone», ha dichiarato. È nelle grandi città che i “profeti del capitale” così come le start up emergenti ritrovano le forme di vita in comune da cui traggono linfa essenziale per il proprio business, oltreché in molti casi l’ambiente istituzionale, sociale e culturale che consente loro di svilupparsi e costruire la propria narrazione di “felicità”.
Il platform capitalism e i collegati fenomeni della smart city e della start-up city in tal senso offrono potente dimostrazione del passaggio, segnalato da Gilles Deleuze poco prima della sua morte, alla scala urbana da una società disciplinare, fondata su meccanismi centralizzati come i “grandi eventi” e i “grandi progetti” (la recente crisi economica e politica brasiliana, all’indomani di Olimpiadi e Mondiali, è una prova della crisi del “mega-evento” come propulsore di sviluppo economico), a una società del controllo fondata sulla dispersione dei meccanismi di coinvolgimento sociale e valorizzazione, ma oggi tenuta insieme dalla rendita del comando capitalistico, in particolare da quello che qui chiamiamo “capitalismo delle piattaforme”.
Vent'anni di lavori di bonifica di un'area preziosa per il futuro della città completamente inutili?Siamo davvero alla vigilia sull'orlo di una catastrofe ecologica? Difficile da credere. la Repubblica, ed. Napoli blog "Orazio post", 2 marzo 2017
E’ veramente difficile non cedere allo sconforto, leggendo le anticipazioni di stampa sulla super perizia commissionata dal Tribunale di Napoli, che doveva dire una parola definitiva sulla conduzione della bonifica di Bagnoli. Le conclusioni cui i periti giungono sono raggelanti: le operazioni di bonifica, anziché migliorare lo stato ambientale dei luoghi, ne avrebbero addirittura compromesso la possibilità d’uso futura, rendendo comunque necessaria una nuova attività di caratterizzazione, di messa in sicurezza, bonifica.
“L’è tutto sbagliato, l’è tutto da rifare”, avrebbe sbrigativamente concluso Bartali. Considerato che le prime attività di caratterizzazione risalgono al 1997, il senso della perizia è che abbiamo perso un ventennio, oltre a una barca di soldi, e la prospettiva è ora quella di ricominciare da capo, rituffandoci in un brutto sogno che non vuole finire mai.
Un incubo che non riguarda solo noi, perché il fallimento di Bagnoli è solo un capitolo di una storia più vasta, se in Italia in un quarto di secolo siamo riusciti a portare a termine meno dell’un per cento delle bonifiche previste nei Siti di Interesse Nazionale. Insomma, le bonifiche sono una pagina nera della storia della Repubblica, e questo fatto merita una riflessione seria, lasciando da parte le fumisterie specialistiche, l’atmosfera esoterica, da iniziati più che da addetti ai lavori, che ammanta solitamente queste cose.
C’è, innanzitutto, una difficoltà di governance, perché le competenze alla fine sono distribuite lungo tutta la filiera istituzionale, dallo Stato centrale al Comune, e la cooperazione tra i diversi organi dell’Amministrazione non è mai stato il nostro forte, con una inclinazione piuttosto al rimbalzo di responsabilità. In più c’è l’instabilità istituzionale: nella pluridecennale vicenda di Bagnoli si sono succeduti quattordici governi centrali, cinque amministrazioni regionali, e quattro diversi sindaci, con momenti di stallo e incomunicabilità che si sono pure verificati, soprattutto quando ai diversi livelli sedevano amministrazioni di differente segno politico.
A complicare ulteriormente le cose, c’è stata poi l’evoluzione legislativa, nel caso di Bagnoli le leggi di riferimento sono cambiate ben due volte, con la difficoltà, che si è puntualmente verificata, di dover decidere se e come adeguare i piani di bonifica, faticosamente approvati in conferenza dei servizi, alle nuove regole e ai nuovi standard.
Esiste poi senz’altro un problema di comunicazione e partecipazione pubblica, che alla fine conta, e fa la differenza. Nei paesi che queste cose le sanno fare, con approccio sobrio e in tempi rapidi, proprio la consapevolezza della delicatezza di questo tipo di operazioni, che toccano nel vivo interessi economici rilevanti, ma anche la vita dei cittadini, il diritto alla salute, la qualità degli ambienti di vita, spinge le amministrazioni a sollecitare la partecipazione pubblica, con la produzione di rapporti periodici sullo stato di avanzamento dei lavori, la possibilità di visitare i cantieri, tutte cose che rafforzano la credibilità e la fiducia nelle istituzioni, e che aiutano gli stessi attuatori a non smarrire la rotta. A Bagnoli tutto questo è mancato, l’area è stata di fatto negata alla città per un lungo ventennio, il muro di cinta ha funzionato da limite invalicabile, e nessun racconto, nessun rendiconto è stato fatto alle comunità, con l’effetto di alimentare il disamore, la diffidenza, il distacco.
Ora, con la super perizia, sembra giunto il momento della verità, della resa dei conti. Come altre volte è successo in Italia, la risposta di ultima istanza ad un fallimento politico-amministrativo è di tipo giudiziario, ma anche qui bisogna mantenere i nervi saldi, e intendersi. Perché dopo una lettura attenta della perizia, e della minuziosa ricostruzione tecnico-amministrativa che essa contiene, è possibile e doveroso sottoporre le conclusioni cui giungono gli esperti ad un vaglio critico, con tutto il rispetto dovuto al poderoso lavoro svolto.
Tra le diverse cose che i periti hanno fatto, c’è stato lo scavo e il campionamento di quindici trincee nelle aree funzionali del Parco dello Sport e del Parco urbano, con il prelievo di una quarantina di campioni di suolo. Ebbene, il 90% dei campioni prelevati nel Parco urbano, e il 45% dei campioni prelevati nel Parco dello Sport, hanno evidenziato un contenuto di inquinanti organici (IPA e idrocarburi nel Parco urbano, IPA e PCB nel Parco dello Sport), superiori agli obiettivi di bonifica che erano stati previsti. Questo sia nello strato profondo, di riempimento con materiali più grossolani, sia nello strato superiore, a granulometria più fine, servito a ricostruire il suolo superficiale.
Sulla base di questi dati, gli esperti giungono alla conclusione che “… gli interventi di bonifica certificati, così come realizzati abbiano compromesso la futura fruibilità dei luoghi, perlomeno quelli a destinazione d’uso residenziale, arrivando talora a incrementare le concentrazioni esistenti prima della bonifica. Tale compromissione determina la necessità di una nuova attività di caratterizzazione e di bonifica/messa in sicurezza, finalizzata a rendere tali luoghi a tutti gli effetti conformi ai sensi di legge, nei termini di un’analisi di rischio”.
Ora, se è senza dubbio deprecabile il fatto che una bonifica costosa e complessa non abbia condotto, foss’anche solo nei punti di campionamento interessati dalla perizia, alla risoluzione dei problemi iniziali di contaminazione, è sul giudizio netto di “compromissione dei luoghi” che non è possibile essere d’accordo, proprio perché, alla luce della procedura prevista dalla legge, esso può essere legittimamente espresso solo dopo aver realizzato ad un’analisi di rischio sito-specifica, la stessa chiamata in causa dai periti, i quali però, nell’ansia di giungere comunque a un verdetto netto e definitivo, sembrano incorrere in un curioso loop logico.
Quello che si vuole affermare è che “compromissione dei luoghi” significa una cosa ben precisa, e cioè che quei luoghi non possono essere utilizzati dalle persone in condizioni di sicurezza, senza che ci siano ragionevoli rischi per la salute, dovuti all’esposizione concreta a sostanze pericolose, per contatto, inalazione o ingestione. Per sapere questo occorre l’analisi di rischio.
Resta il fatto, che i dati epidemiologici di scala comunale, pure citati dalla perizia, dicono che la mortalità per tumore è più bassa a Bagnoli che nel resto della città, mentre le analisi effettuate dall’ABC hanno evidenziato come le acque di falda risultino pulite anche a monte della barriera idraulica, e questa è la migliore conferma che i potenziali contaminanti presenti nei suoli hanno una bassissima mobilità, e non se ne vanno in giro per l’ambiente.
Alla fine, anche la perizia deve riconoscere, seppur con formula involuta, che “non sono emersi elementi che ci permettano di concludere con certezza che esiste un rapporto fra inquinamento ed eventuale danno alla salute nel caso specifico, poiché mancano dati epidemiologici e dati di monitoraggio biologico, che esprimono la reale dose assorbita.”
Insomma, se sono stati fatti errori devono essere perseguiti, ma l’insieme delle cose che oggi sappiamo su Bagnoli ci dice che, per grazia di Dio, la catastrofe ecologica e il disastro ambientale, non abitano qui. E’ un pezzo di città da mettere a posto, ed è a questo punto assolutamente necessario che le attività di caratterizzazione e analisi del rischio, recentemente decise nel tavolo istituzionale tra Governo, Regione e Comune, procedano il più velocemente possibile, per dare risposta ai dubbi e alle inquietudini che la perizia ha lasciato in sospeso.
 «Quali forme e funzioni alternative a quelle puramente decorative possono essere immaginate per le aree verdi che fanno parte dello spazio pubblico e come esse possono adattarsi ai bisogni e alle diverse modalità di fruizione della città?» Millennio urbano, 1 marzo 2017 (c.m.c.)
«Quali forme e funzioni alternative a quelle puramente decorative possono essere immaginate per le aree verdi che fanno parte dello spazio pubblico e come esse possono adattarsi ai bisogni e alle diverse modalità di fruizione della città?» Millennio urbano, 1 marzo 2017 (c.m.c.)
Una filosofia del verde urbano è questione seria ed essa ha innanzitutto bisogno di un glossario per inverarsi sia nella sua declinazione amministrativa che nella percezione collettiva della parte non edificata delle città. Vale la pena tornare quindi sulla polemica delle palme messe a dimora nelle aiuole di piazza del Duomo a Milano e farlo a partire da alcuni concetti sulla cui confusione spesso indugiano gli amministratori.
Partiamo quindi dalla nozione di giardino pubblico, al quale appartiene l’aiuola che di esso è una versione spazialmente limitata e preclusa alla pubblica fruizione. Sorvoliamo qui sulla storia dell’apparizione dei giardini pubblici nello spazio urbano per concentrarci solo un attimo sui loro aspetti progettuali e sulle relazioni di questi ultimi con gli elementi naturali.
Rispetto allo scandalo delle palme a Milano ciò che qui interessa sottolineare è che i giardini, in ogni loro forma e manifestazione aiuole comprese, sono un consolidato esempio di globalizzazione botanica e l’arte della composizione delle differenti specie vegetali ha storicamente cercato di essere qualcosa di distinto dalla rappresentazione della natura circostante. Segno di questo scostamento dalla imitazione della natura può essere colto da ciò che scriveva nel 1838 lo scozzese John Claudius Loudon in The Suburban Garden. Piantare alberi e arbusti non autoctoni era l’unico modo per fondare un’arte del giardinaggio altrimenti impossibile, dato che la semplice imitazione della natura non ha di per sé qualità artistiche. A partire dalla metà del XIX secolo il principio dello stile gardenesque, che ha influenzato tanto i giardini privati quanto quelli pubblici, si è andato via via consolidando come un vasto repertorio di piante esotiche.
Di esse fanno parte le palme cinesi (Trachycarpus fortunei) piantate nell’aiuola tripartita di piazza del Duomo che hanno stupidamente fatto gridare all’africanizzazione di Milano. A ragione il progettista del recente allestimento sponsorizzato da Sturbucks ha affermato che non c’è da meravigliarsi dell’uso delle palme e dei banani, perché soprattutto le prime, nella versione cinese climaticamente più adattabile, sono presenti da oltre un secolo anche nei giardini lombardi. L’esotismo della composizione vegetale, che sta per essere completata di fronte al monumento che di Milano è il simbolo, non ha quindi di per sé nulla di scandaloso ed è una solenne stupidaggine rivendicare il primato delle piante autoctone negli allestimenti delle aiuole.
Eppure nel precedente allestimento della piccola area verde di piazza del Duomo, realizzato grazie ad un differente sponsor nel 2014, un insieme di alberi, arbusti e piante erbacee “autoctone della pianura Padana” aveva sostituito i “fiorellini laccati e cavolfiori ornamentali nel luogo simbolo di Milano”. “ La natura entra in città. E lo fa dalla porta principale”, era la perentoria affermazione che accompagnava la descrizione giornalistica della nuova filosofia milanese del verde urbano, che«non asseconda il gusto del momento con fiori che durano una stagione, ma preferisce specie perenni, nella loro forma spontanea, che rappresentano il territorio».
Qui sta lo scandalo, almeno nel significato etimologico di inciampo: solo tre anni fa l’obiettivo era la rinaturalizzazione delle aree verdi, con conseguente risparmio sui costi di gestione, e ora si dà via libera ad una interpretazione decisamente artificiale dell’aiuola che fa parte della pavimentazione della piazza simbolo di Milano. Quanta confusione, quindi, tra i carpini del 2014 e le palme del 2017, riguardo la funzione ecosistemica e simbolica del verde urbano.
Le palme dello scandalo, al di là del dibattito sul valore estetico del nuovo allestimento dell’aiuola, potrebbero fornirci l’occasione per interrogarci sulla funzione di quel fazzoletto di verde non fruibile a chiusura di una piazza che è ormai anche uno dei centri nevralgici dei flussi turistici globali. Rispetto poi al fatto che non vi è dubbio che un’aiuola abbia eminentemente una funzione ornamentale c’è però da chiedersi cosa significhi questa infinitamente piccola mimesi della estremamente grande diversità botanica del pianeta modificata ogni tre anni per iniziativa dello sponsor di turno con l’alternanza di flora locale e globale. Quali forme e funzioni alternative a quelle puramente decorative possono invece essere immaginate per le aree verdi che fanno parte dello spazio pubblico e come esse possono adattarsi ai bisogni e alle diverse modalità di fruizione della città?
A questo riguardo una riflessione può essere fatta a partire dalla foto del 1943 che fa da testata a questo articolo. Durante l’ultima guerra la necessità di trovare spazi per la produzione di cibo in una città ridotta alla fame non aveva risparmiato l’aiuola di piazza del Duomo, dove al posto delle piante ornamentali fu seminato il grano. In anni più recenti Renzo Piano e Claudio Abbado avevano pensato a quell’area per mettere a dimora una piccola parte dei 90.000 alberi che avrebbero dovuto costituire il rimedio principale ai mali ambientali di Milano secondo la provocatoria proposta del grande direttore d’orchestra.
Essa aveva sicuramente il pregio di considerare il verde urbano molto al di là della funzione decorativa da mero compendio vegetale delle composizioni architettoniche tipico della tradizione Beaux-Art. Tra la decorazione vegetale, la produzione di cibo e la valenza ecosistemica si snoda tutta l’indeterminatezza del concetto di verde urbano, che include una certa quantità di usi diversi del suolo: dalle aiuole spartitraffico alle aree agricole e boschive interne alla città, passando per i parchi pubblici, le aree cani, i giardini privati e persino le terrazze e i balconi.
Il passaggio dalla gestione pubblica a quella sponsorizzata di quella porzione di verde urbano rappresentata dall’aiuola di piazza del Duomo dovrebbe quindi farci riflettere su quanto sia fondato continuare a considerarla tale. Tanto le piante autoctone quanto quelle esotiche vengono temporaneamente messe a dimora in una scenografia di elementi vegetali che diventa un episodio del paesaggio urbano. Se la sua funzione è simile a quella che hanno le fioriere sui balconi degli edifici, essa avrà necessariamente poco a che fare con il concetto di “area verde” inteso come spazio non edificato e non impermeabilizzato.
Se è così lo scandalo delle palme non deve sorprendere, ma invece deve meravigliare la confusione che regna sul concetto di verde urbano. Esso viene continuamente sbandierato come elemento cruciale di concetti quali la sostenibilità, la resilienza e l’equità sociale delle città, finendo così per far parte della ulteriore confusione che attorno ad essi gravita. Spesso utilizzato per operazioni di creazione preventiva del consenso delle politiche pubbliche, esso viene infine assimilato all’idea di bene comune che piace tanto agli amministratori in virtù della sua genericità.
Se si vuole affrontare seriamente una nuova filosofia del verde urbano che lo sottragga innanzi tutto alla mera funzione decorativa, diventata economicamente insostenibile per le casse pubbliche, si deve prioritariamente far uscire il concetto dalla vaghezza con il quale lo si evoca quando di mezzo ci sono questioni importanti come il rapporto tra pubblico e privato nella gestione delle città.
Riferimenti
L. De Vito,Orti perenni e prati fioriti la nuova filosofia del verde inizia da piazza Duomo, La Repubblica, 4 luglio 2014.

L'incredibile vicenda del parere di una commissione per la valutazione d'impatto ambientale che è positivo nonostante ci siano 142 (centoquarantadue) cose che non vanno nel progetto presentato. Fuori i nomi! La Città invisibile, 27 febbraio 2017 (c.m.c.)
L’aeroporto di Firenze e l’insostenibile leggerezza del Master Plan
In attesa che il prossimo 10 marzo, con la presentazione del progetto per il nuovo stadio di Firenze, il Sindaco Nardella annunci finalmente dove e come saranno localizzate e distribuite le funzioni di cui si parla oramai da tempo immemorabile (mercafir, stadio, aeroporto), ho pensato di leggere (attentamente) le 216 pagine del parere della Commissione nazionale di VIA sull’aeroporto di Firenze e mi permetto di giudicarle un mero esercizio di equilibrismo terminologico e dialettico.
Partendo dalla doverosa ricostruzione degli aspetti amministrativi del procedimento, il documento riporta l’elenco delle osservazioni (analizzate e contro dedotte in sede istruttoria) e, prendendo atto dei pareri del Mibac e della Regione Toscana e del pronunciamento del TAR (attraverso la sentenza 1310/2016 su questioni di merito poste da ricorrenti), si dilunga in una approfondita descrizione dei contenuti dei tre quadri di riferimento (programmatico, progettuale e ambientale) in cui è suddiviso lo studio di impatto ambientale presentato dal proponente.
L’istruttoria si conclude con l’espressione del parere positivo della Commissione condizionato dall’ottemperanza di 62 prescrizioni, a loro volta contenenti circa 80 sub-prescrizioni, per un totale quindi di circa 142 indicazioni obbligatorie ai fini della realizzazione dell’intera opera.
Rispetto all’abnorme numero di “condizioni” a cui è sottoposto il progetto dell’aeroporto di Firenze, prima di commentarne i contenuti, vorrei ricordare quanto già dichiarato in occasione di una precedente riflessione relativa allo stesso argomento, e cioè che, in tema di valutazioni ambientali, vi è un rapporto inversamente proporzionale tra la qualità del progetto e il volume del quadro prescrittivo elaborato dall’autorità competente per la valutazione: a forti carenze del progetto e dello studio di impatto tende a corrispondere un alto numero di prescrizioni, finalizzate a sopperire a quanto non è stato approfondito nella proposta.
Se, di per se, non bastasse a generare preoccupazione il dato numerico (partendo dalla constatazione che 142 prescrizioni sono, a tutti gli effetti, una “bocciatura mascherata” dell’iniziativa), la conferma dell’irrealizzabilità dell’aeroporto (almeno allo stato attuale delle conoscenze) emerge chiaramente dal “peso” di alcune prescrizioni.
Il particolare mi soffermo sui temi più rilevanti, citandone i contenuti e commentandone le conseguenze.
Rischio di incidente aereo
Con la prescrizione n. 3 la Commissione ha imposto la redazione di «uno studio riferito agli scenari probabilistici sul rischio di incidenti aerei considerato anche l’uso esclusivamente monodirezionale della pista … Lo studio dovrà essere redatto da soggetto terzo pubblico con esperienza per la previsione del rischio degli incidenti aerei mediante modelli di calcolo. Lo studio dovrà descrivere e quantificare i possibili rischi per la salute umana e per l’ambiente…. con la stima dei danni materiali attesi … Lo studio dovrà anche individuare le misure … per eliminare o ridurre il danno, misure inclusive della delocalizzazione delle preesistenze qualora emerga un rischio per la perdita di vite umane …».
Dunque, il proponente, prima che il Ministro delle infrastrutture approvi definitivamente l’opera, dovrà rivolgersi ad un organismo pubblico al quale sarà dato l’onere di descrivere il rischio di incidente aereo, perché tale imprescindibile analisi non ha fatto parte della documentazione presentata, pur trattandosi di un tema quale la perdita di vite umane, la cui rilevanza credo sia inoppugnabile.
Stante tutto ciò, mi chiedo quale credibilità possa avere un parere espresso in assenza di elementi di tale importanza, in grado di condizionare, qualora correttamente evidenziati, la stessa realizzabilità del progetto.
Stabilimenti a rischio di incidente rilevante presenti nell’intorno aeroportuale
Con la prescrizione n. 4, la Commissione, così come per la prescrizione n. 3, certifica un’altra sostanziale carenza progettuale, riferita alla necessità di evidenziare «… la probabilità di accadimento di un impatto aereo sugli stabilimenti circostanti l’aeroporto, in particolare su quelli classificati dalla Direttiva Seveso come a rischio di incidente rilevante. Questa stima sarà finalizzata a valutare tutti i possibili effetti domino o di amplificazione e a definire idonee procedure di sicurezza …».
Valgono per questo argomento le stesse considerazioni fatte al punto precedente, ricordando – quindi – che attualmente nulla si sa del rapporto tra le modalità di sorvolo del territorio e le attività insediate.
Terre e rocce da scavo
L’Argomento, per Firenze, è delicato, visti i precedenti relativi alla TAV (tra l’altro ancora non risolti a 5 anni dalle indagini della magistratura).
La prescrizione n.8 sub c), conclude dichiarando «La presentazione del Piano di utilizzo [delle terre e rocce da scavo] al MATTM (art. 5 DM 161/2012) è condizione necessaria alla preventiva autorizzazione alla realizzazione di qualsiasi opera prevista …».
Tale condizione è totalmente in contrasto con i contenuti dello stesso art. 5 del DM 161/2012 citato, che impone invece (opportunamente) la presentazione del Piano di utilizzo «… prima dell’espressione del parere di valutazione ambientale», e non prima dell’autorizzazione alla realizzazione.
La questione – tra l’altro – era già stata trattata nel parere VIA della Regione Toscana, ove si dichiarava l’illegittimità del procedimento, proprio con riferimento alla mancanza tra i documenti del richiamato Piano di utilizzo.
E’ quindi del tutto incomprensibile come la Commissione, in totale difformità dalla legge, abbia potuto rimandare ad una fase procedimentale successiva alla VIA la presentazione di un elaborato la cui importanza è legata anche ai quantitativi in gioco (oltre 3 milioni di mc di terre, o altro che dovranno essere rimosse e/o trattate).
Valgono- purtroppo – anche per questo argomento le stesse considerazioni in merito alla attendibilità di un giudizio di compatibilità ambientale, che più che a uno strumento di tutela da eventuali impatti sembra assomigliare ad una cambiale da scontare.
4) Fosso reale: attraversamento autostrada A11
Con la prescrizione n. 29 si impone al proponente, in sede di progettazione esecutiva, di “sviluppare la soluzione di attraversamento della autostrada A11 …. risolvendo la problematica tecnica evidenziata nel parere del Genio Civile di Bacino Arno …”.
Nella sostanza la Commissione è costretta a constatare che il progetto, relativamente alle opportune modifiche al Fosso reale per consentirne il passaggio sotto il rilevato autostradale in assoluta sicurezza, non individua soluzioni accettabili, ma ciò non ha impedito alla Commissione stessa di esprimersi favorevolmente anche con riferimento agli aspetti idraulici, seppure attribuendo ad elaborazioni da presentare nella successiva fase autorizzativa l’onere di trovare soluzioni alla problematica.
Alla luce di tali gravi carenze progettuali (alle quali si devono aggiungere molte altre che non cito), le imbarazzanti conclusioni del parere sono totalmente contrarie ai principi che regolano le procedure di valutazione, e inducono a delegittimare – di fatto – il ruolo stesso della Commissione (e la finalità per cui è stata istituita), minandone la credibilità e producendo il solo effetto di allontanare ancor di più i cittadini dalle istituzioni.
Per essere più chiaro e diretto potrei dire che la fiducia riposta – oggi – nel lavoro della Commissione è la stessa che ognuno di noi avrebbe nei confronti di un meccanico che giudica le prestazioni di una automobile senza conoscerne le caratteristiche, o di uno chef che commenta una pietanza senza averla assaggiata.
Sarebbe l’ora che tutto questo finisse, che ognuno tornasse a fare il proprio mestiere (in scienza e coscienza): che chi è chiamato a valutare lo facesse in autonomia e chi deve decidere evitasse di cercare sempre compiacenti coperture.
I virtuosi comportamenti che dovrebbero caratterizzare le azioni quotidiane di tutti coloro che operano per il bene della società furono rappresentati già sette secoli fa da Ambrogio Lorenzetti nell’allegoria del “Buon governo”, ma, a quanto pare, perché tutto ciò entrasse nel sentire comune, non è bastato fissarlo su un muro.
P.S. Dei 48 membri della Commissione VIA, 35 hanno sottoscritto il parere e 10 sono risultati assenti. Tre sono i membri che hanno espresso un parere contrario: chapeau!
 «I prefabbricati sono costati 6,5 milioni, cade l'idea di usarli per allestire un villaggio della solidarietà e ospitare i senzatetto, dopo il no netto della Regione alla possibilità di utilizzarli per i profughi. Verrà ceduto a chi paga le spese per smontarlo». la Repubblica, ed Milano, 27 febbraio 2017 (p.s.)
«I prefabbricati sono costati 6,5 milioni, cade l'idea di usarli per allestire un villaggio della solidarietà e ospitare i senzatetto, dopo il no netto della Regione alla possibilità di utilizzarli per i profughi. Verrà ceduto a chi paga le spese per smontarlo». la Repubblica, ed Milano, 27 febbraio 2017 (p.s.)
E anche l'ultimo tentativo del Comune di "salvare" il campo base di Expo trasformandolo in un "villaggio dell'accoglienza " per sfrattati e senzatetto è fallito. Alla fine Palazzo Marino si è arreso. Con l'assessore alle Politiche sociali Pierfrancesco Majorino che accusa la Regione di «atteggiamento ottuso». Il motivo? «Finora non ci hanno risposto: mi pare evidente che non vogliano aiutarci e a questo punto non possiamo perdere più tempo ». Corsa terminata, si torna alla casella di partenza. E al bando che i liquidatori di Expo spa pubblicheranno già in questi giorni. Obiettivo: vendere al miglior offerente, che dovrà anche smontarle a proprie spese, le palazzine prefabbricate con 576 alloggi, ma anche uffici, un edificio utilizzato come mensa e un magazzino.
Sembra una storia senza fine, quella dell'ex campo base. Una piccola città sorta a Rho, a un chilometro in linea d'aria dal sito, per accogliere durante la corsa contro il tempo del cantiere gli operai che hanno costruito i padiglioni e, durante i sei mesi dell'Esposizione, le forze dell'ordine che hanno vigilato sull'evento. Una sorta di Fortezza Bastiani, poi. Rimasta intrappolata dalle polemiche politiche, come quelle che hanno diviso i partiti e le istituzioni sulla possibilità di accogliere i migranti.
Un "no" alla presenza dei profughi, che la Regione ha continuato a ribadire. Ricordando come gli accordi originari tra Expo spa e il Comune di Rho imponessero lo smantellamento delle costruzione e la trasformazione dell'area in una zona verde. Il Comune con questo ultimo tentativo avrebbe voluto utilizzare gli spazi per l'emergenza abitativa. «Ma anche in questo caso - dice Majorino - se Regione lo avesse chiesto, non avremmo mai potuto accettare un vincolo discriminatorio che escludesse persone senza casa di origine straniera».
Un rischio concreto, per il Comune. Che alla fine ha abbandonato l'idea. Passando a quello che l'assessore chiama "il piano B". Eccolo: «Gli alloggi per 300 persone che in via Lombroso dovevano restare in piedi per qualche settimana saranno aperti per sei mesi. Se quell'area dovesse servire, poi, discuteremo con Sogemi (la società comunale che gestisce l'Ortomercato, ndr) per trovarne un'altra in zona».
A questo punto, però, il progetto si allargherà e sarà destinato non solo a clochard, ma anche «a persone senza casa e a richiedenti asilo». E il campo base? Dopo quasi due anni dall'inizio di Expo, andrà all'asta. Con i liquidatori che già lo scorso novembre avevano preparato il bando e hanno la necessità di "valorizzare i cespiti aziendali". Si prova almeno a risparmiare i 2,2 milioni che servirebbero per smontare tutto. E a non buttare via beni pagati con soldi pubblici: i prefabbricati hanno un valore di 6,5 milioni e in tutto, tra recinzioni e fondamenta, ne sono stati spesi 9 per far sorgere il villaggio.
Il bando dovrebbe essere pubblicato già domani e le eventuali offerte potranno essere presentate fino al 31 marzo. Expo spa si rivolge a «enti pubblici e a operatori economici e non», come "società e associazioni". Potranno acquistare il campo base a pezzi. A parte i tre moduli che la Regione ha voluto destinare alle popolazioni colpite dal terremoto, tutto il resto va sul mercato. A cominciare dalle 16 palazzine su tre livelli, con 576 camere: ognuna, grande otto metri quadrati, ha un bagno privato, l'aria condizionata ed è arredata.
Nel giorno dell'assegnazione degli Oscar, vi raccontiamo una storia di un cinema abbandonato. Ha un lieto fine, per quanto provvisorio e affidato esclusivamente alla buona volontà dei cittadini. (m.b.)
A Catania, da qualche mese, è stato occupato il vecchio cinema San Cristoforo-Midulla, ristrutturato negli anni novanta come centro polifunzionale grazie ai fondi speciali del programma "Urban", e poi abbandonato per mancanza di risorse ordinarie. E' una storia piuttosto comune, nel sud Italia e non solo, provvisoriamente a lieto fine grazie all'iniziativa della cittadinanza attiva.
Sul sito del Labsus (Laboratorio di sussidiarietà) potete conoscere i dettagli dela storia dell'ex Cinema Midulla. Sul sito degli Attivisti per il Medulla trovate il resoconto delle cose fatte nel primo mese di attività.
Nota
A Pistoia, durante la scuola di eddyburg, parleremo delle strutture culturali di prossimità. Proveremo a capire se e in che modo, attraverso i piani urbanistici e l'iniziativa delle amministrazioni locali, si possano scrivere storie a lieto fine, possibilmente senza passare attraverso ristrutturazioni effimere, chiusure e degrado, occupazioni con o senza sgomberi. A seguire, si svolgeranno i quattro giorni di incontri pubblici dell'iniziativa Leggere la città, quest'anno dedicata al tema Cultura è comunità. Sul sito della scuola, sono disponibili le informazioni per partecipare. Vi aspettiamo (m.b.).
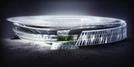 Prosegue il bailamme. Una cosa è chiara: hanno perso tutti. Articoli di Mauro Favale, Marina della Croce, Giuliano Santoro, da la Repubblica/Roma e il manifesto, 26 febbraio 2017 (c.m.c.)
Prosegue il bailamme. Una cosa è chiara: hanno perso tutti. Articoli di Mauro Favale, Marina della Croce, Giuliano Santoro, da la Repubblica/Roma e il manifesto, 26 febbraio 2017 (c.m.c.)
la Repubblica/Roma
STADIO: PRIMA PIETRA NEL 2017
MA LA REGIONE AVVISA RAGGI «SERVE UNA NUOVA DELIBERA»
di Mauro Favale
«“Spieghino dove sta la pubblica utilità. Vigileremo su trasporti e ambiente” La Lazio torna alla carica: “Ora un impianto anche per noi. E non al Flaminio”»
Virginia Raggi, l’altra sera, al termine dell’incontro, ha chiamato Nicola Zingaretti per avvisarlo dell’accordo con la Roma. Ieri, però, l’assessore regionale ai trasporti, Michele Civita, ha sottolineato come, per ora, «non si conoscono le opere e le infrastruture per garantire la mobilità, il miglioramento dell’ambiente e della qualità urbana.
Su tutto ciò la Regione eserciterà il ruolo e la funzione di sua competenza ». E non solo: mentre è scontato che la conferenza dei servizi subisca un nuovo slittamento di 30 giorni (stavolta su richiesta della Roma), sempre la giunta Zingaretti avvisa il Campidoglio che, sebbene consideri l’accordo «una buona notizia perché fa compiere un importante passo in avanti e supera le incertezze degli ultimi 7 mesi», è comunque necessaria una nuova delibera da approvare in Aula Giulio Cesare.
«L’attuale conferenza dei servizi — ricorda Civita — è incardinata sulla delibera approvata dal consiglio comunale che ha riconosciuto il pubblico interesse al progetto presentato nel 2014. Se il progetto cambia bisognerà richiedere una nuova valutazione tecnica e un nuovo pronunciamento da parte dell’Aula». A questo servirà il mese in più, prima della riapertura della conferenza dei servizi, il 3 aprile e non più il 3 marzo.
Entro quella data, la maggioranza dovrà approvare il nuovo atto che autorizza la costruzione a Tor di Valle 500 mila metri cubi anziché il milione previsto inizialmente. Comunque 5 volte in più rispetto al piano regolatore. «Abbiamo condotto il lavoro con fermezza e compattezza», rivendica il capogruppo M5S in Comune Paolo Ferrara.
Silenziato il dissenso interno, con la deputata Roberta Lombardi, spesso critica, che rende merito a Virginia Raggi: «Stracciato il progetto iniziale — scrive su Twitter — dimezzate le cubature extra-stadio. Nessun grattacielo. Questo è uno stadio fatto bene. Brava Virginia». E pazienza se nel nuovo disegno il ponte sul Tevere e la bretella sulla Roma- Fiumicino verranno realizzate in un secondo momento rispetto all’arena. Restano, invece, le opere di messa in sicurezza del fosso di Vallerano, gli interventi sulla via del Mare e il potenziamento della Roma-Lido.
Il giudizio di Legambiente rimane molto critico: «Si conferma l’errore dell’area scelta, che rimarrà irragiungibile con la metropolitana». Negativa anche la posizione di Verdi e Radicali. Il Pd, invece, si dice soddisfatto ma chiede che la giunta chiarisca «iter amministrativo, impegni finanziari e opere pubbliche». E mentre l’iter del vincolo sulle tribune dell’Ippodromo va avanti (superabile, con ogni probabilità, dal parere unico dello Stato in Conferenza dei servizi), anche la Lazio chiede «par condicio» per la costruzione del suo stadio. Lo fa per bocca del suo presidente Claudio Lotito che però avverte la giunta di «non ricorrere allo stratagemma dello Stadio Flaminio che non ha alcun requisito e condizione oggettiva per essere lo stadio della Lazio».
il manifesto
STADIO «IRRAGGIUNGIBILE».
I TIMORI DI AMBIENTALISTI E REGIONE LAZIO
di Marina Della Croce
«Calata di cemento. Le infrastrutture dovrebbero essere realizzate in tempi diversi ma per ora non c’è alcuna certezza. La Pisana: "Controlleremo"»
Il fischio di inizio della prima partita nel nuovo stadio della Roma a Tor di Valle è fissato per il 2020. Resta da capire se quel giorno i tifosi potranno sostenere la propria squadra del cuore dagli spalti oppure no. Come sarà possibile raggiungere il nuovo impianto è infatti uno dei punti ancora da chiarire dell’accordo siglato la scorsa sera in Campidoglio. «Forse in funivia», ha ironizzato ieri l’esponente del Pd romano Giovanni Zinola.
Il taglio delle opere pubbliche concesso dalla sindaca Virginia Raggi rischia infatti di mandare definitivamente in tilt un’area della città già pesantemente congestionata dal traffico. Qualche chiarimento in più dovrebbe essere contenuto nella nuova delibera che la maggioranza capitolina dovrà approvare una volta che il documento sarà stato esaminato dagli uffici competenti, e che andrà a sostituire quella varata dalla precedente amministrazione guidata da Ignazio Marino. Il tutto dovrebbe avvenire nell’arco di un mese ma nel frattempo va avanti l’iter del vincolo sull’ippodromo di Tor di Valle avviato dalla soprintendenza.
L’accordo raggiunto prevede infatti la realizzazione di opere per complessivi 500 mila metri cubi, la metà del milione di metri cubi contenuti nel progetto precedente ma molti di più rispetto ai 350 mila previsti dal piano regolatore dell’area. La legge sugli stadi esclude però dal conteggio la struttura sportiva e gli spogliatoi, rendendo così fattibile il progetto che comunque non comprende più a realizzazione delle tre torri previste inizialmente.
Il problema riguarda le infrastrutture che verranno realizzate. Un particolare che preoccupa anche la regione lazio. «Mentre è stato detto chiaramente che le attuali cubature saranno ridotte in modo significativo – ha detto l’assessore regionale Michele Civita annunciando controlli – non si conoscono a oggi le opere e le cubature che l’accordo reputa indispensabili per garantire la mobilità sia pubblica che privata, i miglioramento dell’ambiente e della qualità urbana, decisivi per lo sviluppo sostenibile di quel quadrante della città».
In realtà ieri qualche particolare in più dell’accordo si è saputo, non abbastanza però da rendere ingiustificate le preoccupazioni espresse finora. Secondo quanto si è appreso, infatti, il piano di opere pubbliche dovrebbe essere realizzato in due fasi. Le opere propedeutiche allo stadio, e quindi da realizzare subito, sarebbero il potenziamento della Roma-Lido, gli interventi sulla via del Mare e la messa in sicurezza idrogeologica del fosso di Vallerano, nell’area di Decima.
In seguito, ma non è specificato quando, dovrebbero essere realizzati il ponte aggiuntivo sul Tevere e la bretelle sulla Roma Fiumicino. Salta il prolungamento della metropolitana B, al quale i 5 Stelle si sono sempre detti contrari. «Resta in piedi la farsa del raddoppio della via del Mare, solo per il breve tratto iniziale, che aumenterà l’effetto imbuto gravando pesantemente sulla viabilità», ha spiegato ieri l’urbanista Raimondo Grassi. «Quanto alla stazione di Tor di Valle anche qui si prendono in giro i romani: la stazione già esiste ed è attualmente oggetto di riqualificazione».
Preoccupazioni espresse ieri anche da Legambiente, per niente convinta dell’area scelta per realizzare l’opera. «Rimarrà irraggiungibile con la metropolitana, visto che il progetto sembra finanziare solo la riqualificazione della stazione di Tor di Valle, ma continueranno a passare solo i vecchi treni di una linea che funziona malissimo e non emerge alcun finanziamento pubblico che preveda il potenziamento della linea», ha spiegato il vicepresidente nazionale Edoardo Zanchini.
La firma dell’accordo è servita almeno a riportare una pace apparente in casa grillina. «brava@virginiaraggi» ha scritto ieri in un tweet Roberta Lombardi, non proprio un’amica della sindaca. «Abbiamo dimostrato che quando lo Stato fa lo Stato non si inchina davanti ai costruttori, ai palazzinari. Lo stadio d farà, ma si farà secondo le nostre regole», ha esultato invece il vicepresidente della Camera Luigi Di Maio guardandosi bene però dal rispondere alle preoccupazioni di quanti si interrogano sul futuro di Tor di valle.
Intanto, come era prevedibile, adesso anche la Lazio reclama un suo impianto. «Cara sindaca raggi – ha fatto sapere ieri il presidente Claudio Lotito – ci aspettiamo che applichi par condicio nei confronti degli innumerevoli tifosi biancocelesti e consenta la creazione di un nuovo impianto della Lazio»
il manifesto
RAGGI-PARNASI,
«UN COMPROMESSO CHE HA IL SAPORE DELLA SCONFITTA»
di Giuliano Santoro
«I malumori della base grillina. L’accordo verbale annunciato dalla sindaca non soddisfa molti consiglieri comunali»
Dopo l’annuncio di Virginia Raggi sullo stadio della Roma a Tor di Valle con (ridotta) cementificazione annessa, tutti aspettano di vedere concretamente in cosa consiste il ridimensionamento delle cubature. Tra addetti ai lavori, attivisti e tecnici, il leit motiv è uno solo, scandito con mal celata disillusione: «Bisogna vedere le carte, al momento c’è solo un accordo orale».
Dalla base del m5s,la stessa che nei giorni scorsi aveva manifestato in Campidoglio contro l’intesa e che aveva costretto Beppe Grillo fino alla quasi negazione di ogni margine di trattativa, trapelano motivi di amarezza, quando non di risentimento. Il gruppo del Movimento 5 Stelle al municipio VIII, quello interessato dalla grande opera, aveva annunciato un incontro assieme al Comitato contro il cemento a Tor di Valle e alla Carovana delle periferie. Mestamente, quell’assemblea è stata annullata. «Non c’è più motivo di discutere pubblicamente, almeno per adesso – ci spiegano – Di sicuro, al momento pare proprio che comandino sempre gli stessi, con le stesse logiche». Le voci sugli incontri preparatori segreti tra costruttori e amministratori per arrivare all’accordo non aiutano i sostenitori della partecipazione dal basso.
Poco si sa del compromesso annunciato da Raggi. Si conoscono i problemi che esso solleva. Il primo è quello relativo alle opere di urbanizzazione. Giovanni Caudo, assessore all’urbanistica nella giunta di Ignazio Marino e regista della prima fase dell’accordo, aveva puntato tutto sull’investimento dei privati in opere pubbliche, in una sorta di logica di riduzione del danno. Il cuore del lodo Raggi-Parnasi pare invece battere il ritmo opposto: il costruttore rinuncia a una parte di cubature ma al tempo stesso il suo impegno sulle spese di compensazione viene meno.
Traballa il rafforzamento della ferrovia Roma-Lido, si allontana il prolungamento della metro B, vacilla il ponte sul Tevere. Caudo risponde dall’estero: «Non conosco i dettagli del progetto attuale», dice. Poi aggiunge con una punta di sarcasmo: «Nessuno regala niente a nessuno, ma se davvero ci fosse una diminuzione di cemento a parità di opere pubbliche sarei contento come tutti».
Le opere pubbliche previste nell’accordo contemplano due fasi. La linea Roma-Lido, la via del Mare e le opere contro il dissesto idrogeologico da realizzare prima dell’apertura dello stadio. Il ponte sul Tevere e lo svincolo della Roma-Fiumicino in un secondo momento. Fuori resterebbe il raccordo con la metropolitana. Preoccupa soprattutto la seconda parte, temporalmente troppo lontana e da realizzare quasi «fuori tempo massimo». «Mentre è stato detto chiaramente che le attuali cubature saranno ridotte – fa notare l’assessore regionale al territorio Michele Civita – non si conoscono a oggi le infrastrutture per garantire la mobilità, il miglioramento dell’ambiente e della qualità urbana».
I prossimi giorni, da questo punto di vista, saranno decisivi. Gli uffici comunali già da lunedì lavoreranno a un testo di delibera che assorbirà anche la variante al Piano regolatore necessaria per autorizzare almeno 150 mila metri cubi in più, rispetto ai 350 mila del Prg vigente. Parallelamente alla delibera, il Campidoglio e la Roma dovrebbero lavorare anche sullo Schema di convenzione. Dal 3 marzo tornerà a riunirsi la Conferenza dei servizi. Una riunione che in teoria avrebbe dovuto essere l’ultima, quella decisiva, ma che nei fatti invece dovrebbe concludersi con la concessione di una ulteriore dilazione dei tempi richiesta dai proponenti.
Almeno altri 30 giorni per permettere all’amministrazione capitolina di scrivere un nuovo testo, e al consiglio comunale di votare, una nuova delibera. Si arriverebbe così al 3 aprile. Fino a ieri, si contavano una decina di consiglieri M5S critici sul progetto. Ora la posizione vacilla, dopo che anche Roberta Lombardi ha accolto la linea dei vertici e sposato l’ipotesi di compromesso: «Stracciato il progetto iniziale. Dimezzate le cubature extra-stadio. Nessun grattacielo. Questo è uno #StadioFattoBene, brava Virginia Raggi», ha twittato.
Parole concilianti arrivano anche da Cristina Grancio, una delle consigliere più critiche: «In politica nessuno asfalta nessuno, ma il sospetto di un pareggio che accontenta tutti mi viene. Allora incominciamo con il dire che senza la vigorosa fermezza dell’azione di contrasto, cara Virginia, non avremmo portato a casa il ‘nuovo e più contenuto progetto’. Lo confesso, giocavo per vincere e non per pareggiare. Ma come si usa dire proprio nel calcio ‘la partita finisce quando l’arbitro fischia’».
Gli accadimenti di questi giorni rischiano di far dimenticare un impedimento non da poco: la procedura di vincolo avviata dalla soprintendente Margherita Eichberg sull’ippodromo di Tor di Valle. L’iter dura 120 giorni, Parnasi e Pallotta potrebbero richiedere quattro mesi di proroga alla Conferenza dei servizi, scommettendo su una futura bocciatura da parte del Ministero della cultura della richiesta di vincolo. Beppe Grillo era calato a Roma per annunciare che lo stadio sarebbe stato opera di costruttori e non di palazzinari.
La via di mezzo individuata da Virginia Raggi rischia di imboccare la strada opposta: se prima una cementificazione imponente (e largamente discutibile) imponeva opere pubbliche e impegni verso la città, questo accomodamento potrebbe svincolare la cittadella dello stadio da ogni opera pubblica. Questo è quel che appare dai primi rilievi. Nei prossimi giorni, vedremo le carte.
Il drammatico resoconto di un missionario che dalle bidonville dell’Africa nera è piombato nella “periferia interna” di Napoli, Italia. Scritto il 22 febbraio 2017
Solo ora, dopo tanti anni di presenza nel rione Sanità, unadelle periferie interne di questa città, riesco a capire quanto complessa siala situazione e quanto difficile sia essere missionario in luoghi come questi. Vista dalle periferie, Napoli salta subito all’occhio comeuna metropoli spaccata in due, la “Napoli bene” come la borghesia di Chiaia,Vomero, Posillipo e la “Napoli malamente” che va dalle periferie esterne diScampia, Ponticelli, Barra alle periferie interne (il centro storico degradatodi Forcella, Quartieri Spagnoli, Rione Sanità). C’è un muro invisibile chesepara queste due Napoli, due città che non vogliono incontrarsi. Da una parteuna ricchezza ostentata e dall’altra una bomba sociale che fa paura.
Si sentono superiori ai vecchi boss. Vogliono tutto esubito. Qui e ora. Se, hanno deciso di uccidere, lo fanno. Sparano nel mucchio,uccidono vittime innocenti» Questi giovani, con le loro “stese” terrorizzano ilterritorio e proclamano a tutti che loro sono in controllo. Questi ragazzi nonimitano più neanche la fiction televisiva di Gomorra, ma imitano l’Isis. «Unfilo sottile ed esistenziale lega i giovani che scorrono in armi nel centrostorico di Napoli per uccidere e farsi uccidere e i militanti della Jihad - cosìafferma il giudice Nicola Quatrano nella condanna contro la Paranza dei Bambinidi Forcella - Entrambi sono ossessionatidalla morte, forse la amano, probabilmente la cercano, quasi fosse l'unica chanceper dare senso alla propria vita e vivere in eterno»
“Un Popolo in cammino” ha reagito all’uccisione di un altroinnocente Ciro Colonna, sfilando con un migliaio di persone per le strade di Ponticelli.Marciando ho potuto osservare bene il Lotto 0: una piccola Scampia! Che vergognaquesti ghetti di Napoli. E come azione positiva abbiamo, insieme ai cittadini,ripulito un campo abbandonato, dove ora i ragazzini del Lotto 0 giocano apallone. Piccoli segni che nascono dal basso.
 «Campidoglio. Dopo un ricovero per un malore, Raggi incontra i proponenti a Palazzo Senatorio per l’intesa: dimezzate le cubature della cittadella» È davvero un miglioramento? il manifesto, 25 febbraio 2017, con postilla
«Campidoglio. Dopo un ricovero per un malore, Raggi incontra i proponenti a Palazzo Senatorio per l’intesa: dimezzate le cubature della cittadella» È davvero un miglioramento? il manifesto, 25 febbraio 2017, con postilla
Il dg giallorosso Mauro Baldissoni, il costruttore Luca Parnasi e il project manager della sua società Parsitalia, Simone Contasta, accompagnati da Gianluca Comin, responsabile della comunicazione per il progetto di Tor di Valle – il business park con annesso stadio della Roma – entrano finalmente in Campidoglio alle 21.30 circa per l’atteso incontro con la giunta pentastellata.
I proponenti dell’opera hanno analizzato le proposte dell’amministrazione Raggi per ore, mentre attendevano che la sindaca facesse il punto preliminare con gli esponenti della sua maggioranza. E alla fine hanno deciso di accettare i paletti imposti dalla giunta: abbattimento del 50% delle cubature, sostanzialmente le tre torri di Libeskind e rifacimento del progetto, tenendo conto del rischio idrogeologico dell’area di Tor di Valle.
La sindaca Raggi, malgrado la giornata decisamente pesante, ne è uscita soddisfatta, determinata com’era a chiudere la «vertenza stadio» il più velocemente possibile, anche perché incombe la deadline della conferenza dei servizi fissata al 3 marzo. In mano aveva una carta in più: il parere dell’avvocatura capitolina che sarebbe comunque favorevole all’annullamento (senza conseguenze pecuniarie) della «delibera Marino» sulla pubblica utilità dell’opera.
Dunque la trattativa è arrivata al punto – l’unico per salvare capra e cavoli, sia per la giunta a 5 Stelle che per gli impresari Luca Parnasi e James Pallotta – della modifica del progetto originario di Tor di Valle. Già respinto duramente dal presidente di Eurnova e proprietario dei terreni lo spostamento ad altra location, l’unica possibilità rimasta era quella di una riperimetrazione del progetto, con spostamento di qualche centinaio di metri, pur rimanendo nell’area di Tor di Valle, di una riduzione sostanziosa delle cubature, (secondo quanto promesso, sostanzialmente senza le tre torri), e una serie di modifiche dei materiali e delle tecniche da impiegare per adeguarsi al rischio idrogeologico dell’area.
La sindaca, al termine del vertice con la Roma, è apparsa sorridente accanto al dg della società Mauro Baldissoni. «Le cubature saranno dimezzate, in un nuovo progetto ecocompatibile, con una nuova fermata della Roma-Lido e la riqualificazione viaria tra Ostiense e via del Mare. L’As Roma sarà nostra alleata». Baldissoni concorda e ringrazia la sindaca visibilmente soddisfatto: «Si inizia, è una giornata storica. Abbiamo adattato i piani alle esigenze della nuova giunta. Siamo sicuri che sarà un progetto che renderà orgogliosi non solo i tifosi romanisti ma tutti i romani».
«Ho lasciato l'ospedale. Sto bene. Grazie a tutti per l’affetto. Ora sono in Campidoglio a lavorare per la città», è il post su Fb con cui Virginia Raggi poco dopo le 18 annuncia di aver superato il malore. Per tutto il pomeriggio è rimasta in contatto telefonico con il suo ufficio e con Beppe Grillo, preoccupata per la riunione sul bollente «dossier stadio» che avrebbe dovuto svolgersi nel primo pomeriggio. I suoi, dal blog di Grillo, la incitano con un «#ForzaVirginia, giornalisti restate umani», per chiedere ai media di rispettare la privacy della sindaca. Un abbraccio caloroso le arriva pure dalla deputata Roberta Lombardi che twitta: «Forza Virginia, rimettiti presto. Ti siamo vicini!». E dal gruppo del Pd, dal leader della Lega Matteo Salvini e da Fdi giungono «i più sentiti auguri di una pronta guarigione».
In piazza del Campidoglio intanto i tifosi giallorossi (pochi, a dire il vero), che hanno risposto al tam tam mediatico, srotolano lo striscione «Sì allo stadio, basta melina» e seguono la ola catastrofista lanciata dal presidente Pallotta scandendo: «Un solo grido un solo allarme: sì a Tor di Valle, sì a Tor di Valle» e «Famolo, famolo sto stadio, o Virginia famolo sto stadio». Attendo una «buona notizia» e invece apprendono quella spiacevole della Digos che ha già iniziato ad identificarli, uno per uno, dai video registrati in piazza, perché il loro assembramento non era autorizzato. Con loro, anche l’ex candidato sindaco e vicepresidente della Camera Roberto Giachetti che si autodenuncia: «Qualunque iniziativa verrà presa nei confronti dei tifosi – annuncia l’esponente del Partito radicale – deve essere presa anche nei miei, e da subito annuncio che rinuncio a qualunque immunità parlamentare».
postilla
A qualcuno potrà sembrare un buon compromesso. Invece il rimedio è peggiore del male. La soluzione della Giunta Marino accettava la scelta sbagliata dello stadio della Roma in quel luogo migliorando il progetto presentato dai padroni del vapore e ottenendo in cambio consistenti vantaggi per un vasto settore della città. Scelta, sosteniamo, sbagliata anche perché non si contrattano volumi edilizi non necessari in cambio di benefici per la città. Ma la scelta della sindaca e dei suoi supporters non riduce il danno e in più riduce il vantaggio per la città. Ci domandiamo: era impossibile per la Giunta Raggi cancellare la dichiarazione di "interesse pubblico" con gli stessi poteri con cui la giunta Marino" l'aveva approvata? Se non lo ha fatto, è evidentemente perché era disposta fin dall'inizio a mettere lì lo stadio e gli annessi. Tanto più che, come ricorda Eleonora Martini nel suo articolo, «il parere dell’avvocatura capitolina sarebbe comunque favorevole all’annullamento (senza conseguenze pecuniarie) della "delibera Marino" sulla pubblica utilità dell’opera».
 Podemos ha fallito nell' obiettivo per mezzo delle elezioni generali. Tuttavia, da Barcellona a Madrid, passando per Valencia e Saragozza, le forze progressiste critiche hanno conquistato molti municipi strategici. Ma cambiare il sindaco permette di cambiare il mondo? il manifesto, "Le Monde diplomatique", 25 febbraio 2017 (c.m.c.)
Podemos ha fallito nell' obiettivo per mezzo delle elezioni generali. Tuttavia, da Barcellona a Madrid, passando per Valencia e Saragozza, le forze progressiste critiche hanno conquistato molti municipi strategici. Ma cambiare il sindaco permette di cambiare il mondo? il manifesto, "Le Monde diplomatique", 25 febbraio 2017 (c.m.c.)
Nella piazza del Pilar si erge una montagna di fiori e di crocifissi; è metà ottobre, periodo in cui si svolge l’annuale festa di Saragozza. Le strade sono invase da turisti e i grandi magazzini sono pieni: non ci troviamo di fronte ai soviet o alla presa di un Palazzo d’inverno iberico. Qui, come a Madrid, Barcellona o ancora Valencia, le elezioni municipali del maggio 2015 sono state vinte da una «coalizione di unità popolare» formata da militanti dei movimenti sociali e da diversi partiti di sinistra. Malgrado le grida di terrore lanciate dai conservatori, angustiati da questi successi, la rivoluzione mantiene un basso profilo. «Non si può cambiare una città in un anno e mezzo», dichiara Guillermo Lázaro, coordinatore del gruppo municipale della coalizione Zaragoza en Común (Zec) (1).
Prima di aggiungere che, malgrado le promesse di progresso sociale assicurate dai programmi elettorali, la popolazione sembra aspirare più all’allontanamento della «casta» che all’abolizione della proprietà privata: «La gente non si aspettava un reale cambiamento delle condizioni di vita, ma piuttosto l’accesso al governo di persone normali, simili a sé».
A Santiago di Compostela, la piattaforma vincente Compostela Aberta («Compostela aperta») è nata da «un disgusto», ci spiegano Marilar Jiménez Aleixandre e Antonio Pérez Casas, rispettivamente portavoce e militante della coalizione. «Appena un anno dopo la sua elezione, il precedente sindaco, il conservatore Gerardo Conde Roa, è stato condannato per frode fiscale». Altri due amministratori si sono susseguiti nel corso di un mandato scandito dai processi giudiziari; da qui il soprannome attribuito alla città di «Santiago de Corruptela».
Questa crisi della rappresentanza politica, motore del movimento 15-M (sorto il 15 maggio 2011 a Madrid), ha favorito la nascita di coalizioni eteroclite, che rinnovavano il profilo dei tradizionali esecutivi: «Compostela Aberta è in parte composta da ex militanti dei grandi partiti, ma non solo, affermano Jiménez Aleixandre ePérez Casas. Molti dei suoi membri non avevano mai fatto politica prima o provenivano dalle associazioni di vicini (2), dal movimento femminista o sindacale, dai collettivi di lotta contro la speculazione immobiliare, ecc. Vi si trovano anche personalità, scrittori, rappresentanti del mondodella cultura, oltre a persone coinvolte nel 15-M». E non tutti si definiscono «di sinistra».
La denominazione «comuni Podemos» (dal nome del partito costituito nell’ottobre 2014), utilizzata dagli avversari e da una parte della stampa, non tiene conto dei rapporti complicati, spesso conflittuali, che queste squadre intrattengono con la giovane formazione. Del resto, «al di là delle differenze tra noi e le altre coalizioni municipali, abbiamo un presupposto comune, osserva Jiménez Aleixandre: non ci concepiamo come dei partiti. La maggior parte dei tradizionali partiti di sinistra dà la priorità agli interessi dei propri nuclei dirigenti: mantenere il posto, senza il minimo dialogo con i militanti. Anche all’interno di Podemos si osserva un’evoluzione simile. Noi sperimentiamo diverse forme di organizzazione per dare la priorità al nostro programma».
Mano nella mano o faccia a faccia?
Quale? Da una città all’altra, strategie specifiche si affiancano a diversi propositi comuni: democrazia, ripartizione della ricchezza, riduzione del peso della Chiesa, riappropriazione dei servizi pubblici, diritti delle donne, ecc. A pochi minuti dall’inizio del nostro incontro, il sindaco di Santiago di Compostela, Martiño Noriega Sánchez, si alza: «Scendo in cortile, ci avvisa. Osserviamo un minuto di silenzio ogni volta che una donna muore per le percosse di un uomo». In questa città di quasi centomila abitanti, parallelamente a iniziative del genere, assistiamo al ripristino di un centro d’accoglienza per le donne vittime di aggressioni, ma anche a campagne di sensibilizzazione per dare visibilità alla loro lotta. Il 25 novembre, data che le Nazioni unite hanno individuato come Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, la città si è tinta di nero e, su autobus e vetrine, è comparsa la scritta «Contra a violencia».
Al suo ritorno, il sindaco ci espone il piano per le prestazioni sociali entrato in vigore a ottobre e a cui spera si ispirino altri governi. «“Compostela Suma” è il programma più ambizioso che a oggi sia stato presentato. Abbiamo firmato degli accordi con alberghi, associazioni, come la Croce rossa, e sbloccato i fondi per dare riparo ai senza fissa dimora, utilizzando edifici del comune mai destinati prima a questo scopo». Il programma prevede di aiutare gli abitanti considerati «troppo ricchi» per accedere ai sussidi di inclusione sociale della Galizia (Risga). Noriega Sánchez non nasconde, inoltre, il proprio sostegno ai lavoratori in sciopero che hanno preso parte alle grandi giornate di mobilitazione dei lavoratori precari e in subappalto presso Telefónica, il principale operatore di telecomunicazioni spagnolo.
Tra i bersagli delle nuove squadre municipali ci sono alcuni simboli. A Barcellona, la ricomparsa di una statua decapitata del generale Francisco Franco ha turbato i conservatori.
Per l’Epifania, il 6 gennaio 2016, il sindaco di Valencia ha fatto gridare allo scandalo per la sostituzione di alcuni Re magi con delle regine. Provocazioni gratuite? Si tratta piuttosto di una critica alle eredità franchiste e cattoliche, eco dell’ideale repubblicano del 15-M, che continua ad aleggiare sulle manifestazioni spagnole, per mezzo della bandiera viola, gialla e rossa (i colori della seconda repubblica spagnola, 1931-1939).
Dopo aver definito il programma e vinto le elezioni, bisogna governare. L’ingresso nell’istituzione di ex militanti associativi abituati, per averli spesso subiti, a rapporti conflittuali con le squadre municipali ha provocato un cambio di atteggiamento del nuovo potere locale verso il settore associativo. «Constatiamo la volontà di includerci nei processi decisionali, afferma compiaciuto Enrique «Quique» Villalobos, presidente della Federazione regionale delle associazioni di vicini di Madrid (Fravm). Ottenere le informazioni è diventato più facile. Può sembrare poca cosa, ma è un passo enorme, perché quando si entra in possesso delle informazioni, è possibile formulare delle rivendicazioni. I conflitti che attualmente ci oppongono al comune sono stati favoriti dal comune stesso!»
Lavorare mano nella mano, ma senza rinunciare al faccia a faccia: per i collettivi militanti, la collaborazione con i propri ex compagni impone la preservazione della propria indipendenza, per «mantenere alta la pressione». Perché il miglioramento dei rapporti tra gli attori delle sfere pubbliche e politiche non garantisce progressi sociali, così come la cordialità non è sinonimo di collaborazione. «Il nostro sguardo sulla prima fase del governo di Barcelona en Comú è contrastante, dichiara Daniel Pardo, membro dell’Assemblea dei quartieri per un turismo sostenibile (Abts). Si sono aperti degli spazi di dialogo, mentre prima le questioni legate al turismo erano competenza esclusiva dell’istituzione, in stretto rapporto con i professionisti del settore: i secondi decidevano e la prima firmava. Ma siamo decisamente sorpresi nel vedere che lanostravoce, a difesa dell’interesse pubblico, è messa sullo stesso piano del parere di un qualsiasi albergatore».
Nell’ottobre 2016, in un giorno di consiglio municipale, Carlos Macías, portavoce della Piattaforma delle vittime del credito ipotecario (Pah) di Barcellona, in compagnia di una ventina di militanti riconoscibili per le magliette verdi e gli slogan allegri, manifesta davanti alcomune. È appena stata adottata una mozione che sostengono da lunghi mesi. Denuncia una clausola per l’indicizzazione degli interessi di alcuni prestiti immobiliari su un indice il cui metodo di calcolo è stato rivisto in maniera molto favorevole alle banche da una legge di settembre 2013. La vicenda riguarderebbe più di un milione di prestiti e molte famiglie si troverebbero nell’impossibilità di pagare la rate a causa del gravoso costo aggiuntivo frutto di questa disposizione, regolarmente giudicata illegale dai tribunali.
Ormai, a Barcellona, il comune si impegna a non lavorare più con le banche che la utilizzano e a fornire un aiuto amministrativo alle vittime. Tuttavia, su scala nazionale, il ruolo dei comuni è limitato: nel migliore dei casi, possono chiedere al governo spagnolo di modificare la legge, di adottare un sistema di prestiti a tasso zero e di rimborsare tutti gli interessi illecitamente riscossi dalle banche. Di che far tremare i grandi gruppi finanziari. «So che è altamente improbabile che il comune smetta di lavorare con questi istituti finanziari, confessa Macías. Rimarrebbero solo due banche, tutt’al più, e nessuna che possa concedere prestiti.
Ma sono convinto che si debba continuare a fare pressioni affinché la squadra municipale non si arrenda».
Non abbandonare la lotta, questa sarebbe la priorità. «Barcelona en Comú o Podemos hanno una responsabilità: quella di un discorso coerente, prosegue Macías. Se il messaggio che viene mandato ai propri elettori è: “Va tutto bene, calmiamoci, siamo arrivati al potere e sistemeremo ogni cosa”, vuol dire che nel corso degli ultimi quarant’anni non abbiamo imparato nulla». Le nuove squadre sostengono di essere consapevoli del rischio: «Non vogliamo assolutamente ripetere l’errore del 1982, quando la vittoria del Psoe [Partito socialista operaio spagnolo] ha portato allo sgretolamento del movimento sociale, rassicura Luisa Capel, membro della squadra di comunicatori di Ahora Madrid («Madrid ora»). Allora, la sinistra aveva scelto la logica della democrazia rappresentativa, e noi abbiamo perso potere nelle piazze. Questa situazione si è protratta durante gli anni 1990, con effetti devastanti. Ci auguriamo che il movimento sociale mantenga il proprio ruolo per aiutarci a portare avanti la nostra politica.Dall’altra parte, non smettono certo di eserciare pressioni».
«Tecnica di profanazione delle istituzioni»
Tuttavia, quest’invito provoca alcune tensioni. A Barcellona, si concentrano sulla lotta contro il turismo di massa, punto forte del program- ma di Barcelona en Comú. Nell’estate 2015, il sindaco Ada Colau, ha adottato una moratoria di un anno (prorogata fino al giugno 2017) sulle licenze per l’apertura di nuovi spazi ricettivi, in attesa di mettere a punto una politica di lungo termine in una città in cui tutti i quartieri subiscono le conseguenze del turismo di massa. Se la moratoria – a scapito dei rappresentanti del settore – offre una risposta alla prima delle esigenze dell’Abts, il Piano speciale urbanistico per gli alloggi turistici (Peuat) che la accompagna ha provocato forti critiche da parte dell’associazione.
Questa normativa, di cui si sta ancora discutendo per via del susseguirsi di un centinaio di emendamenti, prevede la definizione di quattro zone urbane. Nel centro, zona detta di «decrescita naturale», non verrebbe autorizzata alcuna nuova costruzione alberghiera, e le strutture esistenti non potrebbero essere ingrandite o sostituite qualora l’attività dovesse cessare; nella seconda zona, verrebbe mantenuto lo status quo; invece, si permetterebbe l’attribuzione «sostenibile» di licenze nei quartieri periferici della terza e della quarta cintura, con delle restrizioni in funzione della superficie e del numero di posti delle strutture. «Sappiamo che questo progetto è quanto di più coraggioso sia stato proposto per Barcellona, ma sappiamo anche che è insufficiente, spiega Pardo.|
Il comune ci chiede di sostenerlo, ma non possiamo firmargli un assegno in bianco. La “decrescita naturale” è un abile raggiro di retorica. Allo stato attuale, alcuni quartieri rappresentati nelle nostre assemblee si ritroverebbero immediatamente in balia della speculazione. La nostra esigenza? Una moratoria indifferenziata. Politicamente, forse, è un suicidio, ma non possiamo chiedere niente di meno». Ogni giorno, i «comuni del cambiamento» devono affrontare le difficoltà che insorgono con il passaggio dalla piazza alle istituzioni.Quest’evoluzione priva il movimento sociale di una parte significativa delle proprie forze.
Seduta nel dehors di un bar, Ana Menéndez, recentemente catapultata a capo della Federazione delle associazioni di vicini di Barcellona Favb), conta i suoi ex compagni che ora lavorano per i servizi municipali. Questo fenomeno siergià presentato all’epoca in cui Podemos si era accaparrata molti militanti attivi nel movimento sociale. Jiménez Aleixandre, dalle file di Compostela Aberta, non riesce a mascherare il proprio sconforto quando analizza l’impatto sull’azione militante dell’anno e mezzo di presenza nelle istituzioni: «Negli ultimi tempi, il funzionamento di Compostela Aberta, come quello di altri “comuni del cambiamento”, ha subito i gravi effetti dei processi elettorali. In un anno e mezzo, abbiamo attraversato un’elezione municipale, due generali e una regionale! Ci siamo buttati a capo fitto in questi appuntamenti, che hanno assorbito una parte enorme dell’energia che avremmo potuto dedicare alla città. Senza contare le tensioni interne che questo processo ha provocato, perché le coalizioni cambiavano a seconda del tipo di elezione».
VALENCIA. Manifestazione degli indignados. Queste tensioni non derivano solo da visioni divergenti. Mettono in luce anche la difficoltà di riprodurre le pratiche e le parole d’ordine del movimento sociale nelle istituzioni politiche. I nuovi comuni, fedeli all’empowerment, rielaborato e sviluppato da Podemos, si approcciano alla sfera istituzionale come a un campo di sperimentazione politica. Investono nella creazione di piattaforme digitali civiche (3) – una riproposizione dei metodi attuati durante il 15-M, quando alla fine di un dibattito, in un angolo della piazza, chiunque poteva scrivere le proprie proposte su un cartellone bianco. «L’obiettivo è spezzare la burocratizzazione della partecipazione per fare qualcosa di più dinamico, in linea con lo spirito del 15-M, in cui gli accordi si raggiungano attraverso il consenso e in cui non sia necessario appartenere a una determinata associazione per poter partecipare», spiega Capel a Madrid.
ASTURIE, OVIEDO. Manifestazione in appoggio al movimento 15-M Ma quest’inventiva digitale – che il giornalista Ludovic Lamant definisce «tecnica di profanazione delle istituzioni (4)» – e la buona volontà che la accompagna si scontrano, a volte, con le consuetudini degli abitanti. «Molti hanno finalmente capito che l’istituzione non è Twitter», constata il direttore della Fravm. A Santiago di Compostela, il voto dei bilanci par- tecipativi ha coinvolto un migliaio di persone, ossia un po’ meno di un abitante su cento. A Madrid, nel 2016, durante la grande campagna di riabilitazione della piazza di Spagna, 31.761 persone hanno votato on line per i diversi progetti: circa l’1% della popolazione totale della capitale. La scelta della ripartizione dei 60 milioni di euro del bilancio partecipativo, invece, ha suscitato l’interesse di 45.522 abitanti. Illu- sionismo o «democrazia reale»? Per il sindaco di Santiago di Compostela, Noriega, questi metodi dimostrerebbero la propria efficacia in maniera retroattiva, «non appena gli abitanti si accorgeranno che le proposte, di cui loro stessi sono gli autori, sono state adottate e messe in pratica».
Diventare semplici esecutori locali?
Tuttavia, la condizione necessaria è che queste misure siano portate avanti e adottate dal con- siglio municipale. Nessuna delle coalizioni di sinistra giunte al potere nel maggio 2015 gode della maggioranza assoluta. «Governiamo la città, ma non abbiamo il potere», riassume Pablo Hijar, consigliere municipale per le politiche abitative di Zec. Quindi, il sostegno di altri gruppi – spesso il Psoe, o partiti regionali come Chunta aragonesista (Unione aragonese, Cha), movimento nazionalista ed ecosocialista, in Aragona – diventa indispensabile. A Saragozza, «i socialisti ci impediscono di applicare dei criteri di progressività fiscale», afferma con irritazione Pedro Santisteve. «Il Psoe ostacola sistematicamente le grandi decisioni, quelle che mettono in discussione il sistema capitalistico», aggiunge Guillermo Lázaro, di Zec.
Senza contare che alcune misure presenti nei programmi elettorali sono prerogative regionali o nazionali. «Se il cambiamento si fosse verificato simultaneamente anche a questi livelli, sarebbe stato più facile, sospira Villalobos. La regione di Madrid gestisce gli ospedali, la pubblica istruzione, la legge del suolo. Molte decisioni del comune sono quindi accessorie: invita
la regione a prendere questa o quella misura... per lo più senza successo».
I mezzi non bastano per mettere in pratica le disposizioni radicali promesse contro gli sfratti. Soprattutto perché i comuni subiscono la pressione finanziaria di Madrid: «A loro arriva solo il 12,8% del bilancio nazionale, riprende Santisteve. Eppure, devono rispondere ai bisogni fondamentali dei cittadini per quanto riguarda trasporti, gestione dell’acqua e dei rifiuti».
La strategia di «cambiamento dall’interno» promossa dai nuovi esecutivi municipali si arena sulla definizione delle competenze, ereditata dalla transizione democratica e dalle leggi nazionali. In particolare la legge di razionalizzazione e sostenibilità dell’amministrazione locale, detta legge Montoro, dal nome del ministro delle finanze di Mariano Rajoy, Cristóbal Mon- toro, al quale si deve la sua adozione nel 2013. La prima fase del suo preambolo non lascia margini di dubbio sulle sue mire: «La riforma dell’articolo 135 della Costituzione spagnola (...) consacra la stabilità di bilancio come il principio fondante alla base dell’azione di tutte le amministrazioni pubbliche».
Questa legge, dettata dal «rispetto degli impegni europei in materia di consolidamento fiscale», e arrivata sulla scia delle politiche di austerità, impone, oltre alla riduzione del deficit, anche la destinazione di un eventuale attivo di bilancio al rimborso del debito. Al di là delle esigenze della propria politica, i sindaci devono portare avanti una battaglia sul concetto stesso di azione municipale: bisogna accontentarsi di diventare gli esecutori locali in un ambito definito dallo Stato, oppure tentare di rafforzarsi come entità politiche a pieno titolo, sulla scia della tradizione «municipalista» radicata nella storia del paese dal XIX secolo?
Questa situazione impone alle coalizioni progressiste strane acrobazie in materia di comunicazione. Nonostante possano tutte vantare il risanamento dei conti pubblici e la creazione di un favorevole attivo di bilancio dal loro arrivo al potere (5), hanno dovuto, in virtù della legge Montoro, versare quest’ultimo alle banche (2,3 miliardi di euro accumulati [6]). Tuttavia, alcune decidono di fare buon viso a cattivo gioco: non potendo investire i soldi recuperati, scelgono di presentare questi rimborsi come prova della buona gestione.
Una simile strategia non impedisce agli uomini e alle donne di punta del movimento di battersi per una modifica della legge. Nell’ottobre 2016, con il sostegno dei «comuni del cambiamento», il gruppo parlamentare Podemos ha presentato una proposta di legge in questo senso. Alla fine di novembre, una cinquantina di rappresentanti municipali si è riunita a Oviedo allo scopo di lanciare un ciclo di incontri per denunciare il debito illegittimo e i tagli di bilancio. La riunione di Oviedo, che non è sola nel suo genere, rispecchia una pratica classica dei «comuni ribelli»: far fronte. Il 4 e il 5 settembre 2015, a Barcellona si è tenuto il summit «Città per il bene comune. Condividere le esperienze del cambiamento», continuato il mese successivo a La Coruña. In entrambi i casi si sono dibattuti i soggetti più conflittuali: la rimunicipalizzazione dei servizi pubblici, i centri di identificazione ed espulsione, i rifugiati, la memoria.
Vincolati alle decisioni dei predecessori Per alcuni, tuttavia, dodici mesi sono basta- ti per far nascere un sentimento di delusione. Macías, successore di Colau nel ruolo di portavoce della Pah della capitale catalana, si rammarica per la lentezza dei cambiamenti promessi: «Si prenda ad esempio la questione della sanzione delle banche proprietarie di alloggi tenuti sfitti: il sindaco non ha tenuto fede alla propria missione. Ha inflitto tra le cinquanta e le sessanta sanzioni, invece delle duemila dovute. O non sta andando nella giusta direzione, oppure è troppo lenta. E, a riguardo, non c’è dubbio sulle sue prerogative: è proprio competenza sua».
All’inizio del 2016, la squadra municipale è stata scossa da un conflitto sulla gestione dello sciopero dei lavoratori nei trasporti pubblici. A fine febbraio, durante il Mobile World Congress, vetrina internazionale del settore della telefonia, sono state organizzate delle mobilitazioni che chiedevano la fine dei contratti precari, lo sblocco degli stipendi e la pubblicazione dei redditi dei quadri dirigenti. Quando i sindacati hanno respinto le soluzioni proposte dal «comune ribelle» per l’interruzione dello sciopero, Colau ha definito il movimento «sproporzionato», e la sua consigliera ai trasporti, Mercedes Vidal,ha rivolto ai lavoratori in sciopero un appello alla «responsabilità».
«Questa posizione totalmente ostile allo sciopero, più feroce forse di quella di altre squadre municipali, ha stupito molto, riferisce José Ángel Ciércoles, delegato Cgt Metro, il sindacato maggioritario in questa branca dei trasporti. Naturalmente quanti avevano votato per Ada Colau si sono sentiti traditi».
Albert Ruba Cañardo, presidente di Ateus de Catalunya («Atei di Catalogna»), un’associazione nazionale che denuncia il peso della religione cattolica nella società spagnola, si chiede quando sarà portato a termine il censimento delle proprietà immobiliari della Chiesa – e dei relativi privilegi –, reclamato al comune di Barcellona e considerato un dato fondamentale nella questione della casa. «Il concordato, che vogliamo abolire, esonera dalle imposte le pro- prietà della Chiesa accatastate come luoghi di culto. Ma è un’ipocrisia. Un edificio immenso di proprietà della Chiesa, con una facciata lunga più di cento metri, affacciato sulla piazza centrale della città, con all’interno uffici di avvocati, negozi, tutti in affitto. Su questo immobile, la Chiesa non paga alcuna imposta. Perché? Perché in un angolo ha messo la statua di un santo».
Prendendo il posto della destra, come a Madrid, dove Manuela Carmena è stata eletta dopo ventiquattro anni di governo del Partito popolare (Pp), le coalizioni ereditano accordi e progetti precedenti. Così, i nuovi arrivati subiscono delle critiche che dovrebbero per lo più essere rivolte alle amministrazioni passate. La capitale spagnola ha appena avallato la costruzione del quartiere Los Berrocales, progettato dalla precedente squadra municipale. Più di 22.000 alloggi da costruire entro il 2018. «Il Pp ha lasciato dietro di sé un’eredità di contratti di trent’anni o più, con questa o quell’impresa, commenta Villalobos.
Per annullarli bisognerebbe pagare enormi indennizzi. Los Berrocales, per esempio, è una follia. Oggi, la città dispone di un numero di alloggi sufficiente per i prossimi trenta o quaranta anni. Se costruiamo un nuovo quartiere, altri si svuoteranno». Carmena aveva promesso che non avrebbe autorizzato nuovi cantieri urbani di questa entità; tuttavia, ha considerato di non poter revocare questo progetto concepito dai suoi avversari politici.
Nell’aprile 1931, la vittoria delle forze progressiste in molte grandi città del paese, tra cui Madrid, aveva posto le basi per la II Repubblica. Alcuni sembrano scorgere nei «comuni del cambiamento» un’eco di questo precedente. Ma si sta diffondendo una forma di delusione, pari all’entusiasmo suscitato dalle vittorie del 2015, seppure in un contesto diverso. Allora, nuove formazioni politiche, Podemos in testa, avevano dalla loro un forte dinamismo. Speravano di trionfare alle ultime elezioni legislative. I loro dirigenti teorizzavano l’idea di un «assalto istituzionale»: la conquista rapida del potere a tutti i livelli attraverso una consapevole strategia elettoralista, poco conflittuale (il discorso del «né destra né sinistra») e apertamente rivendicata come «populista».
In attesa di un nuovo assalto, e al di là delle contraddizioni interne, i «comuni del cambiamento» devono affrontare esecutivi nazionali e regionali strutturalmente più potenti, e ben decisi a tenerli in scacco.
(1) Formata da Podemos, Izquierda Unida (unione del Par- tito comunista spagnolo e altri partiti della sinistra radicale), Equo (ecologisti), Puyálon (sovranisti aragonesi anticapita-listi), Somos (repubblicani di sinistra), Demos Plus (nato dal movimento sociale di difesa della sanità e dell’educazione pubbliche) e Piratas de Aragón (Partito pirata).
(2) Il movimento delle associazioni di vicini ha un ruolo particolare in Spagna dall’epocadella dittatura franchista.
Queste ultime, presenti in tutto il paese, sono raggruppate in federazioni nelle comunità autonome e partecipano in maniera attiva al dibattito pubblico.
(3) Il comune di Madrid, per esempio, ha creato la piattaforma https://decide.madrid.es
(4) Ludovic Lamant, Squatter le pouvoir. Les mairies rebelles d’Espagne, Montréal, Lux, 2016.
(5) Madrid, in particolare, passa per l’«alunna modello», dopo aver ridotto il debito pubblico del 19,7% in un anno.
(6) Eduardo Bayona, «La deuda en los ayuntamientos del cambio se reduce 160.000 euros cada hora», Público, 26 novembre 2016.
(Traduzione di Alice Campetti)
 Ecco dove spinge la logica del Mercato secondo la confessione di quelli che realmente governno i processi di trasformazione della città. il Sole24ore, 23 febbraio 2017, con postilla
Ecco dove spinge la logica del Mercato secondo la confessione di quelli che realmente governno i processi di trasformazione della città. il Sole24ore, 23 febbraio 2017, con postilla
La domanda residenziale che negli ultimi semestri si è riaffacciata al mercato deve fare i conti con una serie di variabili determinanti per il real estate e con alcune anomalie caratteristiche del mattone italiano. È in estrema sintesi il riassunto del report pubblicato da Rur, Rete Urbana delle Rappresentanze, e Yard, società che si occupa di consulenza nel real estate, per fotografare trend e tendenze del nostro mercato immobiliare.
Fatto 100 il numero base nel 2006 oggi la domanda abitativa è a quota 81,4, ma le compravendite si fermano al 59. Oggi sono 950mila i potenziali acquirenti, rispetto ai 907mila del 2012.
Secondo Yard non pochi sono i rischi interni e internazionali con il quale lo stesso mercato immobiliare deve fare i conti. Tra quelli interni Yard nomina la produttività, ma anche le calamità naturali oltre all’alto debito, tra quelli internazionali le elezioni in Europa, le migrazioni ma anche la riduzione degli investimenti cross-border.
Ma l’analisi del settore è più complessa. «Il ciclo immobiliare, e soprattutto quello delle costruzioni, ha subìto, a partire dalla metà dello scorso decennio, un ridimensionamento di proporzioni che non hanno avuto eguali in passato - recita il report -. Un settore fortemente esposto alla componente residenziale: circa l’80% del fatturato immobiliare deriva dalla componente del “mercato di consumo residenziale” in gran parte per uso proprio, mentre negli altri grandi mercati europei si attesta attorno al 60%, pur avendo dimensioni assolute comparabili».
In Italia, e gli operatori locali e internazionali da tempo lo segnalano, manca la componente essenziale dell’immobiliare per le attività produttive e di servizio urbano che costituiscono il vero motore dello sviluppo territoriale.
«Il fatturato di quello che Eurostat classifica come real estate activities nel 2015 vale, infatti, 130 miliardi di euro in Germania, 83,5 miliardi nel Regno Unito, 80,8 in Francia e 36,2 in l'Italia. Inoltre, nel nostro Paese dal 2006 il turnover si è ridotto del 27%, mentre in Germania è cresciuto del 21%» recita ancora lo studio.
Bisogna reinventare il real estate. Come nel segmento “commercial” (non residenziale) si sta passando sempre più a investimenti value added - edifici da riqualificare per ricavarne valore - così bisogna rigenerare pezzi di città attraverso la demolizione di quartieri degradati, obsoleti o invivibili (pensiamo ad alcuni quartieri di case popolari). Questo il pensiero del team di Yard e di Giuseppe Roma, segretario generale di Rur.
La riqualificazione permette da un lato di non consumare nuovo suolo e dall’altro di innescare un processo di sviluppo che può incidere sulla ripresa dell’economia.
Da segnalare anche lo stop dello sviluppo nel residenziale, che in un momento di crisi ha evitato però di mettere sul mercato abitazioni che non avrebbero incontrato domanda. Nel 2006 a fronte di cento abitazioni vendute si registravano permessi per 30 nuove costruzioni, nel 2016 ogni cento transazioni vengono autorizzate sette nuove abitazioni.
Il Rei (Real Estate Italia) Index (somma le opinioni di miglioramento e la metà di quelle che indicano stabilità) riferito al 2017 per quanto riguarda i volumi scambiati, nel solo comparto residenziale supera la soglia del 50% che rappresenta una prevalenza di opinioni positive per il futuro. Per quanto riguarda i prezzi, gli opinionisti interpellati dalla Rur, segnalano per il 2017 ancora una fase di contenimento nel settore abitativo, con una sostanziale stabilità, tranne che per l’usato di bassa qualità che dovrà subire ancora qualche rastrematura.
Il mercato abitativo sembra soggetto a una forma di “astinenza” da parte dei proprietari di immobili medio–alti, non offerti in vista di una possibile inversione di tendenza. Quindi, i prezzi medi sono in discesa per una diversa composizione qualitativa dei beni scambiati, rispetto al passato.
postilla
Abbiamo capito la logica del Mercato. Case vuote ne abbiamo costruite troppe. Ma gli investimenti, e il lavoro, non possono essere impiegati per restaurare i territori degradati, perché il danaro pubblico serve per gli armamenti, alla faccia della Costituzione. Allora "rigeneriamo" fisicamente e socialmente la città: aumentiamo le cubature nei vecchi quartieri, sovraccarichiamo i servizi già insufficienti, mandiamo fuori i poveri, e dentro i benestanti.
Un'analisi del paradosso italiano: da più di mezzo secolo si costruiscono troppe case. a non ce ne sono abbastanza per chi ne ha bisogno. Ecco che succede quando si passa dalla programmazione alla speculazione (chiamala, se vuoi, "mercato"). E che cosa, invece, bisognerebbe fare
Il libro di Enrico Puccini è un vero e proprio saggio che auspico sia letto sia da addetti ai lavori che da amministratori locali e, non per ultimo, quanti hanno a cuore le sorti delle nostre città e i diritti sociali che devono essere resi esigibili.
Il libro di Puccini sostenuto da dati inoppugnabili ed in alcuni casi delle vere chicche, parte da un assunto assolutamente condivisibile: uscire dalla cosiddetta “emergenza abitativa” a “politiche abitative”.
Questo è il cuore della questione ed è la questione ineludibile infatti si tratta di abbandonare definitivamente le politiche emergenzialiste alle quali abbiamo assistito almeno negli ultimi 20 anni. Politiche emergenzialiste che hanno di fatto contribuito a recintare la questione abitativa all’interno del mantenimento delle politiche nel recinto dell’emergenza. Emergenza utile a continuare una dannosa, cementificazione del territorio senza produrre alcuna risoluzione della questione abitativa.
L’esempio più evidente deriva dalla questione “residence” ovvero quei luoghi, a dire il vero assai lugubri, nei quali a Roma sono stati costretti a vivere poco più di 1800 famiglie ad un costo esorbitante, fuori da qualsiasi contesto e corretta gestione, anche solo amministrativa, pari a circa 38 milioni di euro all’anno.
Come sia possibile che Roma Capitale di un Paese del G8 non sia in grado di assegnare un alloggio, nel corso di decenni, a 1800 famiglie non è il frutto di un destino cinico e baro ma di una scelta ben definita.
A Roma si è scelto di mantenere in vita una finta “emergenza abitativa” solo per inseguire e sostenere politiche urbanistiche che nulla avevano a che vedere con il fabbisogno reale e questo dal libro di Enrico Puccini si evince con estrema chiarezza e dovizia di particolari.
Ma quanto accaduto a Roma in materia di politiche abitative non è una questione circoscrivibile alla città di Roma, con altri numeri, è lo stesso atteggiamento sostenuto dalla varie amministrazioni locali, indipendentemente se di centro sinistra o di centro destra. Non vi è poi tanta differenza tra la scelta dei “residence” romani e gli alberghi o ricoveri presso strutture assistenziali, che vengono offerti, raramente, dai comuni in alcuni casi di sfratti eseguiti dove sono presenti minori. E’ un evidente sperpero di risorse pubbliche mai sufficientemente indagato, è la negazione dei più elementari diritti costituzionali.
Enrico Puccini non si ferma a ciò ma indica una interessante confronto con l’Europa. A parte la evidente e risaputa differenza di presenza di alloggi sociali tra i Paesi europei e l’Italia, Puccini ci aiuta a comprendere ancora meglio come la maggiore presenza di alloggi sociali si è associata, in Europa, con sussidi e contributi rilevanti che abbattono i canoni di locazione anche degli alloggi sociali garantendo al contempo la sostenibilità degli affitti e la possibilità di garantire le necessarie manutenzioni degli alloggi sociali, ossia della vivibilità degli stessi.
Questo stride fortemente con quanto avvenuto in Italia dove non solo la presenza di alloggi sociali è con tutta evidenza insufficiente, ma la qualità del vivere nelle case di edilizia residenziale pubblica è spesso pessima, a Roma sulla base dei dati forniti dal libro di Enrico Puccini si sostanzia in un fabbisogno di risorse da destinare alle manutenzioni di almeno 700 milioni di euro, questione che fornirebbe, anche, un formidabile volano occupazionale.
In Italia invece e al contrario del necessario assistiamo ad una miopia o vera e propria cecità, in materia di politiche abitative, al plurale perché ci sarebbe bisogno di politiche abitative che aggrediscono i vari segmenti del fabbisogno abitativo e del disagio abitativo. Come definire la, ancora, pervicace volontà di Governo, Regioni e Comuni nel perseguire la politica di sostegno all’acquisto in particolare per giovani coppie, quando a questi si offre un mercato del lavoro ad intermittenza, precario, pagato con voucher ?
Come è pensabile sostenere la sfida con la crisi economica se da una parte si tende sempre più ad immobilizzare un Paese con oltre il 70% di unità immobiliari in proprietà e dall’altra si sostengono politiche del lavoro basate oltre che sulla precarietà anche e soprattutto sulla mobilità. Basta vedere quanto successo nel comparto della scuola con professori, residenti a Palermo e magari inviati nelle valli bergamasche. Non può essere un caso che i Paesi europei dove gli effetti della crisi economica sono stati più pesanti sono Spagna, Italia e Grecia ovvero i Paesi europei dove l’incidenza degli alloggi in proprietà è più alta.
Quando, ad esempio, la Germania che è il motore dell’economia europea il 60% della popolazione vive in affitto e con forti sussidi all’affitto, questo dimostra la stretta correlazione tra lavoro e abitare. Uno slogan che riecheggia spesso afferma: “ Perdi il lavoro – Perdi la casa”. Casa e lavoro sono un binomio inscindibile non a caso l’innalzamento degli sfratti per morosità (incolpevole) corrisponde più o meno esattamente agli anni di crisi economica.
Nonostante ciò, in Italia, il Governo con la legge di bilancio per il 2016 ha proceduto all’azzeramento del fondo contributo affitto, riproposto anche nella legge di bilancio 2017 per gli anni fino al 2019. Quel contributo affitto che, come ben dettagliato nel libro di Enrico Puccini, dovrebbe essere uno dei pilastri per politiche abitative degne di questa definizione.
A Roma il contributo affitto ha consentito a oltre 13.000 famiglie di non cadere nel baratro dello sfratto per morosità, in Italia parliamo di 350.000 famiglie. Ora il Governo, le Regioni e i Comuni che non destinano risorse o ne destinano in forma residuale risorse a contributi per il sostegno alla locazione né perseguono seriamente il riuso dell’esistente a partire dall’enorme patrimoni del demanio civile e militare inutilizzato, scelgono la strada di aumentare il disagio abitativo, perché ancora ancorati a una strategia obsoleta che trascura il fabbisogno ma persegue la cementificazione del territorio a sostegno della rendita immobiliare e della speculazione.
Non a caso il Censimento Istat del 2011, ci dice che tra il 2001 e il 2011 in Italia si sono realizzate oltre 1,5 milioni di unità immobiliari ad uso abitativo, di queste forse meno dell’1% alloggi sociali a canoni “moderati” .
E che dire della legge sulla morosità incolpevole? Una legge che prevedeva, come giustamente sottolineato nel libro di Enrico Puccini, un percorso condivisibile ovvero la presa in carico da parte dei comuni degli sfrattati per morosità incolpevole, al fine di un accompagnamento sociale prioritariamente verso un nuovo contratto a canone agevolato, tentando di ridurre il peso delle famiglie con sfratto. La legge si basa su un contributo congruo (8000 euro ora passati a 12.000 euro) e sul fatto che i comuni stilassero un elenco delle famiglie con sfratto per morosità incolpevole per consentire ai prefetti di procedere alla graduazione degli sfratti questo per consentire ai comuni di avere il tempo necessario per l’accompagnamento sociale. Nulla di tutto questo è stato fatto anzi i Comuni, anche Roma, ha utilizzato, nella maggioranza dei casi le risorse solo per prorogare gli sfratti di qualche mese. Abbiamo, quindi, assistito ad un fallimento dovuto anche alla pretesa dei Comuni, come Roma, di limitare la definizione delle famiglie con sfratto per morosità incolpevole, applicando il decreto attuativo del ministero delle infrastrutture in maniera del tutto restringente.
Il risultato è che per il 2017 il Governo ha stanziato solo 36 milioni di euro a livello nazionale se solo rapportiamo queste risorse ai soli sfrattati per morosità del 2015 abbiamo un contributo possibile di circa 50 euro mensili, si cinquanta euro.
Il libro di Enrico Puccini non è solo una utile ed essenziale saggio, ricchissimo di dati ma affronta nella parte finale anche la questione delle proposte per politiche abitative attraverso le quali passare dall’emergenza abitativa a politiche strutturali e programmatiche basate sul fabbisogno reale come ben descritto da Enrico Puccini.
Proposte che a mio dire vanno prese in seria considerazione e credo debbano essere oggetto di approfondimento e implementazione, perché si tratta di proposte che si basano su una analisi rigorosa dei dati e del contesto vissuto dalle famiglie in disagio abitativo.
Sarebbe, infine, sbagliato catalogare, il libro di Enrico Puccini, di lettura “locale”. Quanto avvenuto a Roma, le condizioni del disagio abitativo, l’impatto urbanistico delle scelte passate e la netta necessità di procedere ad una concreta discontinuità in materia di politiche abitative, rappresentano una traccia di analisi che riveste un carattere nazionale.
Il mio auspicio e che il libro di Enrico Puccini sia letto anche al di fuori di Roma e che rappresenti un contributo scientifico per indicare un nuovo modello nazionale, regionale e comunale di politiche abitative qualificate, che non guardino, come fatto fino ad oggi, al solo fabbisogno della rendita e della speculazione immobiliare a forte impronta liberista, i cui risultati sono sotto gli occhi di tutti: 700.000 famiglie collocate nelle graduatorie comunali, costrette ad “abitare” una graduatoria, circa 80.000 sentenze di sfratto all’anno, il 90% per morosità, un patrimonio di edilizia residenziale pubblica composto da circa un milione di alloggi lasciati al degrado strutturale e umano, un patrimonio immobiliare demaniale civile e militare del valore di circa 60 miliardi di euro lasciato spesso vuoto, utile solo a valorizzazioni di tipo speculativo. E’ ora di invertire lo stato di cose presenti in materia di politiche abitative ed urbanistiche, il libro di Enrico Puccini è un contributo efficace e va in questa direzione. Buona lettura.
Massimo Pasquini
 «Maremma amara. Domenica la manifestazione contro la trasformazione dell'Aurelia in autostrada. A, alla vigilia della conferenza dei servizi per il via libera al progetto, sostenuto da governo, Regione Toscana, Pd e dal fuoriuscito Rossi». il manifesto, 24 febbraio 2017 (c.m.c.)
«Maremma amara. Domenica la manifestazione contro la trasformazione dell'Aurelia in autostrada. A, alla vigilia della conferenza dei servizi per il via libera al progetto, sostenuto da governo, Regione Toscana, Pd e dal fuoriuscito Rossi». il manifesto, 24 febbraio 2017 (c.m.c.)
«Per la prima volta in trent’anni di lotta questo progetto ha saputo mettere tutti d’accordo contro l’autostrada tirrenica». Tutti tranne il Pd con i suoi satelliti e la Regione Toscana; per il resto Angelo Gentili di Legambiente non ha torto: alla manifestazione di domenica 26, con due cortei provenienti da Grosseto a nord e da Orbetello a sud, ci saranno fra i tanti perfino i sindaci di Grosseto, Capalbio, Magliano e Orbetello. Primi cittadini assortiti, anche di centrodestra, ma richiamati all’ordine – la volontà popolare – dall’ennesimo appello delle associazioni ambientaliste, nazionali e locali, al completo (Italia Nostra, Legambiente, Wwf, Fai) e dai numerosissimi comitati locali. Tutti convinti che l’alternativa ci sia: «Nessuno di noi pretende che l’Aurelia rimanga com’è adesso – sintetizza Nicola Caracciolo – però vogliamo che l’alternativa alla Tirrenica non sia il nulla ma l’adeguamento dell’Aurelia, meno dispendioso e con meno consumo di suolo». «L’unica soluzione di buon senso», sottolinea Gentili.
Occorre far presto, dalla Conferenza dei servizi di martedì 28 febbraio scatterà il conto alla rovescia: due mesi di tempo per un definitivo sì o no alla grande opera. Il parere della Regione Toscana è favorevole, al pari di quello del governo, non soltanto da parte del Pd ma anche da quello del fuoriuscito Enrico Rossi: il presidente toscano ha replicato agli ambientalisti che l’Anas non ha i soldi per mettere in sicurezza la variante Aurelia, e che quindi va fatta l’autostrada.
Eppure tante cose non tornano: già uno studio del Politecnico di Milano di fine anni ’90 rimarcava l’anti economicità della grande opera, visto che il traffico non pendolare sull’arteria stradale era troppo scarso. Oggi le associazioni e i comitati ambientalisti attualizzano quei numeri: «I dati del traffico non giustificano l’autostrada. Le stime, per il 2040, nel lotto 5b (Orbetello) prevedono 22mila veicoli al giorno, per il lotto 4 meno di 18mila. Pochi. Quanto alla sicurezza stradale, altro argomento usato, oggi si viaggia in media a 77 km orari, con l’autostrada si salirebbe a 127».
Intanto le autorità aspettano ancora da Sat (Società autostrade toscane) il piano finanziario della grande opera, mentre la durata della concessione, data senza gara, è stata sottoposta a una procedura di infrazione europea. Eppure si va avanti. E con una interrogazione al ministro dell’interno, la senatrice Alessia Petraglia di Sinistra italiana vuol capire cosa sta succedendo in questi giorni: «Tanti automobilisti hanno raccontato che ai controlli della polizia sull’Aurelia si affiancano persone che, approfittando del fermo e talvolta anche sotto indicazione della stessa polizia, pongono dei questionari sull’uso della strada, facendo domande in merito alla tratta percorsa, alla frequenza e al motivo per cui si utilizza l’Aurelia». Domenica anche gli attivisti di Si con i civatiani di Possibile, Rifondazione e il M5S saranno fra i manifestanti.
Riferimenti
Potete trovare su eddyburg numerosissimi articoli sulla pluridecennale vicenda dell'autostrada Grosseto- Civitavecchia rovistando nelle cartelle Sos Maremma, Sos Toscana
 Con meno clamore rispetto a Roma, anche a Firenze si decide del nuovo stadio. In questo caso, il comune sceglie l'area e assume l'iniziativa dell'operazione. Tutto bene, quindi? Decisamente no, spiega l'ex sindaco di Sesto Fiorentino sulla sua pagine facebook (m.b.)
Con meno clamore rispetto a Roma, anche a Firenze si decide del nuovo stadio. In questo caso, il comune sceglie l'area e assume l'iniziativa dell'operazione. Tutto bene, quindi? Decisamente no, spiega l'ex sindaco di Sesto Fiorentino sulla sua pagine facebook (m.b.)In questi giorni tutti i tg sparlano della querelle sul nuovo stadio della Roma e ci dicono di cosa pensa Grillo e delle dimissioni di Berdini, senza dirci di cosa si tratta.
Io ho capito questo:
- L’Associazione Sportiva Roma spa (valutata da Forbes con un valore di 307 milioni di dollari) chiede di aver un impianto proprio per evitare e di collegare al calcio nuove e redditizie attività quali centri commerciali, show room, ristoranti,ecc. il tutto immerso in un ambiente gradevole con cosiddette “attività di pregio”, viabilità adatta e gli immancabili enormi parcheggi;
- l’ex sindaco Marino rivendica di avere dichiarato il progetto di pubblica utilità e di averlo subordinato ad un tale numero di opere pubbliche di carattere ambientale e viario da rendere la zona degradata di Tor di Valle un nuovo e ridente quartiere di Roma a spese del privato;
- giungono notizie dalla sovraintendenza di aver, ex post, bloccato la demolizione della tribuna dell’ippodromo di Tor di Valle, quello della mitica “mandrakata” di Gigi Proietti;
- la Giunta Raggi come al solito non sa cosa fare e si affida alla Casaleggio ed eredi.
Finite le favole, alla beneficienza dei privati oramai non ci credono più neanche i bambini. La storia ci insegna che l’urbanistica contrattata, dopo aver raccontato una bella novella, dieci, venti anni dopo “fatta la festa, gabbato lo santo, lascia ai posteri traffico, inquinamento, concorrenza commerciale, consumi energivori, congestione urbana e spesso qualche fallimento. È la storia dell’urbanistica di questi ultimi 60 anni. La sinistra in alcuni casi ha creduto di essere più furba del mercato per poi accorgersi, nella migliore delle ipotesi, di non avercela fatta.
Veniamo a Firenze. Domenici a fine mandato, consentì ai Della Valle di annunciare la volontà, tramite un progetto fatto per altre società, di realizzare un nuovo impianto per il gioco del calcio diverso dal monumentale Artemio Franchi. La famosa “nuvola” dell’archistar Fuksas. Tutto ciò in piena redazione del regolamento urbanistico, con i lavori della Stazione Foster e della tramvia in corso e con ancora aperta la questione del Pue di Castello. Senza un’idea delle funzioni della Firenze Grande intesa come area vasta più complessa della Grande Firenze asfittica e chiusa nelle mura.
All’epoca, ero sindaco di Sesto Fiorentino, convinto che l’idea di un nuovo, più piccolo ma più moderno impianto fosse positiva suggerii alla Fiorentina e all’inesistente Città Metropolitana di individuare un’area in località Osmannoro dove il piano strutturale prevedeva già insediamenti commerciali e direzionali, attività per lo svago e dove insistevano una serie di attività economiche in palese affanno. La proposta che avrebbe visto la realizzazione di un nuovo casello autostradale a servizio di una delle aree produttive più vivaci della Toscana, la riconversione di un’area degradata e la risistemazione idrogeologica dell’intero quadrante trovò l’opposizione del comune di Firenze (Renzi sindaco) perché afflitta dalla maledizione del 50019 (il cap di Sesto Fiorentino): nessuna funzione pregiata doveva essere fatto al di fuori dell’asfittico e congestionato confine del capoluogo. La Piana, nei desideri di Renzi, ma anche di Rossi, doveva essere il contenitore delle cose brutte: impianti per i rifiuti, grande viabilità, centri commerciali, ecc. Tant’è che si è preferito far sviluppare con risorse pubbliche un aeroporto privato a spese dell’espansione del Polo Scientifico dell’Università di Firenze. Dimenticavo: la famiglia Della Valle da gran signori quali sono manco rispose “no grazie”.
La cronaca di questi anni ci racconta della volontà di insediare il nuovo stadio in uno dei quartieri più popolosi di Firenze, con una viabilità congestionata e un antico problema nella ricerca della sosta di superficie. Per fare il nuovo stadio dunque si devono trasferire i Mercati Ortofrutticoli di Firenze. Vi domanderete dove, pensando sicuramente che quell’attività che non richiama televisione e trasmissioni via satellite dei sindaci in tribuna, potesse essere decentrata in un’area produttiva limitrofa a Firenze, un’area industriale dismessa dello sprawl urbano fiorentino. Giammai! Perdere l’ICI di questa grande impresa sarebbe un problema, poco importa se ci saranno problemi di viabilità e d’ambiente, l’importante è che tutto rimanga nella firenzina bella e dorata. Quella con il cap 50100.
Quale sarà dunque l’incastro? E qui viene il bello. Qualche lettore più anziano si ricorderà la querelle “Fiat-Fondiaria” della fine degli anni '80 con la famosa frase “sentivo puzza di bruciato” di Achille Occhetto. Dopo il completo fallimento del Piano urbanistico di Castello, dopo lo sfregio della nuova Scuola Marescialli dei Carabinieri, l’area, funestata da numerose inchieste giudiziarie è recentemente passata di mano da Fondiaria al gruppo Unipol. L’area libera più grande di Firenze quindi, nell’intenzione dei nuovi urbanisti fiorentini (quelli del cemento zero) vedrà una parte occupata da una nuova ed inutile pista aeroportuale per la delizia dei banchieri e dei turisti danarosi e poi il trasferimento (c’è uno scontro tra comune di Firenze e Unipol sul prezzo) delle attività di logistica distributiva di frutta e verdura. Sicuramente nessuna crescita “smart”. Il comune di Firenze dovrà comprare e trasferire le attività delle aziende che operano attualmente dentro l’attuale mercato ortofrutticolo mentre il gande Diego comprerà (suppongo) l’area di Novoli per farci stadio, centro commerciale e quant’altro necessario per tenere in piedi economicamente un’operazione di puro lucro privato.
Tutto al contrario di come si dovrebbe fare. Vuoi fare lo stadio? Trovati e compra un’area compatibile con il Piano Strutturale, trasferisci le attività, compra l’area e costruisci. Il tutto a spese tue. Il tutto dentro un progetto di sviluppo del quadrante Nord Ovest di Firenze insieme ai comuni confinanti (Sesto Fiorentino e Campi Bisenzio) ma anche con la vicina Prato. Ma di piani strutturali di area o di piani di sviluppo regionale degni di questo nome neppure l’ombra.Ho richiamato tutto questo per riportare sulla terra il dibattito sulla scissione del Pd e sulla costruzione di una sinistra nuova, sia essa di Fratoianni, di Pisapia o di Emiliano.Il mondo è cambiato. Crisi economica e demografica, riscaldamento globale, finanziarizzaione del capitalismo, falsa austerità hanno messo in ginocchio l’occidente ed in particolare i paesi più deboli come l’Italia.Sarà possibile anche solo pensare ad una sinistra nuova, moderna, popolare che abbia compreso la lezione?Sarà possibile rompere con il renzismo senza invertire nessuna delle politiche che ce l’hanno regalato? Di questo mi piacerebbe parlare.
Riferimenti
Sullo stadio di Firenze, vedi in eddyburg, l'articolo di Ilaria Agostini Prima lo stadio poi l'urbanistica. Numerosi articoli sullo stadio a Roma vedi nella cartella Roma
Una lettera alla sindaca Raggi trasmessa, con preghiera di pubblicazione, a eddyburg da un gruppo di esperti, ricercatori e docenti dell'Universitè Paris-est, che evidentemente conoscono bene Roma, l'urbanistica romana e le sue recenti vicende
Questo interesse per la città di Roma ci porta a seguire con attenzione i recenti sviluppi della vita politica romana e a reagire a uno degli ultimi episodi: le dimissioni dell’assessore all’Urbanistica Paolo Berdini a causa di un disaccordo con la sindaca Virginia Raggi circa il progetto del nuovo stadio dell’AS Roma nella periferia sud della città.
Deploriamo questa decisione e vogliamo attirare l’attenzione della Sindaca sulle incertezze che, in seguito all’uscita di scena dell’assessore Berdini, gravano sia sulla città che sul Comune di Roma.
La periferia romana devastata dalla speculazione edilizia
Abbiamo potuto, nell’ambito delle nostre ricerche, condividere alcune delle battaglie di Paolo Berdini, in particolare quella a favore di un nuovo e diverso sviluppo urbano per la capitale d’Italia: uno sviluppo al servizio dell’interesse generale e non della somma di interessi dei singoli che da troppo tempo influenzano, determinano e anche dominano l’azione pubblica nella città. Moltissime ricerche hanno messo in luce la responsabilità di tali interessi privati sul degrado della città.
È innegabile, a nostro avviso, che le recenti rivelazioni di Paolo Berdini alla stampa siano state fatte in modo goffo e inopportuno. Sarebbe un’inutile perdita di tempo supporre un complotto nei suoi confronti. Ma sarebbe un’ingenuità ridurre le sue dimissioni a un ennesimo episodio della “telenovela” politico-mediatica che purtroppo scuote il comune di Roma da 8 mesi. Al di là del gossip, si tratta in questo caso di escludere dalla Giunta un assessore la cui legittimità non è mai stata contestata e che è sempre stato totalmente indipendente, in lotta e denuncia dei circoli di influenza, gruppi di potere e lobby legate all’onnipotente settore fondiario e edilizio romano.
Sono questi stessi gruppi che, nonostante la lunga fase di stagnazione economica e demografica della città di Roma, hanno continuato a costruire enormi “cattedrali” abitative e commerciali nel cuore dell’agro romano: tra il 2001 e il 2013, 38 nuovi centri commerciali sono stati creati, per lo più in zone già maltrattate da decenni di speculazioni edilizie.
Il casus belli del nuovo stadio della Roma
In questo senso, l’opposizione di Paolo Berdini alla costruzione del nuovo stadio dell’AS Roma a Tor di Valle incarnava, più degli altri impegni presi, il suo rifiuto di consegnare ancora una volta la periferia romana nelle mani della speculazione edilizia. Come recenti progetti fortemente contestati (“OL Land” a Lione), si tratta in realtà di un vasto complesso sportivo, ludico e terziario di 130 ettari, che include tre torri di 150 a 200 metri di altezza, per un totale di 900.000 metri cubi - ben al di là delle previsioni del Piano Regolatore Generale.
Il progetto originale è stato significativamente migliorato nel 2014 grazie all'azione energica dell’ex assessore Giovanni Caudo. Tuttavia, in qualità di storici della città, geografi, architetti, urbanisti, paesaggisti, vogliamo ribadire che ci sembra ancora inadatto ai bisogni e alle problematiche attuali del territorio romano: nuove costruzioni piuttosto che recupero urbano; primato accordato al miglioramento dell’accessibilità su gomma (130 milioni di euro di investimenti) piuttosto che quella su ferro (40 milioni, non in grado di garantire l'ipotetico prolungamento della linea B della metropolitana); deficit di democrazia partecipativa; programmazione impostata sulle strutture di divertimento e del commercio piuttosto che su una vera diversificazione funzionale; costruzione di grandi edifici quando la domanda per nuovi spazi nel settore terziario è molto limitata a Roma - senza dimenticare che tanti edifici in centro come in periferia restano miseramente vuoti!
Insomma, il progetto del nuovo stadio contribuisce a dare ancora una volta l’immagine di una città che continua a costruire il nuovo lasciando marcire il vecchio - le sue strutture urbane, le sue periferie, gli stadi: Roma ha già due stadi! Nonostante il cattivo stato di manutenzione, potrebbero entrambi divenire l’oggetto di trasformazioni innovative con costi e tempi contenuti.
Infine, questo progetto è il simbolo delle derive causate dalla finanziarizzazione del calcio: diverse ricerche hanno già evidenziato che i veri beneficiari dei nuovi stadi non sono né i clubs (lo stadio della Roma sarà infatti autonomo ed indipendente rispetto alla Società) né i fans (i tifosi romanisti, tra i quali quasi tutti i firmatari, subiranno l’aumento dei prezzi dei biglietti), bensì le ambizioni speculative dei loro proprietari, per i quali il calcio è diventato un investimento come tanti altri.
Alla luce di tali problemi, gli argomenti dei sostenitori del nuovo stadio appaiono deboli: alcuni si meravigliano che gli investitori privati debbano sostenere gli oneri di urbanizzazione, comprese le infrastrutture di mobilità e la sistemazione degli spazi pubblici circostanti. Ma questa non è una contropartita minima a fronte degli ingenti guadagni che otterranno dal futuro stadio? E che tipo di investitore avrebbe lasciato i suoi uffici isolati nel bel mezzo della campagna romana?! Altri sottolineano l'impatto positivo del futuro stadio sull'economia romana e sul quartiere, afflitto da un crescente degrado sociale e urbanistico. Questa doppia retorica dei “benefici” per la città e degli “effetti strutturanti” sulle periferie era già al centro della creazione delle nuove “centralità” del PRG del 2008. Fortemente contestata da molti ricercatori, è stata totalmente smentita dai fatti, come si può constatare osservando quanto avvenuto a Bufalotta, Ponte di Nona o Romanina. E come si può credere seriamente che un intervento puntuale, quale la costruzione di uno stadio e di tre torri firmate da “archistar”, possa far tornare gli investitori stranieri a Roma, in primo luogo scoraggiatati da una serie di carenze strutturali?
Per un’urbanistica al servizio del bene comune
Per gli esperti in questioni urbane come per i semplici visitatori che atterrano a Fiumicino, il paesaggio che si dipana lungo il tragitto dall’aeroporto alla stazione Termini è la dimostrazione lampante del degrado delle periferie romane, in totale contrasto con lo splendore della città antica, rinascimentale e barocca: è un paesaggio fatto di palazzi e spazi pubblici all'abbandono, cimiteri di gru, stazioni fantasma, passerelle che minacciano di crollare, strade distrutte, cumuli di immondizia. In questo contesto, un’azione pubblica rivolta verso il bene comune non può avere come punto cardinale di favorire la costruzione di un nuovo stadio di calcio, che soddisferà in primo luogo le ambizioni del manager di un hedge fund statunitense associato a uno dei più potenti gruppi di costruttori italiani.
L’uscita di scena di Paolo Berdini, che giustamente incarnava agli occhi di molti Romani competenza e indipendenza, costituisce un segnale inquietante per il seguito del mandato elettorale. Noi speriamo senza polemica che la sindaca Raggi continuerà a combattere le battaglie del suo ex-assessore e a portare la speranza di una Roma democratica, trasparente, moderna e adatta alle sfide del XXI secolo.
Non siamo qui per “fare la morale” venendo dall’Estero: siamo anche noi quotidianamente confrontati alle difficoltà sociali, economiche e politiche che colpiscono le nostre città. Tuttavia, noi che abbiamo dedicato tutta o parte della nostra vita professionale allo studio di questa città unica al mondo, proviamo nei sui confronti, come i suoi abitanti, tanto una passione incondizionata quanto un immenso desiderio di cambiamento.
I PRIMI 25 FIRMATARI
Dott. Julien ALDHUY, Professore associato, École d’urbanisme de Paris, Université Paris-Est Créteil
Dott. Fabien ARCHAMBAULT, Professore associato, Université de Limoges
Dott.ssa Sarah BAUDRY, Dottoranda, Université Paris Diderot
Prof. Denis BOCQUET, Professore ordinario, Ecole nationale supérieure d’architecture de Strasbourg
Eléonore BULLY, Studentessa di Laurea specialistica, Ecole d’urbanisme de Paris Dott.ssa Hélène DANG-VU, Professore associato, Université de Nantes
Dott. Aurélien DELPIROU, Professore associato, École d’urbanisme de Paris Adeline FAURE, Studentessa di Laurea specialistica, Ecole d’urbanisme de Paris Dott. Vincent GUIGUENO, Ricercatore, Ecole Nationale des Ponts et Chaussées Dott. Maxime HURE, Professore associato, Université de Perpignan Via Domitia Dott. Antoine LEBLANC, Professore associato, Université du Littoral Côte d’Opale Dott. Giulio LUCCHINI, Ricercatore indipendente
Dott. Fabrizio MACCAGLIA, Professore associato, Université de Tours Dott.ssa Charlotte MOGE, Ricercatrice, Université Jean Moulin Lyon 3
Dott. Stéphane MOURLANE, Professore associato, Université Aix-Marseille Dott.ssa Hélène NESSI, Professore associato, Université Paris Nanterre Dott. Arnaud PASSALACQUA, Professore associato, Université Paris Diderot Dott. Thomas PFIRSCH, Professore associato, Université de Valenciennes Dott. Clément RIVIÈRE, Professore associato, Université Lille 3
Prof.ssa Dominique RIVIÈRE, Professore ordinario, Université Paris Diderot Dott.ssa Victoria SACHSE, Dottoranda, Université de Strasbourg
Dott.ssa Annick TANTER-TOUBON, Ingegnere di ricerca, Ecole des hautes études en sciences sociales (Paris)
Arch. Laure THIERREE, Paesaggista
Dott.ssa Céline TORRISI, Dottoranda, Université de Grenoble
Prof. Serge WEBER, Professore ordinario, Université Paris-Est Marne-la-Vallée
«... la metamorfosi dell’urbanistica in ragioneria» Accurata analisi della svendita dl patrimonio pubblico a Firenze, e del quadro nazionale. ReTe territorialmente online, 22 febbraio 2017 (c.m.c.)
«Il testo è la trascrizione dell’intervento al convegno promosso dall’Assemblea dei Comitati Fiorentini e dalla ReTe dei Comitati per la Difesa del Territorio, "Città pubblica vs città oligarchica. Vita immaginata e desiderata, politica subìta", Firenze, 11 febbraio 2017, Teatro dell’Affratellamento».
A Firenze, l’alienazione degli edifici monumentali pubblici e di appartamenti destinati a residenze sociali sottrae alla cittadinanza le migliori occasioni per la riqualificazione dell’habitat urbano. E l’urbanistica si riduce a esercizio da contabili.
Da decenni, i programmi politici evitano l’elaborazione di un’idea di città alternativa al modello economicista, che vuole la città smart, creative, ridotta a brand da impiegare nell’agone della competizione globale. L’aspetto sociale non fa cassa e perciò è stato obliterato. A questo svuotamento di senso delle politiche urbane hanno contribuito, nell’Italia neoliberista, alcuni provvedimenti legislativi – giunti da destra e da sinistra – di matrice squisitamente economica, attinenti cioè a mere questioni di bilancio degli enti locali o dello Stato. E che hanno relegato la gestione della città e del territorio a pratiche di ragioneria.
Sia chiaro, ciò non discolpa l’urbanistica. Nell’abbandono delle finalità sociali e nell’impoverimento della città pubblica, l’urbanistica ha avuto infatti il suo ruolo in commedia, rispondendo senza pudore ai richiami della sirena del libero Mercato. Se non altro con i suoi silenzi e le sue elusioni. Anche a Firenze.
Ripercorriamo alcune tappe della metamorfosi.
Un importante impulso iniziale proviene dal varo della L 386/1991 (Trasformazione degli enti pubblici economici, dismissione delle partecipazioni statali ed alienazione di beni patrimoniali suscettibili di gestione economica) che rende possibile la conversione degli enti pubblici in Società per Azioni. Con la privatizzazione e finanziarizzazione degli enti, servizio pubblico e beni urbani e territoriali fanno ufficialmente il loro ingresso in Borsa.
Nel frattempo, la L 537/1993 – legge finanziaria del governo Ciampi – predisponeva il campo, prevedendo l’emanazione di norme dirette ad alienare intere classi di beni pubblici (art. 9).
Dopo sei anni – siamo nel gorgo della (sinistra) ristrutturazione dell’ordinamento amministrativo a firma Bassanini – è varata l’Agenzia del Demanio (DL 300/1999) avente ad oggetto l’amministrazione dei beni demaniali (pubblici), con «modalità organizzative e strumenti operativi di tipo privatistico».
Il successivo passaggio è compiuto sotto la guida di Giulio Tremonti, ministro dell’Economia nel Berlusconi bis: la L 410/2001 istituisce la “Società per la Cartolarizzazione degli Immobili Pubblici”: SCIP Srl, nomen omen. L’impiego del lessico finanziario – cartolarizzazione, ossia trasformazione dei crediti in titoli negoziabili sul mercato – è parte atttiva nella “transustaziazione” del bene pubblico in rendita privata.
Un anno dopo, un Tremonti non sazio affianca allo SCIP la “Patrimonio dello Stato SpA” con finalità di «valorizzazione, gestione ed alienazione del patrimonio dello Stato». Si noti che la L 112/2002 mette la Patrimonio SpA (art. 7) in stretta relazione con la istituenda “Infrastrutture SpA” (art. 8): un meccanismo che travasa i proventi della vendita del patrimonio disponibile e indisponibile dello Stato – ivi compresi i beni culturali – nel finanziamento delle infrastrutture.
Bisogna attendere il 2008 per registrare, con i Piani di Alienazione, la deflagrante incursione della ragioneria nell’urbanistica comunale. La L 112/2008 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica) dà infatti facoltà agli Enti locali di redigere un elenco degli immobili pubblici posti in vendita – il Piano delle Alienazioni –, da allegare al bilancio di previsione dell’ente stesso.
Corre l’obbligo di richiamare l’attenzione sul fatto che il Piano delle Alienazioni «costituisce variante allo strumento urbanistico generale» (art. 58): consente cioè automaticamente il cambio della destinazione d’uso di un immobile (o di un fondo) presente nell’elenco. Proprio sul cambio di destinazione urbanistica, come tutti sanno, si incardina la rendita fondiaria e immobiliare; non solo nel caso classicamente inteso – quello da Mani sulla città – che vede l’agricolo tramutarsi in “murativo”, ma anche nel passaggio, ad esempio, da “attrezzatura militare” a “turistico-ricettivo”: una caserma venduta come potenziale albergo diventa ben più appetibile per il mercato. Non c’è bisogno di spiegare perché.
Una sentenza della Corte costituzionale, la n. 340/2009, ha riportato nell’alveo democratico tale automatismo, imponendo il passaggio della variante in Consiglio comunale. L’art. 58 della L 112/2008 toglie comunque di mano agli urbanisti un importante strumento regolativo e progettuale.
Per concludere la descrizione di questo quadro desolante (dopo aver ricordato il DL 85/2010 detto del “federalismo demaniale” che dà l’avvio al trasferimento a titolo gratuito di beni demaniali agli enti territoriali al fine di «ampliare il proprio portafoglio immobiliare»), occorre soffermarsi sul funesto DL 173/2014. Meglio noto come “Sblocca Italia”, all’art. 26 il decreto renziano prevede che quota parte dei proventi delle vendite degli immobili pubblici del demanio militare sia destinata proprio a quegli enti territoriali che hanno contribuito alla conclusione del procedimento di vendita, ossia a quegli enti che hanno vestito i panni di agenti immobiliari.
Firenze. Le occasioni perdute
I Piani delle Alienazioni rappresentano l’elenco delle occasioni mancate nella “rigenerazione” urbana che gli amministratori professano di perseguire. A dispetto di pratiche urbanistiche consolidate ed esemplari, infatti, le politiche urbane neoliberiste (anche fiorentine) rifiutano il progetto di città imperniato sulle potenzialità offerte dagli immobili pubblici. E proprio attraverso le alienazioni esse sottraggono alla città il fondamento materiale del progetto collettivo.
Un solo illustre esempio. Bologna, anni ’70: il piano per il centro storico, tutt’oggi indicato a livello internazionale come ricetta valida per contrastare i fenomeni di gentrificazione, era fondato sulla restituzione all’uso collettivo degli edifici di valore monumentale che, oltre a comporre la scena urbana, furono il luogo del potere e dei soprusi. Palazzi, carceri e caserme – liberàti – vengono riconsegnati alla cittadinanza, sia come centri di quartiere sia come contenitori di funzioni rare, ma comunque ad alta socialità.
In tema di trasmutazione dell’ente locale in piazzista, a Firenze si assiste forse al caso più luminoso. Sul sito del Comune è ancora disponibile (e quindi, immaginiamo, ancora attuale) il catalogo Florence city of the Opportunities (sic, 2014) che illustra, a mo’ di catalogo commerciale, una serie di 59 edifici in vendita, dei quali ben 42 sono privati o di enti pubblici diversi dal Comune (Ferrovie, CNR, Poste etc.).
Del catalogo, presentato nel 2014 dal sindaco in persona alle fiere della speculazione immobiliare, sono stati venduti alcuni bocconi pregiati: via Bufalini (già proprietà Cassa di Risparmio, 18.800 mq di SUL, superficie utile lorda) alla Colony Capital di Tom Barrack, «close friend of President Donald Trump»; alla stessa compagnia statunitense vanno gli 89.000 mq della Manifattura Tabacchi. L’ex collegio della Querce (13.400 mq), a un magnate indiano «che ne farà un “sette stelle” extralusso», parola di Nardella. Lo Student Hotel nel Palazzo del Sonno aprirà a settembre.
La vendita di tre importanti edifici di proprietà comunale, presenti in catalogo, è avvenuta secondo un medesimo copione (che evidenzia la forza del legame Firenze-Roma). Il Teatro Comunale viene comprato dalla Cassa Depositi e Prestiti SpA (CDP), pochi giorni prima della chiusura del bilancio comunale: siamo nel dicembre 2013, Renzi è in ascesa verso palazzo Chigi. (Per inciso, CDP diventa società per azioni nel 2003, tradendo il suo mandato di Banca di Stato nata per elargire prestiti alle amministrazioni locali, finalizzati ad opere di pubblica utilità). Lo stesso salvataggio del bilancio avviene l’anno successivo con l’acquisto di palazzo Vivarelli Colonna, ancora da parte della CDP. E nel 2015 con palazzo Gerini.
L’ultimo piano comunale delle alienazioni, approvato nei giorni scorsi con il bilancio preventivo 2017, offre in pasto al libero mercato:
– la rinascimentale Villa di Rusciano, posta in vendita malgrado la clausola testamentaria che ne vincolerebbe l’uso. Si noti che per trasferire la Direzione Ambiente (che ora ne occupa i locali) ed altri uffici comunali, è stato autorizzato l’acquisto dalla “FS Sistemi Urbani-Società a responsabilità limitata”, di due immobili in viale Fratelli Rosselli per 9.828.520 euro. Tale acquisizione viene giustificata con l’argomento dei «fitti passivi». Ma perché investire 10 milioni di euro con tanti immobili vuoti di proprietà comunale? I 6-7 milioni stimati come base d’asta per la vendita della villa di Rusciano non porterebbero l’operazione in pareggio. Forse non è solo una scelta di bilancio;
– il palazzo Vegni, che ospita una delle sedi della facoltà di Architettura;
– la palazzina Grilli (Scuola di Polizia) nel Parco delle Cascine;
– il deposito del tram a Varlungo;
– il Nuovo conventino, per cui si prevede la demolizione con ricostruzione;
– il Padiglione 37 a San Salvi;
– le Gualchiere di Remole, documento di archeologia industriale medievale;
– la scuola di via di Villamagna. Un inciso: a questo edificio, sede storica del CPA (Centro Popolare Autogestito Fi-Sud), potrebbe essere applicato qualcosa di simile alla famosa delibera “per l’ex Filangieri” di Napoli (n. 400/2012, cfr. anche la recente 446/2016). Come è noto, la delibera napoletana fa leva sulla categoria giuridica di «bene comune» e riconosce ad alcune esperienze di riappropriazione in autogestione di edifici dismessi il «valore sociale di ambienti di sviluppo civico», e come tali le ritiene strategiche. Quando con alcuni comitati proponemmo qualcosa di analogo nelle osservazioni al RU 2014, per l’area del CSA-Next Emerson di via di Bellagio, assessore e ufficio tecnico rigettarono la proposta come «non pertinente». Un caso di lungimiranza urbanistica.
Nel piano delle alienazioni comunale, infine, è messa in vendita una sessantina di appartamenti. Tra di essi, l’immobile di via del Leone in cui da anni è portata avanti una sperimentazione sociale che ravviva il quartiere di piazza Tasso (anche per questo edificio varrebbe l’argomento dello «sviluppo civico» contenuto nella delibera napoletana).
Nella lista troviamo inoltre, non senza disapputo, gli appartamenti di via dei Pepi: si tratta di case «storicamente» utilizzate con «finalità sociali proprie dell’edilizia residenziale pubblica» (LRT 96/1996, art. 2) e gestite da Casa SpA, cioè dal Comune. Esse, quindi, come tali – scrive il Movimento di Lotta per la Casa – sarebbero «alienabili solo con i piani di vendita dell’edilizia residenziale pubblica che ne vincola i proventi a reinvestimenti per le stesse finalità». Questo provvedimento di alienazione va ad inserirsi in un quadro di disagio abitativo assai esteso e, purtroppo, in progressiva espansione, che vede a Firenze oltre 12.000 famiglie organizzate in 160 comitati di autogestione, vessate dai regolamenti sempre più restrittivi per l’assegnazione degli alloggi. Famiglie che lottano contro l’impoverimento e il furto operato in città dalla privatizzazione di beni e servizi.
Per favorire il ripopolamento dei quartieri storici, per contrastare la sostituzione degli abitanti, e per calmierare la rendita posizionale, sarebbe opportuno invece un rilancio dell’edilizia residenziale pubblica che potrebbe far perno sugli appartamenti pubblici in area centrale (come lo fu nel citato piano bolognese). Ma niente da fare. Il Comune prosegue in una strategia di fallimentare gestione urbana: allentare le maglie dei regolamenti urbanistici, ammutolire il progetto sociale, dismettere l’idea di uguaglianza urbana, e quindi favorire l’acquisizione di interi pezzi di città da parte del mercato di lusso e del turismo globale.
Il piano delle alienazioni fiorentine comprende anche la concessione pluridecennale a privati: i 10.800 mq dell’ex Tribunale di San Firenze (il contratto è stato sottoscritto a fine 2016 con Zeffirelli per un «Palazzo delle Arti e dello Spettacolo»); l’ippodromo delle Mulina, al centro di un’indagine della Magistratura, che vede coinvolti esponenti del giglio magico (“il Fatto quotidiano”, 20 dicembre 2016); l’ex ristorante Le Rampe; porzioni di villa Favard; e l’«ex» Mercato ortofrutticolo di Novoli: la concessione è legata al project financing per la realizzazione del nuovo stadio e strutture annesse che troveranno sede proprio sull’area Mercafir; ma di questo abbiamo già scritto.
Neanche la Città metropolitana mette in pratica politiche più illuminate. Nel suo piano delle alienazioni sono presenti:
– il complesso di Sant’Orsola, 17.500 mq centralissimi da attribuire con concessione a lungo termine: si ventila l’ipotesi della Bocelli Academy, esclusiva scuola di arti liriche di cui proprio il quartiere non riusciva a fare a meno;
– la fattoria di Mondeggi: sede di un’esperienza rilevante di neoagricoltura e autogestione di terreni demaniali; villa e poderi sono ora in vendita in unico lotto;
– ex ospedale di Bonifacio sede della Questura di Firenze;
– la caserma dei pompieri, in via La Farina.
Passiamo alla Regione. In questo caso il lusso – luxury – è pervasivo, sia nel messaggio che nel vettore comunicativo. Il sito Invest in Tuscany si propone ai mercati stranieri con un’aura da real estate magazine d’alto bordo. Tra gli edifici pubblici immolati al mercato: villa Basilewsky (900 mq e 3.000 di giardino, alla Fortezza); villa Fabbricotti (1.800 mq, in quasi 4 ettari di parco pubblico in piena città); ex Meyer (2.500 mq); ex sede regionale di via Pietrapiana, 1600 mq «di straordinaria qualità» e 650 mq di giardino, a cinque minuti dal Duomo; villa Larderel sulle colline di Pozzolatico (11.800 mq con sette ettari di parco).
Alcuni edifici di competenza regionale, già destinati ad usi sanitari e perciò situati in quota, costituiscono il fronte collinare di aggressione alla città pubblica: il sanatorio Luzzi, 6.800 mq con 29 ettari di terreno; il sanatorio Banti a Pratolino (13.000 mq, 4 ettari e mezzo di terreno); l’ospedale di Fiesole in via Vecchia Fiesolana, 4000 mq ancora in uso.
Su Invest in Italy Real Estate, l’omologo statale del sito toscano, troviamo l’avviso di vendita della vasta area centrale delle Officine Grandi Riparazioni. 54.000 mq di superficie utile lorda, con base d’asta di 16 milioni e mezzo, sono messi in vendita da FS Sistemi Urbani e Società Rete Ferroviaria Italiana. Nell’area sono previsti: «Edifici residenziali (32.400 mq), turistico-ricettivi (8.100 mq), commerciali (4.860 mq), direzionali e servizi per studenti (8.640 mq)» (cfr. RU, scheda ATa 08.10).
Altro, non secondario, capitolo è quello delle ex caserme.
Le caserme, oggi vuote, si presterebbero – per qualità intrinseche – ad un progetto di accoglienza provvisoria di rifugiati, richiedenti asilo, senza tetto e profughi dello sviluppo, resosi urgente dopo l’ultima vittima nell’incendio del capannone Aiazzone. Le caserme sono edifici adatti all’ospitalità del “popolo nuovo”, non solo per la loro conformazione architettonica, ma anche per la loro localizzazione per lo più nella città consolidata, talvolta ubicate proprio in quei settori del centro cittadino nei quali risulta evidente una situazione di disagio sociale e abitativo. Da questa immissione demica i quartieri potrebbero trarre le forze per la loro rinascita.
Un’ottima occasione di riscossa è però andata persa con la vendita della caserma di costa San Giorgio all’argentino Lowenstein (lo stesso che ha acquistato la villa-fattoria medicea di Cafaggiolo). Merita ricordare che per il complesso della ex caserma (15.230 mq), stretto tra i bastioni michelangioleschi di San Miniato e il giardino di Boboli, la proprietaria CDP in vista della vendita presentò osservazioni al RU (2014) che lo faceva ricadere parte in zona G (“Servizi pubblici di quartiere”), parte in zona F (“Attrezzature pubbliche di interesse generale”). Le osservazioni erano «finalizzate ad ottenere che la futura destinazione urbanistica dell’immobile preved[esse] destinazione ricettiva, residenziale e commerciale, secondo un mix funzionale da definire e comunque con destinazione prevalente ricettiva». Non stupisca che la proposta trovò pronta disponibilità presso gli uffici tecnici, e fu accettata (cfr. RU, scheda AT 12.05).
Questo l’elenco delle caserme (proprietà del “Fondo Investimenti per la Valorizzazione” della CDP) in trasformazione o in vendita nel centro cittadino:
– ex ospedale militare San Gallo, oggetto di un concorso bandito dalla stessa CDP «per la definizione della normativa urbanistica» (sic) da «sottoporre all’esame dell’Amministrazione comunale ai fini dell’elaborazione di una variante al Regolamento Urbanistico» (Bando progettosangallo.it, p. 6), Regolamento Urbanistico che, per i 16.200 mq in pieno centro storico, ha elaborato la stringente destinazione a «mix funzionale da definire» (RU, scheda AT 12.43);
– ex Scuola dei Marescialli, di fronte alla Stazione di Santa Maria Novella. 4.400 mq dell’ex convento sono destinati dal Comune a raddoppiare la sede museale. Per i rimanenti 16.000 mq dell’ala ottocentesca, malgrado la carenza di spazi per gli uffici comunali, non esiste ancora un progetto (la consigliera Amato, di Alternativa libera, vi proponeva: «anagrafe, cultura, polizia municipale, altri eventuali servizi sanitari e pubblici, e housing sociale»);
– ex caserma Ferrucci a fianco della chiesa brunelleschiana di Santo Spirito (6.200 mq in Oltrarno, occupati al 25%); il complesso, rassicura Invest in Italy, «non sarà alienato dal Ministero della Difesa ma verrà assegnato, mediante concessione d’uso»;
– ex caserma Redi nel convento del Maglio – 4.560 mq oggi parzialmente occupati dal Dipartimento di Medicina legale Militare – diverrebbe la sede del «politecnico del restauro», ERihs European Research Infrastructure for Heritage, grazie a dieci milioni della Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze (cfr. “Corriere fiorentino”, 17 gennaio 2017);
– nella ex caserma Cavalli, 6.225 mq in «fase di liberazione», la Fondazione CR «farà nascere l’incubatore di imprese», così afferma Nardella; ma nel sito della CDP ancora si legge essere destinata alla «vendita con trattativa privata».
Discorso a parte per la ex caserma dei Lupi di Toscana, 53.000 mq di SUL ai confini comunali. Passata nelle mani del Comune di Firenze grazie al federalismo demaniale, la caserma è attualmente oggetto di concorso internazionale. Il concorso è partito prima della conclusione della consultazione pubblica che, adattando ai tempi il dettato di La Pira, portava il titolo: «Non case, ma città 2.0». Senza il plauso dell’Unione inquilini.
Ulteriori edifici concludono, per ora, il lungo elenco delle occasioni vanificate per ricostituire la città pubblica. A ciascuno di essi, il sito della CDP da cui li ho tratti, attribuisce possibili destinazioni, nel segno del lusso (residenza, turismo, rappresentanz):
– villa Banti (1.335 mq, proprietà del Ministero della Difesa, nei pressi di piazza Donatello);
– villa Sepp, di proprietà CREA-Consiglio per la Ricerca e l’Analisi dell’Economia Agraria: 2.200 mq affacciati su piazza D’Azeglio;
– complesso Bardini (via dei Bardi, 2.141 mq) ed «Eredità» Bardini (via San Niccolò 78, 1.234 mq), entrambi di CDP Investimenti SGR SpA, in vendita con trattativa privata;
– villa Tolomei a Marignolle, in vendita con trattativa privata, 4.303 mq con 18 ettari di terreno, è un caso emblematico: villa privata, poi scuola pubblica poi comando dei Carabinieri, ora – in concessione dallo Stato – resort di super lusso (qualcuno disse che doveva diventare il modello per la gestione di Pompei).
Quanto al palazzo in via de’ Benci prospiciente il Museo Horne (proprietà: CDP Investimenti SGR Spa), l’offerente opera un significativo cortocircuito tra slancio del desiderio e vincolo urbanistico. Nell’edificio, si legge sul catalogo, «secondo lo strumento urbanistico adottato, le funzioni private sono liberamente insediabili, pur con alcune limitazioni». Sembra il minimo.
[]
Archistar, grandi opere, assenza di governo, mancanza di dosi anche minime di programmazione e coordinamento: ecco come si gettano al vento le risorse e si caricano di debito pubblico i vivi e i futuri. Corriere della sera, 22 febbraio 2017
La nuova stazione dell’Alta velocità di Afragola, progettata da Zaha Hadid e inserita dalla Cnn tra le perle dell’architettura contemporanea, già più volte visitata da governatori e ministri, sarà inaugurata ufficialmente tra un paio di mesi nella campagna a Nord di Napoli: in grande ritardo rispetto all’avvio dei lavori, iniziati nel 2003 e poi bloccati per oltre un decennio, ma ora addirittura in anticipo rispetto all’ultimo cronoprogramma. Quarantamila metri quadrati distribuiti su quattro livelli, 5 mila metri di vetrate, vuoti da vertigine e spazi in abbondanza per uffici e servizi: insomma, roba da squilli di tromba, l’ideale per ridare un po’ di tono a questa immensa periferia impoverita. E invece, c’è già chi nutre dubbi sulla sua utilità, perché è diventata il simbolo di ciò che il Paese potrebbe essere e invece non è.
Michele Oricchio, procuratore generale della Corte dei Conti, ne ha parlato nella sua relazione di apertura dell’anno giudiziario. Un paio i passaggi. Il primo, generale, quando ha fatto riferimento a «un investimento eccessivo» e alla «troppa superficialità nella spesa pubblica in Campania». Il secondo, quando è entrato nel merito. «La chiamano pomposamente — ha detto — “Porta del Sud”. Ma mi chiedo se sarà davvero dimensionata al reale numero di viaggiatori che prenderanno ad Afragola un treno per la Calabria o per Bari». Ironica la conclusione: difficile pensare a un traffico di viaggiatori «da Victoria Station».
Costata finora sessanta milioni, ma ne occorreranno molti altri per completarla e «connetterla» al territorio, la stazione di Afragola fu originariamente pensata per accorciare le distanze dell’Alta velocità. I Frecciarossa da e per il Sud non sarebbero stati più obbligati a entrare e uscire da Napoli, ma avrebbero potuto fermarsi ad Afragola e poi proseguire in linea retta. Sennonché è successo esattamente quello che non doveva succedere. Non solo l’Alta velocità si è fermata a Napoli, come si sa. Ma dal 2003, a cantieri aperti, nulla è stato fatto per garantire contemporaneamente il collegamento locale tra la nuova mega stazione galattica e quella ormai storica di Napoli-centrale. Niente metropolitana, che si ferma a 20 chilometri di distanza. Niente Circumvesuviana, che chissà come tira avanti essendo da anni classificata come la peggiore ferrovia italiana. Solo progetti più o meno vaghi e finanziamenti tutti ancora da confermare. E addirittura — almeno finora — non è previsto neanche un servizio alternativo su gomma. Tanto che il sindaco di Afragola, Domenico Tuccilo, ancora si sbraccia nel tentativo di richiamare l’attenzione di qualcuno: governo, Regione, Comune metropolitano. Qualcuno purchessia. Chiede navette, parcheggi, attrezzature per la vivibilità e lo sviluppo. Tutto tranne i soliti supermercati.
«La nuova stazione — dice — non può rimanere lì come un’astronave abbandonata nei campi». Tuttavia per ora la conseguenza è paradossale. Afragola sarà attraversata solo da qualche Intercity o Frecciargento, ma non sostituirà Napoli-centrale. A maggior ragione per l’Alta velocità. I Frecciarossa si fermeranno nella stazione di Zaha Hadid solo quando sarà completata la tratta Nord-Sud, o quella, già avviata, Napoli-Bari. Se ne riparlerà, in ogni caso, non prima del 2022. Intoppi permettendo. E sempre che si trovi un taxi per raggiungerla.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
<div id="div_bg_btnData" class="CHitNPReader_toolbar_btn_bg" >Data</div> <div id="div_bg_btnContenuti" class="div_bg_btnData" ></div> <div id="div_bg_btnData" class="CHitNPReader_toolbar_btn_bg" >Contenuti</div> <div id="div_bg_btnContenuti" class="div_bg_btnContenuti" ></div>
Un'intelligente sintesi del pensiero di David Harvey, premessa a una stimolante visione poliedrica della condizione urbana nel capitalismo del XXI secolo. casadellacultura online, ciclo "città bene comune, febbraio, 2017 (c.m.c.)
L'agile volume di David Harvey, Il capitalismo contro il diritto alla città, riedito per tipi di Ombre corte nel 2016 (I ed. 2012), raccoglie in centoventiquattro pagine tre articoli e un'intervista all'autore già pubblicati in inglese su altrettante riviste. Nel primo, Il diritto alla città, è chiarito e analizzato il senso di tale diritto in quanto "collettivo". Il secondo, La visione di Henri Lefebvre, è un breve saggio sull'ormai classico testo, Il diritto alla città, del filosofo marxista francese, uscito per la prima volta a Parigi nel 1969 e rieditato in italiano nel 2014 da Ombre corte. Il terzo, Le radici urbane delle crisi finanziarie. Restituire la città alla lotta anticapitalista, è un saggio dove l'autore ripropone in breve, e in relazione alle crisi finanziarie come quella recente, le tesi, strutturate e sviluppate in altri suoi libri, sulla relazione tra la necessità di assorbimento della sovraccumulazione di capitale e l'urbanizzazione, che pone la "città" - la parola è usata da Harvey per il suo valore iconico - come luogo centrale delle lotte anticapitaliste (dunque non più solo la fabbrica come nelle teorie marxiste tradizionali). Chiude il libro l'intervista, che verte, appunto, sulle possibilità di una Rivoluzione urbana.
Le tesi di Harvey
Il primo articolo funge da introduzione. È utile soffermarvisi perché fornisce, in modo abbastanza semplice e chiaro, la chiave interpretativa dell'intero sviluppo discorsivo. Constatata la centralità del tema dei diritti umani nell'attuale dibattito etico e politico, Harvey distingue quelli - dominanti nel nostro tempo - basati sull'individualismo, proprietà privata e ricerca del profitto, da quelli "collettivi" (lavoratori, donne, gay, minoranze etniche e così via), per porre al centro dell'attenzione tra questi ultimi il diritto alla città, che in qualche modo sembra implicitamente unificare gli altri.
È così già lasciata emergere una delle contraddizioni del capitalismo, ossia un'opposizione cosciente di diritti e di conseguenza una lotta, perché solo lo scontro pratico può deciderne la gerarchia. Si tratta - come ricorda Harvey - di un concetto centrale nel pensiero di Marx in vari luoghi della sua pubblicistica. Ma anche, possiamo aggiungere, riassunto con più rigorosa coerenza in questo aforisma di Nietzsche: «il diritto è la volontà di rendere eterno un rapporto di potenza momentaneo», ossia qualsiasi diritto ottenga da un determinato scontro di potere una qualche supremazia, questa sarà sempre contingente.
Rivendicare il diritto alla città «significa rivendicare una forma di potere decisionale sui processi di urbanizzazione e sul modo in cui le nostre città sono costruite e ricostruite» [pp. 9-10]. Fin dalle origini le città sono concentrazione geografica e sociale "di un surplus produttivo". Perciò, ne deduce Harvey, «l'urbanizzazione è sempre stata in qualche modo un fenomeno di classe, dal momento che tale surplus si è sempre dovuto ricavare da qualche parte e da qualcuno, mentre il controllo del suo uso è sempre rimasto nelle mani di pochi» [p. 10].
E anche oggi è così, ma con una differenza peculiare. Il capitalismo è continua ricerca del profitto. I capitalisti, realizzatolo, si trovano di fronte a un "dilemma faustiano": "reinvestire" il profitto "per guadagnare ancora più denaro" o impiegarlo "in spese voluttuarie".
«Le dure leggi della concorrenza - dice Harvey - li obbligano a reinvestire, perché, se qualcuno decide di non farlo, ci sarà sicuramente qualcun altro che lo farà al suo post» [p. 10]. Di qui una crescita tendenzialmente esponenziale di plusvalore e la conseguente «perenne ricerca di territori favorevoli alla produzione e all'assorbimento delle eccedenze di capitale» [p. 11]. Il processo continuo di accumulazione è così descritto nella sua essenza. Il capitalista deve affrontare una serie di ostacoli: trovare "nuovi mezzi di produzione" e "nuove risorse naturali", incrementando la pressione sull'ambiente.
La concorrenza tra capitalisti fa sì «che vengano continuamente messe in azione nuove tecnologie e forme organizzative»; perché solo coloro che possiedono "una produttività più elevata" riescono a prevalere. Ma, eccoci al punto. Quando uno di questi "ostacoli alla circolazione e all'espansione del capitale" si rivela insuperabile, "l'accumulazione stagnerà o cesserà, il capitale si svaluterà (o andrà perso)" [p. 11] e il capitalismo dovrà affrontare una crisi. «In che modo dunque - scrive Harvey - l'urbanizzazione permette al capitale di superare tali ostacoli e di allargare il terreno per svolgere un'attività remunerativa? La mia ipotesi - afferma - è che l'urbanizzazione svolga un ruolo particolarmente attivo (insieme ad altri fenomeni, come le spese militari) nell'assorbire l'eccedenza prodotta dalla continua ricerca di plusvalore» [p. 12]. Segue una interessante serie di esempi storicamente determinati di processi di crisi e di impiego delle eccedenze di capitale nell'urbanizzazione a partire dal caso della Parigi di Haussmann fino all'enorme crescita urbana nei paesi emergenti del nostro tempo.
Ed ecco infine quel che Harvey ne deduce: «l'urbanizzazione ha svolto un ruolo cruciale nell'assorbimento delle eccedenze di capitale, agendo su una scala geografica sempre più ampia, ma al prezzo di processi di distruzione creativa che hanno espropriato le masse urbane di qualunque diritto alla città. Questo meccanismo - prosegue l'autore - sfocia periodicamente in rivolte, come quella degli espropriati di Parigi del 1871 che cercavano di riprendersi la città che avevano perso. I movimenti sociali urbani del 1968, da Parigi a Bangkok, a Città del Messico e Chicago, hanno analogamente cercato di definire un sistema di vita urbano diverso da quello imposto dai costruttori capitalisti e dallo Stato» [p. 34].
A seconda di come è interpretato il pensiero di Marx, si può ritenere che il capitalismo sia destinato a perire sotto il peso delle sue intime contraddizioni e a dar luogo, in senso deterministico, a una società senza classi. Oppure ritenere che ciò non è detto che accada, se non c'è un intervento rivoluzionario che faccia leva sulle contraddizioni, dando loro la soluzione voluta dagli sfruttati. Queste sono appunto opposizioni coscienti di classe, da intendersi oggi non più solo nella visione ristretta di un tempo, lavoratori di fabbrica e capitale, ma nel senso più ampio che investe ogni forma di produzione e riproduzione del capitale e dunque di spoliazione di sempre più vasti strati sociali urbani.
Harvey propende esplicitamente per quest'ultima interpretazione come viene in chiaro in tutti i suoi scritti, tra questi a esempio Diciassette contraddizioni e la fine del capitalismo (2014), dove ribadisce (autocitandosi da L'enigma del capitale): «Il capitalismo non cadrà mai da solo: dovrà essere spintonato […]. La classe capitalista non cederà mai volontariamente il potere; dovrà essere espropriata […]. Ci vorranno ovviamente un forte movimento politico e moltissimo impegno individuale».
Si pone tuttavia l'annoso problema di come condurre a unità le ribellioni che gli effetti negativi del capitalismo continuamente provocano nei diversi luoghi e nei diversi momenti dei suoi cicli di espansione e crisi. I numerosi e vari movimenti urbani esplodono, separati gli uni dagli altri, e si spengono.
Ed ecco l'ipotesi di Harvey variamente espressa anche in altri luoghi e nell'articolo in esame ribadita: «Ma se questi vari movimenti di opposizione dovessero in qualche modo incontrarsi e coalizzandosi, ad esempio, sulla parola d'ordine del diritto alla città, che cosa dovrebbero chiedere? La risposta è piuttosto semplice: un maggiore controllo democratico sulla produzione e sull'uso dell'eccedenza.Dal momento che il processo urbano ne rappresenta un importante canale di assorbimento, il diritto alla città si costituisce con l'instaurazione di un controllo democratico sulla distribuzione di tale eccedenza attraverso l'urbanizzazione. Avere un surplus di produzione non è un male: anzi, in molte situazioni è decisivo per una sopravvivenza accettabile […]. L'aumento della quota di surplus sotto il controllo dell'apparato statale funziona solo qualora lo Stato verrà riformato e riportato sotto il controllo democratico popolare» [pp. 35-36].
Harvey, nel capitolo successivo, vede nel pensiero di Lefebvre interessanti anticipazioni: «Il nostro compito politico, suggerisce Lefebvre, è immaginare e ricostruire un tipo completamente diverso di città, lontano da questo immondo bazar creato da un capitale che globalizza e urbanizza in modo sfrenato. Ma ciò non potrà accadere senza la creazione di un vigoroso movimento anticapitalista che abbia come proprio obiettivo la trasformazione della vita quotidiana nella città» [p. 50]. La teoria di un movimento rivoluzionario di Lefebvre consiste nel «convergere spontaneo in un movimento di "irruzione", quando gruppi eterotopici vedono all'improvviso, anche solo per un attimo, la possibilità di una azione collettiva per creare qualcosa di radicalmente diverso» [p. 51].
Ma «Lefebvre - mette in evidenza Harvey - era fin troppo consapevole della forza e del potere delle pratiche dominanti per non riconoscere che il compito ultimo richiedesse di sradicare tali pratiche attraverso un più ampio movimento rivoluzionario. […]. Rivendicare il diritto alla città è una tappa verso questo obiettivo. Non può mai essere un fine in sé, anche se appare in modo sempre più crescente come uno dei percorsi più propizi da seguire» [p. 52].
L'analisi che segue nel terzo capitolo sfrutta e aggiorna, per porla al centro della forma odierna del capitalismo, quella di Marx sul "capitale fittizio", avendo di fronte, tra l'altro, la crisi attuale scatenata dalla "bolla immobiliare". L'intento è di chiarire «come circolazione di capitale produttivo e fittizio si combinino all'interno del sistema del credito dei mercati immobiliari» [p. 74].
La sopravvivenza del settore edilizio «presuppone […] che possa non solo essere prodotto ma anche realizzato sul mercato. È qui che entra in gioco il capitale fittizio. Il denaro è prestato ad acquirenti che si presume abbiano la capacità di restituirlo con le loro entrate (salari e profitti). In questo modo il sistema finanziario disciplina in misura considerevole sia l'offerta che la domanda di abitazioni […].La stessa società finanziaria spesso può fornire finanziamenti sia per costruire sia per comprare ciò che era stato costruito» [p. 75].
«Ma […] mentre banchieri, immobiliaristi e imprese di costruzione si uniscono facilmente per stringere un'alleanza di classe […], i mutui dei consumatori sono individuali e divisi […]» [p. 75]. «I marxisti hanno tradizionalmente relegato queste forme di sfruttamento, e le lotte di classe […] che inevitabilmente ne nascono, ai margini della loro riflessione teorica e delle loro scelte politiche […]. Quel che voglio qui sostenere - afferma Harvey - è che invece tali forme costituiscono, almeno nelle società a capitalismo avanzato, un vasto terreno di accumulazione ottenuto con l'esproprio [più appropriato è il termine "spoliazione" n.d.r.], attraverso il quale il denaro è risucchiato nel flusso di capitale fittizio per sostenere le grandi fortune create all'interno del sistema finanziario» [p. 82].
Una delle affermazioni significative di Harvey nell'intervista che chiude il volume è la seguente: «L'urbanizzazione è essa stessa un prodotto» [p. 98] e «Il diritto alla città non è un diritto esclusivo, ma un diritto mirato. Include non solo i lavoratori edili ma anche tutti coloro che facilitano il riprodursi della vita quotidiana: badanti, insegnanti, addetti alle fognature e alla metropolitana, idraulici ed elettricisti, lavoratori ospedalieri e conduttori di camion, autobus e taxi, lavoratori dei ristoranti e intrattenitori, impiegati di banca e amministratori pubblici. È una ricerca di unità all'interno di un'incredibile varietà di spazi sociali frammentati […]. Questa è - secondo Harvey - la forza proletaria che deve essere organizzata se si vuole cambiare il mondo […]. I produttori urbani devono sollevarsi e rivendicare il loro diritto alla città che collettivamente producono» [p. 106].
Alcune considerazioni
Da almeno due secoli si confrontano riflessioni sul capitalismo e sui suoi esiti. Le principali sono raggruppabili in due poli dell'economia politica: le teorie liberali e quelle socialiste più o meno marxiste. La dimensione filosofica resta sullo sfondo e per lo più in ombra. Ma, in specie Karl Marx, è innanzitutto filosofo. Non solo, senza aver presente il senso dello strutturarsi e coerentizzarsi del pensiero filosofico è difficile venir a capo dello spazio concettuale in cui si muovono e da cui sono condizionati pensiero e agire del nostro tempo.
Lo scontro teorico e pratico tra le varie forme di liberalesimo più o meno a sostegno del capitalismo e le varie forme di socialismo più o meno contro il capitalismo è tra due opposte basi etiche sulle quali poggiare la società. Scontro che peraltro vede ancora in campo grandi etiche di più antica formazione, quali Cristianesimo e Islam. E nel clima di liberazione dalle tradizioni, oltre alle varie declinazioni della democrazia, si è creato lo spazio per il proliferare di proposte etiche differenti anche da quelle più recenti. Ciò è indizio che il coerentizzarsi del pensiero filosofico ha condotto negli ultimi due secoli alla consapevolezza che nessuna etica ha fondamento incontrovertibile: nessuna ha verità nel senso forte della tradizione.
Il pensiero di Marx è uno dei contributi significativi - ma non definitivo - in questa direzione. Quando a esempio - come cita più volte Harvey - afferma che "fra diritti uguali decide la forza". Nella forma più generale il concetto è espresso nella seconda Tesi su Feuerbach: «La questione se al pensiero umano appartenga una verità oggettiva non è una questione teoretica, ma pratica. È nella prassi che l'uomo deve dimostrare la verità […]». In base a questo principio - si noti per inciso - il "socialismo reale", stando all'esito della sua più grandiosa sperimentazione, quella sovietica, risulta storicamente una verità smentita, avendo perso lo scontro pratico col suo nemico mortale. E, a un tempo, quello stesso principio ci dice che la (apparente) vittoria del capitalismo non è verità, se non nella più assoluta contingenza storica.
Ecco, la verità nel nostro tempo è il divenire delle cose quale totalità della realtà e la conseguente impossibilità di qualsiasi immutabile a suo dominio. Il che implica la completa disponibilità delle cose alla costruzione e distruzione: l'assoluta libertà di creare e distruggere, dunque anche di rifare da capo il mondo, come, a esempio, vogliono le rivoluzioni o le utopie; e come pure opera, a scopo di profitto, la "distruzione creativa" del capitale.
Indizi se ne trovano nello stesso pensiero di Harvey laddove, a esempio, afferma «Non esiste […] una risposta non contraddittoria a una contraddizione» (Diciassette contraddizioni e la fine del capitalismo). Questo l'esito, in forma succinta, della coerentizzazione del pensiero filosofico greco emersa negli ultimi due secoli di speculazione. Tuttavia è ancora raro incontrare chi ne trae fino in fondo le conseguenze. Forse perché, oltre che irritanti sul piano etico e politico, possono risultare anche psicologicamente spaventose.
Guadagnata una relativa consapevolezza che nessuna etica può aver fondamento non smentibile, si è di fronte a una pluralità di etiche in conflitto, ciascuna determinata dal proprio scopo primario: salvezza dell'anima nelle diverse religioni, profitto, molteplici sensi del "bene comune" (democrazie, socialismi, liberalesimi e così via). A differenza del passato, vi è consapevolezza che determinante nello sconto non è la supposta verità dell'etica, da farsi valere solo in forza dell'argomentazione tesa a mostrarne incontrovertibilmente il fondamento, ma la capacità pratica di prevalere sulle avversarie, in modo tale che lo scopo primario dell'una domini i fini delle altre.
Il dominio si realizza riducendo i fini delle altre a mezzi di perseguimento dello scopo vincente. Ma stante tale logica, è impossibile che la contesa abbia fine, se non contingente. Nella nostra contingenza è per lo più dominante il capitalismo, ossia quell'agire individuale e sociale il cui scopo primario è il profitto. Di qui la riduzione a denaro, a valore venale, di ogni altro valore d'uso e godimento di qualsiasi bene materiale e immateriale. Ogni altro valore è subordinato a quello di scambio. Ogni altro fine è mezzo di perseguimento dell'accumulazione di denaro.
Ma è proprio il caso del capitalismo a rivelare, in modo ben poco equivocabile, quale sia la logica del rapporto mezzo fine. Il denaro è un potente mezzo di scambio delle merci, ossia la più rilevante tecnica economica. Il capitalismo è il rovesciamento del mezzo in scopo. Un rovesciamento, logicamente necessario, proprio perché è potenza di realizzazione di quello scopo costituito dalla volontà di scambiare le merci. Marx nel Capitale rappresenta tale rovesciamento contrapponendo due formule, dove M sta per merce e D per denaro: M-D-M, la merce è venduta in cambio di denaro allo scopo di acquistare un'altra merce, e D-M-D, la merce è acquistata col denaro allo scopo di rivenderla in cambio di una maggior somma di denaro. In tal modo il capitalista acquista potenza sul mercato rispetto a chi ha solo scambiato merci a mezzo di denaro e non denaro a mezzo di merci.
La storia, letta in questa chiave, potrebbe mostrare una lunga serie di rovesciamenti del mezzo in scopo, ben al di là del caso del denaro. In generale, posto uno scopo, che in quanto è ciò che si ha in mente di realizzare è sempre ideologico, si ha necessità di individuare, possedere e ordinare i mezzi per perseguirlo. La connessione calcolata, secondo differenti razionalità, dei mezzi al fine si chiama "tecnica". Nelle diverse epoche e culture la tecnica ha assunto varie configurazioni a seconda del senso del mondo e del tipo di razionalità che guidava l'esistenza individuale e sociale: mitologica, metafisico teologica e, nel nostro tempo, scientifico tecnologica. La tecnica è, tradizionalmente e tuttora, posta quale mezzo per perseguire scopi.
Ma così come (e lo si è visto anche leggendo Harvey) la concorrenza tra capitalisti costringe ciascuno a reinvestire il profitto (declassandolo tendenzialmente da scopo a mezzo) nell'accrescimento della produttività (potenziamento dei mezzi di produzione e realizzazione del profitto: nuove tecnologie, nuove organizzazioni del lavoro, nuove configurazioni delle leggi e delle politiche economiche, nuovi modi di governo e così via), il conflitto tra i differenti scopi posti come primari dalle diverse etiche - e tra queste e il capitalismo stesso - costringono ognuna di esse ad assumere quale scopo il potenziamento del mezzo per prevalere nello scontro pratico con le altre. È questo l'autentico "dilemma faustiano", come lo chiama Harvey, ma che non sta in relazione solo alla concorrenza tra capitalisti.
È così che si spiega il crollo, a esempio, dell'Unione Sovietica. Lo scontro pratico tra i due paesi egemoni, gli USA del capitalismo e l'URSS del comunismo, li ha condotti a potenziare, in linea di principio indefinitamente, i loro rispettivi armamenti nucleari, insieme alla scienza e la tecnologia necessarie. I Sovietici a un certo punto (in specie dopo il lancio da parte di Reagan del progetto di "scudo spaziale" o "guerre stellari") si sono resi conto che tener fermo lo scopo del comunismo avrebbe indebolito il mezzo: l'uso logora il mezzo e lo scopo è un limite al potenziamento che lo scontro pratico con lo scopo avverso continuamente richiede.
Mantenere fermo lo scopo del comunismo significava essere perdenti, continuare a potenziare il mezzo implicava lasciar tramontare lo scopo. Il dilemma faustiano, cui è destinata qualsiasi volontà etica, è stato sciolto a favore del potenziamento del mezzo.
La Russia, non più comunista, è tuttora la seconda potenza militare del mondo. Insieme agli USA detiene circa il 95% degli armamenti nucleari coi quali è possibile distruggere il mondo, rendendo improbabile una terza guerra mondiale.
Se si volge lo sguardo all'insieme dell'apparato scientifico tecnologico del nostro tempo, tenendo presente la logica del rapporto mezzo scopo sopra succintamente esposta, allora ci si può rendere conto che la tendenza che viene a determinarsi, per effetto dell'azione delle differenti etiche in conflitto, è il continuo potenziamento della capacità della tecnica nel suo complesso di realizzare scopi: qualsiasi scopo di qualsiasi orientamento etico. Il che implica che questa crescita della potenza toglie a ogni scopo etico posto come primario la pretesa di escludere gli altri e dunque la sua supposta primarietà.
In altri termini e per concludere, ciò che Harvey sembra non considerare è che spesso più che le differenti etiche a cui comunemente guardiamo e con cui spieghiamo la realtà che ci circonda è la potenza della tecnica a dominare (1). Anche lo spazio urbano. È con questo che dovremmo misurarci, qualsiasi sia la nostra idea di città e di società.
Note
(1) Rigorose speculazioni, tra le più profonde e coerenti, intorno alla tecnica, in specie alla logica del rapporto mezzo scopo, si trovano in alcuni dei numerosi scritti di Emanuele Severino, quali a esempio: Gli abitatori del tempo. Cristianesimo, marxismo, tecnica (1978); Téchne. Le radici della violenza (1979); La tendenza fondamentale del nostro tempo (1988); Il declino del capitalismo (1993); Il destino della tecnica (1998); Tecnica e architettura (2003); Capitalismo senza futuro (2012); e (con Natalino Irti) Dialogo su diritto e tecnica (2001).
«Una città in cui la povertà e le disuguaglianze sono impresse nella superficie sgualcita degli spazi pubblici, nelle periferie come nel centro, ha bisogno di altro».massimocomunemultiplo, 18 febbraio 2017 (c.m.c.)
Il progetto del Nuovo Stadio di Tor di Valle, come già le Olimpiadi Roma2024, in questi giorni monopolizza il dibattito perfino più del gossip sulla Sindaca e delle vicende giudiziarie. Si fronteggiano molti interessi e due passioni: quella per la propria squadra dei romani romanisti e quella di tanti cittadini e comitati che in quei tre grattacieli che irromperebbero nello skyline della Capitale vedono l’ennesima resa della città al potere del cemento. Eppure meriterebbe per un momento cambiare lo sguardo sulla vicenda , come in quei disegni in bianco e nero dove lo sfondo rivela altre figure.
Perchè i rendering dello Stadio e delle torri si sono presi il centro della scena, spingendo nel back stage la città reale, sovrapponendo un luminoso futuro a un irrisolto presente, come nel gioco del “prima e dopo”, cancellando nobili architetture non più desiderate e spazi incolti per sostituirli con un ordine virtuale adatto a visitatori felici e impiegati modello.
Eppure è proprio lo sfondo che ci può dire molto sulla nostra città. Basta scorrere quell’elenco di opere – impianti e strutture per la mobilità e non solo – che la delibera capitolina di Marino e Caudo hanno messo come condizione per il pubblico interesse all’operazione e che sono pagate con il surplus immobiliare di un Business center (i tre grattacieli di uffici e il centro commerciale), per capire che qualcosa non va.
Perchè molte sono infrastrutture indispensabili per la qualità della vita – ma forse sarebbe più giusto dire per la sopravvivenza – dei cittadini, che in altre metropoli europee sono di ordinaria amministrazione pubblica, mentre nella Capitale d’Italia devono invece essere racimolate nelle maglie delle operazioni del “business privato”, come in questo caso, o di grandi eventi come le Olimpiadi. Faccio tre esempi.
Primo quadro: cosa si vede in questa mappa del rischio idraulico del PAI (Piano Assetto Idrogeologico) dell’area di Tor di Valle e Torrino/Decima? Qualcuno vi trova i motivi per non realizzare lo Stadio, altri, come l’Autorità di Bacino del Fiume Tevere, i motivi per inserire la messa in sicurezza del Fosso del Vallerano tra le condizioni per realizzare lo Stadio (3). Anche perchè, secondo il PAI l’area di Tor di Valle è a rischio R3 (area azzurra), mentre l’area rossa, quella che secondo le Norme Tecniche di Attuazione del PAI è classificata come R4, cioè a massimo rischio, riguarda una zona densamente abitata . E viene da chiedersi: da quanti anni quella zona è esposta a un rischio così grave? E come mai in questo florilegio pluriennale di Vele di Calatrava, Nuove Fiere di Roma, Nuvole di Fuskas, piscine poi mai finite o finite male per i Mondiali di nuoto, nessuno ha pensato di investire soldi pubblici per mettere al sicuro gli abitanti della zona?
Secondo quadro: da vari anni ad ogni tornata elettorale i candidati si premurano di ricordarsi dei pendolari della Roma Lido, promettendo di trasformare la linea in Metropolitana leggera, trasferire al Comune la linea (oggi della Regione gestita da ATAC), potenziare i treni, aumentarne la frequenza. L’ha detto Veltroni, l’ha detto Alemanno, l’ha detto Marino. E tutto è rimasto uguale. Un servizio che è più degno di una città del quarto mondo che della Capitale d’Italia. E che (forse) potrebbe essere adeguato se si fa lo Stadio. Ma la domanda è: e se lo Stadio non si fa, ciccia?
Terzo quadro: stesso discorso per l’unificazione della Via Ostiense con la Via del Mare, una delle tratte urbane più trafficate e con più vittime per incidenti stradali. Non sappiamo se i benefici dell’intervento, che interessa il tratto dal Nodo Marconi al raccordo anulare, non rischino di essere annullati dall’aumento del flusso automobilistico per lo Stadio e per il Business center.
Si può scoprire facilmente attraverso i relativi studi trasportistici. Ma possiamo ancora una volta chiederci se nei decenni passati, prima di fare gli investimenti sopra elencati, non sarebbe stato il caso di occuparsi della sicurezza stradale dei cittadini romani. E anche se, nel caso che il progetto dello Stadio fosse cancellato o la sforbiciata alle cubature comportasse anche la sforbiciata di questa come di altre infrastrutture della mobilità, per quanto tempo rimarrebbe ancora questo micidiale status quo.
E se trovo inacettabile l’operazione Tor di Valle soprattutto a causa di quelle torri, che a mio avviso sono l’ennesima riproposizione dello scambio tra servizi pubblici indispensabili e cubature ai privati, che lo Stadio si faccia o non si faccia, sarà sempre una sconfitta o, meglio, una resa. Quella di chi, anche con le migliori intenzioni, per mettere in cantiere opere che il pubblico non può pagare (ma anche questo è tutto da dimostrare) continua a cercare di approfittare di occasioni che – ce lo dice la storia della città – troppo spesso perdono poi per strada ogni utilità collettiva. Anche perchè troppo spesso nessuno fa patti chiari prima, controlli durante e verifiche dopo.
Ma anche se si rispettassero fino in fondo le prescrizioni sulle opere e sui tempi, non mi convince la solita “narrazione” dei posti di lavoro e dello sviluppo economico che la nuova centralità annessa allo Stadio porterebbe alla città. E’ un discorso lungo, ci sono anche studi dell’università, ma quello che voglio dire è che, anche in questo caso, mi sembra che si continui ad inseguire una modernità che non è moderna per niente.
Perchè continua a puntare su un modello che sta implodendo, che continua a mettere avanti il settore edilizio e a proporre nuovi centri direzionali e commerciali in una città in cui gli uffici non trovano affittuari e i negozi di prossimità come le grosse catene chiudono i battenti per mancanza di clienti.E una città in cui la povertà e le disuguaglianze sono impresse nella superficie sgualcita degli spazi pubblici, nelle periferie come nel centro, ha bisogno di altro.
In questi giorni è tornata al centro del dibattito anche Mafia Capitale. Per molti si è trattato di un’esagerazione, o non è mai esistita. Eppure basta cambiare sguardo e se ne possono vedere le tracce in ogni anfratto della nostra città, nelle strade senza manutenzione, nelle aree verdi non curate, negli autobus scalcinati, negli abusi edilizi, nella gente che dorme in macchina , nei tavolini che occupano illegalmente i marciapiedi, nelle liste d’attesa per un esame medico urgente. E anche nel “si salvi chi può” del cittadino arreso, che difende il suo spazio da chiunque, senza solidarietà e sguardo al futuro. Neanche per i suoi figli.
E quelle tre torri svettanti in scenari notturni con ponti e passerelle luminose sembrano un’astronave aliena atterrata provvisoriamente in un pianeta tornato allo stato selvaggio.
 Facce di bronzo. «Le imprese del Consorzio Venezia Nuova chiedono di tornare all’assegnazione diretta dei lavori, senza gare di appalto, ovvero a quel sistema che ha consentito il proliferare del malaffare».il Fatto Quotidiano online, 19 febbraio 2017 (p.s.)
Facce di bronzo. «Le imprese del Consorzio Venezia Nuova chiedono di tornare all’assegnazione diretta dei lavori, senza gare di appalto, ovvero a quel sistema che ha consentito il proliferare del malaffare».il Fatto Quotidiano online, 19 febbraio 2017 (p.s.)
Lo scontro avviene nello scenario di un commissariamento che le aziende non hanno digerito affatto, perché ha tagliato la catena di potere che orchestrava i grandi affari legati alle paratie mobili che dovrebbero salvare Venezia dalle acque alte.Intanto al processo veneziano hanno fatto irruzione le agende di Giovanni Mazzacurati. Erano in un magazzino del Consorzio, dentro uno scatolone.
Come se non fosse successo nulla. Come non ci fosse stato l’allegro balletto del Consorzio Venezia Nuova attorno al Mose, opera da cinque miliardi e mezzo di euro. Come non ci fossero state le accuse di corruzione ai manager delle società che fanno parte della compagine che negli ultimi quindici anni si è spartita i finanziamenti pubblici. Come non ci fosse il commissariamento deciso per bonificare la situazione all’indomani dello scandalo che nel 2014 ha portato in carcere politici, uomini degli apparati dello Stato, tecnici e portaborse.
Le imprese del Consorzio Venezia Nuova chiedono di tornare all’assegnazione diretta dei lavori. Senza gare di appalto. Senza bandi. Senza offerte e ribassi. Ovvero a quel sistema che ha consentito il proliferare del malaffare, per il semplice fatto che non esistevano controlli sulle opere e sui costi, anche perché i vertici del Magistrato alla Acque dell’epoca erano, secondo i corposi capi d’accusa formulati dalla Procura di Venezia, a libro-paga del Consorzio.
In questo tentativo di far tornare indietro la macchina del tempo, le imprese interessate hanno scritto un «Atto di contestazione di inadempimento e intimidazione». Il mittente è il Covela del gruppo Mantovani, di cui è presidente Romeo Chiarotto, titolare del gruppo stesso. Lo ha fatto per conto anche dei consorzi Italvenezia e San Marco, nonché di Astaldi e Itinera.
I destinatari sono i tre commissari Luigi Magistro, Francesco Ossola e Giuseppe Fiengo, nonché il provveditore interregionale Roberto Linetti (che ha assunto le funzioni dell’ex Magistrato alle Acque), il presidente dell’Anac, l’Autorità Nazionale Anticorruzione, Raffaele Cantone e il prefetto di Roma Paola Basilone, a cui fa riferimento l’amministrazione straodinaria del Consorzio.
La lettera-diffida ricorda che nel 2015 il piano di riparto affidava alle imprese del Cvn lavori per 192 milioni di euro, ma finora ne sarebbero stati assegnati molto meno, circa una novantina. E così le imprese chiedono il rispetto degli impegni presi due anni fa. «E’ una situazione inaccettabile, illegittima, illecita e gravemente lesiva dei nostri diritti».
A sostegno della sua tesi, Chiarotto cita lo statuto del Consorzio che affidava i lavori pro quota-parte alle imprese consorziate.
E cita anche le conclusioni dell’istruttoria europea che una decina di anni fa mise in mora l’Italia per la mancanza di gare pubbliche, salvo poi stabilire che per una serie di interventi andava garantita la continuità ai consorziati, anche perché la responsabilità sul funzionamento dell’opera dev’essere a carico loro. «L’Unione europea – scrive Chiarotto – ha definitivamente escluso che si potesse ricorrere a imprese terze, se non per il subappalto di opere altamente specialistiche per le quali non esistsessero i requisiti tra le imprese consorziate».
Allora la Ue cercò di contemperare una parziale assegnazione diretta con l’obbligo a mettere in gara opere per almeno 720 milioni di euro (obiettivo non ancora raggiunto). Ma se gli appalti tornano ad essere assegnati con il vecchio modus operandi a cui fa riferimento Chiarotto, si riprodurrebbe il meccanismo che tanti guasti ha causato, fino alle aule del Tribunale penale.
E proprio l’Anac, con il commissariamento del Consorzio, voleva porre fine a quel sistema. Anzi, nel 2015 aveva commissariato anche la società Comar, sostenendo che dal 2002 era il braccio operativo del Consorzio per consentire il controllo nell’assegnazione degli appalti. Dopo l’arrivo in autunno a Venezia del nuovo provveditore Linetti, l’ex Magistrato e i commissari avevano progettato di aumentare ancora le quote di lavori da assegnare con gara. Anche per questo Mantovani, Astaldi e Itinera sono uscite alla scoperto.
E’ uno scontro che avviene nello scenario di un commissariamento che le aziende non hanno digerito affatto, perché ha tagliato la catena di potere che orchestrava i grandi affari legati alle paratie mobili che dovrebbero salvare Venezia dalle acque alte. Ma gli arresti hanno costretto le imprese del Cvn a mandare giù il rospo. Adesso, tre anni dopo, cercano di riprendersi parte di quello che hanno perso. Nel Mose del dopo-scandalo ci sono ancora tanti soldi presenti e futuri (ad esempio al gestione del sistema) ed è proprio sulla questione economica che si annunciano gli scontri più aspri.
I commissari hanno deciso da tempo di far causa alle imprese coinvolte nelle inchieste per ottenere un risarcimento di almeno 27 milioni di euro, per inadempienze e pagamenti “in nero”. Si tratta di 18 soggetti diversi, tra cui Mantovani e Condotte. La Procura veneziana ha chiuso da poco il filone di indagine relativo alla vicenda Mose che vede coinvolte direttamente otto imprese (e non le persone fisiche) che hanno lavorato alle barriere mobili o alle opere accessorie per non aver controllato i loro manager che pagavano tangenti per sostenere l’opera a livello politico.
Intanto il processo che si sta svolgendo a Venezia entra in una settimana cruciale. Giovedì l’interrogatorio di due imputati eccellenti, l’ex ministro Altero Matteoli e l’ex sindaco di Venezia, Giorgio Orsoni. E nel dibattimento fanno irruzione le agende di Giovanni Mazzacurati. Erano in un magazzino del Consorzio, dentro uno scatolone. Contengono le annotazioni di tutti gli appuntamenti dell’ingegnere, già presidente del Cvn e grande regista della corruzione. I pubblici ministeri Stefano Ancilotto e Stefano Buccini, ma anche gli avvocati difensori vi cercano conferme o smentite di incontri e frequentazioni in odore di tangenti.
Riferimenti
Vedi su eddyburg l'articolo di Armando Danella Venezia, il rischio MoSE, che racconta fatti clamorosi che tutti fanno finta di non conoscere. Inoltre i numerosi articoli nelle cartelle dedicate al MoSE nel vecchio e nel nuovo archivio.