 «Secondo gli esperti, siamo sul punto di giungere ad un punto di svolta sociale, con la produzione di energia eolica e solare in grande espansione». RegionieAmbiente, 4 luglio 2017 (c.m.c.)
«Secondo gli esperti, siamo sul punto di giungere ad un punto di svolta sociale, con la produzione di energia eolica e solare in grande espansione». RegionieAmbiente, 4 luglio 2017 (c.m.c.)


 «La legge regionale lombarda n.31/2014 così come recentemente modificata, sembra avviata, paradossalmente, ad accelerare l’attuazione delle aree programmate rimettendo in gioco anche quelle ferme da tempo». millenniourbano, 4 luglio 2017 (c.m.c.)
«La legge regionale lombarda n.31/2014 così come recentemente modificata, sembra avviata, paradossalmente, ad accelerare l’attuazione delle aree programmate rimettendo in gioco anche quelle ferme da tempo». millenniourbano, 4 luglio 2017 (c.m.c.)
Il Consiglio della Regione Lombardia nella seduta del 23 maggio 2017 ha approvato una significativa modifica alla LR 31/2014 e ha contemporaneamente adottato la variante del PTR (Piano Territoriale Regionale) in attuazione di quanto previsto a fine 2014 dalla medesima legge approvata nell’autunno di quello stesso anno. La legge prevede di fissare attraverso il PTR soglie per una progressiva riduzione dell’elevato quantitativo di aree programmate e non attuate esistente nei piani comunali, e definisce a tale fine un periodo transitorio di moratoria, di circa 2 anni, entro il quale i comuni possono fare unicamente varianti di riorganizzazione dei piani, ma non possono prevedere il consumo di nuovo suolo agricolo (1).
I contenuti della prima bozza degli elaborati del PTR erano stati commentati su questo sito ad aprile 2016 (2), manifestando molte perplessità sulla loro possibile efficacia ai fini del contenimento del consumo di suolo. Gli elaborati del PTR adottato a maggio sono stati alleggeriti e resi più leggibili rispetto alla prima bozza, ma l’impostazione attuativa è rimasta invariata. In ogni caso quel poco di utile che il PTR poteva portare alla pianificazione di area vasta rischia di essere neutralizzato dai sorprendenti contenuti della contemporanea modifica alla LR 31/2014. Il tema è molto tecnico e complesso. Provo qui a sviluppare qualche considerazione preliminare attraverso un’esposizione semplificata dei contenuti della modifica, senza addentrarmi nei dettagli, per dare un’idea degli effetti che ne deriveranno.
La LR 31/2014 nel suo testo originario aveva previsto un percorso attuativo lineare, attraverso un PTR che dettasse gli indirizzi, da declinare successivamente nei PTCP/PTM (Piani Territoriali di Coordinamento Porivnciale / Piano Territoriale Metropolitano) secondo le specificità delle singole province e della Città metropolitana, e infine da attuare operativamente nei piani comunali secondo le disposizioni dei piani provinciali e metropolitano. Il tutto era calendarizzato secondo tempi stringenti, e fino all’approvazione dei PTCP/PTM le possibilità di modificare la pianificazione comunale venivano molto limitate. Il percorso è entrato in crisi quando ANCI ha fatto notare che i tempi si stavano allungando troppo: l’adeguamento del PTR ha infatti già oggi accumulato un ritardo di quasi due anni, e i PTCP probabilmente richiederanno molto più dei 12 mesi originariamente previsti.
La Regione ha così adottato una variante alla legge che ha di fatto eliminato l’obbligo per i comuni di attendere l’approvazione delle varianti dei PTCP/PTM, permettendo da subito di attuare direttamente quanto previsto dalla LR 31/2014 attraverso una sorta di autocertificazione dei comuni stessi. Gli effetti negativi della modifica normativa non si fermano qui, ve ne sono altri, che rischiano di portare al risultato esattamente opposto a quel contenimento di consumo di suolo che è fin dal titolo dichiarato come obiettivo principale della legge.
Per tutto il periodo fino all’adeguamento dei PTCP i comuni possono modificare il PGT (Piano di Governo del Territorio) a patto di realizzare un “Bilancio ecologico sostenibile” (così definito dalla legge) pari a zero. In parole semplici nel PGT per prevedere nuovi ambiti di trasformazione che impegnano suolo agricolo si deve contemporaneamente ridestinare ad uso agricolo almeno una pari quantità di superficie programmata ma non ancora attuata. Accade così che previsioni insediative che fino ad oggi non sono state attuate perché poco appetibili per il mercato si trovano improvvisamente ad assumere un valore, potendo essere scambiate per rendere edificabile una zona agricola più appetibile collocata in un’altra parte del territorio comunale.
Di fatto la modifica alla legge ha attivato un plusvalore, una sorta di rendita fondiaria, un regalo per i fortunati proprietari delle aree programmate, comprese tutte quelle società e banche che nel periodo di crescita immobiliare, prima del 2007, avevano acquisito e inserito nei loro bilanci ampie aree con prospettive edificatorie. Inoltre, a quantitativo complessivo bloccato i proprietari delle aree oggi programmate si trovano in pratica ad operare in una situazione di quasi monopolio.
Fino a ieri il mercato immobiliare fermo spingeva molti proprietari ad accettare nel PGT il ritorno a destinazione agricola delle aree programmate per evitare di continuare a pagare le salate tasse collegate con la previsione edificatoria. In questi due anni dopo l’entrata in vigore della L 31/2014 i pochi comuni che si sono avventurati nella variazione del proprio PGT hanno potuto ridurre in modo consistente le aree programmate, anche oltre il 50%, in generale senza resistenze da parte dei proprietari, con qualche eccezione. Ora, la prospettiva di potere rimettere in gioco in altri settori comunali i diritti edificatori, anche mediante permute, restituisce interesse ai proprietari. Qualche primo segnale in tale senso si vede già a un solo mese dall’approvazione della variante normativa. La legge sul contenimento del consumo di suolo così modificata sembra avviata, paradossalmente, ad accelerare l’attuazione delle aree programmate rimettendo in gioco anche quelle ferme da tempo e meno appetibili per il mercato.
Il fatto che l’approvazione dei PTCP non sia più condizione preliminare necessaria per variare i PGT allontanerà probabilmente nel tempo la redazione delle varianti dei PTCP, almeno fino a quando non si arriverà vicini all’esaurimento del quantitativo di aree programmate attraverso permute e riprogrammazioni in zone più favorevoli. Teniamo presente che oggi negli organi delle province ci sono gli amministratori comunali, e a loro spetta la decisione di quando avviare le modifiche al PTCP.
Unica via d’uscita, almeno per il periodo di transizione fino all’approvazione dei PTCP, è di rafforzare le verifiche di compatibilità delle province sui piani comunali, anche utilizzando gli importanti principi sul ruolo dei piani provinciali affermati dal Consiglio di Stato a giugno 2016 (3). La modifica alla LR 31/2014 attribuisce alle province, questo è un aspetto positivo, il compito di verificare i PGT rispetto ai criteri generali del PTR. Considerando che già oggi molti dei PTCP vigenti contengono indicazioni dettagliate che in parte si sovrappongono ai criteri generali del PTR, basterebbe raccoglierle e creare un quadro di corrispondenze rispetto a ciascuno dei criteri regionali per fornire un utile riferimento ai tecnici provinciali che hanno il compito di verificare i PGT. Tutto questo potrebbe essere fatto a normativa invariata, in attesa delle varianti dei PTCP, semplicemente riorganizzando quanto le province hanno già fatto fino ad oggi.
(1) Sulla LR 31/2014 vedere intervento su Arcipelago Milano 3 dicembre 2016.
(2) Sulla proposta di PTR vedere serie di 3 articoli su Millennio Urbano del 27 , 30 marzo , 4 aprile 2016.
(3) Sentenza del Consiglio di Stato n.2921/2016 nella quale viene definita la funzione di coordinamento territoriale sui temi di area vasta; vedere articolo su Arcipelago Milano del 13 luglio 2016.
Traslato sull’ambiente urbano, l’estrattivismo assume i tratti di accumulazione di capitale a spese della città, che è, per definizione, costruzione collettiva e bene comune, nonché giacimento limitato. Tale modello si manifesta nelle alienazioni degli edifici pubblici, nella privatizzazione delle imprese pubbliche, dei servizi e delle risorse primarie (acqua etc.), nella chiusura di parti di città (si ricordi la cena Ferrari sul Ponte Vecchio), nella locazione di sale monumentali e musei, nella brandizzazione, ossia nella collocazione del marchio cittadino (il brand) sui mercati immobiliari e finanziari globali. Nella creazione del brand, l’Unesco ha un ruolo non secondario (Choay). Si tratta, insomma, di un meccanismo di produzione di denaro attraverso l’acquisizione privata (indebita e sotto costo) di patrimonio pubblico. Senza neanche la contropartita di lavoro dignitoso e impiego di lunga durata che pure era offerta dal capitalismo temperato dalla socialdemocrazia.
È il caso del colosso statunitense Airbnb[3]. A dispetto delle premesse (in nome dell’economia della condivisione) Airbnb crea diseguaglianze tra piccoli locatori e grandi agenzie che gestiscono per conto terzi centinaia di appartamenti. Il fenomeno è pervasivo: a Firenze oltre il 18% dell’intero patrimonio immobiliare del centro storico è un b&b promosso dalla piattaforma americana[4]. La massima parte è costituita da interi appartamenti in affitto gestiti da terzi, poche invece le singole stanze presso famiglie. È un dato che dimostra peraltro l’internità dei cittadini alle dinamiche estrattive. Ricordo che a Firenze, nel 2016, si sono registrate 9 milioni e 391.000 presenze (fonte: Città metropolitana di Firenze, Centro Studi Turistici) che hanno insistito principalmente sull’area centrale abitata da 52.527 persone[5].
Con l’esperienza della delibera Filangieri, a Napoli è stata messa in campo una possibilità concreta da perfezionare ed estendere alle altre città italiane. La delibera fa leva sulla categoria giuridica di “bene comune” e riconosce ad alcune esperienze autogestite di riappropriazione di edifici dismessi il «valore sociale di ambienti di sviluppo civico», e come tali le ritiene strategiche garantendo le condizioni di sopravvivenza alle microresistenze urbane.
Proprio mentre stiamo parlando, a Mondeggi si festeggiano i tre anni di presidio della tenuta messa in vendita dalla Città metropolitana, tre anni di custodia popolare delle terre e di sperimentazione collettiva di autogoverno. Si tratta di un progetto a scala locale che potrebbe essere declinato in chiave urbana, ad esempio alla scala rionale. Sul modello dell’autonomia municipalista, di rione, teorizzata da Murray Bookchin.
Esempi interessanti, tra gli altri, provengono da: “Facciamocispazio”, laboratorio rionale “dal basso”promosso da comitati e associazioni (Giardino San Jacopino, Leopolda Viva, ex FIAT Belfiore-Marcello, e Tutela dell’ex Manifattura Tabacchi); da inKiostro, luogo di «agibilità sociale» a disposizione per le realtà di movimento attive in un centro storico deprivato di spazi per momenti di incontro, confronto e lotta; o da La Polveriera Spazio Comune che, nell’ambito delle proprie attività in un ambiente dismesso dal DSU (agenzia per il diritto allo studio universitario), mette in relazione un quartiere del centro storico con le produzioni “genuine e clandestine” del contado e lavora per rafforzare l’alleanza città-campagna.
Poiché lo spazio pubblico è testimonianza e garanzia di vita civica, e ne rappresenta la possibilità di riproduzione nel futuro, l’alienazione degli immobili pubblici spossessa la cittadinanza di progettualità sul proprio ambiente di vita. Il progetto locale, urbano e rionale, farà leva dunque sulla presenza – ancora in mano pubblica – di grandi “contenitori storici” che, per localizzazione centrale, qualità architettonica e superficie, costituiscono l’importante occasione per un’intrapresa collettiva che dia vita ad alternative d’uso risolutive dei mali urbani sopra velocemente descritti. Tali immobili rappresentano inoltre la possibilità concreta di restituire all’uso cittadino edifici un tempo luogo del potere e dei soprusi: il palazzo, la caserma, il convento, il carcere, il manicomio. Molti dei quali, essendo edifici nati per la residenza collettiva, possono oggi essere convertiti in luoghi di accoglienza dei migranti e delle migliaia di persone che vivono il disagio abitativo. I rioni trarrebbero forza dalla presenza di questo nuovo afflusso di vita urbana.
Restituire disponibilità e funzioni collettive ai contenitori storici intra moenia contribuisce a restituire ai quartieri centrali quel carattere di promiscuità d’usi e di vissuti, che è il primo presidio contro la mercificazione e la desertificazione degli spazi urbani. Contro la monocoltura del lusso.
[2] Raúl Zibechi, L’estrattivismo come cultura, “comune.info”, 31 ottobre 2016; Id., La nuova corsa all’oro Società estrattiviste e rapina, camminardomandando/Re:Common, 2016.
[3] Molto ne è stato scritto recentemente su quotidiani e riviste anche a seguito della pubblicazione di uno studio di ricercatori dell’Università di Siena (S. Picascia, A. Romano, M. Teobaldi, The airification of cities: making sense of the impact of peer to peer short term letting on urban functions and economy, “Proceedings of the Annual Congress of the Association of European Schools of Planning”, Lisbon 11-14 July 2017).
[4] Ernesto Ferrara, Case in centro ma ricavi per pochi. Così Airbnb ha invaso l’Italia, “la Repubblica”, 12 giugno 2017, che riprende i dati del succitato saggio di Picascia et al.
[5] Firenze “invasa” dai turisti, la fuga dei fiorentini: via in 20mila dal centro, “Corriere fiorentino”, 13 ottobre 2016.
[6] Su questi temi si veda la riflessione di carattere generale: Giorgio Grappi, Logistica, Ediesse, Roma, 2016. Qui il video della presentazione del libro, a cura di perUnaltracittà.
[7] Così in un filmato pubblicitario delle ferrovie statali, risalente al 2013.
[9] Rimando al mio Alienazioni a Firenze. O la metamorfosi dell’urbanistica in ragioneria, “La Città invisibile”, 17 febbraio 2017.
[10] Sempre in tema di alloggi popolari, il 2 marzo 2017 Nardella affermava ai microfoni di una radio locale che «Il vincolo dei 5 anni di residenza è troppo poco, bisogna aumentarlo. […] Vuoi avere un alloggio popolare? Bene, devi essere residente da almeno 10 anni in Italia». Avviandosi verso la sublime conclusione: «Tu, famiglia rom, non mandi il figlio a scuola, allora devi esseri punito e tra la punizione ti levo anche la casa. Non è una questione di razzismo, io combatto il razzismo, ma di civiltà» (cfr. Alessandro De Angeli, Le case impopolari/2 – I numeri di Nardella, ovvero Nardella dà i numeri, “La Città invisibile”, 10 aprile 2017; ma anche Nardella: «Troppi immigrati nelle case popolari. Il rischio è che si creino dei ghetti», “La Nazione”, 3 marzo 2017).
Una volta si parlava correntemente di urbanistica come idea di città complessiva, ma forse già covava qualcosa di sbagliato, e lo si doveva capire guardando certi «progetti ideali» cavati dal cappellino di prestidigitazione degli ubiqui studi di architettura. Non per discutere la qualità di quei progetti, nessuno vuol contestare nulla in quel senso, ma proprio il metodo. Ricordo di averne usato uno (uno fra i tanti che però aveva il vantaggio, non da poco, di essere integralmente disponibile, e orgogliosamente pubblicato da Urbanistica, organo ufficiale e istituzionale) per cercare di spiegare un pochino alle menti aperte degli studenti di pianificazione del territorio, cosa avrebbe dovuto in teoria distinguere il loro approccio da quello dei progettisti tout court. Si trattava di uno di quei «quartieri autosufficienti», ideologicamente concepiti come tali e cacciati nella più bieca estrema periferia extraurbana, nella fase matura e discendente di quel genere di trasformazioni, dopo che dal punto di vista simbolico erano già girate in tutto il mondo le riprese della morte dell’architettura-urbanistica moderna, con le cariche di dinamite a tirar giù gli stecconi del Pruitt-Igoe di Minoru Yamasaki. Il fatto più significativo e abbastanza spudorato, di quel progetto, era la vera e propria cancellazione dell’urbanistica, ridotta a puro fatto tecnico e autoreferenziale, in cui i retini e le norme arrivavano a valle del progetto, anziché precederlo immediatamente alla fine di tutt’altro percorso logico. Metafora illuminante, quei retini già sgocciolanti di rendering (anche se allora non si usava la pratica, pudicamente contenuta in qualche schizzo prospettico a china e matita «per dare l’idea»).
IL DIBATTITO SUL
TUNNEL A MISSORI
di a.m. e i.c.
Analisi del malessere crescente che porta in piazza migliaia di persone di provenienza diversa. Articoli di Claudia Fornasier e Alon Altaras. Corriere del Veneto online e il Fatto Quotidiano, 3-4 luglio 2017 (m.p.r.)
la Nuova Venezia, 4 luglio 2017
GLI SQUILLI DELL'ALTRA VENEZIA
di Claudia Fornasier
La prima volta è stato il funerale di Venezia, nel 2009, un po’ protesta, un po’ goliardia, con qualche decina di persone. Sette anni dopo, alla protesta dei carrelli della spesa (organizzata dai giovani di Generazione 90), i veneziani in manifestazione erano 500 e altri 500 al corteo dei trolley e a quello delle lenzuola appese alle finestre dei palazzi, con lo slogan «Venezia è il mio futuro». Domenica i cittadini che sono sfilati tra le calli al grido di «mi no vado via» erano quadruplicati. In mezzo c’è stato il contestato referendum sulle navi fuori dalla laguna, organizzato dai No Nav, con i suoi 18 mila partecipanti. Per qualcuno sono i «nemici» della giunta Brugnaro, per altri la sinistra nostalgica, i reduci del movimento ambientalista. Loro si definiscono la città che resiste. Può darsi non siano rappresentativi di tutti i veneziani, ma sono il segnale di un malumore crescente e insieme di una spinta civica che non può essere liquidata con il timbro di «opposizione».
Domenica in corteo c’era la sinistra ma anche la destra, proprietari di immobili, architetti, professionisti, dipendenti pubblici e gente che lavora nel turismo, pensionati, separatisti, anti separatisti, partigiani, artigiani, accomunati dal sentirsi ogni giorno più orfani di un tessuto sociale ed economico che possa definirsi «cittadino». Venezia non è l’unica città a soffrirne. Tutte le capitali dell’arte, soprattutto con centri storici piccoli, devono affrontare il paradosso di vivere e di «morire» di turismo. La città d’acqua ne è l’avanguardia, per i suoi numeri micro (l’estensione) e macro (29 milioni di turisti l’anno), per la rapidità con cui il fenomeno si espande alle isole e a Mestre, dove già scarseggiano le case in affitto a favore di Airbnb. E i proprietari non sono certo stranieri. Mille a protestare, gli altri 49 mila a fare il check-in del b&b ha titolato Lo Schitto, giornale satirico popolare nei social network. Alla velocità di espansione del turismo non corrisponde la velocità delle idee e degli atti amministrativi adatti a gestire i nuovi fenomeni, per trovare un equilibrio tra l’immensa ricchezza che porta a tutta la Città metropolitana e gli effetti da tornado su attività storiche, affitti, prezzi, artigianato.
Il governo non ha ancora indicato una strategia complessiva per le città d’arte e le loro specificità. La Regione ha votato una legge sul turismo adatta al Veneto ma non a Venezia. Il Comune ha mosso i primi passi con la delibera sul blocco dei cambi d’uso, ma con una lista di eccezioni così ampia da renderla meno coraggiosa di quanto poteva essere. Perfino l’Unesco di fronte alla complessità del problema e alla realizzabilità delle ipotesi in campo ha preso tempo... due anni. Ma tempo rischia di essercene poco. Perché rispetto ai grandi dibattiti del passato, oggi non c’è un progetto di Città metropolitana e c’è il quinto referendum per la separazione di Venezia e Mestre alle porte, a cui sempre più cittadini guardano come tentativo in extremis (qualcuno sì di interrompere l’esperienza Brugnaro) di risolvere il problema del turismo, con una sorta di autogestione.
Venezia, Pisa, Napoli, Palermo sono, nella maggior parte dei casi, patrimonio dell’Umanità e non mi riferisco tanto a un’etichetta formale, a uno statuto dato da un’organizzazione mondiale, ma a una realtà tangibile e visibile che tutti i visitatori, istruiti o meno, sentono.
Venezia non è di Brugnaro. Una vittoria politica è un fenomeno passeggero, di breve durata, mentre il danno che fa l’entrata in laguna delle grandi navi (una visione inquietante, poiché sono alte quasi quanto il campanile di San Marco) è permanente, colpisce le rive, erode le fondamenta dei palazzi, dei monumenti che sono la ragione per cui il mondo viene a vedere Venezia.
Negli ultimi due anni, da quando si è insediato il sindaco attuale, 1.600 persone hanno lasciato la città, proprio quel Brugnaro che aveva promesso di riportarne 30mila: una fake promessa, la chiamerebbe Donald Trump nei suoi tweet notturni.
Sei anni fa ho lasciato Tel Aviv per vivere a Venezia. Già dai primi giorni mi aveva colpito vedere, nella vetrina di una farmacia a pochi metri dal monumento di Goldoni in campo San Bartolomeo, le cifre che indicavano il numero degli abitanti di Venezia. Mi pare fossero 60mila. Oggi quella vetrina segnala che ce ne sono meno di 55mila. Ma duemila dei suoi cittadini, domenica 2 luglio hanno deciso di ribellarsi ad una visione della città che di fatto li vuole allontanare.
Una cinquantina di associazioni: Fai, Italia Nostra e Confartigianato, coordinate da Venezia mio futuro, è partita dall’Arsenale (sì, quell’Arsenale da cui uscivano le galee e galeazze della Serenissima) per arrivare non lontano dal Palazzo Ducale. Duemila cittadini che hanno gridato “non vogliamo andare via”, “basta alberghi a Venezia”, “più residenti meno turisti”. Si è trattato di una manifestazione pacifica con un chiaro messaggio all’autorità politica: fermatevi! guardate bene ciò che amministrate: non è un casinò, né un cantiere edile o una squadra di pallacanestro!
Espropriazione dei beni comuni in Polonia, la destra populista autorizza il disboscamento dell’ultima foresta vergine Europea, il Manifesto, 4 Luglio, (i.b.)
Una parte della Polonia piange i suoi alberi e lancia un appello alla comunità internazionale. La speranza è quella che la Conferenza del Patrimonio mondiale, in programma a Cracovia fino al prossimo 12 luglio, possa sensibilizzare l’Unesco sul disboscamento di Bialowieza, l’unica foresta vergine rimasta sul continente europeo, vittima di un piccolo coleottero, il bostrico e del governo.
Negli ultimi mesi la mobilitazione ha portato diversi attivisti, alcuni dei quali giunti da Romania e Repubblica Ceca, a incatenarsi agli alberi, mentre altri hanno provato a ostacolare le cesoie forestali al lavoro. Adesso sono arrivati anche i primi fermi e multe. C’è ancora una parte del paese capace di indignarsi e che spera in un «Rospuda-bis», quando nel 2009 dopo otto anni di battaglie, il governo fu costretto a deviare il percorso di un’autostrada che sarebbe dovuta passare attraverso l’omonima valle. Le proteste cracoviane culmineranno in un happening previsto nella giornata di oggi. Una mobilitazione che porterà in strada numerose sigle e Ong: Greenpeace, Wwf, ma anche Fundacja Dzika Polska, Greenmind e Pracownia na rzecz Wszystkich Istot.
Il ministro dell’ambiente polacco Jan Szyszko ha dichiarato che l’argomento non è finito in agenda a Cracovia. Ma l’Unesco starebbe valutando proprio in questi giorni l’invio di un’altra missione di monitoraggio a Varsavia.
Quasi la metà della foresta, che si estende per oltre 3.000 km² tra Polonia e Bielorussia, è protetta come parco nazionale. La presenza di zone cuscinetto e di oasi protette all’interno di Bialowieza, contribuisce a disegnare una mappa amministrativa complessa del parco, dove lo sfruttamento per uso commerciale dei boschi, ai margini dell’aree strettamente protette, è comunque consentito. E lì che il governo della destra populista Diritto e giustizia (PiS) ha deciso l’anno scorso di triplicare il limite al volume di legno recuperabile da Bialowieza. Un’iniziativa, che con buona pace anche degli entomologi, mette a repentaglio tutta la biosfera della foresta. La decisione è stata giustificata dalla diffusione incontrollata del bostrico o tipografo dell’abete rosso, che continua a lasciare il segno in tutti i boschi europei. Abbattere gli alberi di Bialowieza «è il male minore», secondo il ministro Szyszko.
A fare il gioco del partito fondato dai fratelli Kaczynski, c’è anche l’allarmismo di una certa stampa locale che tende a presentare la diffusione del bostrico alla stregua di un’epidemia incontrollabile. Eppure, uno studio del 2008 sull’impatto del bostrico nel parco nazionale di Sumava in Repubblica ceca, ha mostrato un maggior impoverimento del sottobosco nelle aree sottoposte a un abbattimento preventivo. Più in generale, buona parte della comunità scientifica concorda sul fatto che gli alberi vittime del bostrico e il legno morto dovrebbero restare al proprio posto: i tronchi vecchi o caduti attaccati dal tipografo infatti trasformano il legno in humus. Ed è proprio questo a preoccupare maggiormente il governo che non intende rinunciare allo sfruttamento della legna. Che finisca nei camini o venga venduta ai mobilifici poco importa.
La strategia perseguita dal PiS a Bialowieza è solo uno dei tasselli nella disastrosa politica ambientale del governo. Un esempio, la cosiddetta lex Szyszko approvata in sordina dalla maggioranza a dicembre scorso. Il provvedimento in vigore nel 2017 ha autorizzato l’abbattimento degli alberi su un suolo privato senza il via libera della autorità locali. Mettendo insieme i dati raccolti sul territorio polacco si stima che le motoseghe abbiamo fatto fuori almeno 300.000 alberi dall’inizio di quest’anno. Una sorta di condono ecologico «a tempo» durato cinque mesi prima che il governo ponesse nuovamente alcune restrizioni in materia. Il maggior beneficiario delle politiche di Szysko è l’Azienda delle foreste statali polacche, Lasy Panstwowe, che gestisce per conto del governo una superficie pari quasi al 30% del paese. L’amministrazione forestale da lavoro a oltre 26.000 persone e garantisce salari di oltre 6.000 zlotych al mese (circa 1.500 euro) ai suoi dipendenti, oltre il doppio dello stipendio medio in Polonia. Compensi lauti paragonabili soltanto a quelli del settore minerario: legno e carbone, appunto. Da un punto di vista giuridico si tratta di un’azienda statale ibrida che autofinanzia le proprie attività, versa alcune tasse agli enti locali ma senza beneficiare del gettito fiscale dei contribuenti. Un giocattolo difficile da smontare, insomma, anche a medio termine. Il direttore dell’azienda, Konrad Tomaszewski, cugino del numero uno del PiS Lech Kaczynski, continua a paragonare in pubblico l’ecologia a una forma di «nazismo verde». Trasportare, piantare nuovi alberi e tagliare tronchi per conto degli enti locali: un circolo vizioso che permette all’autorità forestale di fare e disfare la tela a piacimento per generare profitti.
«Bialowieza è prima di tutto il risultato dell’intervento dell’uomo nel corso della storia», ha ripetuto come un mantra negli ultimi mesi Szyszko. La natura ridotta a merce è fatta per l’uomo e non il contrario: è questo il messaggio che vuole lanciare la Polonia «orbanizzata» ai tempi del PiS. Ma la foresta primaria di Bialowieza non è un hortus conclusus da potare con le cesoie. E con questi argomenti Szyszko non è riuscito a scongiurare l’intervento di Bruxelles visto che la foresta fa parte anche del programma Ue Rete Natura 2000. Intanto la battaglia per un’altra Rospuda è appena cominciata.
Per alleviare la pressione demografica di Pechino si progetta una nuova citta', si prospettano speculazioni immobiliari, sfratti e dismissione delle attività' agricole, Internazionale, 30 Giugno 2017, (i.b.)
La costruzione del nuovo distretto di Xiongan, nello Hebei, che unisce le contee di Xiaxiong, Rong cheng e Anxin: “Insieme alla zona economica speciale di Shenzhen e al distretto di Pudong a Shanghai, Xiongan rappresenta un importante passo in avanti per tutto il paese”. Nei tre giorni successivi all’annuncio, la contea di Anxin è stata invasa da decine di migliaia di persone in cerca di nuove possibilità di investimento nella zona. Da un lato Yuantou è contento perché se da giovane, quand’era lontano da casa, per spiegare da dove veniva doveva dire “vicino al lago Baiyang”, ora basta che risponda “il nuovo distretto di Xiongan”. Dall’altro, però, Yuantou è preoccupato per le sue anatre, che alleva da 33 anni. Tra gli abitanti della cittadina è quello che lo fa da più tempo. Stando alle stime del 2014, il 12 per cento della produzione nazionale di uova d’anatra proviene dallo Hebei, e più del 60 per cento di quelle salate che si mangiano a Pechino è prodotto nella contea di Anxin. Ogni anno le anatre di Yuantou producono decine di migliaia di uova, che da Anxin si vendono in tutta la Cina.
Quando ha cominciato a circolare la voce sulle demolizioni e i trasferimenti, Li Fei, un compaesano di Yuantou, ha pensato di piantare alberi da frutto sul suo terreno così da far aumentare il suo valore. Ma i coltivatori della zona gli hanno consigliato di lasciar perdere: “Non pensarci nemmeno, tempo fa abbiamo aiutato una famiglia a fare lo stesso e il giorno dopo, le piante sono state sradicate”. Gli abitanti preoccupati devono trovare altri modi per cavarsela. Quando hanno sentito che gli indennizzi sarebbero stati assegnati su base individuale, due abitanti di Santai, un villaggio vicino a Daiwang, hanno chiamato i figli: “Sbrigatevi a fare un bambino, non si sa quanto tempo rimane ancora!”. Altrove si è sparsa la notizia che anche i condizionatori e gli scaldabagno alimentati a energia solare sarebbero stati rimborsati, e una famiglia, che aveva già installato un impianto, è corsa a comprarne un altro. Da un po’ Yuantou trascorre più tempo nel cortile o seduto alla finestra a guardare le anatre razzolare. I tanti anni passati all’aperto s’intuiscono dalla sua pelle color rame, come quella dei pescatori. Ormai è anziano, e sapeva che prima o poi sarebbe arrivato il momento di lasciare la sua casa, ma non pensava che sarebbe successo così all’improvviso.
 «Secondo gli esperti, siamo sul punto di giungere ad un punto di svolta sociale, con la produzione di energia eolica e solare in grande espansione». RegionieAmbiente, 4 luglio 2017 (c.m.c.)
«Secondo gli esperti, siamo sul punto di giungere ad un punto di svolta sociale, con la produzione di energia eolica e solare in grande espansione». RegionieAmbiente, 4 luglio 2017 (c.m.c.)
Il mondo ha bisogno di un'azione climatica estremamente veloce per far scendere la curva delle emissioni globali di gas ad effetto serra, che comporta una drastica riduzione dell'utilizzo di combustibili fossili se si vuole evitare effetti non gestibili come ondate di calore devastanti e l'aumento del livello dei mari.
È quanto scrivono e sottoscrivono 60 scienziati, imprenditori, dirigenti politici, economisti, analisti e opinionisti (tra i più noti: Johan Rockström della Stockhom University; Jochim Schellnhuber e Stefan Rahmstorf del PIK; Anthony Hobley, Direttore esecutivo di Carbon Tracker; Jonathan Bamber, Presidente dell'Unione Europea delle Geoscienze) nell'articolo "Three years to safeguard our climate" pubblicato il 28 giugno 2017 su Nature.
Alla vigilia del G20 di Amburgo (6-7 luglio 2017), gli autori sono sicuri che sia il progresso tecnologico che lo slancio politico hanno raggiunto un punto che permette di avviare la "grande trasformazione della sostenibilità" e che il 2020 è una data fondamentale perché solo in quell'anno gli Stati Uniti potranno legalmente ritirarsi dall'Accordo di Parigi (vedi L'uscita dall'Accordo di Parigi conferma l'isolazionismo degli USA).
Ancora più convincenti sono le considerazioni basate sulla fisica: le recenti ricerche hanno dimostrato che il mantenimento del riscaldamento globale al di sotto dei +2 °C diventa quasi impossibile se si ritarda l'azione climatica oltre il 2020 e il superamento di quel limite sarebbe pericoloso E la violazione della linea a 2 ° C sarebbe pericolosa, poiché il numero dei fenomeni destabilizzanti del sistema Terra, come lo scioglimento delle grandi masse di ghiaccio, potrebbero risultare irreversibili.
«Finora siamo stati beneficati dalla notevole resilienza del Pianeta negli ultimi 100 anni, che ha assorbito la maggior parte dei nostri abusi sul clima - ha dichiarato a sua volta Rockström, riconosciuto a livello internazionale come uno dei massimi esperti sulle questioni legate alla sostenibilità globale per la teoria dei "Planetary boundaries" ovvero dei 9 confini planetari, oltrepassati i quali, gli effetti a cascata che ne derivano possono essere assolutamente fuori delle nostre capacità di controllo e devastanti per l'umanità - Ora abbiamo raggiunto la fine di questa epoca e abbiamo bisogno di piegare immediatamente la curva globale delle emissioni, per evitare risultati ingestibili per il nostro mondo moderno».
Secondo gli esperti, siamo sul punto di giungere ad un punto di svolta sociale, con la produzione di energia eolica e solare in grande espansione. In Europa, ad esempio, più di tre quarti delle nuove capacità energetiche installate si basano su tali fonti rinnovabili. La Cina sta rapidamente istituendo un sistema nazionale di scambio delle emissioni. Gli investitori finanziari negli Stati Uniti sono sempre più preoccupati per i rischi da carbonio.
Sono 6 le tappe che gli autori indicano accelerare la trasformazione in atto entro il 2020.
«La matematica del clima è brutalmente chiara: mentre il mondo non può essere guarito in pochi anni, può essere tuttavia ferito fa morte se la negligenza continua fino al 2020 - ha concluso Schellnhuber, Climatologo di fama mondiale e conosciuto per i suoi studi sui cosiddetti "tipping points" del sistema Terra ovvero il livello oltre il quale un cambiamento diviene inarrestabile - È necessario agire entro il 2020, ma non è chiaramente sufficiente: occorre impostare il percorso per dimezzare le emissioni di CO2 ad ogni decennio. Analogamente, alla leggendaria 'Legge di Moore' che afferma che i processori per computer raddoppiano di potenza ogni due anni, la 'Legge del Carbonio' può diventare una profezia che si autoadempie, mobilitando le innovazioni e le forze di mercato. Ciò diventerà inarrestabile, ma solo se spingiamo ora il mondo ad agire».
 I punti di forza della Venezia del Quattrocento. Traduzione dalla rivista francese Futuribles n° 414, settembre-ottobre 2016 a cura degli autori e di Mario Santi».Ytali, 2 luglio 2017 (c.m.c)
I punti di forza della Venezia del Quattrocento. Traduzione dalla rivista francese Futuribles n° 414, settembre-ottobre 2016 a cura degli autori e di Mario Santi».Ytali, 2 luglio 2017 (c.m.c)
Nei prossimi anni, certi paesi riusciranno a svilupparsi nel lungo termine per il Bene comune, appoggiandosi su valori umanisti. Saranno dei territori creativi che avranno voluto e saputo sfruttare la creatività dei talenti locali e stranieri per produrre nuovi lavori e una migliore qualità di vita; non per un piccolo numero di privilegiati ma per tutti. La Venezia del Quattrocento ci dimostra quali sono le quattro principali condizioni per riuscire questa sfida.
Da un mezzo secolo, la Silicon Valley e la Route 128 sono prese come modelli dei territori creativi: li, le attività economiche e i posti di lavoro sono generati da sinergie tra ricercatori, imprenditori e finanzieri. Molti hanno cercato di copiarli, spesso invano. Per capire come una terra diventa creativa, aldilà delle specificità della mutazione digitale, trasferiamoci al XV esimo secolo. La nascita della stampa e dell’editoria moderne è stata ancora più fondatrice che l’arrivo, sette decenni fa, dell’informatica e delle tecniche digitale: la diffusione dei libri ha modellato le evoluzioni del mondo, al punto che il declino dell’Impero ottomano ha cominciato nello XVIesimo secolo col rifiuto della stampa.
Un’orchestrazione di tecniche antiche
In terra tedesca, Gutenberg ha innovato, come farà più tardi Steve Jobs, adattando armoniosamente tecniche esistenti. Produsse dal 1455 a Magonza 180 copie della Bibbia quarantadue, “quarantadue righe per pagina.” Ma gli mancò l’ambiente necessario per passare dall’invenzione all’innovazione capace di diffonderla. Il creativo fu spogliato, rovinato dal suo socio, il banchiere Johann Fust diventato suo rivale. L’Arcivescovo Adolf von Nassau, che salvò Gutenberg dalla miseria, ha anche, paradossalmente, assicurato la continuità del suo lavoro saccheggiando Magonza nel 1462: i dipendenti di Gutenberg e Fust fuggirono e fondarono stamperie a Bologna, Basilea, Roma … e infine a Venezia verso il 1470. Ma di tutte le città che in questo modo ebbero a disposizione le tecniche della stampa, una sola è stata capace di trarne una delle poche innovazioni rivoluzionarie che, pur basate sulla tecnica, esigono assai più che la sola tecnica. Venezia offriva un contesto in grado di attrarre e valorizzare i talenti necessari, in particolare quello di un orchestratore eccezionale, Aldo Manuzio.
Le condizioni dell’esplosione creativa
Alessandro Marzo Magno (1) descrive i punti di forza di Venezia, capitale di quasi centomila abitanti. Il Veneto era il territorio più urbanizzato e più industrializzato d’Europa, dinanzi alle Fiandre. Aveva, come la Lombardia, in gran parte peraltro conquistata dalla Repubblica di Venezia, l’energia idraulica e l’acqua pulita necessarie per produrre della carta di qualità. (2) Ma secondo Marzo Magno, i quattro atout essenziali erano immateriali. C’era una concentrazione di pensatori umanisti, letterari, filosofi, scienziati, e la vicina Università di Padova giocava un ruolo prefigurando quello di Stanford nella Silicon Valley. Ricchi mercanti volevano diversificare i lori investimenti. Disponevano d’un’alta competenza commerciale e di reti internazionali. L’ultimo atout, l’eccezionale libertà di pensiero, si è rivelato determinante. Religioni e lingue coesistevano nella città più cosmopolita del mondo, accogliente per gli stranieri. Per questo, dopo la caduta di Costantinopoli, gli studiosi bizantini si rifugiarono a Venezia e a Padova, nella Repubblica che allora difendeva ancora, tenacemente, la sua indipendenza, perfino contro il Vaticano, mantenendo una laicità relativa; l’ateismo era tollerato.
Dirigenti più colti e meno corrotti
Altri due punti di forza rinvigorivano i precedenti: il livello culturale dei dirigenti e un eccezionale rigore dello Stato contro la corruzione. Molti patrizi si formavano all’Università di Padova, diventata città veneziana nel 1405. Era un focolaio culturale di filosofia e scienza greca e araba. Contro la scolastica della chiesa, l’aristotelismo padovano difendeva le conoscenze sperimentali, chiavi del progresso scientifico. Inoltre, la Serenissima si dotò di due scuole dedicate alla formazione delle sue élite. Fondata nel 1408 da un “straniero”, un mercante fiorentino, la Scuola di Rialto (3) divenne la prima scuola pubblica e laica della Repubblica. Insegnava la logica, le scienze naturali, e le matematiche contabili. Uno dei suoi professori fu l’umanista Luca Pacioli, fondatore della contabilità moderna. Dal 1443, un’altra scuola pubblica, la Scuola di San Marco, attraeva i figli dei nobili col suo insegnamento umanistico e i suoi insegnanti in maggioranza non veneziani. Per questo, “la classe dirigente veneziana era forse la più coltivata d’Europa” (4). Un’élite, interessata alle arti, alle scienze e alle lettere, che rispettava i creativi e si metteva in valore finanziando i loro lavori. L’altra eccezione veneziana era il rigore contro la corruzione. Funzionari e patrizi erano fortemente incoraggiati a non confondere interessi privati e bene pubblico. Jean-Claude Barreau (5) osserva una qualità unica, allora: l’onestà finanziaria. I funzionari statali non erano corrotti, in un’epoca in cui grandi servitori dello Stato francese, Richelieu e Mazzarino, riempivano i loro forzieri personali attingendo nelle casse riempite dal contribuente.
Realtà osservata o rivelata?
Questo contesto ha attirato Aldo Manuzio. Nulla predestinava quell’insegnante in latino e greco, nato vicino a Roma intorno al 1449, a diventare un imprenditore innovativo, salvo il suo impegno nelle reti umanistiche. Era amico di Giovanni Pico della Mirandola (1463-1494), l’autore d’un Discorso sulla dignità dell’uomo difendendo il libero arbitrio in quanto “creatore di se stesso.” Questo tema, allora ricorrente della dignità, doveva far fronte a violente resistenze. Pico, morto a 31 anni, probabilmente avvelenato, ha influenzato umanisti e utopici, tra cui Thomas More. Nel 1504, Thomas More tradusse in inglese una biografia di Pico. Il Movimento umanista promuoveva una visione del mondo basata sulla Ragione e, seguendo Aristotele, sull’osservazione individuale della realtà. S’opponeva alla visione dogmatica dominante che imponeva una verità rivelata da Dio e dai suoi rappresentanti, sacerdoti o sovrani. Aldo Manuzio decise di partecipare alla liberazione della Ragione grazie alla diffusione degli scritti di Aristotele e di altri pensatori antichi. Capì che la stampa sarebbe potuta diventare un formidabile promotore d’idee. Il professore si trasformò in imprenditore, tipografo ed editore, non per il denaro, ma per ideale. E divenne il più importante editore della storia e anche un esempio di capitalismo di lungo termine rispettoso dei stakeholder, delle parti interessate. Manuzio si stabilì nel 1489 a Venezia. Questo pensatore idealista si trasformò in un uomo d’azione realista, moltiplicando i contatti con intellettuali umanisti influenti e notabili colti vicini al potere. S’avvalse un tipografo importante, Andrea Torresano, prima di stabilirsi come tipografo-editore e di pubblicare un primo libro, nel novembre 1494. Lo stesso mese in cui il re francese Carlo VIII saccheggiava a Firenze la biblioteca di Lorenzo de’Medici. Una coincidenza che spiega perché Manuzio volle scrivere all’ingresso della sua bottega:Se si maneggiassero di più i libri che le armi, non si vedrebbero tante stragi, tanti misfatti e tante brutture. Per Aldo, la cultura greco-romana era essenziale allorché guerre immani (…) devastano tutta l’Italia e tra breve par che sommoveranno il mondo intero fin dalle fondamenta. Di qui la sua determinazione a rinunciare a “una vita tranquilla” per “dedicare la vita al vantaggio dell’umanità,” spiega Tiziana Plebani: egli credeva che si potesse far argine alle armi con le idee e offrire così agli uomini «la speranza di tempi migliori grazie ai molti buoni libri che usciranno stampati, e dai quali, ci auguriamo sarà spazzata via una buona volta ogni barbarie (Aristotele Opere logiche 1495).
In una prefazione ancora oggi d’attualità, affermava che la conoscenza della letteratura greca era una “necessità” per i giovani e per gli adulti in “tempi tumultuosi e tristi in cui è più comune l’uso delle armi che quello dei libri” (6). Aldo fondò nel 1495 la sua impresa con due azionisti, Andrea Torresano, che contribuì come professionista e finanziatore, e l’imprenditore Pierfrancesco Barbarigo, figlio e nipote di due dogi, che assicurò il sostegno finanziario e politico. Attirò i migliori collaboratori, una dozzina, dagli operai agli eruditi, che preparavano i testi appoggiandosi sui rari manoscritti esistenti. Dava importanza alla qualità della carta, acquistata a Fabriano, e dell’inchiostro fabbricato nel suo laboratorio. Primo tipografo-editore, capace di essere allo stesso tempo erudito, pedagogo, tecnico, uomo di marketing, manager, inventò, passo passo, il mestiere dell’editore moderno. Nel suo laboratorio, luogo di cultura dove si parlava greco, Aldo installò l’Accademia Aldina, che riuniva una trentina di umanisti, senatori veneziani, medici, futuri cardinali, intellettuali europei. Uno degli accademici, Giambattista Cipelli detto Egnazio, aveva scritto nel 1505 che era vitale per Venezia rispettare le acque della sua Laguna, una necessità sbeffeggiata, violata oggi da mezzo secolo.
Un’impresa incentrata sul cliente
Dato che il suo scopo non era di vendere, ma di fare leggere, Manuzio organizzò quello che oggi è chiamata l’impresa incentrata sul cliente e il libro di agevole uso. Curava l’impaginazione, introdusse l’uso dei paragrafi, della numerazione delle pagine, organizzò la punteggiatura, creò il punto e virgola, il carattere corsivo (per questo chiamato in francese italique) per condensare il testo, ridurre i prezzi e rendere i libri più accessibili. Curava la creazione di bei caratteri grechi, romani, ebraici. Il suo incisore Francesco Griffo immaginò per un libro di Pietro Bembo, futuro cardinale e amico di Manuzio, un carattere romano che influenzò Claude Garamond, padre del carattere omonimo, e il tipografo Stanley Morison, che introdusse nel 1932 il Times. Manuzio fu nel 1501, il primo a utilizzare il formato in-ottavo per pubblicare testi letterari. Questo formato, facilmente portabile, era fino allora riservato soprattutto ai libri dei religiosi. I viaggiatori che percorrevano l’Europa potevano finalmente partire con i loro libri. Il passaggio dalla lettura di libri molto pesanti a quella di libri più piccoli e spesso tascabili ripresenta una rottura paragonabile alla rivoluzione del digitale portatile, dai computer agli smartphone. Da allora, personaggi importanti si sarebbero fatti ritrarre tenendo in mano un libro tascabile, come i nostri contemporanei esibiscano il loro smartphone. Aldo dedicava prefazioni per annunciare le prossime edizioni e spiegare il suo progetto editoriale. Fu anche il primo a pubblicare cataloghi. Per differenziare le sue opere dalle imitazioni, in particolare eseguite a Lione, stampò nei suoi libri il suo logo, un’ancora e un delfino.
Una biblioteca senza limiti
Un’altra innovazione aldina fu il frequente inserimento d’immagini nei testi grazie alla nuova tecnica di xilografia sviluppata da Ugo de Carpi. L’Hypnerotomachia Poliphili, I sogni di lotte amorose di Poliphile, pubblicato nel 1499 con 172 xilografie sfruttò largamente questa tecnica. Questa opera erotica, di autore e illustratore sconosciuti, uno dei più bei libri illustrati del Rinascimento, è diventato un bestseller internazionale a partire delle sue riedizione dal 1545. Ha ispirato Rabelais, Gérard de Nerval e Roman Polanski (“Nona porta-2,1999). Le sue illustrazioni sono servite da modelli ai giardini europei nel corso di tre secoli. Aldo Manuzio morì il 6 febbraio 1515, esausto dal lavoro. Aveva pubblicato circa 130 libri in greco, latino, italiano, stampandone anche tremila copie. E’ stato riconosciuto da tutta l’Europa umanista. Erasmo, venuto nel 1507 ad abitare da lui nei nove mesi della ristampa dei suoi Adagia, ne divenne amico. Scrisse che Aldo aveva voluto “costruire una biblioteca senza altri limiti se non quelli del mondo.” Prima di Wikipedia… Nel 1516, Thomas More, amico d’Erasmo, a sua volta rese omaggio all’editore nell’Utopia. Di fatto, Manuzio ha definito norme rigorose che hanno creato le condizioni di una diffusione massiccia dei libri. Ha influenzato le abitudini, la cultura, l’arte. Le sue pubblicazioni hanno contribuito alla moltiplicazione di quadri non più religiosi ma ispirati dalla mitologia. Questo ha indotto un altro sguardo, quasi ecologico, sulla natura; cosi sono apparsi i primi paesaggi nella storia della pittura, come la Tempesta del Giorgione (circa 1503).
Censura e declino industriale
Aldo Manuzio è morto prima di vedere la sconfitta dei suoi valori a Venezia. Uno degli uomini che più hanno nuociuto alla Serenissima, Gian Pietro Carafa, aveva vissuto a Venezia, osservando con disgusto la tolleranza veneziana che consentiva lo sviluppo di movimenti favorevoli alla Riforma. Carafa fu nominato nel 1542 capo della Congregazione del Sant’Uffizio, direzione centralizzata dell’Inquisizione fino ad allora gestita a livello locale. Lanciò un’azione repressiva contro gli eretici e, diventato Paolo IV nel 1555, la perseguì. Aveva impedito, a forza di maldicenze, l’elezione a Papa di Reginald Pole, l’ultimo Arcivescovo cattolico di Canterbury, umanista amico di Bembo. Questo provocò una biforcazione storica e l’avvento della Controriforma. Dal 1548, l’Inquisizione poté imporre a Venezia la distruzione pubblica di decine di migliaia di libri “protestanti” e, nel 1553, in tutta la Repubblica, di centinaia di migliaia di libri ebraici. (7) Venezia fu costretta ad applicare in1558 l’Index vietando seicento autori tra cui Erasmo, Machiavelli e l’Aretino. Ironia crudele della storia, Paolo Manuzio, figlio d’Aldo, fu costretto a pubblicare nel 1564, l’Index Librorum Prohibitorum… L’arrivo della censura del Vaticano segnò l’inizio del declino dell’editoria a Venezia. La proporzione di libri religiosi, meno del quindici per cento delle pubblicazioni veneziane nel 1550, raddoppiò alla fine del secolo. Questo non salvò la supremazia dell’editoria veneziana. Fin dall’inizio del XVII secolo… Venezia e l’Italia cedono il passo ad Anversa, nella parte cattolica dell’Europa. Le Provincie Unite (8) stavano vivendo uno sviluppo particolarmente spettacolare [grazie al fatto che] la giovane Repubblica è un faro di tolleranza … autori e librai di diverse religioni convivono senza scontri. [Le condizioni che avevano fatto il successo di Venezia si trasferirono ad Amsterdam che sviluppò] un’industria del libro di qualità in grande parte per l’esportazione. Il veneziano, fin allora lingua a internazionale, dovette cedere il passo al francese e lo sviluppo della scienza italiana fu spezzato dal processo a Galileo Galilei.
Battaglie di visioni e valori
Se Aldo potesse ritornare, vedrebbe che Venezia non è diventata l’"archetipo" della città aperta all’utopia sperata da Italo Calvino, ma quello di un’Europa agonizzante nonostante gli eccezionali punti di forza che non osa sfruttare per ridiventare una terra creativa. Il futuro rimane aperto. Dipende dai conflitti tra visioni, valori degli attori e dalla loro volontà. Le terre creative saranno quelle dove prevarrà una visione umanistica di un mondo che si può esplorare e dove si può agire liberando la Ragione di ciascuno. Questa visione razionale e libera è attaccata, oggi come ieri, da sostenitori di una realtà rivelata e indiscutibile. Tra questi integralisti, gli islamisti operano nella scia dell’Inquisizione e dell’integrismo cristiano di Savonarola, anch’esso nutrito dall’indignazione di fronte alle disuguaglianze. I creazionisti americani, accaniti contro Darwin, distruggerebbero lo sviluppo scientifico, tecnico e, finalmente, umano delle aree là semmai si potessero impadronire delle scuole. Tutti i razionalisti che portano all’estremo l’importanza dei principi, delle osservazioni, perdendo di vista il Senso, l’Umano, aggrediscono anche la Ragione e ci conducono alla burocrazia, ai totalitarismi e alle derive transumaniste sostenute da miliardari dell’industria digitale americana. Attualmente le visioni dell’Altro come nemico progrediscono con la xenofobia e i neo-fascismi, chiudendo le menti e i territori. Questa tendenza va contro la creatività dei territori che dipende dall’attrattiva per tutti i talenti e dall’accoglienza di personalità forti, spesso disturbanti, capaci di diventare catalizzatori, come Manuzio.
Al funerale di Aldo Manuzio, la sua bara era circondata da tutti suoi libri. Lui avrebbe trovato simbolico che il suo laboratorio e la chiesa del IX secolo dove fu sepolto fossero rasati al suolo, per costruire il mediocre edificio di una banca. Saccheggio autorizzato per compiacenza. Simbolo del (temporaneo?) trionfo della rapacità (9), di fronte al capitalismo sostenibile, incarnato da Manuzio. Egli osserverebbe che Venezia sta spopolandosi, saccheggiata da molti dei suoi notabili che dimostrano come sia possibile sterilizzare e distruggere un territorio. Già nel 1887, il senatore Pompeo Molmenti denunciava la politica del delendae Venetiae. Oggi, è necessario un libro per ricordare che, ancora, “Venezia è una città”, malgrado gli sforzi dei numerosi corrotti e corruttori che vogliano trasformarla in Disneyland senza abitanti. Dalle grandi navi, che distruggono la Laguna al Fontego dei Tedeschi (10) degradato in negozi di lusso, al Mose che ha permesso di rubare un miliardo e mezzo, ci sono tanti scandali cui l’editrice Marina Zanazzo ha potuto, con grande coraggio, dedicare più di quaranta piccoli ma fondamentali libri nella collana Corte del Fontego. Purtroppo, in questo, Venezia è simbolica del nostro mondo. La tendenza lunga mondiale delle compromissioni tra politici e imprenditori ha provocato un hold-up dei finanziari di breve-termine sull’economia reale e la costruzione di plutocrazie totalitarie. Certo, gli Stati Uniti rimangono molto creativi. Ma va notato che ciò avviene perché le major del digitale mantengono ambizioni a lungo termine e riescono a sedurre i finanziatori malgrado introiti per molti anni mediocri o nulli, come quelli di Amazon e Tesla. E questi territori sono (ancora) creativi, ma negli interessi di chi? E sostenibile uno sviluppo economico basato sull’impoverimento della maggioranza? No, risponde anche il Financial Times.
I partigiani dei valori umanistici non sono condannati. Possono costruire territori creativi nel lungo termine sfruttando, anche loro, le proprietà delle reti digitali: potrebbero allora ricreare condizioni globali capaci di generare innovazione sull’esempio di quelle che consentirono il passaggio dall’umanesimo al Rinascimento: bisognerebbe creare una nuova Accademia Aldina! Ma le reti possono anche essere mafiose e gli effetti rete sono anche utilizzati oggi per dominare, spiare, imbrogliare. Esattamente come i modelli rinascimentali della Città ideale sono stati fuorviati dal Panopticon per costruire penitenziari, imprese e uffici tayloriani o manicomi come a Vienna… Oggi la nostra libertà e lo stato di diritto sono minacciati da un Panopticon digitale al servizio di qualche impresa gigantesca. Ancora una volta, tutto dipende dai valori prevalenti e dall’azione dei cittadini desiderosi di difendere la libertà. Manuzio concluderebbe sull’urgenza di fare assimilare ancora molto di più “buoni libri per sbarrare la strada a tutte le barbarie”. La battaglia delle visioni e dei valori inizia a scuola. Subiremo ancora a lungo l’insegnamento di un pensiero cartesiano che fraziona la realtà e impedisce di percepirla? O, finalmente, diffonderemo un pensiero della complessità mettendo in evidenza le interdipendenze, incoraggiando per questo la solidarietà con gli altri e con l’ambiente? La comprensione della complessità fa ammettere l’imperfezione dei nostri atti, umiltà indispensabile per il progresso tecnico. Le nostre scuole, in particolare quelle che formano i nostri dirigenti, continueranno a formare al disprezzo degli altri o stimoleranno alla fine la cooperazione e l’apertura? Persevereremo a selezionare anche i medici, secondo le loro capacita in matematica o secondo la loro empatia, le loro qualità umane? Avremo, come nella Venezia del Quattrocento, dirigenti colti e aperti alla modernità, o subiremo troppi politici altrettanto ignoranti della tecnica moderna che della storia e della cultura classica? Pronti a farsi beffa del nostro patrimonio letterario ed artistico, e a sacrificare la cultura classica? Dipende da noi.
(1) Alessandro Marzo Magno, “L’alba dei Libri. Quando Venezia ha fatto leggere il mondo”, Garzanti 2012
(2) Brian Richarson, “Printing, Writers and Readers in Renaissance Italy”, Cambridge University Press, Cambridge, 1999
(3) Premio Luca Pacioli , Senato Accademico del 24 novembre 2010, Università Ca’ Foscari, Venezia
(4) Gino Benzoni, “Il Rinascimento. Politica e cultura. La cultura: le accademie e l’istruzione”, “Storia di Venezia”, Vol. 4, Enciclopedia Treccani,1996.
(5) Jean-Claude Barreau, “Un capitalisme à visage humain, le modèle vénitien”, Fayard, 2011
(6) Gino Benzoni, cit.
(7) Giovanni Di Stefano, “Venezia e il Ghetto”, Il Gazzettino, 2016.
(8) Il regno dei Paesi Bassi
(9) Italo Calvino, “Venezia archetipo e utopia della città acquatica”, (1974), Mondadori, 1995
(10) Joseph Stiglitz, “Le triomphe de la cupidité”, Ed. Les liens qui libèrent, 2010
(11) Paola Somma, “Benettown”, 2011, e Lidia Fersuoch, “Nostro Fontego dei Tedeschi”, 2015. Corte del Fontego
Più ostinati del sole, più uniti di sempre, persino più numerosi dei turisti, ai quali - per una volta - tolgono i masegni e l'aria, riprendendo possesso di quella riva che fino a qualche anno era la passeggiata dei veneziani, da Piazza San Marco ai Giardini della Biennale e ritorno, con il gelato in mano. Hanno dai 6 ai 76 anni, la maglietta sudata, il cappello calato sulla fronte, chi il megafono, chi uno striscione, chi il gonfalone di San Marco; rappresentano associazioni, gruppi, piccoli comitati, o non appartengono a nessun circolo ma sono lì a titolo personale, famigliare o in rappresentanza del proprio condominio. Soprattutto, sono tantissimi. In oltre duemila, secondo alcuni fino a 2.500, ieri mattina, hanno gonfiato le file della manifestazione - promossa dal Gruppo 25 Aprile - dal titolo che è l'insegna della resilienza veneziana: "Mi no vado via"; cioè io resto, sono qui, nessuno mi farà sloggiare.
«Un tempo si poteva vivere di pesca, oggi l'habitat è stravolto». la Nuova Venezia, 3 luglio 2017 (m.p.r.)
DA NOVENTA ALLA FOCE/3 fine
Treviso. Chiare, fresche e dolci? Torbide, calde e salate, altrochè. Le acque della Piave che vanno da Ponte di Piave fino a Noventa e Fossalta e giù fino al mare sono tutto fuorché degne dei poeti. Pagano il prezzo dei "furti" e delle "ferite" patiti a monte e precedono di poco un fenomeno, quello del "cuneo di sale", che crea gravi problemi all'habitat vegetale e animale del fiume sacro alla Patria. Ne sa qualcosa l'oasi naturalistica "Codibugnolo", nata per autoalimentarsi con piante e animali, ma già in sofferenza e costretta a rifornirsi di varietà e specie provenienti da altre aree protette. Ci è capitato personalmente di trovare una delle sue "anime", nella selva del Parco dello Storga a caccia di erbe, piccole querce e rari salici bianchi con cui integrare la flora autoctona.
Il fatto è che la Piave è snaturata nelle sue acque, che, prive di vita, continuano a perdere biosalubrità. Lo dice anche il nostro giovane "barcaro", Christian, che ci accompagna verso il mare, nel viaggio finale su questo povero Piave desolato. Lui ti porta, con calma, nei luoghi giusti per farti un'idea su quanto accade. Buche dominate dalle mucillagini, calde come un brodo primordiale e non certo animate da vita ittica e capaci di filtrare l'acqua. La colpa non è nemmeno di quelli "lassù": quelli del Bellunese che piantano centraline elettriche come piovesse; o di quelli del medio corso che cavano a piene ruspe e pescano l'acqua dalle falde impoverendole e distruggendo l'equilibrio idrogeologico.
«Qui dovrebbero essere fatti i laminatoi - dice Marco Zanetti, biologo-imprenditore - Non certo nell'alto corso del Piave. Si fanno dove c'è acqua, non dove non ce n'è. E si prova a far ripartire il circolo virtuoso che purtroppo è già saltato o sta saltando. Non stupiamoci se il mare risale il fiume e rende tutto brullo. Se dal fiume non scende niente, c'è il caso, a seconda delle maree, di vedere la stessa bottiglia di plastica navigare prima verso sud, poi verso nord nell'arco della stessa giornata. e allora non stupiamoci se l'acqua non si depura».
Già, l'acqua: tanta, pulita. Dice ancora il biologo Zanetti: «L'acqua ha bisogno di scorrere in superficie per ripulirsi. I nostri nonni, che avevano quasi sempre ragione, dicono che l'acqua "se neta co la gà passà tre sassi". Il mantenimento della qualità dell'acqua è un punto d'arrivo della battaglia che associazioni e comuni devono fare insieme. Ma una larga fetta della Piave circola in tubature parallele e il sole e i sassi non li vede nemmeno. E allora ecco che senza acqua depurata non ci sono nemmeno biodiversità, che creano un circolo virtuoso la cui presenza, un tempo, rendeva vivo il basso corso del Piave».
L'attacco passa per l'alveo ma anche per le rive. Ci fu un momento in cui fu deciso, nel tratto che scende a San Donà, di fare interamente piazza pulita della vegetazione sulle rive (s'intende per non dare riferimenti a chi volesse capire quanto l'erosione che il fiume patisce sia naturale e quanto.... forzata e voluta). «La popolazione si ribellò e fu fiancheggiata dalle associazioni di tutela ambientale - racconta Maurizio Billotto vicepresidente di Legambiente veneta - e ottenemmo lo stop, quindi uno studio di tutto ciò che viveva lungo le rive e un piano molto dettagliato di ciò che si poteva disboscare». E scendendo il Piave ci viene in mente quella sentita al convegno di qualche giorno fa a Maserada: «Come dice Michele Zanetti, dell'Associazione naturalistica sandonatese,- nel letto del fiume abbandonato all'incuria, ti puoi aspettare da un minuto all'altro di veder spuntare una tigre, ma non certo la flora e la fauna che ci furono quarant'anni fa».
«Non chiedete un commento ai pescatori, che ormai non sanno nemmeno più perchè escono la mattina, di buonora, con canna, reti e nasse in mano», dice Christian, che sul fiume, in barca, dove ci ospita, vive. Ci fu anche un tempo in cui si viveva di pesca fluviale, qui, e lo diceva Felice Gazzelli di Ceggia: «Ho sei generazioni di pescatori alle spalle. Io ho pescato fino a che c'è stato mio padre, scomparso 20 anni fa» racconta, «Allora c'era acqua pulita che scendeva da nord e si poteva vivere di pesca. Non è più così, perché qui arriva dal mare l'acqua salata. I pescatori sono gente che ama il fiume e vanno ascoltati. Non c'è più acqua da pesce, qui». E allora al capezzale richiamiamo il biologo Marco Zanetti, della società di ricerche e analisi ecobiologiche Bioprogramm. «I traumi sono molteplici, come abbiamo visto dalle centrali idroelettriche al deflusso minimo imbroglione, dai cavatori che cambiano le caratteristiche del letto del fiume fino a chi depaupera senza controllo le falde, togliendo lo zoccolo liquido alle acque che dovrebbero scorrere in superficie».
Scrive in una relazione: «Il fiume quando viene colpito da un input, un inquinamento, qualcosa che lo modifica al suo interno, ha il potere di assorbirlo e di tornare nelle sue condizioni di equilibrio iniziale. Con la diminuzione della portata, il Piave, degradato nelle sue componenti strutturali, diminuisce il suo potere omeostatico e non è più capace di sopportare piccoli fenomeni di inquinamento che sarebbe stato in grado di sopportare se fosse nelle sue condizioni naturali. Abbiamo alvei che rimangono asciutti per lunghi periodi dell'anno e quindi si impermeabilizzano al ritorno delle acque. Il contatto con la falda comunque viene a mancare e non si ha il processo di filtrazione naturale. Il risultato dell'impermeabilizzazione è che le acque scorrono solo in superficie e producono danni.
«Aggiungeteci le piene improvvise che provocano il "drift" ossia l'asporto di materiali verso valle ed ecco il quadro. Nei periodi di riduzione della portata si ha invece la messa a secco e la scomparsa delle uova e degli avannotti di pesce e la riduzione delle popolazioni biologiche per cambiamenti strutturali dell'habitat. Come tutto questo non possa non ripercuotersi nella vita del Basso Piave è lampante. Ribadisco che dagli sbarramenti servono rilasci d'acqua modulari delle acque, un rilascio costante o limitato a certi periodi non ha senso. I produttori di energia idroelettrica, ad esempio, devono rilasciare dei picchi di magra e di morbida che siano quelli naturali, che ci sono sempre stati nei nostri fiumi. E gli enti captatori dell'acqua devono essere obbligati a smaltirsi anche i picchi di piena: non è possibile che quando l'acqua non c'è, loro possano prelevarsela tutta, mentre quando c'è l'ondata di piena utilizzino il fiume come canale scolmatore. E' inammissibile dal punto di vista biologico, ma anche dal punto di vista etico, perché a rischiare è la vita umana, che conta un po' più di quella del fiume».
Nel frattempo si registra la notizia della prossima chiusura dell'Ispra, Istituto per la Protezione e Ricerca Ambientale. Come a dire che gli americani con Trump fanno solo le cose più in grande di noi, ma l'andazzo è quello. Chi può pagare, ha sempre ragione e a chi importa il destino del Piave dopo che il Veneto ha già assistito allo scippo di Adige e Brenta? Ma il caso Piave è ancora aperto, anche culturalmente. Non esisterebbe la civiltà del fiume e non esisterebbe, almeno in parte, Venezia così com'è, se il Piave non fosse stato una via d'acqua (allora l'acqua c'era) percorsa dagli zattieri con merci e carbone diretti alla foce e quindi alla Laguna.
A proposito di Laguna: su quella del Mort, vicino a Eraclea, dove un tempo terminava il fiume, incombe una minaccia: quella di un affare da mezzo miliardo di euro, chiamato Valle Ossi, fatto di posti barca e villette su 250 mila ettari. I naturalisti vi si oppongono e credono che l'area dovrebbe diventare un parco. I politici si confessano impotenti di fronte a un affare privato. Già l'area è di proprietà degli speculatori. Ma questa è un'altra storia.
Su eddyburg le due precedenti puntate del viaggio il Piave: Le centrali-bancomat che si bevono il Piave e Tra cave e prosecco, così il Piave affonda.
«I furbetti del mattoncino. Un caso ogni tre giorni. Gli effetti di 30 anni di condoni: un furto impunito di 21 miliardi. Dobbiamo ancora regolarizzare 5,3 milioni di condoni dal 1985». il Fatto Quotidiano, 2 luglio 2017 (p.d.)
Si affilano le armi per determinare le scelte del governo. Brugnaro "annuncia l'annuncio del governo", 34 associazioni sfileranno domani contro la monocultura del turismo. Il Comitato No Grandi Navi, dopo il referendum popolare, rilancia con richieste di trasparenza a ministro, governo e porto. Articoli di Enrico Tantucci, Vera Mantengoli e Manuela Pivato. la Nuova Venezia, 1 luglio 2017 (m.p.r.)
IL GOVERNO HA DECISO
NO GRANDI NAVI
«Dalla gestione privatizzata a dieci esempi di progetti che incombono sul patrimonio idrico italiano, la gestione pubblica e partecipata è l'unica strada». acquabenecomune.org, 30 giugno 2017 (p.d.)
La cosiddetta “emergenza idrica” è provocata dalla cattiva gestione e dalla privatizzazione ma si continua a far finta di nulla e a insistere su progetti che rischiano di devastare quanto rimane del residuo patrimonio idrico italiano. I dati che stanno circolando sui media in questi giorni (diminuzione della disponibilità d'acqua, crollo delle precipitazioni e delle portate di fiumi e sorgenti, aumento delle temperature medie) fanno emergere in tutta la sua drammatica realtà l'acuirsi di una crisi idrica che viene da lontano.
E', altresì, evidente come la crisi idrica che si sta palesando in questi giorni in Italia sia il risultato del matrimonio tra il ciclo dell’acqua e il ciclo economico, essa è dovuta principalmente alla scarsità di questa risorsa. Scarsità “man-made”, cioè prodotta dall’uomo, tramite: sovrasfruttamento degli acquiferi, inquinamento delle falde e del reticolo fluviale superficiale, urbanizzazione, con conseguente diminuzione della disponibilità, divisione tra consumo agricolo, industriale, uso civile. E allora l'onestà intellettuale imporrebbe di fare marcia indietro rispetto a una serie di opere e progetti che da una parte tendono a valorizzare economicamente l'acqua e dall'altra considerano il suo depauperamento come un effetto collaterale ineluttabile.
Ne elenchiamo solo dieci delle centinaia in cantiere in Italia:
- pozzo di petrolio ENI di Carpignano Sesia, in area di ricarica della falda idropotabile di Novara, il Min.Ambiente ha appena approvato il progetto mettendo come prescrizione di "prevedere un approvvigionamento alternativo in caso di contaminazione";
-gasdotto Sulmona-Foligno della SNAM, con il tragitto su ben tre crateri sismici con un tunnel appena dietro la più grande sorgente dell'Italia Centrale, quella del Pescara a Popoli, dalla portata di 6000 litri al secondo;
- Centro Oli di Viggiano che incombe sul Lago del Pertusillo, che disseta 4 milioni di italiani in Puglia e Basilicata, sequestrato nel 2016 e oggi protagonista di un ingente sversamento di petrolio;
- Sorgente Pertuso: aumento delle captazioni presso la sorgente del Pertuso che alimenta il fiume Aniene nel Lazio;
D'altra parte si prova ad accreditare la tesi per cui i due referendum per l'acqua pubblica del 2011 siano stati la causa della situazione attuale avendo determinato un crollo degli investimenti per cui non sarebbe stato possibile l'ammodernamento delle reti idriche da parte dei gestori. Una bugia dalle gambe cortissime. Infatti, gli investimenti sono in decisa flessione sin da fine anni novanta (quindi ben prima dei referendum) nonostante le tariffe dell'acqua siano aumentate più di ogni altro servizio pubblico. Allora se le tariffe aumentano, gli investimenti diminuiscono e le perdite delle reti aumentano, appare evidente che c'è qualcosa che non torna.
La questione da porsi, che arbitrariamente viene elusa nel dibattito pubblico, è che il finanziamento del servizio idrico integrato ha dimostrato il suo fallimento dal momento in cui al principio del “full cost recovery”, ossia il costo totale del servizio deve essere interamente coperto dalla tariffa, si è associato l'affidamento a soggetti privati: entrate certe e anticipate a fronte di investimenti sempre più ridotti e dilazionati nel tempo. Con i risultati assolutamente inadeguati rispetto alle ingenti opere di cui il servizio idrico necessita. Superato il concetto del “full cost recovery” ed esautorati i soggetti gestori di natura privatistica, per gli investimenti, occorre progettare, quindi, un sistema di finanziamento sia basato sul ruolo della leva tariffaria, anche su quello della finanza pubblica e della fiscalità generale.
Insomma, il giudizio di fallimento dell'attuale sistema di gestione dell'acqua in Italia è un dato di fatto ben difficilmente contestabile che dovrebbe portare ad un'inversione di rotta immediata soprattutto alla luce della pesante crisi idrica.![]() Diviene in sostanza irrinunciabile e urgente un cambiamento del sistema passando dalla pianificazione dell’offerta, alla pianificazione e gestione della domanda, rimettendo al centro la tutela e gestione partecipativa dell'acqua e dei beni comuni.
Diviene in sostanza irrinunciabile e urgente un cambiamento del sistema passando dalla pianificazione dell’offerta, alla pianificazione e gestione della domanda, rimettendo al centro la tutela e gestione partecipativa dell'acqua e dei beni comuni.
Roma, 30 Giugno 2017
Forum Italiano dei Movimenti per l'Acqua
 Ada Colau ha scelto di gestire i flussi turistici e contrastare le logiche di profitto di speculatori guardando ad esperienze di cogestione: un esempio importante di recupero dello spazio urbano. MicroMega online, 27 giugno 2017 (c.m.c.)
Ada Colau ha scelto di gestire i flussi turistici e contrastare le logiche di profitto di speculatori guardando ad esperienze di cogestione: un esempio importante di recupero dello spazio urbano. MicroMega online, 27 giugno 2017 (c.m.c.)
Un servizio comodo e confortevole. Una manna dal cielo per chi non può permettersi alberghi di lusso. Airbnb è il portale on line che coniuga domanda ed offerta del turismo low cost: una community che dà la possibilità a chi ha una camera libera nella propria abitazione di affittarla. È un modo di viaggiare più economico e "social" della classica sistemazione in hotel. Una rivoluzione, negli ultimi anni, che si è affermata soprattutto tra i giovani.
Ma non è tutto oro quel che luccica perché la politica di Airbnb ci parla infatti di nuova urbanistica e di modelli di città differenti. Per anni siamo stati abituati ad una politica latente che ha dato mano libera ai privati che hanno saccheggiato liberamente gli spazi urbani. Roma, in tal senso, ne è emblema visto lo strapotere di palazzinari e cricche del mattone: nella Capitale si è rotto il legame tra la comunità degli uomini e la città materiale. I Comuni delegano al privato la soluzione dei problemi sociali, come l'emergenza abitativa, con la conseguenza di speculazioni, sperpero di denaro pubblico e mancata soluzione delle questioni (vedi la creazione dei residence). Le nostre città, più in generale, stanno diventando non/luoghi, eppure la cittadinanza è il pieno dei vissuti e il territorio dovrebbe essere inteso come bene comune. È la fine dell'urbanistica, e dunque la fine della città pubblica.
L’impero di Airbnb in Italia
Airbnb si innesca nella stessa logica con un impero da 31 miliardi di dollari incassati dal 2008 ad oggi. Fa profitti imponendo un modello di città sbagliato dove persiste un centro “turistico” e “vetrina” e la contemporanea espulsione degli abitanti verso le periferie. Una ricerca del laboratorio Ladest della facoltà di Scienze Politiche dell’Università di Siena ha fatto luce proprio sull’altra faccia di Airbnb.
A Firenze quasi il 20% delle case dentro le mura medievali è in affitto sulla piattaforma turistica, a Matera addirittura il 25%, a Roma l’8%, a Venezia il 9 e le percentuali sono in crescita dappertutto, da Catania a Milano. A dispetto del concetto di “sharing economy” però su Airbnb i grossi guadagni sono ben poco “shared”, condivisi. Anzi si concentrano sempre più nelle mani di pochi. A Milano ad esempio un unico soggetto ha accumulato più di 520 mila euro solo nel 2016 mentre il 75% degli host ha guadagnato meno di 5.000 euro in un anno. A Roma il 48% dei proprietari è sotto 5.000 euro e un fortunato 0,6% sta sopra 100 mila euro mentre a Firenze, dove l’incasso medio per gli oltre 8 mila host di Airbnb l’anno scorso è stato di 5.300 euro, uno solo è arrivato a incassare la bellezza di 700 mila euro.
“A Roma come altrove – scrive Sara Gainsforth su DinamoPress – Airbnb è uno strumento di concentrazione della ricchezza proveniente dalla rendita immobiliare. Pochi intermediari gestiscono più case, molte delle quali non abitate stabilmente per più di sei mesi. Nella Capitale gli annunci per turisti si concentrano nelle zone più turistiche, centrali e benestanti della città. I dati raccolti da Inside Airbnb mostrano un aumento delle proprietà destinate a turisti nel centro di Roma con un +8,2% negli ultimi sei mesi in I municipio”.
Intanto la città, il futuro si sposta nelle periferie. Anche a causa di valori immobiliari insostenibili continua l’esodo di residenti dal centro. Si creano i quartieri dormitorio, terreni fertili per la guerra tra poveri. Tra cittadini autoctoni arrabbiati dei disservizi versus i centri di accoglienza dei migranti. La grande assente è sempre la politica che da anni si rifiuta a ripensare le città, a ridisegnare le periferie urbane creando condizioni indispensabili di inclusione sociale, intervenendo sugli spazi pubblici. Le città come elemento di rottura e discontinuità, il neomunicipalismo come antidoto alle crisi attuali per un nuovo protagonismo della cittadinanza: il recupero dello spazio urbano con strumenti di co-partecipazione e co-gestione per contrastare rendite finanziarie ed establishment. Tra mille difficoltà, un po' come Davide contro Golia, ci sta provando a Barcellona l'alcaldessa Ada Colau che ha intrapreso un vero e proprio braccio di ferro contro Airbnb e la gentrification.
Barcellona, invasa dai turisti
A Barcellona, infatti, quello del turismo, con tutte le sue derivate (aumento degli affitti, espulsione dei residenti dal centro, distruzione del piccolo commercio, carenza di case popolari, ecc.) è un problema capitale. Se nel 1991, l’anno precedente alle Olimpiadi che hanno cambiato radicalmente il capoluogo catalano, i turisti superavano di poco il milione, nel 2016 hanno già raggiunto quota 9 milioni in una città di 1,6 milioni di abitanti. Se a questi aggiungiamo i turisti che alloggiano in appartamenti senza licenza o che non dormono in città, ma che la visitano, si stimano oltre 25 milioni di turisti all’anno, la maggior parte dei quali alloggiano e si muovono nel centro storico (il municipio di Ciutat Vella), la cui popolazione è in continuo calo e attualmente supera di poco i 100mila abitanti.
La situazione è davvero preoccupante e il rischio che Barcellona si converta in una nuova Disneyland, come è successo a Venezia, è reale. Non è un fenomeno nuovo, evidentemente, ma l’accelerazione degli ultimi anni è stata notevole. E i dati ci mostrano che la questione degli appartamenti turistici, legali e illegali, e il fenomeno di Airbnb pesano moltissimo in tutta la questione. Alla fine del 2016 l’offerta di appartamenti turistici ha raggiunto infatti quasi quella alberghiera, con una crescita vertiginosa dal 2012 (+ 1.633%): secondo il Comune della Ciudad Condal gli appartamenti turistici sul mercato sono quasi 16mila, di cui solo 9.600 dispongono di una licenza. Gli altri 6.200, ossia il 40%, operano senza.
Ma non si tratta solo di stime comunali. La percezione della cittadinanza è una cartina di tornasole della vicenda: e non è un caso che, per la prima volta, il turismo è, secondo i barcellonesi, il primo problema della città, superando la disoccupazione. E che, anche in questo caso per la prima volta nella storia, sono di più i barcellonesi che credono che si sia arrivati al limite di turisti (48,9%, con punte del 65% nei quartieri del centro storico) rispetto a quelli che considerano che la città ne possa accogliere di più (47,5%). E la cittadinanza si è mobilitata, auto-organizzandosi in piattaforme e associazioni – come Barcelona No Está en Venda (Barcellona Non È In Vendita), Fem Sant Antoni o il Sindicato de Inquilinos (il Sindacato degli Inquilini), tra le tante – che lottano contro i processi di turistificazione e gentrificazione della città. Non ci sono solo manifestazioni di protesta, per quanto siano ormai numerose in molti quartieri, ma anche altre azioni per proteggere chi rischia di essere espulso dalla propria casa, per migliorare le condizioni dei contratti d’affitto – solo nel 2016 gli affitti sono aumentati del 24,5% – o per censire i condomini in vendita per evitare che siano acquistati da fondi speculativi.
Ma la cittadinanza si è mobilitata anche votando nel maggio del 2015 la lista civica neomunicipalista Barcelona en Comú, guidata dall’attivista Ada Colau, che è stata la fondatrice e, per oltre un lustro, la portavoce della Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH, Piattaforma delle vittime dei mutui). Nella campagna elettorale la questione di un nuovo modello di città è stata chiave ed era, non a caso, una delle priorità del programma elettorale di Barcelona en Comú, elaborato insieme alla cittadinanza. Non è un caso nemmeno che tra gli undici consiglieri eletti ci sia anche Gala Pin, portavoce del movimento Salvem el Port Vell che ha lottato contro il turismo di massa e l’apertura di un porto di lusso nel quartiere della Barceloneta.
La pressione dei movimenti sociali, da cui provengono la maggior parte dei consiglieri e degli assessori di Barcelona en Comú, facilita in un certo qual modo il lavoro della giunta Colau, per quanto la lotta sia impari e le difficoltà economiche e legali siano enormi. La lobby degli alberghieri, potentissima nel capoluogo catalano, ha sempre visto con preoccupazione la nuova amministrazione comunale e la nuova lobby di Airbnb, che dispone di un potere mediatico incredibile, rifiuta di rispettare le norme e le leggi esistenti, alimentando la compravendita di appartamenti.
Cosa ha fatto la giunta Colau?
Nei primi due anni di governo di Barcelona en Comú si sono fatti importanti passi in avanti. Oltre allo sviluppo di una politica di acquisto e costruzione di nuove case popolari, all’acquisto di interi edifici che stavano per essere comprati da fondi speculativi, alle multe alle banche per non mettere sul mercato gli appartamenti sfitti, ai finanziamenti pubblici per la ristrutturazione degli immobili con l’obbligo di non espellere per almeno un biennio gli inquilini o ai progetti per rendere Barcellona una città sostenibile (limitazione del traffico, creazione di aree verdi, potenziamento del trasporto pubblico, ecc.), la giunta Colau si è spesa notevolmente per regolare gli appartamenti turistici e per limitare lo strapotere di Airbnb.
In primo luogo, è stato approvato un Piano speciale urbanistico di ordinamento degli alloggi turistici (Peuat), elaborato con la partecipazione della cittadinanza e delle associazioni presenti sul territorio, che divide la città in tre zone con l’obiettivo di decongestionare il centro. Nella prima zona, ossia il centro storico, non si concedono nuove licenze per appartamenti turistici e chi cessa l’attività non può essere sostituito; nella seconda zona, si concedono nuove licenze solo se il rapporto degli appartamenti turistici in un’isolato è inferiore all’1,48%; mentre, nella terza zona, la più lontana dal centro storico, si possono ottenere ancora delle licenze. Con il Peuat si è però creata anche un’unità di ispettori – chiamati visualizadores, attualmente formata da 40 persone – che si occupano di localizzare gli appartamenti turistici senza licenza: dal gennaio del 2016 sono state aperte 5.490 pratiche che si sono convertite in quasi 3mila multe – tra i 30 e i 60mila euro – e nella chiusura di 2.015 appartamenti illegali.
In secondo luogo, il Comune ha aumentato la tassa turistica (da 0,65 a 2,25 euro), non solo per chi alloggia in hotel o nelle navi crociera, ma anche per chi lo fa negli appartamenti turistici. Il ricavato – e si parla di oltre 10 milioni di euro all’anno – sarà utilizzato per ampliare il Piano strategico del Turismo 2020 che si propone di rendere sostenibile la città come destino turistico nell’arco dei prossimi quattro anni, ossia rinforzando i trasporti pubblici e ristrutturando la pavimentazione della città.
In terzo luogo, a novembre dello scorso anno si è multato Airbnb con 600mila euro, dopo due precedenti multe di 30mila euro che erano state ignorate dalla compagnia statunitense. Si tratta della prima multa di tale entità di una città contro Airbnb e, come ha dichiarato la sindaca Ada Colau, si faranno “tutte le multe necessarie fino a che Airbnb smetta di annunciare appartamenti illegali. Airbnb deve rispettare la legge!”. Altri portali on line che operano nel turismo, come Homeaway o Nine Flats, anch’essi multati dal Comune di Barcellona, hanno fatto marcia indietro e hanno deciso di rispettare la legge in vigore a Barcellona.
Non così Airbnb che, oltre a fare orecchie da mercante, a proporre accordi farsa – accettati da altre città e rifiutati seccamente dal Comune di Barcellona: l’assessore alla Casa, Josep Maria Muntaner, li ha definiti “una presa in giro” – e a scatenare una campagna mediatica contro la giunta Colau, è stata protagonista di scandali non da poco: Kay Kuehne, ad esempio, ex direttore di Airbnb per la Spagna e il Portogallo e poi per l’America Latina, è stato multato per aver affittato illegalmente un appartamento senza licenza a Barcellona. O, ancora, è notizia della scorsa settimana che Airbnb lascia operare senza controllo reti criminali che affittano appartamenti nel capoluogo catalano per poi trasformarli in appartamenti turistici.
Di casi di questo tipo se ne stanno conoscendo un’infinità negli ultimi tempi, tanto che Janet Sanz, responsabile dell’area di Ecologia, Urbanismo e Mobilità della giunta Colau, ha ribadito l’uso della mano dura contro la compagnia statunitense: «Airbnb ha superato ogni limite. Ha truffato la città. La sua attività sta danneggiando i cittadini perché non rispetta la legge. È ora di dire basta!» E non sono ormai solo voci di corridoio quelle che sostengono che il Comune di Barcellona possa arrivare fino in fondo, obbligando Airbnb a lasciare il capoluogo catalano.
Le difficoltà sono molte per i Comuni, le competenze sono limitate, le lobby, come Airbnb, sono potentissime, ma, come dimostra la giunta Colau, se c’è la volontà politica il turismo si può regolare e fenomeni come quello degli appartamenti illegali possono essere controllati, anche in una città invasa dai turisti come Barcellona.
Quando parliamo di ridefinizione di città, non parliamo solo di urbanistica ma contrasto alle diseguaglianze sociali, di ambiente, di eco-architettura, di modelli di cogestione in antitesi a logiche di profitto di speculatori e establishment, parliamo di tutto questo. La città come bene comune. E se da un lato Airbnb è un servizio agevole, dall'altro va capito che è emblema di una politica urbana sbagliata e escludente. E se imparassimo da Ada Colau?
«Processo veloce. Le divergenze con le difese sono nell'ultimo anello: in sostanza i fondi neri c'erano, ma nessuno degli imputati ammette di averli presi». la Nuova Venezia, 30 giugno 2017 (m.p.r.)
Venezia. La pena più pesante è per l'ex ministro An alle Infrastrutture Altero Matteoli: 6 anni. E poi: 5 per l'imprenditore romano Erasmo Cinque, 4 per l'ex presidente del Magistrato alle Acque Maria Giovanna Piva, 3 per l'imprenditore Nicola Falconi, 2 anni e 6 mesi per l'architetto Danilo Turato, 2 anni e 4 mesi per l'ex presidente di Adria Infrastrutture Corrado Crialese, 2 anni e 3 mesi e 1 milione di multa per l'ex sindaco di Venezia Giorgio Orsoni, 2 anni e 500 mila euro di multa per l'ex europarlamentare di Forza Italia Lia Sartori. Inoltre: la confisca dello stipendio e delle somme dei collaudi per Piva; del profitto di 33 milioni 960 mila euro oltre alle somme ricevute per Matteoli e Cinque. Queste le richieste di condanna della Procura di Venezia - 27 anni e 1 mese complessivamente per 8 imputati accusati a vario titolo di corruzione e finanziamento illecito - dopo cinque ore di requisitoria nell'ambito del processo per le tangenti del Mose. «Si tratta di fatti gravi perché hanno riguardato una delle opere pubbliche più importanti del nostro Paese e gli episodi sono durati anni», ha spiegato il pm Stefano Ancilotto, «Nel conteggio si è tenuto conto dei fatti e delle pene di chi ha patteggiato».
 articolo9.blogautore.repubblica.it. 29 giugno 2017 (c.m.c)
articolo9.blogautore.repubblica.it. 29 giugno 2017 (c.m.c)
Se l'approssimazione conta più della Costituzione. È sotto questo titolo che si potrebbe rubricare il finale tragicomico dell'iter parlamentare del famigerato articolo del ddl sulla concorrenza che avrebbe aperto le porte ad una esportazione selvaggia dei beni culturali privati, di fatto la fine di una politica di tutela iniziata in Italia fin dai primi anni del XVII secolo.
La storia è nota. Un gruppo lobbistico costituito dai grandi antiquari e dalle case d'asta internazionali riesce ad aprirsi un tale varco nel ministero di Dario Franceschini da vedere formalmente nominato un suo rappresentante nel gruppo di lavoro chiamato a riscrivere le norme sull'esportazione. Ne scaturisce un vero capolavoro: tutto può uscire, fa fede l'autocertificazione e il sistema delle soglie di valore. Se autocertifico che quel certo quadro in mia proprietà vale meno di 13.500 euro lo posso portare dove mi pare: tradotto in italiano, bomba libera tutti. Non serve la mobilitazione della comunità scientifica della storia dell'arte, non serve l'indignazione di Italia Nostra, non serve un articolo in cui Gian Antonio Stella smonta pezzo a pezzo l'affidabilità dell'autocertificazione. Niente, il Pd e Franceschini non sentono ragione e oggi, alla Camera, passa definitivamente questa legge-truffa del patrimonio culturale.
Ma c'è un ma. Il comma 176 del provvedimento appena approvato, infatti, subordina tutta la nuova procedura alla tenuta del registro delle cose oggetto di commercio, in forma elettronica, in due sezioni a seconda del valore. Peccato che la legge 222/2016 abbia abrogato l'articolo 126 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (un Regio Decreto del 1931) che istituiva quel registro. Come ha fatto notare, di fronte ad una assemblea incredula, la deputata Claudia Mannino, non essendoci il registro, la nuova normativa sulle esportazioni è inapplicabile. La maggioranza ci potrà riprovare, ma dovrà farlo con una nuova legge ad hoc, sulla quale sarà dura mettere la fiducia come ha fatto sul ddl concorrenza che (del tutto impropriamente) ha provato a smontare un cardine del Codice dei Beni culturali.
Morale: la cialtroneria arriva laddove non arriva il rispetto per l'articolo 9 della Costituzione. Amen.
Pare si stia sviluppando a Milano una interessante discussione sull'invisibilità mediatica del «plinto di Porta Nuova» assediato dai veicoli (segue)
Pare si stia sviluppando a Milano una interessante discussione sull'invisibilità del «plinto di Porta Nuova» assediato dai veicoli. Invisibile nella solita, patinata pubblicistica decantatoria, sulla stampa di informazione, e nella coscienza collettiva in generale, tranne in quella degli utenti di quel luogo, naturalmente. Per chi non lo sapesse, nella terminologia un pochino gergale dei progettisti dicesi plinto urbano (Cfr. Jouke van der Werf, Kim Zweerink, Jan van Teeffelen, History of the City, Street and Plinth, in AA.VV. The City at Eye Level, 2016) l'interfaccia al pianterreno o comunque ai livelli inferiori, tra edificio e città, quello che da un lato sarebbe la vera misura dell'equilibrio prestazionale fra spazio pubblico e privato, ma dall'altro più di ogni altro dettaglio subisce il devastante impatto della coatta eterna «intermodalità», consistente nell'imperfetto passaggio da un veicolo qualsivoglia, alla naturale condizione di nudo pedone.
Oggi iniziano a vedere la luce e a entrare a regime i progettoni privatistici della T Rovesciata di Ricostruire la Grande Milano, variamente concepiti dalle archistar di turno e soprattutto dagli «sviluppatori» di riferimento proprio secondo quel criterio da superblocco, già stigmatizzato sul nascere a suo tempo da William Whyte, secondo cui qualunque obiettivo è da perseguirsi e comunque intendersi internamente alla trasformazione, non certo nel rapporto con la città e men che meno nell'interfaccia del plinto urbano. Il quale viene così a ridursi a incrocio piuttosto casuale fra la città dei rendering tutta pedonale, o addirittura guarnita di tricicli da consegne, deltaplani, droni, danze folk multietniche di passaggio in variopinti costumi tradizionali, e la triste grigia realtà di un sistema di flussi, pendolari o casuali, ancora in gran parte caratterizzato dall'automobile, e di cui i pur progettati interfaccia interni di box sotterranei o autosilo sono solo caricature della soluzione (esattamente come i dettagli folkloristici high tech o di socialità posticcia elencati prima). Accade che poi il solito fai-da-te riempie i buchi vuoti di senso lasciati dalla non urbanistica, ma li riempie a modo proprio, e nel caso specifico di Porta Nuova ammucchiando ferraglia assediante, sotto forma di centinaia di motorini, scooterini e motoroni sparsi sul marciapiede dalla parte del «vicolo di servizio» su cui si aprono alcuni degli scaloni di accesso alla mitica Piazza Aulenti e ai luoghi di lavoro e svago trendy.
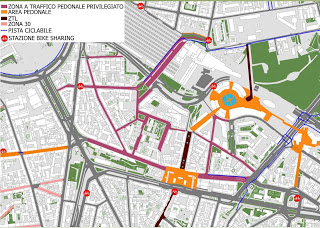 |
| L'area di Porta Nuova in uno dei progetti integrati del PUMS |
Quei racconti di gente che scende dall'aereo e magari trascinandosi appresso un trolley da venti chili scorazza serena da un mezzo di trasporto pubblico sostenibile all'altro, senza neppure smettere di spolliciare sul tablet, come ben si sa appartengono alla narrativa ufficiale, come le promozioni che un paio d'anni fa proponevano improbabili fuori-Expo food-oriented in città al turista internazionale. La realtà più prosaica è quella di chi è almeno tanto fortunato da potersi muovere qualche decina di chilometri in scooter, per poi mollarlo sotto le scale e salire come in un episodio di Star Trek dentro la realtà parallela della post modernità autoindotta. E quanto detto per il caso del quartiere modello, vale ovviamente in termini anche assai peggiori per tanta parte della città e dell'area metropolitana, quella stessa città metropolitana coperta dalla buona novella del nuovo Piano Urbano per la Mobilità Sostenibile, in questo momento nella fase delle osservazioni. Piano che a sfogliarlo, e a osservarlo anche nei dettagli, parrebbe promettere parecchie soluzioni anche al grosso problema descritto sopra, nonché a tanti altri.
Ci sono anche minuscole cadute di stile, dentro al complesso documento di piano del PUMS proposto ai cittadini, di cui val la pena forse ricordare almeno quei passaggi dove si afferma addirittura che «La linea M4, attualmente in costruzione, rivoluzionerà la mobilità [...] connetterà l’aeroporto di Linate, aumentando l’accessibilità internazionale». Prefigurando magari un utente che parte fiducioso dalla sua villetta di Willow Springs, Montana, con già salvato sullo smartphone il biglietto della linea blu che lo porterà dritto dritto davanti al bar del Cerutti Gino al Giambellino, agognata meta finale.
Sul medesimo registro, stavolta probabilmente per dare ai cittadini quel senso di atmosfera accogliente-futuribile già visto nella pubblicistica dei vari Eventi e Fuori-Eventi, la promessa di «realizzare High Line» sul modello dell'imitatissimo progetto newyorchese, anche se a ben vedere si tratta di cose con un rapporto inverso rispetto alla mobilità vera e propria, riuso di infrastrutture di trasporto dismesse ri-adibite al passeggio, ma appunto si tratta di dettagli di poco conto in sé. L'impressione è che anche nel caso del PUMS, esattamente come osservato per i plinti urbani dei progettoni pubblico-privati di riqualificazione, si tratti di qualcosa molto cresciuto su sé stesso e su una (assai organica e interconnessa, per carità) logica interna.
la Nuova Venezia, 29 giugno 2017 (m.p.r.)
Treviso. Entrambi le chiamano coltivazioni. Ma, in termini idrici, intendono cose diverse e concorrenziali tra di loro. Stiamo parlando degli agricoltori e dei cavatori. A entrambi il medio corso della Piave (fiume-madre), di cui ci occupiamo in questa seconda puntata (dal Ponte della Priula a Ponte di Piave) del nostro "viaggio", lascia il proprio obolo fino a svenarsi e a presentarsi a valle, senza nemmeno la forza per opporsi al ritorno delle acque salate dell'Alto Adriatico. Acque che devastano le coltivazioni di mais e soia riducendole a brulle, asfittiche e ingiallite lande nelle terre veneziane.
 «I movimenti ambientalisti si sono appiattiti su valori e «leggi» dell’economia globalizzata. Poi Trump con le sue politiche ci ha ricordato che i problemi ambientali sono un nuovo volto della lotta di classe fra ricchi/inquinatori e poveri/inquinati». il manifesto, 29 giugno 2017 (c.m.c.)
«I movimenti ambientalisti si sono appiattiti su valori e «leggi» dell’economia globalizzata. Poi Trump con le sue politiche ci ha ricordato che i problemi ambientali sono un nuovo volto della lotta di classe fra ricchi/inquinatori e poveri/inquinati». il manifesto, 29 giugno 2017 (c.m.c.)
Col suo brutale discorso del 1° giugno di quest’anno il presidente Trump ha dichiarato che gli Stati uniti non intendono più aderire agli impegni presi dal suo predecessore a Parigi nel dicembre 2015 sulle azioni per attenuare le cause dei cambiamenti climatici. Tali azioni, secondo Trump, limiterebbero certe attività importanti per l’economia e i lavoratori del suo paese (l’uso del carbone come combustibile), faciliterebbero le importazioni di autoveicoli meno inquinanti con danno per l’industria automobilistica americana e imporrebbero ai consumatori americani maggiori costi per merci alternative e maggiori tasse per risarcimenti finanziari ai paesi danneggiati.
Come è ben noto, i cambiamenti climatici sono dovuti a varie cause, tutte di carattere economico e merceologico, distribuite diversamente fra i vari paesi, come sono distribuiti diversamente i danni e i relativi costi. La principale causa è costituita dalla modificazione della composizione chimica dell’atmosfera per la crescente immissione di «gas serra»: anidride carbonica proveniente dalla combustione dei combustibili fossili (in ordine decrescente di danno, carbone, prodotti petroliferi, gas naturale), metano proveniente dall’estrazione e trasporto del gas naturale e dalla zootecnia intensiva, e alcuni altri. In secondo luogo i cambiamenti climatici sono dovuti al taglio delle foreste praticato per «liberare» nuovi spazi da dedicare all’agricoltura e all’estrazione di minerali, soprattutto per ricavarne merci destinate all’esportazione, e alle modificazioni della struttura del suolo a causa delle coltivazioni intensive che assicurano maggiori profitti agli agricoltori e per l’espansione degli spazi urbanizzati.
I soggetti coinvolti sono approssimativamente due: gli inquinatori, soprattutto i paesi industriali tradizionali o di nuova industrializzazione (diciamo i ricchi), e gli inquinati, diciamo i poveri, quelli che sono esposti alla siccità, alla desertificazione, e, d’altra parte, ad alluvioni e allagamenti. Con varie contraddizioni: sono danneggiati anche i paesi inquinatori (le alluvioni e la siccità colpiscono anche Europa, Stati uniti e Cina, importanti inquinatori) e d’altra parte anche i paesi poveri, che subiscono maggiormente le conseguenze dei mutamenti climatici, ne sono anch’essi responsabili in parte, soprattutto per la distruzione delle foreste o le attività minerarie.
Gli accordi di Parigi, come è noto, vincolano i paesi inquinatori a limitare le attività responsabili dei mutamenti climatici (usare meno combustibili fossili, soprattutto carbone, ricorrere a energie rinnovabili, produrre merci, soprattutto autoveicoli, che inquinano meno a parità di servizio, per esempio di chilometri percorsi), e a risarcire i paesi poveri che subiscono maggiormente i danni dei mutamenti climatici.
Il più comune strumento è una imposta, pagata dagli inquinatori in proporzione alla quantità di gas serra emessi, destinata ad azioni di rimboschimento, ad aiuti ai popoli alluvionati o resi sterili dalla siccità. Meccanismi da regolare con accordi commerciali – si tratta di un vero e proprio commercio del diritto di inquinare, una specie di commercio delle indulgenze – abbastanza complicati. Per farla breve, si tratta di soldi che gli inquinatori devono tirare fuori, con tasse e perdita di posti di lavoro e modificazioni dei consumi — cose sgradevolissime per la società globalizzata basata sulla legge fondamentale del capitalismo: la crescita del prodotto interno lordo, alla quale devono ubbidire i governanti per compiacere gli elettori che pensano ai soldi e agli affari.
Si capisce bene, quindi, perché il presidente Trump, con la sua abituale brutalità, ha detto che lui «deve» pensare agli interessi dei lavoratori, dei cittadini e dei finanzieri americani e non al futuro del pianeta Terra e alla sorte dei paesi desertificati o alluvionati. A dire la verità, probabilmente tutti i paesi industriali inquinatori pensano la stessa cosa pur dichiarando a gran voce la fedeltà agli accordi di Parigi. In un certo senso coloro a cui stesse a cuore davvero il futuro del pianeta dovrebbero essere riconoscenti a Trump per aver ricordato con chiarezza i veri caratteri dei rapporti fra natura, società ed economia. Ai tempi dei primi movimenti di contestazione «ecologica», all’inizio degli anni settanta, nel nome dell’ecologia sembrava possibile fermare lo sfruttamento della natura, rallentare i consumi superflui e i relativi sprechi e rifiuti, attenuare le disuguaglianze fra ricchi e poveri. Poi, col passare degli anni, i movimenti ambientalisti si sono appiattiti sui valori e le «leggi» dell’economia globalizzata. Molti sono diventati collaboratori dei governi nelle imprese apparentemente verdi, sostenibili, sono diventati sostenitori delle merci biocompatibili, delle fonti di energia rinnovabili (solare e eolico), in realtà occasioni di nuovi affari e commerci.
Trump ci ha ricordato che i problemi ambientali sono un nuovo volto della lotta di classe fra ricchi/inquinatori e poveri/inquinati e la loro soluzione – e la salvezza del pianeta – sono ottenibili soltanto recuperando la voglia di lottare per superare il capitalismo, per una maggiore giustizia sociale, premessa anche per la liberazione dalla violenza fra le persone, i paesi, le generazioni – oltre che verso la natura.
la Nuova Venezia, 28 giugno 2017 (m.p.r.)
Tre tronconi, per tre racconti diversi ma uniti da un solo filo: il fiume malato. Come tutti i fiumi che soffrono la mancanza d'acqua, l'incuria, il disinteresse pubblico e l'interesse privato. Il Piave, dalla sorgente alla foce, ha malattie diverse. A nord il prelievo della sua ricchezza per lo sfruttamento delle centraline. Nel medio Piave le escavazioni, e in generale l'insediamento agricolo poco rispettoso dell'equilibrio biologico. A sud, gli effetti nel mare che risale con il cuneo salino e il fenomeno delle alghe. In questa prima puntata, nella discesa dal Peralba al Montello, fino a Ponte della Priula, raccontiamo come lo sfruttamento delle centraline idroelettriche, che gli ambientalisti non esitano a definire macchine-bancomat per chi le possiede, stia trasformando il fiume e il flusso delle sue acque.
VIAGGIO DAL PERALBA AL MARE/1
Dal Peralba al Piave sono 220 chilometri, un bacino di oltre 4 mila chilometri quadrati. La Piave che nasce al confine tra Bellunese e Austria attraverso un pezzo di Veneto come un libro di storia, aspro e lacerante. Seducente e sacro nella memoria collettiva, riaccesa oggi a cento anni dalla battaglia finale della Grande Guerra. Ma di quel fiume resta poco. La natura e la mano dell'uomo ne ha trasformato l'aspetto e l'economia. La siccità, i mutamenti climatici. Certo. Ma soprattutto la rapacità degli interessi economici. Abbiamo disceso "la" Piave per raccontarla da dentro. Oggi la prima puntata.
Continua il lavoro su due fronti dell'associazione "Poveglia per tutti", con il demanio per definire i termini per la concessione, e sul campo con azioni concrete per rendere fruibile un bene comune per anni in abbandono. la Nuova Venezia, 27 giugno 2017 (m.p.r.) con riferimenti
Venezia. Nonostante il brutto tempo, la "Sagràanomala", la festa organizzata dall'associazione "Poveglia per tutti", con la collaborazione quest'anno di una trentina di altre realtà veneziane, è andata molto bene. Oltre ai laboratori, ai giochi e al momento di convivialità, c'è stata l'assemblea rivolta ai soci dove si è letta la bozza da presentare al Demanio per chiedere l'utilizzo a tempo determinato dell'isola.
Si veda su eddyburg la nota Poveglia per tutti: una ricchezza da non perdere e il dossier realizzato dall'associazione "Poveglia per tutti" per «far conoscere le vicende attuali dell’isola veneziana di Poveglia, che l’Agenzia del Demanio ha inserito tra i beni dello Stato da dismettere per essere dati in concessione o venduti a privati». In questo sito trovate numerosi articoli sulle vicende recenti dell'isola: basta che scriviate "Poveglia" sulla casella sensibile in cima a ogni pagina.
La quantità e la natura dei reati per i quali il discusso personaggio, oggi sindaco di Milano, è indagato richiederebbero una discussione più ampia sulla città giannibarbacetto.it, 24 giugno 2017, con postilla (m.c.g.)
La candelina del primo anno da sindaco di Giuseppe Sala, a palazzo Marino, è stata spenta dal ventaccio soffiato dal palazzo di Giustizia. La Procura generale ha chiuso l’indagine sul più grande appalto Expo, quello della “piastra”, e ha comunicato a Sala di essere indagato non solo per falso ideologico e materiale, ma anche per turbativa d’asta: ha falsificato la data di nomina di due commissari di gara; e ha condotto in modo irregolare l’appalto per gli alberi dell’esposizione universale, alla fine pagati quasi il triplo del loro valore.
C’è voluta la Procura generale per riuscire a riscrivere la storia della “piastra” Expo, un appalto da 272 milioni di euro per preparare la base su cui impiantare tutta l’esposizione. La Procura di Edmondo Bruti Liberati (nel 2014 in guerra con il suo vice Alfredo Robledo) aveva alla fine chiesto di riporre tutto in archivio. Ma ora il sostituto procuratore generale Felice Isnardi, che aveva avocato le indagini sostituendosi alla Procura, avvisa otto persone e due aziende che l’inchiesta è conclusa e si prepara a chiedere i rinvii a giudizio. Scrive una storia che si dipana tra gli uffici Expo sopra il Piccolo Teatro e l’area dell’esposizione a Rho, ma che arriva fino all’abitazione privata a Brera di Sala, allora amministratore delegato e commissario Expo e oggi sindaco di Milano.
Tutto comincia nel 2012 nella sede di Mm, la società d’ingegneria che insieme a Expo spa prepara il progetto esecutivo della “piastra”. Un dipendente di Mm, l’architetto Dario Comini (già condannato in altre indagini Expo e solo omonimo di un grande barman milanese che realizza ottimi cocktail), estrae dai computer dell’ufficio i documenti sul progetto esecutivo, ancora segreti, e li porta a Piergiorgio Baita, il numero uno della Mantovani, l’impresa già coinvolta nelle indagini sul Mose di Venezia.
Poi lo incontra, per spiegargli per bene, punto per punto, come fosse un personal trainer, il progetto e i suoi problemi. Forte di questa formidabile preparazione atletica, Baita partecipa alla gara e nell’agosto 2012 sbaraglia i concorrenti. Presenta un’offerta tecnica che risulta prima per punteggio qualitativo (46,8 punti su 60) e un’offerta economica prima per ribasso (148,9 milioni su 272, il 41,8 per cento). Comini (l’architetto, non il barman) viene premiato con 30 mila euro mascherati da incarico professionale (inesistente).
Ma intanto era scoppiato il caso della commissione giudicatrice della gara: Sala scopre, dopo che la commissione si è già riunita una prima volta il 18 maggio 2012, che due commissari sono incompatibili. Rischia di saltare tutto. Allora fa carte false. Firma tre atti che annullano gli atti precedenti e aggiungono due commissari “supplenti”, che poi sostituiscono i due incompatibili: li firma il 31 maggio 2012, ma la data sugli atti è 17 maggio. Li firma nella sua casa di Brera, dove gli hanno mandato i documenti.
Poi, nel luglio 2012, la commissione proclama il vincitore. Scoppia il finimondo: a vincere l’appalto doveva essere il costruttore Paolo Pizzarotti, ne erano convinti il presidente della Regione Roberto Formigoni e il suo fedelissimo Antonio Rognoni, numero uno di Infrastrutture Lombarde, gran regista degli appalti lombardi (poi sarà arrestato per altre indagini). E invece, grazie a Comini, stravince la Mantovani. Da dove spunta questo Baita? Rognoni e i suoi cercano di convincerlo a farsi da parte lasciando il posto al secondo classificato (Pizzarotti appunto). Cercano di invalidare la gara. Baita non molla. Allora Pizzarotti stringe con lui un accordo: lo convince a non fare ricorso, nel caso risultasse escluso da una “verifica di congruità” della sua offerta; e in cambio offre di fare a metà, tra Pizzarotti spa e Mantovani spa, dei 50 milioni di differenza tra le due offerte. Ma la verifica poi non viene fatta, perché l’offerta della Mantovani è ai limiti, ma regolare.
Allora Baita viene vessato con richieste aggiuntive (e non previste dal bando): raddoppio della fideiussione assicurativa, limitazione dei subappalti. Baita ingoia. Intanto però ha ingaggiato Angelo Paris, braccio destro di Sala a Expo e rup (responsabile unico del procedimento) della “piastra”, che gli racconta in diretta tutto quello che succede nella sala di comando dell’esposizione. Lo aiuta a far approvare un “premio di accelerazione” (30 milioni) e una ristrutturazione del contratto (55 milioni). Ma nel maggio 2014 Paris viene arrestato per un’altra indagine su Expo e il suo “lavoro” s’interrompe.
Intanto Sala è alle prese con un’altra grana: quella degli alberi di Expo. La fornitura delle 6 mila piante è dentro l’appalto della “piastra”. Ma “esponenti politici della Regione Lombardia” (prevedibilmente i ciellini di Formigoni e Rognoni) vogliono coinvolgere l’Associazione lombarda florovivaisti. È già pronta a scattare la ditta Peverelli, con il sostegno di uno sponsor, la Sesto Immobiliare di Davide Bizzi, che era in attesa di realizzare il progetto di “Città della salute” sull’area Falck di Sesto San Giovanni. Sala accetta: “Senza un provvedimento formale, dispone lo stralcio dal bando” della fornitura di alberi, del valore di circa 5 milioni di euro. L’importo non viene scorporato dai 272 milioni della “piastra”, ma viene “artificiosamente spalmato sulle altre lavorazioni allo scopo di mantenere inalterato il valore della base d’asta”. Viene “omesso di predisporre un nuovo bando di prequalifica” a cui avrebbero potuto partecipare altre imprese e “già dal 15 marzo 2012” viene “individuato l’affidatario della fornitura nella ditta Peverelli in associazione con uno sponsor”. Ecco dunque scattare per Sala la nuova accusa di turbativa d’asta. Poi però la triangolazione non riesce, Bizzi si sfila e Peverelli si ritira. Paris allora “concorda con la Mantovani l’affidamento diretto” della fornitura di alberi, per 4,3 milioni di euro (716 euro a pianta). La Mantovani li compra in un vivaio a 1,6 milioni (266 euro a pianta).
Nell’indagine che la Procura di Milano voleva archiviare, la Procura generale ha individuato ben 12 ipotesi di reato. Una corruzione (Comini e Baita), tre turbative d’asta (Sala, Rognoni, Perez, Comini, Baita, Morbiolo), una ricettazione (Baita), tre abusi d’ufficio (Paris), un falso in atto pubblico (Sala e Paris), una intrusione in illecita in sistemi informatici (Comini), una rivelazione di segreti d’ufficio (Comini), una omessa denuncia (Paris). Ora gli indagati potranno replicare. Poi arriveranno le richieste di rinvio a giudizio.
postilla
Al di là delle effettive responsabilità penali che spetterà alla magistratura valutare, molti avevano ritenuto che quella di Sala fosse una candidatura inopportuna. In questo clima di crescente delegittimazione, sarebbe comunque doverosa una pausa di riflessione da parte del governo locale sui sedicenti grandi progetti di rigenerazione in discussione: in primis sugli Scali Ferroviari, ma anche sul riuso delle aree exEXPO e sul futuro di Città degli Studi (m.c.g.)
la Repubblica, 24 giugno 2017 (m.p.r.)
Sempre meno acqua e sempre più sprechi. I ricercatori del Cnr-Isafom (Istituto per i sistemi agricoli e forestali del Mediterraneo) prevedono che il caldo di quest’anno non sarà un caso sporadico e potrebbe durare, come accaduto ciclicamente 1000 e 2000 anni fa, per circa 150 anni. «Occorre quindi intervenire al più presto per contrastare gli effetti negativi sulla disponibilità delle risorse idriche», dice la ricercatrice Silvana Pagliuca. In pratica, bisogna migliorare i sistemi di raccolta e distribuzione, e invece in Italia l’acqua si spreca a più non posso.
Cambiamenti climatici, sprechi e infrastrutture colabrodo: la mancanza d'acqua investe nuove aree del paese ed è sempre più in anticipo. Articoli di Andrea Giambartolomei e Luca Mercalli. il Fatto Quotidiano, 23 giugno 2017 (p.d.)