

Certo. Un capitalista integralmente onesto sta solo nelle utopie calviniste e in qualche rarissima eccezione che appunto conferma una regola generale fatta di piccole e grandi miserie morali. Questo avviene ora con maggiore intensità perché il mercato dell’auto è da tempo un mercato sostitutivo più che accrescitivo. Vi sono limiti ambientali e sociali che inibiscono il dilagare dell’uso dell’automobile e quindi della sua commercializzazione nel mondo intero. Se i primi possono essere aggirati truccando i dati – come è avvenuto in questo caso e continua ad avvenire in tanti altri con la complicità generale – i secondi sono strutturali. Né in Africa, né in tante amplissime zone del mondo le persone hanno un reddito che neppure lontanamente può fare loro sperare di diventare possessori di un’automobile. Né il capitalismo globalizzato accenna minimamente ad assottigliare le diseguaglianze. Anzi le dilata in continuazione, come, da ultimo, ci ha ben spiegato e documentato Thomas Piketty.
Quindi la lotta della competitività nel campo dell’automotile avviene su un terreno relativamente ristretto. Appena un paese emergente apre i propri mercati ci si buttano a pesce. Quindi da un lato si cerca di sfondare laddove il mercato è già saturo con modelli innovativi (è il caso del motore a diesel negli Usa), dall’altro diventa feroce la competizione sui nuovi lembi di mercato che emergono. Non è forse un caso che la vicenda Volkswagen sia stata disvelata dall’Epa, l’agenzia statunitense incaricata dei controlli ambientali. Anche se qualche dietrologo punta di più sulla faida infinita tra i membri della famiglia Porsche – l’inventore del Maggiolino – e l’attuale management Volkswagen. Probabilmente gli Usa hanno voluto avvertire la Germania che non intendono assistere inerti al suo tentativo di affrontare da sola – asservendo l’Europa a questo disegno – le sfide della globalizzazione. La stessa ragione per cui, probabilmente, la Merkel come i suoi alleati, sapevano e tacevano.
Ma lo scandalo solleva un altro problema ancora più grosso, sia perché avviene alla vigilia del nuovo incontro internazionale di Parigi Cop21, dedicato all’abbassamento delle emissioni per diminuire il riscaldamento globale; sia perché sono in corso le trattative, peraltro segrete, per concludere un accordo di “libero scambio” fra le due sponde dell’Atlantico, il famoso Ttip. Serve agli Usa distruggere l’immagine di un’Europa virtuosa in materia ambientale, contrapposta ad un’America dalla manica più che larga e renitente a ogni forma di stringente accordo in questo campo.
Ma soprattutto, e questo riguarda in particolare il Ttip, lo scandalo Volkswagen ci dimostra ancora una volta – ce ne fosse bisogno – che il moderno capitalismo nel suo complesso, con accelerazioni e responsabilità dirette che dipendono dalle circostanze e dai momenti, non sopporta leggi e norme, né quelle dei singoli paesi in cui opera, né quelle contenute negli stessi trattati che firma. E’ proprio il caso della Germania in surplus esportativo da più di sei anni in barba ai vincoli del Trattato di Maastricht che invece viene fatto valere solo per chi sgarra sul debito. Nel trattato di libero scambio transatlantico si prevede che se la legislazione di un paese o di un ente locale entra in contraddizione con le esigenze esortative di una multinazionale, questa può fare ricorso e un minicomitato di “saggi” definito a livello internazionale può condannare l’istituzione elettiva a rivedere la propria normativa sulla materia. E’ la morte del diritto. E’ la legalizzazione dell’imbroglio, che fin qui è avvenuto per via pratica.
Ma le organizzazioni sindacali non hanno nulla da dire? Questo è il punto più delicato che la vicenda Volkswagen solleva. Infatti nell’industria tedesca, o meglio in parte di essa e certamente nella impresa di Wolsburg, vige la cosiddetta mitbestimmung, ossia la codeterminazione in virtù della quale i rappresentanti dei lavoratori siedono in un comitato di sorveglianza. La mitbestimmung è stata uno dei motivi di vanto dell’esperienza della socialdemocrazia tedesca, oggi peggio che opaca, proprio perché si basa non sull’assunzione del lavoro dentro la logica stretta dell’impresa – che è invece l’essenza del “marchionnismo” – ma sul riconoscimento di una dualità tra capitale e lavoro, dando però a quest’ultimo un ambito nel quale fare valere le sue ragioni anche sugli indirizzi e sulle scelte produttive. E’ lecito chiedersi e indagare su come è stata esercitata e se è stata esercitata, la sorveglianza in questo caso. Quello che è chiaro è che anche la mitbestimmung mostra la corda a fronte delle dimensioni multinazionali dell’impresa e della costruzione di spazi extrasindacali ed extragiudiziali internazionali da parte dell’impresa medesima. Per queste ragioni lo scandalo Volkswagen pone interrogativi seri al movimento sindacale nel suo complesso, ma a quello tedesco ed europeo in particolare.
 «Le centraline truccate sono un evidente strumento di competizione sul mercato. Le stesse regole, come talune normative comunitarie apparentemente generate dal delirio di qualche euroburocrate, nascondono in realtà piccole e grandi guerre commerciali».
«Le centraline truccate sono un evidente strumento di competizione sul mercato. Le stesse regole, come talune normative comunitarie apparentemente generate dal delirio di qualche euroburocrate, nascondono in realtà piccole e grandi guerre commerciali».
Il manifesto, 23 settembre 2015 (m.p.r.)
Alla borsa dell’immagine, in questo travagliato 2015, la Germania balla senza sosta. Prima esibisce il volto spietato del rigore contabile e dell’austerità, poi quello umanitario dell’accoglienza e della solidarietà, infine quello truffaldino della spregiudicatezza commerciale.
Proporsi all’Europa come modello ed esempio è una pretesa che comporta qualche inconveniente. Cosicché lo scandalo delle emissioni truccate nelle auto smerciate dalla Volkswagen sul mercato americano, e chissà su quanti altri, assume un significato e una dimensione ben più vasta di una frode commerciale, sia pure commessa ed ammessa da uno “specchiato” gigante dell’industria mondiale. È l’intera strategia di marketing economico e politico perseguita da Berlino a rischiare di disfarsi. Nel paese dalla più sviluppata sensibilità ecologica e dalle più severe norme ambientali, il primo gruppo industriale, il fiore all’occhiello del successo tedesco, si ingegna nell’eludere l’una e le altre.
A poco vale allora mettersi alla caccia di responsabilità individuali, sostenere che i test, quando non rappresentino una farsa, non sono certo un impeccabile esempio di “neutralità della scienza”, ricordare che gli Stati uniti d’America, nonostante le aspirazioni verdi di Obama, restano un formidabile inquinatore planetario.
Il danno è compiuto e non saranno le multe salatissime o le dimissioni dell’amministratore delegato della casa di Wolfsburg, Martin Winterkorn a poterlo riparare.
Il fatto è che i tre volti del Modell Deutschland, sono in realtà uno solo. La politica di austerità, i bassi salari e le restrizioni del Welfare, imposti all’interno così come agli altri paesi dell’Unione europea, il bisogno di mano d’opera straniera, sia pure forzato nei suoi tempi e nei suoi modi da una pressione migratoria senza precedenti (non dal buon cuore di Angela Merkel) e l’aggressiva politica di sostegno all’export, costituiscono un insieme piuttosto coerente anche se non proprio “esemplare”. E per nulla al riparo da catastrofici incidenti di percorso.
Solo pochi giorni fa la Cancelliera aveva invitato le industrie automobilistiche tedesche ad assumere un alto numero di rifugiati. C’è da scommettere che a Wolfsburg (dove sono stati accantonati 6,5 miliardi, più della cifra complessiva stanziata da Berlino per l’emergenza migranti, allo scopo di far fronte a una parte delle multe che pioveranno su Volkswagen) prevalgano tutt’altre preoccupazioni. Le “spalle larghe” della Germania, sbandierate quotidianamente da Berlino, non sono certo il risultato di una virtuosa etica protestante, ma di una politica di protezione a oltranza delle banche e delle rendite tedesche, nonché di un’accumulazione di surplus commerciale a spese degli altri membri dell’eurozona che, come abbiamo visto, non è quel frutto immacolato dell’eccellenza produttiva teutonica che volevano farci credere. A meno di voler riconoscere anche alla tecnologia della frode una sua qualità di eccellenza.
Beninteso, è assai improbabile che il grande gruppo tedesco, sia stato il solo ad aggirare in un modo o nell’altro gli standard ambientali stabiliti. Solo l’idea, alimentata dall’autocelebrazione del liberismo, che la competitività sia un meccanismo “pulito”, una questione di “merito” e di efficienza, di capacità e di rigore, può farci accogliere con sorpresa lo “scandalo” Volkswagen. Le centraline truccate sono un evidente strumento di competizione sul mercato. Le stesse regole, come talune normative comunitarie apparentemente generate dal delirio di qualche euroburocrate, nascondono in realtà piccole e grandi guerre commerciali. Altrettanti tentativi di spostare il terreno della concorrenza a favore di determinati produttori. In questo gioco di sponda tra standard normativi e competizione sul mercato possono crearsi cortocircuiti e “danni collaterali” come quelli in cui sono incappati gli strateghi di Wolfsburg, anche se, per il momento, solo oltre Atlantico.
Ma per la Germania il cui governo diffonde senza sosta una idea “morale” e virtuosa della competitività, rimproverando i partner europei di non dedicarvi sufficienti energie e “riforme”, il guasto è davvero spaventoso. Chi considera il mercato come lo spazio deregolamentato di una concorrenza senza esclusione di colpi (i Repubblicani Usa, per esempio) non troverà in questa vicenda particolare motivo di stupore, stigmatizzando, semmai, più la frode come turbativa degli scambi che l’inquinamento come danno per la società. Ma per chi sostiene che il mercato rappresenta un “ordine” razionale e la competitività una disciplina che si esercita al suo interno secondo regole certe non sarà facile superare il trauma provocato dalla truffa ad alta tecnologia escogitata dalla Volkswagen e le sue probabili conseguenze commerciali. Di tanto in tanto quell’“ordine” si rivela, infatti, per quello che è: un rapporto di forza.
 I grandi ritornano. Le ragioni dell'attualità dell'analisi del colonialismo e dell'esperienza personale dell'intellettuale nei drammi del mondo di oggi.
I grandi ritornano. Le ragioni dell'attualità dell'analisi del colonialismo e dell'esperienza personale dell'intellettuale nei drammi del mondo di oggi.
Comune-info, newsletter, 11 settembre 2015
Non è certo la prima volta che le idee e la breve esistenza di Frantz Fanon sembrano capaci di far luce tra i dedali intricati e complessi dei percorsi di una realtà contemporanea. Viviamo un tempo in cui l’accumulazione del capitale espropria dei beni comuni interi popoli e depreda la natura in una forma che ripropone diversi aspetti della dominazione coloniale. Una forma che spesso non si limita più a sottomettere i dominati ma non esita a sterminarli, qualora oppongano resistenza e minaccino di sfuggire al suo controllo. Alla decolonizzazione del pensiero critico e delle pratiche di emancipazione ispirate dallo psichiatra nero della Martinica, Raúl Zibechi ha dedicato il suo ultimo libro. In questo articolo riassume le cinque principali ragioni della straordinaria attualità politica della lezione antirazzista e antieurocentrica di Fanon, un pensatore lontano dall’accademia che ha messo la vita intera al servizio della lotta anticoloniale in Algeria e nel mondo
Il pensiero di Frantz Fanon è ritornato. A cinquant’anni dalla morte, i suoi libri tornano ad essere letti nelle università e negli spazi dei settori popolari organizzati. Alcune delle sue riflessioni centrali illuminano aspetti delle nuove realtà e contribuiscono alla comprensione del capitalismo, in questa fase di sangue e di dolore per los de abajo.
La riedizione di alcune delle sue opere come Piel negra, mascaras blancas (Akal 2009) [Pelle nera maschere bianche, Marco Tropea, ndt], con commenti di Immanuel Wallerstein, Samir Amin, Judith Butler, Lewis R. Gordon, Ramón Grosfoguel, Nelson Maldonado-Torres, Sylvia Wynter e Walter Mignolo, ha contribuito alla diffusione del suo pensiero, così come le periodiche ristampe della sua opera principale, I dannati della Terra, con la prefazione di Jean Paul Sartre. Sarebbe necessaria anche la riedizione del suo libro Sociologia di una rivoluzione, pubblicato nel 1966 (in Messico, ndt) dalla Editorial Era (in Italia da Einaudi nel 1963, ndt)
Il rinnovato interesse per Fanon, tuttavia, va ben al di là dei suoi libri e dei suoi scritti. Si tratta, credo, di un interesse epocale, nel duplice significato del periodo attuale che attraversano le nostre società e della nascita di forti movimenti antisistemici che vedono come protagonisti i diversi abajos. Voglio dire che ci troviamo di fronte a un interesse politico più che a una curiosità accademica o letteraria.
A mio parere, ci sono cinque ragioni che spiegano l’attualità di Fanon.
La prima è che nella sua fase attuale, centrata sull’accumulazione per espropriazione (o quarta guerra mondiale), il capitalismo ripropone alcuni aspetti della dominazione coloniale. Alcuni di questi aspetti sono l’occupazione di enclave territoriali da parte di imprese multinazionali e l’occasionale ma importante occupazione militare da parte degli imperialismi di vari paesi con la scusa della guerra contro il terrorismo.
Nella misura in cui accumula rubando i beni comuni di interi popoli, il capitalismo ci permette di dire che ci troviamo di fronte a un neocolonialismo, sebbene, a essere rigorosi, si tratta della fase di decadenza del sistema, che non aspira più ad assorbire le classi dominate bensì, semplicemente, a controllarle e sterminarle nel caso in cui oppongano resistenza.
La seconda [ragione] è che appare sempre più evidente che la società attuale si divide, come dice Grosfoguel basandosi su Fanon, in due zone: la zona dell’essere, dove i diritti delle persone vengono rispettati e dove la violenza è un’eccezione, e la zona del non-essere, dove la violenza è la regola. Il pensiero di Fanon ci aiuta a riflettere su questa realtà che pone la massima distanza tra il capitalismo del XXI secolo e quello dello Stato sociale.
La terza è la critica che Fanon fa ai partiti di sinistra del centro del mondo, nel senso che le loro modalità di azione si rivolgono esclusivamente a un’élite delle classi lavoratrici, lasciando da parte i diversi abajos che nel marxismo sono liquidati come appartenenti al sottoproletariato. Al contrario, Fanon ripone la sua più grande speranza nella gente comune de abajo quale possibile soggetto della sua autoemancipazione o dell’emancipazione tout-court.
In quarto luogo, Fanon non era un intellettuale né un accademico. Metteva la sua conoscenza al servizio di un popolo in lotta come quello algerino, la cui causa ha servito fino al giorno della morte. Questa figura di pensatore-militante, o come si voglia chiamare chi si impegna in modo incondizionato con los de abajo, è un contributo straordinario alla lotta dei settori popolari.
A questo proposito, è bene sottolineare la critica all’eurocentrismo delle sinistre, alla pretesa di trasferire in modo meccanico nel mondo del non-essere, proposte e analisi nate nel mondo dell’essere. La nascita nel continente americano di femminismi indigeni, neri e popolari è una dimostrazione dei limiti di quel primo (e fondamentale) femminismo europeo che, tuttavia, aveva bisogno di essere reinventato tra le donne del colore della terra, in base alle loro specifiche tradizioni e realtà, tra le quali la centralità della famiglia nel mondo femminile latinoamericano.
Sebbene questo breve riassunto trascuri diversi importanti aspetti dell’opera di Fanon, come ad esempio le riflessioni sulla violenza degli oppressi, mi sembra necessario sottolineare un ulteriore aspetto, che ritengo centrale nel pensiero critico attuale. Ci si interroga sulle ragioni per le quali l’uomo nero voglia schiarire la sua pelle, sul perchè la donna nera desideri essere bionda o far parte di una coppia il più bianca possibile. Il dominato, il perseguitato, dice Fanon, non solo cerca di recuperare la tenuta di cui si è appropriato il padrone, ma vuole il posto del padrone. È evidente che, dopo il fallimento della rivoluzione russa e di quella cinese, questa considerazione deve occupare un posto centrale nella lotta anticapitalista.
Non condivido il ruolo che Fanon attribuisce alla violenza de los de abajo nel processo di trasformazione in soggetti delle proprie vite, nel processo di liberazione dall’oppressione. La violenza è necessaria ma non è la soluzione, come rileva giustamente Wallerstein giustamente nel suo commento a Pelle nera, maschere bianche.
Credo che dobbiamo approfondire questa discussione: come fare per non riprodurre la storia nella quale gli oppressi ripetono più volte l’oppressione di cui sono stati vittime. A mio parere, si tratta di creare qualcosa di nuovo, un mondo nuovo o nuove realtà, che non siano la fotocopia del mondo de los de arriba e che siano sufficientemente potenti da dissolvere, dall’immaginario collettivo, il posto centrale che occupa l’oppressore, il padrone, il proprietario. Continuo a credere che l’esperienza delle basi di appoggio dell’EZLN sia un esempio in questa direzione.
Riferimenti
Fonte: La Jornada. Traduzione per Comune-info: Daniela Cavallo
Raúl Zibechi, scrittore e giornalista uruguayano dalla parte delle società in movimento, è redattore del settimanale Brecha. I suoi articoli vengono pubblicati con puntualità in molti paesi del mondo, a cominciare dal Messico, dove Zibechi scrive regolarmente per la Jornada. In Italia ha collaborato per oltre dieci anni con Carta e ha pubblicato diversi libri: Il paradosso zapatista. La guerriglia antimilitarista nel Chiapas, Eleuthera; Genealogia della rivolta. Argentina. La società in movimento, Luca Sossella Editore; Disperdere il potere. Le comunità aymara oltre lo Stato boliviano, Carta. Territori in resistenza. Periferia urbana in America latina, Nova Delphi. L’edizione italiana del suo ultimo libro, Alba di mondi altri, è stata stampata in Italia in luglio dalle edizioni Museodei. Molti altri articoli inviati da Zibechi a Comune-info sono qui.
 L'allarme e la previsione sono più che giusti, ma le parole "classe" e "sinistra" vanno un po' strette rispetto alla catastrofe cui ci stanno portando alcuni secoli di capitalismo e all'immane impresa di scongiurarla.
L'allarme e la previsione sono più che giusti, ma le parole "classe" e "sinistra" vanno un po' strette rispetto alla catastrofe cui ci stanno portando alcuni secoli di capitalismo e all'immane impresa di scongiurarla.
Il manifesto, 9 settembre 2015
Nell’ottobre del 2003, negli Stati uniti, fu pubblicato il rapporto di due ricercatori, Peter Schwartz e Doug Randall, dal titolo «Uno scenario di bruschi cambiamenti climatici e le sue implicazioni per la sicurezza degli Stati uniti — Immaginando l’impensabile».
Il rapporto, probabilmente ispirato da qualche stratega del Pentagono per oscuri motivi, descriveva articolatamente una serie di eventi catastrofici dovuti principalmente ai cambiamenti climatici, con conseguenze politico-sociali dirompenti per alcune zone del mondo.
Dopo aver previsto che «Aree ricche come gli Usa e l’Europa diverranno delle “fortezze virtuali” per impedire l’ingresso a milioni di persone costrette ad emigrare per aver perso le proprie terre sommerse dall’aumento del livello dei mari, o per non poterle più coltivare», i due ricercatori immaginavano così il futuro prossimo dell’Europa: «L’Europa affronterà enormi conflitti interni a causa del gran numero di profughi che sbarcheranno sulle sue coste, provenienti dalle zone più colpite dell’Africa. Nel 2025 la UE sarà prossima al collasso».
Anche se non è stato determinato dai cambiamenti climatici, questo scenario «impensabile» è ora sotto i nostri occhi, né si può escludere del tutto, per gli anni a venire, un eventuale collasso dell’Unione europea. Il punto, ovviamente, non è stabilire se questi avvenimenti fossero o no prevedibili (per quanto essendo l’essere umano anche un demiurgo, l’anticipazione e la prospettiva dovrebbero far parte delle sue capacità), ma di capire il senso di questo flusso epocale di migranti, che non si limiti alle considerazioni generaliste sull’emergenza sociale e non si appaghi dell’altrettanto generico impegno per l’accoglienza e la solidarietà verso di loro.
Alessandro Portelli, con la sensibilità che lo contraddistingue, ha scritto che si tratta di una nuova forma di lotta di classe (anzi antica) anche se l’obiettivo di questi migranti non è il rovesciamento di un sistema, ma semmai il condividerlo. E’ una interpretazione spiazzante per la sinistra (anche quella antagonista) perché ci pone una serie di interrogativi e di compiti che ben poco hanno a che vedere col nostro umanitarismo, intriso com’è di misericordia cristiana e principi illuministici. Vero è che bisogna fronteggiare razzismo e xenofobia, ma questo non può risolversi soltanto nella rivendicazione di un’Europa solidale, col rischio che ciò si tramuti in una sorta di obolo «comunitario» senza per nulla incidere sulle origini e l’entità del male che è stato fatto. Basta fissare qualche immagine estiva per rendersene conto: i profughi siriani che irrompono nelle vacanze dell’agiata borghesia europea sbarcando nell’isola greca di Kos col loro carico di orrori, ne sono la metafora più efficace che mette di fronte chi ha e chi non ha, chi si diverte e chi si dispera, senza possibilità di dialogo, perché la condizione degli uni, in questa società, non può sussistere senza quella degli altri. E noi lo sappiamo, ma abbiamo smarrito le parole e i gesti per cambiare questo stato di cose.
Per questo i migranti ci parlano. Presi singolarmente ognuno dirà che è qui per rifarsi una vita, ma nel loro insieme, nel loro essere «massa invadente», ci dicono che l’altro mondo possibile di cui abbiamo vagheggiato è, in realtà, un cumulo di macerie da cui stanno fuggendo; che il nostro umanesimo e i nostri valori mediterranei, cioè le «essenze occidentali» come le chiamava Franz Fanon (di cui il «basamento greco-latino» costituiva una sorta di logo), sono ormai «soprammobili senza vita e senza colore». Disfarsi di questi soprammobili, cancellando dalla mente degli oppressi l’immagine del «basamento greco-latino» proprio perché simbolo di quelle «essenze» dominatrici, era considerato da Fanon un momento liberatorio nella lotta dei dannati della Terra.
Oggi siamo alla distruzione materiale di quel basamento per mano dell’Isis, che certo non può annoverarsi tra gli emuli di Fanon. Dunque il problema (dell’affrancamento economico e culturale di queste genti), si ripropone in forme tenebrose e non poteva essere altrimenti dato che l’Europa (per non parlare degli Usa) non ha mai smesso di apportare disordine e dolore in Africa e Medioriente. Quanti leader — africani, arabi, progressisti e rivoluzionari — sono stati uccisi, quante rivolte soffocate nel sangue, quanti i governi rovesciati pur di impedire che si affermasse un punto di vista indipendente e/o marxista come lo postulava Fanon: «Lasciamo quest’Europa che non la finisce più di parlare dell’uomo pur massacrandolo dovunque lo incontra, a tutti gli angoli delle sue strade, a tutti gli angoli del mondo». Diversamente l’Isis, nel mentre proclama la distruzione dell’Europa (limitandosi per ora a quella dei templi), mira al controllo delle ricchezze del sottosuolo in Medio Oriente, in Libia, in Nigeria per realizzare (apparentemente) un modello di società ibrida: confessionale, feudale, ma che non disdegna l’uso di tecnologie al passo con i tempi né, soprattutto, la logica di mercato propria del capitalismo.
In altre parole non vogliono essere come noi, ma prendere il nostro posto. Non una vera alternativa quindi, ma una variante sì ed anche efficace, in grado di mobilitare parte delle masse arabe ed africane e di suggestionare l’animo degli esclusi che vivono nelle banlieue europee.
Fate qualcosa, ci dicono ancora i migranti, per far sì che l’Isis non rappresenti più una chance. Ma questa volta fatela bene. Fermate la guerra, ma fermate anche lo sfruttamento, quello che ci accomuna in quanto subalterni, ma ci divide in quanto a fede e nazionalità. È un’istanza di classe, un appello alla sinistra.
 Come gran parte della stampa anche
Come gran parte della stampa anche
la Repubblica (10 luglio) sbatte in prima pagina la consegna di Evo Morales a papa Francesco del singolare connubio di simboli. Ma l'incontro tra i due personaggi, e il discorso di Borgoglio, sono solo l'antipasto di un gigantesco e memorabile evento di massa, che si svolgerà poco dopo a Vera Cruz (vedi in calce)
"Come ospite e pellegrino, vengo per confermare la fede dei credenti in Gesù", ha detto il Papa Francesco rivolgendosi al presidente della Bolivia Morales, alle autorità civili ed alla folla venuta a El Alto. Forte appoggio dal Papa appena giunto a La Paz dall'Ecuador, al cammino di inclusione sociale della Bolivia, alla sua tutela delle nazionalità, idiomi, culture, al suo riconoscere i diritti delle minoranze al suo opporsi al dio denaro che scarta anziani e giovani. Davanti a 500mila persone che lo hanno accolto all'aeroporto di El Alto, papa Francesco ha citato il preambolo della Costituzione boliviana. Subito prima del Papa, Morales, primo presidente indio dello Stato plurinazionale della Bolivia ha detto grazie al Papa "che ha scelto i poveri e ha scelto di chiamarsi come san Francesco d'Assisi, e gli ha chiesto "di aiutare il nostro cammino di cambiamento", "della nostra terra di pace - ha detto - che chiede giustizia".
Sintonia con Morales.
Religione e cultura.
Luis Espinal, il gesuita ucciso.
Riferimenti
Il discorso di papa Francesco all'Incontro mondiale dei movimenti popolari, Vera Cruz, 2015, in lingua spagnola. (inseriremo il testo in lingua italiana appena ne disporremo)
 «Primo Levi scriveva che ciò che è successo avrebbe potuto, per ciò stesso, succedere ancora. Pareva esagerato. Invece no. Tra i campi nazisti e le odierne barriere vi è ancora una non trascurabile differenza. Ma la strada è tracciata se non invertiamo la marcia».
«Primo Levi scriveva che ciò che è successo avrebbe potuto, per ciò stesso, succedere ancora. Pareva esagerato. Invece no. Tra i campi nazisti e le odierne barriere vi è ancora una non trascurabile differenza. Ma la strada è tracciata se non invertiamo la marcia».
Il Garantista, 20 giugno 2015
Chi l’avrebbe detto che dopo l’abbattimento festoso del muro di Berlino nel 1989, i muri si sarebbero moltiplicati? Le note di Bach, dalle suite per violoncello solo, suonate davanti a quelle storiche macerie da Mstislav Rostropovich accorso a Berlino l’11 novembre del 1989, sembravano avere posto fine alle divisioni, agli steccati, alla visione concentrazionaria del mondo. Pure illusioni.
Chi costruisce muri o produce filo spinato, fa affari al giorno d’oggi. Mari e muri si ergono come barriere mortali contro i migranti. Da Ceuta a Melilla; da Tijuana al costruendo muro in Ungheria; dal muro costruito dagli israeliani per separarli dai palestinesi a quello tra India e Bangladesh; e altri ancora: sono 50 le barriere artificiali e ostili sparse in tutto il mondo. Circa 8mila chilometri hanno il compito di separare esseri umani e difendere i più ricchi dalla contaminazione con i più poveri. Alcuni sono grezzi, altri in mattoni, altri mettono in campo materiali più moderni, altri tornano al filo spinato dei campi di concentramento della seconda guerra mondiale. Non a caso Primo Levi scriveva, a conclusione della sua opera, che quello che voleva dire poteva essere riassunto nel fatto che ciò che è successo avrebbe potuto, per ciò stesso, succedere ancora. Pareva esagerato. Invece no. Certo tra i campi nazisti e le odierne barriere vi è ancora una non trascurabile differenza. Ma la strada è tracciata se non invertiamo la marcia.
Papa Francesco ha fatto sentire la sua voce, potente e chiara. Nella sua ultima enciclica non si rivolge solo agli uomini di buona volontà, come Giovanni XXIII nella “Pacem in terris” ma a “ogni persona che abita questo pianeta”. Gli è toccata la risposta volgare di un qualunque Salvini. Pietà l’è morta? Come diceva una bella canzone partigiana? No, non ancora per fortuna. Lo dimostra la manifestazione di sabato 30 a Roma, e tante iniziative di solidarietà che hanno alleviato in qualche misura le pene dei profughi in questi giorni nelle stazioni delle grandi città o sugli scogli di Ventimiglia. Ma l’aiuto spontaneo può bastare? Ovviamente no.
Il problema migratorio, date le cause di fondo che lo hanno generato che ci rimandano alla struttura del capitalismo globalizzato e finanzia rizzato, è di lungo periodo. Uno degli elementi caratterizzanti dell’epoca attuale. Con il quale la politica, se ancora esiste, deve misurarsi. Bisogna sapere affrontarlo nel breve e nel più lungo periodo. L’Europa non lo fa. Anzi su questa questione rinascono i nazionalismi, si ringalluzziscono con forza le organizzazioni di destra, si riproducono i più meschini conflitti di frontiera.
Invece ci sono delle cose che è possibile fare subito, come attivare un programma di ricerca e salvataggio in tutta l’area del Mediterraneo; evitare di pensare a interventi armati contro i paesi di provenienza; aprire canali umanitari e vie d’accesso al territorio europeo; sospendere il regolamento di Dublino che blocca i migranti nei paesi di primo arrivo; sospendere gli accordi di Rabat e di Khartoum che vorrebbero esternalizzare fino in Africa i confini europei; provvedere a piani di investimenti che favoriscano lo sviluppo dei paesi di provenienza, anziché vendere armamenti e fomentare guerre; favorire la rinegoziazione dei debiti pubblici di quei paesi, come del resto la Ue dovrebbe fare nei confronti della Grecia, anziché portarla irresponsabilmente sull’orlo del default.
Non è vero che l’Italia non può accogliere migranti. Anzi. Dal punto di vista squisitamente numerico la situazione è tutt’altro che quella che le televisioni ci trasmettono e che è frutto dell’incapacità di governo del fenomeno. In una recente intervista al Sole24Ore il responsabile dell’accoglienza immigrati, Mario Morcone, ci fa capire che c’è un’agitazione spropositata e strumentale attorno al tema, fino a farlo diventare uno degli argomenti o principali delle recenti campagne elettorali. “Ci sono oggi circa 90mila immigrati in accoglienza in tutta Italia – dice Morcone – è come dire che possiamo distribuire circa dieci stranieri per ognuno degli 8mila comuni del nostro Paese. L’impatto è senza dubbio sostenibile. Le cifre sono molto basse.” Certo la politica, neppure quella dell’accoglienza, si può fare con l’aritmetica, ma questa considerazione smonta alla radice l’allarmismo gettato a piene mani da Salvini a da Grillo.
E poi, è proprio vero che gli immigrati sono un peso e non una risorsa per il nostro paese? Il nostro è un paese che invecchia – ci avverte l’Istat -; la crescita demografica è sotto zero; il movimento naturale della popolazione, cioè il saldo tra nascite e decessi, ha fatto registrare nel 2014 un computo negativo di quasi 100mila unità, come non succedeva dagli ultimi due anni dalla “Grande Guerra” del ’15-’18; gli arrivi dall’estero hanno a mala pena compensato questo calo. Nessuno sogna una famiglia con sei figli, come al tempo del Duce, ma una società che solamente invecchia e non partorisce non ha un grande futuro.
Quindi le politiche di accoglienza dei flussi migratori dovrebbero fare parte non dell’emergenza negativa, ma delle nuove politiche di un nuovo modello di sviluppo per un paese europeo, e in particolare per il nostro paese. Questo chiama in causa le responsabilità della Ue e del governo Renzi. L’Europa pensata a Ventotene è sepolta dalle politiche di austerity e dalle concezioni del Vecchio Continente come fortezza.
Mentre scorrono le immagini delle forze dell’ordine che trascinano chissà dove i pacifici corpi dei migranti, si sta consumando il dramma greco. Sia verso l’esterno che al proprio interno le attuali politiche della Ue non reggono e rischiano di fare implodere il continente. L’intransigenze del Fmi e delle elite europee nei confronti della Grecia sono tipiche di chi si vuole perdere. Ha ragione Jeffrey Sachs, un economista americano, che ha recentemente avvertito che "Il governo greco ha ragione ad avere tracciato un limite invalicabile. Ha una precisa responsabilità nei confronti dei suoi cittadini. La vera scelta. dopo tutto, non spetta alla Grecia, bensì all'Europa" Quel limite invalicabile riguarda le pensioni, con cui gli anziani vengono in aiuto ai giovani, visto l’inesistenza , come in Italia, di qualunque forma di reddito minimo garantito, e i contratti collettivi nazionali di lavoro. Limiti di civiltà, di cui una volta il nostro continente andava fiero, ma che il cinismo del neoliberismo nella sue versione peggiore ha distolto dalla mente dei governanti europei.
Anais Ginori intervista Marek Halter: «Oggi il problema non è più redistribuire i disperati alle frontiere ma pensare ai milioni che seguiranno» Comprendere questo è solo un primo passo per capire che cosa occorre fare. Ma proseguire il ragionamento è molto faticoso e scomodo . La Repubblica, 14 giugno 2015
FUORI da una chiesa, quante persone si fermano per dare una moneta al mendicante? Pochissime. Eppure sarebbe un dovere prescritto in tutte le religioni, anche nell’Islam. Allo stesso modo, i governi si sottraggono alla loro responsabilità morale: non esiste una legge che obbliga a essere generosi». Lo scrittore francese Marek Halter ha vissuto per dieci anni come ebreo polacco sans papiers e poi trent’anni da rifugiato politico. «Porto con me la memoria delle mie origini. Ma non voglio essere un demagogo, né un sognatore », avverte. «L’immigrazione è un tema sul quale anche noi intellettuali dobbiamo provare a ragione in modo pratico».
Cosa pensa di due paesi europei che si rimpallano migranti al confine, come accade in queste ore a Ventimiglia?
«Non è un bello spettacolo ma il governo francese non lo fa per ragioni ideologiche. È sotto pressione dell’opinione pubblica che ha paura. Dagli anni ‘60 agli anni ‘90 l’Europa viveva in una relativa tranquillità sociale. La Francia ha accolto più di un milione di francesi di Algeria. Oggi non sarebbe più possibile. C’è la crisi, esistono tre milioni di disoccupati che vivono con i sussidi. Come può reagire un francese, o un italiano, che ha paura per l’avvenire dei suoi figli vedendo arrivare migliaia di migranti?».
Si può sconfiggere il discorso della paura?
«Dovremmo tutti farci una domanda: sono pronto ad accogliere una famiglia di rifugiati a casa mia? Io lo farei, perché mi ricordo nel 1938 quando Hitler non aveva ancora deciso di massacrare tutti gli ebrei ma voleva già sbarazzarsene. Ci fu la conferenza internazionale di Evian per sapere quali paesi erano disposti ad accogliere ebrei. La sola nazione che ha risposto positivamente è stata la Repubblica Dominicana. In fondo oggi accade la stessa cosa. La reazione dei governi a Bruxelles, davanti al piano della Commissione che prevede la redistribuzione dei rifugiati, è stata la stessa di Evian: una serie di rifiuti».
Il ruolo di chi governa non dovrebbe essere proprio affrontare con lucidità emergenze come queste?
«Oggi il problema non è più redistribuire i migranti che sono a Calais o Lampedusa. Bisogna pensare ai milioni che seguiranno. Dobbiamo essere capaci di immaginare una soluzione globale per l’Africa. Abbiamo lasciato che la miseria devastasse un continente e ne paghiamo le conseguenze».
I campi di migranti evacuati nelle capitali, i piani Ue rifiutati, i muri anti-migranti ai confini. Qual è la differenza tra sinistra e destra sull’immigrazione?
«Magari non nelle azioni, ma almeno nelle parole. La destra non ha bisogno di trovare giustificazioni morali. La sinistra è costretta a fare dei gesti. La Francia è pronta a mandare coperte e cibo per dei migranti a patto che rimangano in Italia. Se il governo decidesse di aprire la frontiera a Ventimiglia, sa con matematica certezza che perderebbe le elezioni. E comunque la questione è complessa. Anne Hidalgo (sindaco socialista di Parigi, ndr ) ha chiesto di aprire un centro in cui accogliere i migranti. Ma per quanto tempo, e chi penserà al loro futuro? Non si tratta solo di accoglierli, bisogna anche sapere come integrarli nella società. Sono dilemmi umani che esistono dalla notte dei tempi. Caino si domanda se deve essere il guardiano di suo fratello. Di sicuro non deve essere il suo genitore ».
Perché si sente così poco la voce degli intellettuali?
 Destra e sinistra (si fa per dire) unite nella lotta per spolpare lo Stato, accrescere i guadagni dei “capitani coraggiosi” e far pagare di più i posteri. Un’analisi che non rivela tutti i malefici della “finanza di progetto, ma quanto basta per capire la truffa.
Destra e sinistra (si fa per dire) unite nella lotta per spolpare lo Stato, accrescere i guadagni dei “capitani coraggiosi” e far pagare di più i posteri. Un’analisi che non rivela tutti i malefici della “finanza di progetto, ma quanto basta per capire la truffa.
Il Fatto quotidiano, 10 giugno 2015.
Un benedetto emendamento arrivato in Senato. Benedetto almeno per quei privati che con questo sistema si arricchiscono senza alcun rischio d’impresa. Il nuovo codice degli appalti una delega al governo che Palazzo Madama sta per approvare doveva essere il segno tangibile che il clima era cambiato: pubblicità, trasparenza, gare pubbliche, più poteri all’Autorità Anti-corruzione. In parte, va detto, la legge rispetta le premesse, ma crea uno strano binario parallelo in cui la trasparenza serve un po’ meno: l’obbligo di affidare i contratti di lavoro, servizi e forniture “mediante procedura ad evidenza pubblica” non vale infatti per le concessioni “affidate con la formula della finanza di progetto”. L’emendamento lo firmano i due relatori Stefano Esposito (Pd) e Lionello Marco Pagnoncelli (fittiano, ex FI) il che significa che è frutto di un accordo che comprende maggioranza e governo. di progetto”, meglio nota come project financing, funziona così: lo Stato decide di aver bisogno di un’opera, un privato la costruisce in cambio della concessione di utilizzo (o di un canone d’affitto) per un numero di anni sufficienti a ripagare la spesa e guadagnarci il giusto.
Fin qui, tutto bene, il problema è che le cose vanno così solo in teoria: intanto spesso i soldi con cui i privati fanno l’investimento sono garantiti dal pubblico (è il caso dell’autostrada Brebemi, costruita dai privati coi fondi di Cassa depositi e Banca europea degli investimenti) e poi la remunerazione della spesa iniziale è sempre scandalosamente alta. Tradotto: zero rischi, molto guadagno. Contrariamente a quanto si pensa, però, il project financing non viene usato solo dallo Stato per opere enormi tipo le autostrade, ma è il mezzo con cui Regioni, Comuni e Asl in questi anni hanno aggirato gli (stupidi) vincoli di bilancio che gli impediscono di fare investimenti. Per un ente locale o un’azienda sanitaria è oggi quasi impossibile costruire una scuola o un ospedale chiedendo un mutuo: sforerebbe i parametri sia sul deficit che sul debito. E qui arriva la finanza di progetto: il privato chiede il mutuo e costruisce l’opera, il sindaco firma un contratto d’affitto ventennale con annesso servizio di pulizia, manutenzione e chi più ne ha più ne metta. Quando questo accade e accade sempre senza gara il costo occulto viene scaricato sulla spesa corrente degli anni successivi con risultati bizzarri in termini di rapporto costi/benefici.
Qualche esempio aiuterà a capire di che buco nero stiamo parlando. Giorgio Meletti ne ha raccolti alcuni gustosi sul Fatto economico dell’8 aprile: l’ospedale di Nuoro doveva costare 45 milioni, ma l’affitto più contratti per vari servizi non sanitari per la bellezza di 28 anni porteranno ai privati circa 800 milioni; la centrale tecnologica del Sant’Orsola di Bologna costava 30 milioni, ma il contratto con forniture varie per 25 anni porterà a Manutencoop circa 400 milioni; la nuova sede del Comune di Bologna era un appalto da 70 milioni che porta ai costruttori un affitto da circa 9,5 milioni l’anno per 28 anni (all’ingrosso 250 milioni in tutto); l’ospedale di Mestre è costato al privato che l’ha costruito 140 milioni, ma la regione gliene sta ridando indietro 400 più contratti di forniture per 1,2 miliardi in 24 anni. Tradotto: con la “finanza di progetto” un’opera può essere pagata dieci o venti volte più di quel che costa. In totale secondo gli addetti ai lavori una stima prudente dell’indebitamento implicito, sotterraneo o nascosto spalmato sui prossimi due decenni ammonta a 200 miliardi di euro.
Anche i numeri totali confermano che si tratta di cifre molto rilevanti. Secondo l’ultimo report annuale di Palazzo Chigi disponibile, nel 2013 in Italia sono stati chiusi contratti di partenariato pubblico/privato per 19,5 miliardi (peraltro picco negativo causa spending review), in tutto il resto d’Europa per soli 16,2 miliardi. Magari l’idea di non fare le gare pubbliche non è proprio una furbata. O sì?
Il capitalismo ha vinto, afferma il sociologo tedesco, «ma è una vittoria di Pirro. Intanto cedono le strutture democratiche, e poi lo sfruttamento parossistico delle risorse energetiche sta distruggendo l’ecosistema. Alla fine il capitalismo distruggerà se stesso». Corriere della sera, 17 maggio 2015
TORINO «Sono venuto a Torino all’inizio degli anni Ottanta, il Lingotto era stato chiuso da poco. Svolgevo una ricerca sulle grandi fabbriche di auto. Avevo già visitato Wolfsburg, la fabbrica della Volkswagen: costruita nel 1938, 15 anni dopo il Lingotto, funziona ancora. Wolfsburg e il Lingotto sono le cattedrali del XX secolo» (quello studio fu pubblicato nel 1984, con il titolo Relazioni industriali nella Germania Ovest. Il caso dell’industria automobilistica, ndr). Parla Wolfgang Streeck, a Torino con il suo saggio Tempo guadagnato (Feltrinelli) .
Oggi, però, si dice che gli effetti della crisi del 2008 cominciano a essere superati. «Comunque è ormai divenuta prassi quella di affidare a organismi non eletti dai cittadini le decisioni politiche. Come la Bce. È la finanza che comanda, e che vive sulla mobilità dei capitali: ci possono essere problemi a delocalizzare un’industria, ma per spostare il capitale da Francoforte a un qualunque paradiso fiscale ci vogliono pochi secondi. In questo regime, con i sindacati che hanno perso la loro forza, con l’aumento di disoccupazione e di povertà, la già fragile democrazia sta soccombendo». Il capitalismo neoliberista trionfa? «Già nel 1989, con la caduta del Muro di Berlino, si scrisse della vittoria del capitalismo. E la globalizzazione ha amplificato le sue potenzialità. Ma è una vittoria di Pirro. Intanto cedono le strutture democratiche, e poi lo sfruttamento parossistico delle risorse energetiche sta distruggendo l’ecosistema. Alla fine — quando, non si sa — il capitalismo distruggerà se stesso».
Critico nei confronti dell’euro («nel 1994, Ralf Dahrendorf lo definì una “pessima idea”, e già denunziava il progetto di far diventare tedesca l’Europa»), Streeck oggi indica i risultati di questa Europa nel manifestarsi ovunque di movimenti populisti, o peggio ancora xenofobi e neofascisti come il Front National. «Espropriati dei propri diritti — la Bce non è eletta dal popolo — i cittadini non hanno più fiducia nella politica, cresce l’astensionismo e chi vota sceglie formazioni populiste o anti-sistema. E non solo nei Paesi più esposti come Grecia, Spagna, Italia». Ma il quantitive easing di Draghi potrebbe cambiare le cose. «È un trucco, che serve solo a guadagnare tempo, ma non muta la situazione».
Negli anni Settanta e Ottanta, Streeck era un attivo sostenitore dei socialdemocratici tedeschi. «Guardavamo all’Italia, a Enrico Berlinguer — ricorda — che staccava il Pci dall’Unione Sovietica e si avvicinava all’area di governo. Ero a Firenze e andai ad ascoltare un suo comizio in Piazza della Signoria. Stimavo molto Berlinguer, la sua onestà intellettuale, la sua chiarezza. In Germania avevamo seguito il tentativo di Aldo Moro di far entrare il Pci al governo. Poi, Moro venne ucciso. Verrebbe voglia di credere alle teorie dei complotti... Sì, perché da allora la storia d’Italia ha preso un’altra strada. Berlinguer non si riprese più da quella sconfitta, cominciò l’ascesa dei socialisti di Craxi». E di Matteo Renzi, che cosa pensa? «Ha riempito un vuoto che si era aperto dopo la fine di Berlusconi. Fa bene o male? Difficile dirlo, certo si muove. Una cosa però non mi piace: la cura esagerata della comunicazione. Anche la scelta di mettere come ministri tutte quelle belle ragazze...» .
C'è chi dice "prima le rendite e i profitti delle imprese, e chi invece dice "prima le persone", negli Usa come in Europa. I primi vogliono il TTIP, i secondi no. «Puntano a cambiare le regole e a liberalizzare commerci e investimenti. Ma contro i nuovi accordi di libero scambio voluti da Obama, cresce negli Usa e in Europa la rivolta dei consumatori che temono l’invasione di prodotti Ogm e lo strapotere delle multinazionali». La Repubblica, 7 maggio 2015
«TPP Free! Faremo di New York una città immune dai trattati di libero scambio». La promessa solenne risuona nell’aula del consiglio comunale. È d’accordo il sindaco Bill de Blasio. E’ d’accordo il deputato democratico Jerrold Nadler che rappresenta questa città al Congresso di Washington. Così come esistono in Italia i comuni che si proclamano “denuclearizzati”, può New York City chiamarsi fuori dai nuovi trattati di libero scambio? Naturalmente no, è un gesto politico, dal valore simbolico. Ma la dice lunga sulle resistenze che si oppongono alle nuove liberalizzazioni dei commerci e degli investimenti. Eppure, se non tutta l’America, certamente New York sta dalla parte dei “vincitori” della globalizzazione, con Wall Street che domina la finanza senza frontiere, un mercato che risucchia capitali dal mondo intero.
Lo stesso paradosso si applica alla Germania. Il suo attivo commerciale sta polverizzando tutti i record storici: vale l’8% del Pil tedesco. E’ una nazione che riemerge dalla crisi con la ricetta (squilibrata) di sempre: esportando molto più di quanto importa. Dalla globalizzazione sembra avere tratto solo vantaggi. E tuttavia è proprio in Germania che il mese scorso si sono svolte le manifestazioni più affollate per dire no ai nuovi trattati. Un partito di governo, i socialdemocratici della Spd che partecipano alla coalizione con Angela Merkel, sono risolutamente contrari. Così come negli Stati Uniti la spaccatura attraversa il partito democratico. Barack Obama vuole questi trattati con tutte le sue forze. Elizabeth Warren, la senatrice del Massachusetts che è la beniamina della sinistra, guida la rivolta contro le nuove liberalizzazioni.
Tpp o Ttip? Attenzione alle sigle, segnalano una sfasatura nei tempi e nei dibattiti. In America al momento si parla del primo: Trans Pacific Partnership. Riguarda i paesi dell’Asia-Pacifico, con i due pesi massimi che sono Stati Uniti e Giappone, ma senza la Cina. È il primo in dirittura di arrivo. Per il Tpp Obama ha già ottenuto al Congresso il “fasttrack”: la corsìa veloce che consente un’approvazione rapida perché i parlamentari possono votare solo sì o no all’intero pacchetto, senza emendamenti su singoli aspetti. Obama ha ottenuto il “fast-track” grazie ai voti dei repubblicani, tradizionalmente liberisti. Non avrebbe mai avuto la maggioranza dei democratici. La sinistra del suo partito, gli ambientalisti, i sindacati, le organizzazioni della società civile come MoveOn, 350.org, Courage Campaign, Corporate Accountability, Democracy for America, continuano a battersi per far deragliare questo accordo: si moltiplicano le petizioni popolari, i sit-in davanti al Congresso e agli uffici dei singoli deputati e senatori.
Il trattato che interessa gli europei è in seconda posizione nella tabella di marcia, si chiama Transatlantic Trade and Investment Partnership (Ttip). Che cos’hanno in comune Ttip e Tpp? Tre cose importanti. Anzitutto si tratta della prima revisione generale delle regole della globalizzazione dal lontano 1999 (creazione della World Trade Organization, l’arbitro del commercio mondiale), cui poi seguì nel dicembre 2001 la dirompente adesione della Cina. Secondo: questi due nuovi trattati riuniscono paesi abbastanza simili tra loro per livelli di sviluppo e garanzie di diritti (Usa, Giappone, Ue) mentre non includono i Brics (Brasile Russia India Cina Sudafrica). Terzo: la nuova tappa delle liberalizzazioni cerca di smantellare i protezionismi occulti, fatti di barriere non-tariffarie, perché i tradizionali dazi doganali sono già scesi molto. Su questi aspetti Obama insiste nella sua campagna a favore dei nuovi trattati: «Ci danno l’occasione – dice il presidente – di scrivere regole che proteggano i nostri lavoratori, tutelino l’ambiente, i consumatori, la salute, i diritti umani. Se non siamo noi a stabilire queste regole, il commercio mondiale andrà comunque avanti, ma le regole le faranno i cinesi e con priorità ben diverse». La Dottrina Obama punta quindi a creare un “fatto compiuto”, fissare dei principi che poi la stessa Cina e altre nazioni emergenti saranno costrette ad applicare in futuro.
Perché questa argomentazione non convince una parte delle opinioni pubbliche europee? Il Ttip riguarda 850 milioni di abitanti fra il Nordamerica e l’Europa, che insieme rappresentano il 45% del Pil mondiale. Il commercio transatlantico che verrebbe influenzato dalle nuove regole del Ttip, in settori come le commesse, opere pubbliche, servizi, supera i 500 miliardi di euro all’anno. I soli investimenti diretti dagli Usa in Europa superano i 320 miliardi, quelli europei negli Stati Uniti sono un po’ più della metà. Siamo quindi nel cuore della globalizzazione “avanzata”, quella che unisce tra loro paesi ricchi, non c’entra qui la concorrenza asimmetrica con le potenze emergenti. E tuttavia si è fatta strada nel Vecchio continente l’idea – non infondata – che siano gli europei a godere oggi delle regole più avanzate in materia di salute, protezione del consumatore, qualità dei servizi pubblici. Le obiezioni al Ttip si concentrano su due aspetti. Da un lato si teme che sia il cavallo di Troia per introdurre nei supermercati e sulle tavole degli europei gli organismi geneticamente modificati, la carne agli ormoni, o altri tabù del salutismo. Ma questo problema è già risolto: l’Unione europea ha stabilito che non rinuncerà al suo “principio di precauzione”; sugli ogm resta perfino il diritto dei singoli Stati membri dell’Unione di vietarli se lo ritengono necessario. L’altro tema scottante è la clausola Investor to State Dispute Settlement (Isds), che consentirebbe alle imprese private di far causa agli Stati davanti a una corte arbitrale per annullare provvedimenti considerati discriminatori. Il pericolo è che potenti multinazionali, difese da eserciti di avvocati, possano intimidire piccoli Stati, o perfino Regioni e Comuni, per far valere i propri interessi. L’Unione europea potrebbe attenuare il pericolo, se otterrà che queste cause vengano giudicate da un’apposita corte, permanente e pubblica, non da collegi arbitrali privati.
Un punto debole resta la trasparenza. Lo rinfaccia Elizabeth Warren a Obama: «Se sono nell’interesse dei lavoratori e dell’ambiente, perché non pubblicare la totalità dei testi in discussione? ». Anche l’ultima tornata negoziale Usa-Ue, che si è svolta a fine aprile a New York, è avvenuta a porte chiuse. Le stime sui benefici di questa globalizzazione 2.0 indicano un aumento dello 0,5% del Pil europeo (che di questi tempi non è poco) grazie all’abbattimento delle “barriere invisibili” che ostacolano le imprese. Ma in passato le previsioni sui benefici del Nafta o del mercato unico europeo peccarono sistematicamente per eccesso di ottimismo. E dal 1999 in poi, la fiducia delle opinioni pubbliche nella preveggenza degli esperti è in netto calo.
«».
Sbilanciamoci.info
Un eccesso di regolamentazione delle banche sarebbe nocivo e potrebbe ostacolare la crescita. Parola di Douglas Flint, a capo di quella Hsbc al centro dello scandalo SwissLeaks per avere aiutato decine di migliaia di facoltosi clienti ad aprire conti cifrati per nascondere i propri soldi in giro per il pianeta. La stessa ad avere ricevuto nel 2012 1,9miliardi di dollari di multa dalle autorità statunitensi per una vicenda legata al riciclaggio dei proventi dei cartelli della droga messicani.
L’elenco potrebbe continuare, così come potrebbero essere molte altre le banche chiamate in causa per scandali, truffe e crimini che vanno dalla manipolazione dei tassi di interesse (Libor ed Euribor) a quella del mercato delle valute o del prezzo dei metalli, a casi di evasione fiscale, riciclaggio, corruzione e chi più ne ha più ne metta.
Alcuni casi al limite – e spesso ben oltre il limite – della legalità, che non devono nascondere i devastanti impatti della speculazione e delle attività a regime di un sistema responsabile dell’esplosione della peggiore crisi degli ultimi decenni e salvato con montagne di soldi pubblici, secondo il noto principio di socializzare le perdite dopo avere privatizzato i profitti. Dopo la bolla dei subprime, ogni vertice internazionale si è chiuso con roboanti dichiarazioni sulla necessità di chiudere una volta per tutte il casinò finanziario. In quasi otto anni poco o nulla è stato fatto. La speculazione è ripartita come e peggio di prima, le lobby rialzano la testa, mentre passa l’idea che la finanza pubblica sia il problema, quella privata la soluzione. Austerità per Stati e cittadini che hanno subito la crisi, liquidità illimitata per chi l’ha provocata.
Se l’impegno messo nell’imporre politiche devastanti ai governi europei fosse stato indirizzato a regolamentare la finanza privata, probabilmente oggi la situazione in Europa sarebbe parecchio diversa. Sappiamo cosa andrebbe fatto e come procedere: una tassa sulle transazioni finanziarie, limiti all’utilizzo dei derivati, un contrasto ai paradisi fiscali e al sistema bancario ombra, dei controlli sui movimenti di capitale e via discorrendo. Il problema non è di natura tecnica ma nella volontà politica di procedere. Se, grazie alle spinte delle reti della società civile, molti di questi temi sono entrati nell’agenda europea, in troppi casi si va avanti, al meglio, con il freno a mano tirato. Solo per citare un esempio: perché in finanza non esiste un principio precauzionale analogo a quello che impedisce di immettere sui mercati un prodotto finché non se ne dimostri la non pericolosità e nocività? Non posso vendere una lavastoviglie se rischia di allagarmi la cucina, ma posso mettere in commercio un derivato in grado di mettere in ginocchio interi Paesi.
Non solo oggi la finanza crea disastri ed esaspera instabilità e diseguaglianze, ma al culmine del paradosso non fa nemmeno ciò che dovrebbe fare. Da un lato una quantità sterminata di denaro è all’esasperata ricerca di profitti. Dall’altro fasce sempre più ampie della popolazione sono escluse dall’accesso al credito. Domanda e offerta di denaro non si incontrano, nel più clamoroso fallimento di mercato dell’era moderna.
Per questo l’introduzione di regole e controlli è necessaria ma non sufficiente. Prima ancora, occorre ricostruire l’immaginario della crisi che si è imposto in questi anni e che di fatto ne ribalta cause e conseguenze. Perché la finanza dovrebbe essere uno strumento al servizio della società, non l’opposto; dovrebbe essere una parte della soluzione, e non come oggi, uno se non il principale problema.
Thomas Fazi intervista il politologo Kees van der Pijl: «Siamo passati da una forma di capitalismo ancora interessato ai processi di accumulazione reali ad uno puramente speculativo». Sblanciamoci, newsletter 361 del 4 ottobre 2014
Il conflitto ucraino non è solo il frutto di una crescente tensione tra Occidente e Russia. Esso riflette anche una crescente tensione interna all'Occidente, tra Stati Uniti e «vecchia Europa», in cui il tentativo dei primi di mantenere il continente saldamente assoggettato alla propria strategia economico-militare (un esempio su tutti: il fatto che l'adesione delle ex repubbliche sovietiche all'Ue è di fatto condizionale all'adesione alla Nato) si scontra con un'influenza economica e militare in declino e con la crescente ambizione di paesi come Francia e Germania di esercitare una maggiore autonomia in politica estera (ma non solo). Questo scontro, a sua volta, è l'espressione di una politica che, su entrambe le sponde dell'Atlantico, è sempre più asservita agli interessi del grande capitale, il quale ha bisogno di uno stato di «conflitto e destabilizzazione permanente» per portare a termine i suoi obiettivi: l'accaparramento di risorse e materie prime sempre più rare (all'estero) e il saccheggio della cosa pubblica (in casa). Di questo e altro abbiamo parlato con Kees Van Der Pijl, professore di relazioni internazionali all'Università del Sussex.
Professore, lei sostiene che stiamo attraversando una fase inedita del capitalismo. Quali sono le sue caratteristiche principali?
«Nel corso degli anni novanta abbiamo assistito a una serie di mutazioni molto profonde. In ambito economico siamo passati da una forma di capitalismo interessato ancora ai processi di accumulazione reali ad un capitalismo puramente speculativo ed estremamente finanziarizzato che si nutre di enormi bolle destinate inevitabilmente a scoppiare. Uno dei principali fautori di questa forma di capitalismo speculativo è stato Alan Greenspan, governatore della Federal Reserve tra il 1987 e il 2006, che difatti nel corso degli anni novanta ha inaugurato quella politica di "welfare per i ricchi" a cui abbiamo assistito in seguito alla crisi del 2007-8, in cui lo stato, per mezzo di enormi iniezioni di denaro pubblico, si fa carico di tenere in piedi e di "rimpolpare" il sistema finanziario in seguito allo scoppio di ogni bolla. Uno dei problemi del capitalismo speculativo è che tende ad arricchire solo una piccolissima percentuale della popolazione: allo scoppio di ogni bolla le classi medio-basse si impoveriscono sempre di più, mentre gli ultra-ricchi diventano sempre più ricchi. In questo senso è una forma di capitalismo che tende inevitabilmente all'oligarchia.
Lei sostiene che in questa fase è il ruolo stesso dello stato, nell'accezione liberal-democratica del termine, a venire meno e a "disintegrarsi" .
«Assolutamente. Storicamente nelle democrazie occidentali il ruolo dello stato è sempre stato quello di mediare, di trovare una coerenza tra i vari interessi economici, di classe, ecc. che attraversano la società. In un contesto sempre più oligarchico come quello in cui ci troviamo oggi, però, in cui una piccolissima minoranza detiene un potere economico spropositato, lo stato non è più in grado di mediare tra le varie "fazioni" e finisce per diventare asservita unicamente agli interessi nudi e crudi della classe dominante, che non è più obbligata a trovare un compromesso all'interno dell'arena politica. In sostanza, lo stato perde la sua coerenza e comincia a "disintegrarsi". Questo è senz'altro vero negli Usa, come dimostra l'incoerenza di Obama in politica estera. Ma è un discorso che vale anche per l'Europa, dove è sempre meno chiaro quali siano le funzioni esercitate a livello europeo e quali quelle esercitate a livello nazionale. Questo è un classico esempio di incoerenza, di cui le élite possono facilmente approfittarsi per imporre la propria visione senza dover passare per il processo democratico. Nel medio termine una politica di questo tipo ha un effetto estremamente destabilizzante per i processi democratici, e nel caso specifico dell'Europa sta portando a una serie di spinte centrifughe (Scozia, Catalogna, ecc.) che rischiano seriamente di far implodere il processo di integrazione europeo».
Lei traccia una legame tra i processi di disgregazione europea in corso e l'involuzione autoritaria dell'Ue, a sua volta - sostiene - una conseguenza inevitabile del modello di capitalismo predatorio dominante.
«Sì, il caso europeo è particolarmente preoccupante, perché assistiamo a un'involuzione autoritaria non solo a livello nazionale - poiché le élite politiche non sono più in grado di mediare tra gli interessi delle varie classi, come dicevo prima - ma anche a livello sovranazionale, in cui l'Ue è sempre più incapace di mediare tra gli interessi dei vari stati e si fa garante unicamente degli interessi degli stati dominanti e del grande capitale finanziario, assumendo dei tratti sempre più autoritari. Molto si è parlato, infatti, dell'apparato di sorveglianza estremamente pervasivo, facente capo all'Nsa statunitense, portato alla luce da Snowden. Ma la realtà è che tutti governi europei erano - e continuano senz'altro ad essere - complici del programma di sorveglianza americano. A questo poi bisogna aggiungere la crescente incapacità degli Stati Uniti di agire da "collante" e da stabilizzatore politico nel continente. Questo sta determinando una situazione in cui i cittadini si sentono sempre meno rappresentati dalle élite politiche nazionale, ma soprattutto dall'establishment politico europeo. L'acuirsi delle tendenze nazionaliste, regionaliste ed anti-europee e l'ascesa di movimenti populisti e neofascisti in tutta Europa si può in buona parte imputare a questa dinamica».
Che ruolo ha giocato la crisi economica e finanziaria in questo processo in Europa?
«La crisi del 2007-8 ha drammaticamente accelerato queste tendenze già in corso. Mascherandosi dietro al mantra delle riforme strutturali, del consolidamento fiscale, ecc., le autorità politiche europee hanno di fatto implementato una serie di politiche finalizzate unicamente a perpetuare e a rafforzare l'attuale modello di capitalismo predatorio, che sta determinando un trasferimento di ricchezza dal basso verso l'alto senza precedenti. Come dicevo prima, è un capitalismo che non punta più a rilanciare il processo di accumulazione. Il tasso di investimento è ai minimi storici. L'infrastruttura energetica di molti paesi europei è vicina al collasso. L'obbiettivo non è rimettere soldi nel sistema ma sottrarli ad esso, per esempio saccheggiando le infrastrutture pubbliche esistenti attraverso i processi di privatizzazione».
Questa forma estrema di capitalismo predatorio non rischia di mettere a rischio la tenuta stessa del sistema?
«Il processo di concentrazione di ricchezza in corso determinerà tensioni sociali e politiche che il sistema politico farà sempre più fatica a gestire. La risposta iniziale sarà un'involuzione autoritaria e repressiva sempre più forte, un fenomeno a cui stiamo assistendo anche in Europa. Ma prima o poi il sistema - e con esso il processo di integrazione europea - è destinato a implodere. Questo potrebbe avvenire per cause endogene - l'elezione di un partito anti-europeo in un grande paese europeo (la Francia è il candidato più ovvio in questo momento), il moltiplicarsi delle spinte centrifughe, ecc. - o per cause esogene, come per esempio un'altra grande crisi finanziaria, che considero inevitabile. Nel breve termine questo darà luogo a una situazione di grande instabilità. Ma nel medio termine credo che assisteremo a una profonda riforma del capitalismo, in cui le autorità politiche si vedranno costrette a riprendere in mano le redini dell'economia per frenare gli eccessi dei mercati. Di fatto assisteremo a una ripubblicizzazione e ri-democratizzazione dell'economia. E forse alla ripresa del processo di integrazione europeo su basi radicalmente diverse».
 In una frase si potrebbe dire: "carità pelosa". L'articolo, e il libro di cui parla, ci raccontano come la filantropia nata in USA è stato, ed è ancora, un poderoso strumento di colonizzazione e di dominio.
In una frase si potrebbe dire: "carità pelosa". L'articolo, e il libro di cui parla, ci raccontano come la filantropia nata in USA è stato, ed è ancora, un poderoso strumento di colonizzazione e di dominio.
Comune-info.net, 22 settembre 2014
A prima vista il mio libro potrebbe sembrare una critica un po’ dura, ma nel rispetto di quella tradizione che riconosce il merito ai propri avversari, potrebbe anche essere letto come riconoscimento della visione, della flessibilità, della raffinatezza, e della determinazione incrollabile di un sistema al quale molti hanno dedicato la loro vita, riuscendo con il loro impegno a far sì che questo mondo restasse solidamente nelle mani del capitalismo.
È una storia coinvolgente, forse svanita dalla memoria del mondo contemporaneo, una storia che cominciò negli Stati Uniti all’inizio del XX secolo, quando venne trovata una forma legale – una legge – che istituiva le fondazioni, fu così che la filantropia delle aziende più ricche e potenti) cominciò a sostituirsi al ruolo finora svolto dalle attività missionarie per aprire la strada al capitalismo (e all’imperialismo) e ai sistemi di controllo del sistema.
Tra le prime fondazioni istituite negli Stati Uniti ci furono la Carnegie Corporation, finanziata nel 1911 con i profitti della Carnegie Steel Company, e la Fondazione Rockefeller, finanziata nel 1914 da JD Rockefeller, fondatore della Standard Oil Company. I più grossi finanzieri del loro tempo.
Sono molte la istituzioni che sono state finanziate, con un capitale iniziale o con donazioni sostenute dalla Fondazione Rockefeller come le Nazioni Unite, la CIA, il Council on Foreign Relations (CFR), il favoloso MOMA – Museum of Modern Art di New York – e, naturalmente, il Rockefeller Center a New York (dove dovettero cancellare il murale nel quale Diego Riviera aveva maliziosamente raffigurato dei capitalisti reprobi e un valoroso Lenin). Rockefeller fu il primo miliardario americano e l’uomo più ricco del mondo. Era abolizionista, sostenitore di Abraham Lincoln e astemio. Credeva che il suo denaro gli fosse stato dato da Dio e che per questo Dio si sentisse soddisfatto.
Le prime fondazioni che presero dei fondi dalle imprese erano negli Stati Uniti e ci furono degli accesi dibattiti sulla provenienza dei fondi, sulla legalità, e sulla mancanza di responsabilità. Furono in tanti a suggerire che se le aziende avevano modo di accumulare così tanto denaro (tanto da non averne bisogno), avrebbero dovuto aumentare i salari dei loro lavoratori – (C’era gente capace di fare proposte tanto scandalose per quei tempi, anche in America.)
Solo immaginare queste fondazioni – che sembrano una cosa tanto normale al giorno d’oggi – all’epoca era come pensare di dover fare un salto nel vuoto per il mondo degli affari. Era difficile immaginare che potessero esistere delle persone giuridiche con risorse enormi, autorizzate a non pagare le tasse, a godere inspiegabilmente la facoltà di agire, quasi illimitatamente, nella non-transparenza …..
Quale modo migliore poteva essere inventato per trasformare la ricchezza economica in capitale politico, sociale e culturale?
Quale modo migliore si poteva trovare per trasformare il denaro in potere?
Quale modo migliore si poteva trovare per consentire agli usurai di usare una percentuale minima dei loro profitti per riuscire a governare il mondo?
Come avrebbe potuto fare, del resto, Bill Gates, che sicuramente conosce bene un paio di cosette sui computer, ad arrivare nella posizione di poter parlare di istruzione, di sanità e di politiche agricole, non solo con il governo degli Stati Uniti, ma anche con i governi di tutto il mondo?
Nel corso degli anni, come molti possono testimoniare, si è assistito veramente anche a molti ottimi lavori fatti dalle fondazioni (gestione di biblioteche pubbliche, lotta contro le malattie ecc.): i risultati ottenuti e il velo che ormai è sceso sul collegamento diretto che esiste tra le società finanziatrice e le fondazioni che le alimentano con il tempo hanno cominciato a far dimenticare. Alla fine, a far svanire del tutto e a far apparire normale questo stato delle cose. Adesso, neanche chi si professa di sinistra, prova vergogna a considerare “generosa la natura dei donatori”.
Dal 1920 negli USA il capitalismo aveva cominciato a rivolgersi verso l’estero per comprare materie prime e per accedere ai mercati d’oltremare. Fu allora che le Fondazioni cominciarono a formulare una nuova idea di governance globale gestita dalle Corporate. Nel 1924 la Rockefeller e la Carnegie Foundation crearono congiuntamente quello che oggi è il gruppo di pressione politica estera più potente del mondo, il Council on Foreign Relations (CFR), che più tardi cominciò ad essere finanziato anche dalla Fondazione Ford.
Nel 1947 la CIA, subito dopo essere stata creata, fu sostenuta e lavorò a stretto contatto con il CFR. Nel corso degli anni sono stati nominati ben ventidue Segretari di Stato degli Stati Uniti che avevano prestato servizio presso il CFR. Nel Comitato Direttivo che nel 1943 che programmò la nascita delle Nazioni Unite c’erano cinque membri del CFR, e il terreno su cui si trova il quartier generale delle Nazioni Unite fu acquistato con una sovvenzione di 8,5 milioni di dollari offerta da JD Rockefeller.
Tutti gli undici presidenti della Banca Mondiale dal 1946 sono uomini che si sono presentati come missionari tra i poveri – ma sono stati tutti membri del CFR. (L’eccezione fu George Woods, che era fiduciario della Fondazione Rockefeller e Vice Presidente della Chase Manhattan Bank)
A Bretton Woods, la Banca Mondiale e il FMI decisero che il dollaro avrebbe dovuto diventare la valuta di riserva del mondo, e che per migliorare la penetrazione del “capitale globale” sarebbe stato necessario universalizzare e standardizzare le modalità di commercio in un mercato aperto e fu proprio per quel motivo che si cominciò a donare una grande quantità di denaro per promuovere il buon governo (buono finché sarà permesso tenerne salde le fila), il concetto di Stato di diritto (fino a quando sarà permesso avere voce in capitolo nel legiferare) e centinaia di programmi anticorruzione (che servono per semplificare il sistema messo in piedi).
Ci sono due tra le organizzazioni meno trasparenti del mondo, che chiedono ai governi dei paesi più poveri del mondo di assumersi le loro responsabilità e di essere trasparenti. Dato che la Banca Mondiale ha più o meno diretto le politiche economiche del Terzo Mondo, obbligando e imponendo le regole del mercato per aprire i paesi alla finanza globale, si potrebbe dire che la filantropia delle Corporate si è rivelata essere l’affare più lungimirante di tutti i tempi.
Le Fondazioni amministrate con i fondi donati dalle Corporate, fanno commerci e incanalano il loro potere mettendo i loro uomini nelle caselle giuste della scacchiera, per mezzo di un sistema di club d’elite e di think-tank, facendo in modo che queste persone possano interscambiarsi e muoversi liberamente, come attraverso una porta girevole, attraversando tutte le istituzioni. Contrariamente a quello che professano le varie teorie del complotto in circolazione – in particolarmente quelle dei gruppi di sinistra – non c’è nulla di segreto, di satanico, o di massone che regoli questo modo di fare. E’ tutto una normale prassi: non è molto diverso dal modo in cui le aziende-multinazionali utilizzano società di comodo e conti off-shore, per trasferire e gestire i loro soldi. Con una sola differenza, si trasferisce e si gestisce potere, non denaro.
L’equivalente transnazionale del CFR è la Commissione Trilaterale, istituita nel 1973 da David Rockefeller, l’ex-consigliere per la Sicurezza Nazionale degli Stati Uniti Zbignew Brzezinski (membro fondatore dei mujahidin afghani, precursori dei talebani), la Chase Manhattan Bank, e di alcune altre eminenze private. Il suo scopo era creare un legame duraturo di amicizia e di cooperazione tra le élite del Nord America, l’Europa e il Giappone. Ora è diventata una Commissione Pentalaterale, essendosi allargata a partecipanti provenienti da Cina e India (Tarun Das del CII; NR Narayana Murthy, ex CEO di Infosys; Jamsheyd N. Godrej, Amministratore Delegato di Godrej; Jamshed J. Irani, Direttore di Tata Sons, e Gautam Thapar, CEO del Gruppo Avantha).
L’Istituto Aspen è un club internazionale di élite locali, che raggruppano imprenditori, burocrati e politici, ed ha aperto filiali in diversi paesi. Tarun Das è il presidente dell’Aspen Institute, India. Gautam Thapar è presidente. Diversi alti ufficiali del McKinsey Global Institute (proponente del Delhi Mumbai Industrial Corridor) sono membri del CFR, la Commissione Trilaterale, e l’Istituto Aspen.
La Fondazione Ford (quella che si presenta come liberale e in opposizione alla più conservatrice Fondazione Rockefeller- ma le due fondazioni lavorano costantemente insieme -) fu istituita nel 1936 e, anche se viene spesso sottovalutata, ha una sua ideologia molto chiara, ben definita e lavora a stretto contatto con il Dipartimento di Stato. Il suo progetto di promuovere la democrazia e il “buon governo” è parte integrante del sistema di Bretton Woods che prevedeva di standardizzare le modalità commerciali e di promuovere l’efficienza nel mercato libero. Dopo la seconda guerra mondiale, quando il governo degli Stati Uniti mise, al posto dei fascisti, i comunisti in cima alla lista, come Nemico Numero Uno del paese, fu necessario pensare a nuovi tipi di istituzioni per affrontare la Guerra Fredda. Ford allora finanziò il RAND (Research e Development Corporation), un think tank militare che iniziò con una ricerca sulle armi per i servizi di difesa degli Stati Uniti.
Nel 1952, per contrastare “il persistente sforzo comunista per penetrare e distruggere le nazioni libere”, fu istituito il Fondo per la Repubblica, che poi si trasformò nel Centro per lo Studio delle Istituzioni Democratiche, il cui intento era di fare una guerra fredda in modo intelligente, senza incorrere negli eccessi maccartisti.
E ‘attraverso questa lente che dobbiamo guardare il lavoro che la Fondazione Ford sta facendo con i milioni di dollari che ha investito in India, finanziando il lavoro di artisti, di registi e di attivisti e le generose donazioni che sono serviti a finanziare corsi universitari e borse di studio.
Gli “obiettivi per il futuro dell’umanità” dichiarati dalla Fondazione Ford includono interventi effettuati su movimenti politici di base a livello locale e internazionale. Negli Stati Uniti la fondazione Ford fu quella che ha sovvenzionato con milioni di dollari i prestiti per sostenere il movimento sindacale per il credito (sperimentato per la prima volta, dal proprietario dei magazzini Edward Filene nel 1919). Filene credeva nella creazione di una società dei consumi di massa orientata verso l’acquisto di beni di consumo, per questo era bene accordare ai lavoratori un accesso al credito a prezzi accessibili: una idea geniale per quel tempo. A dirla tutta, questa era solo la metà della sua idea geniale, perché l’altra metà del pensiero di Filene credeva in una più equa distribuzione del reddito nazionale.
I capitalisti apprezzarono e si impossessarono solo della prima parte del pensiero di Filene e cominciarono a erogare a tutti i lavoratori prestiti “abbordabili” per decine di milioni di dollari, trasformato così la classe operaia degli Stati Uniti in una massa di persone permanentemente indebitate, che dovettero, da allora in poi, correre sempre di più per restare al passo con lo stile di vita che, altrimenti, non si sarebbero potuti permettere.
Molti anni dopo, questa idea è arrivata ad essere sperimentata anche nella parte più povera delle campagne del Bangladesh: fu quando Mohammed Yunus e laGrameen Bank portarono il microcredito a contadini che letteralmente stavano morendo di fame, e questo provocò delle conseguenze disastrose. Tutti i poveri del subcontinente indiano hanno sempre vissuto sul debito, stretti nella morsa spietata dell’usuraio del loro villaggio – il Baniya. Ma la microfinanza ha standardizzato, ha regolato rigidamente anche questo modo di vivere. Le imprese della microfinanza in India si sono rese responsabili di centinaia di suicidi – duecento persone si sono ammazzate in Andhra Pradesh solo nel 2010. Recentemente un quotidiano nazionale ha pubblicato un articolo sul suicidio di una ragazzina di 18 anni che è stata costretta a consegnare le sue ultime 150 rupie – quelle che le servivano per pagare le tasse scolastiche – nelle mani dei dipendenti di una società di microfinanza che non smettevano più di vessarla e tormentarla.
Estratto da Capitalism: A Ghost Story, (Haymarket Books, 2014) di Arundhati Roy. L’autrice vive a New Delhi, India e ha scritto anche “Il Dio delle piccole cose” e “Power Politics” (South End Press). Questo articolo [titolo originale "Lavora sodo se ti servono soldi, ma non prendere mai prestiti" Dalla povertà si possono tirare fuori un sacco di soldi, ma anche un paio di premi Nobel (di troppo)] è stato tradotto da Bosque Primario per Comedonchisciotte.org
 «In un capitalismo che ha distrutto la forza politica
della classe operaia, i movimenti sociali, a causa anche di una crisi ormai permanente, hanno caratteristiche spurie.
Dobbiamo quindi immaginare
una lotta di classe che
si faccia carico della
sofferenza alimentata
dalla crescita
delle diseguaglianze». Intervista di Gigi Roggero.
«In un capitalismo che ha distrutto la forza politica
della classe operaia, i movimenti sociali, a causa anche di una crisi ormai permanente, hanno caratteristiche spurie.
Dobbiamo quindi immaginare
una lotta di classe che
si faccia carico della
sofferenza alimentata
dalla crescita
delle diseguaglianze». Intervista di Gigi Roggero.
Commonware, 16 Settembre 2014
Un secolo e mezzo fa Marx scriveva che non ci sono crisi permanenti, ma quella che oggi stiamo vivendo sembra averne le caratteristiche. Arrivati al suo ottavo anno, proviamo con Christian Marazzi a farne una periodizzazione, ad approfondire, mettere a verifica ed eventualmente ripensare le analisi che abbiamo fatto a partire dal 2007-2008. Ora qualcuno parla di una fase “post-austerity”: cominciamo con il capire se è davvero così e cosa questa fase significa realmente.
«Siamo nuovamente in una situazione in cui si addensano una serie di elementi di forte crisi, sicuramente nella zona euro ma anche su scala globale. Ciò avviene dopo un periodo durante il quale le politiche monetarie delle grandi banche centrali come la Federal Reserve, la Banca d’Inghilterra e la banca centrale giapponese, con forte iniezione di liquidità, avevano in qualche modo attenuato gli elementi strutturali della crisi. Questa era giunta al suo apice alla fine del 2011 in Europa e aveva registrato la svolta di Draghi con l’iniezione di 1.000 miliardi di euro nel sistema bancario, con la speranza o l’obiettivo di rilanciare il credito privato, sia alle imprese che alle famiglie.
«Oggi ci sono di nuovo tutti i presupposti per una fase turbolenta. Anche i maggiori analisti sono molto scettici rispetto all’ennesimo tentativo da parte del presidente della Banca Centrale Europea di far fronte ai grossi problemi che hanno una natura strutturale con una riedizione su scala europea di strategie monetarie basate sull’inondare il sistema bancario nei prossimi quattro anni con un credito che dovrebbe essere destinato alle economie domestiche e alle imprese e con una sorta di quantitative easing in versione europea per affrontare la deflazione. C’è scetticismo perché la domanda non tira: quindi, si può anche avere del credito a tassi di interesse pressoché nulli, ma se le imprese non si rivolgono alle banche perché non prevedono un rilancio della domanda di beni e servizi non creano occupazione. Genera perciò molti dubbi il tentativo di americanizzare la politica monetaria in Europa, soprattutto guardando a quelli che sono stati gli effetti delle politiche monetarie fortemente espansive negli Stati Uniti, in Inghilterra e in Giappone; ancora si dibatte sul ruolo che ha avuto l’azione della Federal Reserve nel resistere alla recessione, con tassi di crescita superiori a quelli europei e anche a quelli giapponesi. C’è dunque scetticismo sulla possibilità di fare quella politica monetaria che i governi, per motivi diversi, non vogliono fare.
«Ci sono per esempio le premesse per la riapertura del dibattito sui destini dell’euro, che pensavamo di avere rimosso e che invece si ripresenta grosso modo negli stessi termini. L’euro è una moneta che regge la crescita ma non la crisi. Più o meno funziona, come è stato negli anni dopo Maastricht, quando c’è uno sbocco per il credito agevolato, il più delle volte in termini di bolle speculative o immobiliari, ma quando entra in zona tensione come adesso riemergono tutte le sue debolezze. Ciò soprattutto in una fase in cui all’interno dell’Unione Europea non ci sono ancora un consenso e soprattutto una forza politica sufficienti per far fronte alla Germania e alla politica di austerità che continuamente impone, anche per ragioni molto autoreferenziali, in particolare per l’esposizione delle banche tedesche rispetto al debito sovrano di paesi fragili. Infatti, qualora i paesi del Sud non dovessero portare avanti tagli alla spesa pubblica, misure di ulteriore flessibilizzazione del mercato del lavoro e di contenimento delle pensioni, non potrebbero ripagare le banche tedesche».
«Mi sembra allora che siamo in una situazione in cui ci sono tutti gli elementi che portano da una parte a riaprire la questione dell’euro, dall’altra al problema politico che già abbiamo visto di un forte spostamento a destra su scala europea. La sinistra mostra invece di essere ampiamente inadeguata sulle grandi questioni, per esempio su quanta sovranità verrà erosa ai paesi membri nella prossima fase, oppure in che modo si riuscirà a rispondere alla tendenza dei movimenti di destra e di estrema destra che cavalcano gli effetti dell’austerità per ripristinare un concetto di democrazia su scala nazionale. Il quadro ovviamente è fortemente aggravato dalle tensioni geopolitiche che stiamo attraversando. Checché se ne dica, quello che sta succedendo in Ucraina ha degli effetti sull’economia tedesca: anche se non sono statisticamente rilevanti, è un ulteriore peggioramento del cosiddetto clima di fiducia rispetto al futuro e alla possibilità di investimento della classe imprenditoriale. Lo stesso dicasi della situazione in Medio Oriente. È anche vero che la crisi della zona euro ha a che fare con delle tendenze di fondo che avevamo già evidenziato: per esempio il fatto che la Germania sia orientata verso la Cina, la Russia e i Brics, mentre il suo interscambio con il resto dell’Europa sta diminuendo. È dunque chiaro che questa miscela tra lo sguardo verso oriente dell’economia tedesca e la situazione geopolitica è piuttosto esplosiva. Io continuo a credere che per la Germania l’Europa sia un fardello di cui in futuro, chissà, potrebbe cercare di liberarsi. Ovviamente sono tendenze a lungo termine, però dentro a questo quadro le tensioni continuano ad accumularsi, anche all’interno della stessa Germania, per non parlare di quello che sta succedendo tra i paesi membri, in particolare l’Italia e la Francia, che non sono in grado di scalfire l’egemonia tedesca.
«Tutto ciò per dire che siamo di nuovo a un punto di inizio di una fase di crisi che però è peggio di un punto zero, perché nel frattempo gli effetti dell’austerità, in particolare la deflazione, si stanno facendo sentire molto pesantemente, quindi ne vedremo delle belle nei prossimi tempi».
Il nodo dell’Europa resta irrisolto, nel frattempo procede la sua implosione, o quantomeno l’estrema frammentazione. Draghi sostiene che è arrivato il momento in cui i paesi della zona euro cedano sovranità all’Europa per le riforme strutturali, proponendo uno scambio tra flessibilità sui conti e riforme. Ciò alimenta ulteriormente la reazione sovranista, ma al contempo pone seri problemi a una prospettiva europeista che non prenda atto di ciò che oggi l’Unione Europea è: un mostro, come l’hai definita l’anno passato. Come vanno ricalibrate le prospettive politiche rispetto a questo nodo?
«Lo manterrei irrisolto. Nemmeno dal punto di vista del peso della destra nel Parlamento europeo, per quello che può contare, si vede una forza sufficiente per frenare, condizionare o ri-orientarequesto tipo di crisi permanente. La Bce ci sta provando, quella che si può definire una svolta americana nella politica monetaria europea guidata da Draghi contrasta con le idee e gli obiettivi di una Bundesbank. Fino a qualche mese si poteva usare la formula ‘una vecchia tattica per una nuova strategia’, per evitare di cadere nella trappola tra l’uscita dall’euro secondo un approccio basato sulla sovranità monetaria nazionale oppure un sostegno all’euro così com’é. Noi avevamo buttato lì l’idea della moneta del comune, per evitare di essere strozzati dentro questa alternativa che aveva in entrambi i casi qualcosa di pericoloso. Mi domando infatti come possa essere immaginata una sovranità monetaria nazionale oggi, anche in una sua declinazione di sinistra, con delle monete nazionali legate tra di loro da tassi fissi ma aggiustabili, con un euro sovranazionale. Bisogna però riconoscere che finora la moneta del comune resta una prospettiva tutta da costruire anche teoricamente. Per il momento mi sembra che sia stata intesa nei movimenti più che altro nei termini di monete sub-sovrane e parallele; per quanto siano cose sperimentalmente interessanti, siamo però ben lontani da una costruzione teorico-politica tale da rendere l’idea della moneta del comune qualcosa di operativo o comunque di agibile, capace cioè di aggregare forze, consensi, alleanze. Insomma, resta un capitolo da scrivere: da salvaguardare è tuttavia l’intento politico, cioè da una parte porre un’istanza di redistribuzione della ricchezza, dall’altra fare in modo che questa istanza abbia una valenza sovranazionale in termini di definizione di diritti e di spazi di democrazia. Ciò rimanda alla questione dell’organizzazione e delle sue forme, su cui poi vale la pena ritornare»
Nello scenario che hai delineato che peso ha il T-tip, l’accordo tra Europa e Stati Uniti?
«Gli Stati Uniti hanno fatto dei passi in avanti con questi accordi di libero scambio e ciò li mette in una condizione di egemonia rispetto all’Europa. D’altronde gli Stati Uniti sono ancora detentori del dollaro che, per quanto sia diminuito il suo ruolo come valuta di riserva, resta però ancora la moneta che decide dei flussi su scala mondiale, soprattutto in una fase di crisi. Il tentativo degli Stati Uniti è di uscire dal quantitative easing nei prossimi mesi, e non è detto che necessariamente ciò comporti un aumento dei tassi di interesse; potrebbe darsi che l’acquisto di buoni del tesoro e di obbligazioni cartolarizzate venga effettuato a svantaggio dell’Europa, cioè con flussi di capitale che vanno dal vecchio continente agli Stati Uniti. Ciò potrebbe sì favorire l’Europa dal punto di vista dei tassi di cambio: una delle cose previste dalla maggioranza degli analisti è una svalutazione dell’euro, dovuta sia alle politiche monetarie espansive della Bce, sia a questi flussi verso l’area del dollaro. Significherebbe però che l’economia potrebbe crescere nella crisi in termini di esportazione, come è successo soprattutto alla Spagna: non è dunque di per sé una buona notizia, perché si tratta di forme di crescita in cui si possono avere dei tassi di povertà e disoccupazione molto elevati e allo stesso tempo, o meglio proprio per questo, un aumento di esportazioni che sarebbero più competitive sul piano sia dei costi che dei tassi di cambio. Tutti capiscono che c’è un problema di domanda, quindi di salari e di distribuzione della ricchezza. Le ineguaglianze sono cresciute mostruosamente, prova ne è – anche dal punto di vista mediatico ma non solo – il successo del libro di Piketty. Tuttavia, se da una parte si vede questa carenza di domanda, dall’altra ci sono dei problemi che rendono terribilmente difficile immaginare (al di là delle forme trite e ritrite del vecchio keynesismo, del rilancio delle spese infrastrutturali e degli investimenti pubblici) come si possa effettivamente rilanciare la domanda interna.
«Credo che qua il capitale stia subendo una sua nemesi storica. Ha distrutto la classe operaia fordista, questo è il miracolo che gli è riuscito; però, il capitale è per definizione, in termini marxiani, un rapporto sociale, quindi distruggere la classe operaia ha significato distruggere quella dinamica che è legata all’essenza stessa del capitale, appunto il suo essere un rapporto sociale, quello che gli permette di crescere. In un certo senso, quindi, la vittoria sulla classe operaia ha avuto e sta avendo un effetto negativo per il capitale stesso, che certo persegue anche dal punto di vista ideologico la sua lotta per l’attacco ai salari e alla stabilità occupazionale, però si ritrova nella forte difficoltà a perseguire degli obiettivi che farebbero il suo stesso interesse, come una più equa distribuzione della ricchezza. Uno dei problemi centrali delle politiche monetarie è certamente legato alla trappola di liquidità, cioè il fatto che se il cavallo non beve si può anche abbassare il tiro dei tassi di interesse, ma non si ha una ripresa dell’economia e del credito, incorrendo nel rischio di avvilupparsi. «Credo però che il problema sia ancora più radicale: quando il capitale ha distrutto la classe operaia così come l’abbiamo conosciuta, soprattutto l’ha distrutta attraverso la desalarizzazione, la decontrattualizzazione e le misure capillari di precarizzazione del lavoro, si è privato della possibilità stessa non tanto di creare la liquidità, ma di integrarla nel circuito economico. Il denaro viene creato per monetizzare i salari; nel momento in cui i salari non ci sono più nella forma della contrattazione e dell’ubicazione della classe operaia, si aprono le porte a un’integrazione della liquidità che va da tutte le parti, che crea rendite e reddito non nella forma di leva del consumo ma come ricchezza improduttiva, molto concentrata nelle classi alte, il famoso 1% più ricco, incapace di sgocciolare verso il basso. C’è quindi un problema serio creato dalla distruzione dell’istituzione del salario, che rende la politica monetaria destinata ad alimentare la finanziarizzazione e la concentrazione della ricchezza verso l’alto. In questo senso il problema è strutturale»
Possiamo quindi dire che l’esplosione della forma-salario come misura di un rapporto sociale fondato sull’antagonismo è un problema tanto per le lotte quanto per il capitale...
«Esatto. Non è consolatorio dire che questa è una forma di vendetta della classe operaia fordista; però, non solo noi siamo orfani delle logiche del movimento operaio, ma il capitale stesso si è privato di un soggetto con il quale fare luce e creare sapere sulla possibilità di produzione di ricchezza. Nel ‘Poscritto’ a Operai e capitale, Tronti scriveva che quello che aveva portato alla grande crisi del ’29 era stato il silenzio operaio nel corso degli anni ’20. La mancanza di lotte opacizza anche la possibilità di sviluppare dei sentieri di crescita che siano capaci di creare società. Negli anni ’30 i primi esperimenti di stato sociale, ancora insufficienti, avevano indicato una strada verso il welfare state; oggi questo non c’è. La centralità odierna della geopolitica riflette l’affannata ricerca di interlocutori su un piano globale e non locale; questo però non basta, perché se tutti i paesi sono in crisi o non riescono a trovare delle modalità di crescita, ciò non fa che acuire le tensioni e le contraddizioni geopolitiche. Credo quindi che si tratti di una questione molto profonda: pone a tutti noi, che stiamo dalla parte del proletariato e dei soggetti della crisi, il problema di quale possa essere un modo di ricostruire un terreno sul quale la lotta degli uni sia anche la lotta degli altri. Ciò ovviamente senza tornare al rapporto salariale, che è sempre stato un rapporto capitalistico, per quanto al suo interno ci fosse la dimensione dell’antagonismo e della conflittualità. Siamo di fronte al problema di definire una lotta di classe post-salariale. Certo, ci sono stati e ci sono dei tentativi e delle rivendicazioni condivisibili sul reddito che pongono il problema della ridefinizione di un terreno di contrattazione in cui si possano aggregare dei soggetti che un salario non sanno nemmeno cosa sia, che conoscono una remunerazione puntuale ma non qualcosa che abbia un futuro e un percorso. La forza della relazione salariale era infatti di comprendere la vita nella sua interezza, dalla formazione dei figli alla vita attiva fino al pensionamento; oggi questa consequenzialità non c’è più. Forse molti esperimenti (tra cui le monete parallele, o quelli di cui parla il libro di Rifkin sulla società della condivisione) sono materia per poter cominciare a elaborare delle strategie. Da questo punto di vista, quella che chiamiamo organizzazione politica è allo stesso tempo un’organizzazione che produce questo terreno dell’aggregazione e della condivisione, senza un prima e senza un dopo, ma in una dimensione di contemporaneità tra lotta politica e lotta per la costruzione di tessuti e spazi condivisi».
La definizione di un campo di lotta post-salariale è una questione centrale. La prospettiva del reddito è importante, ma va incarnata in terreni concreti. Uno di questi può forse essere quello della fiscalità e delle tasse, portato in primo piano da movimenti come quello del 9 dicembre che hanno quelle caratteristiche ambivalenti e spurie che tu qualche tempo fa avevi individuato come connotazioni prevalenti e inevitabili delle lotte dentro la crisi. Cosa ne pensi?
«È una questione grande e inaggirabile. In molti paesi si è cercato di far fronte ai problemi della spesa pubblica e della gestione del debito sovrano attraverso una fiscalità incrementale, che però impatta in modo iniquo. Si pensi per esempio alla distribuzione patrimoniale: appena si toccano le aliquote sul patrimonio si colpiscono soprattutto i ceti più deboli, per quanto si parli di evasione fiscale. Da una parte penso che vada affrontata la questione della fiscalità come migliore equità, dall’altra mi sembra che ci sia un problema di rappresentanza: c’è il vecchio slogan ‘no taxation without representation’, che si potrebbe anche invertire in ‘no representation without taxation’, nel senso che l’evasione fiscale è un fatto gigantesco, ovviamente facilitato dalla globalizzazione, e va riportato alla questione dei beni comuni. Il libro della Mazzucato Lo stato innovatore pone a suo modo la questione di quanto denaro pubblico sia stato investito nella ricerca di base e di quanto sia stato appropriato privatamente, con tutti i risultati, le scoperte e le innovazioni finanziate da noi, dalla collettività. Si pensi al funzionamento di Apple e delle grandi corporation della nuova economia. Riuscire a ristabilire un ordine fiscale che abbia al suo centro ciò che di comune c’è nella crescita e nell’innovazione è un criterio per affrontare la questione fiscale».
Come dici tu la questione è enorme. C’è un discorso classico della sinistra contro l’evasione fiscale; oggi però dobbiamo chiederci cosa la fiscalità e le tasse significhino per le nuove figure del lavoro e per i soggetti colpiti dalla crisi, per i lavoratori autonomi di seconda ma anche di prima generazione, per i ceti medi impoveriti, per chi cerca di sbarcare un lunario con qualche attività più o meno improbabile, fino ad arrivare alle imposte comunali che costituiscono un prelievo forzoso sui servizi alla collettività, sul cosiddetto “diritto alla città”. Il rifiuto delle tasse può in questo senso essere agito e diventare uno dei terreni di lotta post-salariale?
«Già qualche tempo fa, come dicevi, abbiamo parlato della natura di questi movimenti, che è molto difficile definire in un senso o nell’altro. Mi ricordo per esempio una serie di analisi fatte sulla composizione sociale del movimento dei ‘forconi’. Rientra in quanto dicevamo prima: in che misura riusciamo effettivamente a dare corpo a questa moltitudine, in quanto soggetti plurali che non si lasciano comprimere o ridurre alla sintesi, che restano tanti in quanto tanti e che però sono accomunati dalla possibilità stessa di sopravvivere. Ciò attraversa una serie di ambiti, si pensi alla speculazione immobiliare che espelle gente dai quartieri per svuotarli e lasciare spazio alle iniziative dei privati. Oppure si pensi al ruolo delle tasse che sono delle forme di rendita dello Stato».
Anche perché dobbiamo porci il problema di non lasciare le lotte contro le tasse, in quanto rendita dello Stato appunto, alla destra o nel caso italiano alla Lega, per farne un terreno di conflitto comune dei soggetti della crisi...
«Concordo. È delicato, però credo sia giusto cominciare a porre oggi la questione dell’organizzazione: non per fare chissà quali salti in avanti, ma è un modo per affrontare tutte queste istanze nei termini di un agire politico che renda conto della deflagrazione sociale. È un passaggio obbligato dei prossimi anni. Dobbiamo iniziare a pensare all’organizzazione militante e politica da una parte in termini di condivisione, dall’altra come costruzione paziente di terreni di alleanze e anche di linguaggi che ci permettano di capire e interloquire con questi soggetti della crisi, non necessariamente nuovi. È la questione che ci sta davanti».
Il che è stato uno degli elementi che ha consentito al ciclo di lotte di Occupy una capacità espansiva...
«Bisogna riuscire a distillare da queste grandi esperienze recenti qualcosa che permetta di andare al di là della loro apparente orizzontalità. È vero, dal 2011 in poi sembra che questi movimenti non si siano posti il problema di una verticalizzazione delle mobilitazioni, però bisogna stare attenti: in questa orizzontalità c’è anche molta profondità, ed è la cosa che va ripresa e tesaurizzata politicamente. I movimenti esplodono, pongono delle questioni, hanno una loro esemplarità, però non tengono in eterno, sono destinati a ritornare sottotraccia. E tuttavia, cosa c’è dopo e cosa hanno sedimentato? A me sembra che sia proprio questo consolidamento del comune concreto e di soggetti del comune che permettono di far fronte alla sofferenza, alla solitudine, all’isolamento, a tutto ciò che rende le aspettative decrescenti qualcosa di insopportabile».
Per concludere, ritorniamo allo scenario geopolitico e alle crescenti contraddizioni che hai individuato. Pensiamo, per citare un’ulteriore fonte di grande apprensione in Occidente, alla scelta dei Brics di creare la propria istituzione finanziaria, la New Development Bank. Nel frattempo, tra Ucraina, Siria e Iraq la guerra torna al centro della scena, insieme all’ennesima aggressione militare di Israele contro i palestinesi. La guerra, nelle forme parzialmente nuove che ha assunto, ridiventa così per il capitale un modello per affrontare la crisi globale e regolare i conti geopolitici?
«Qualche settimana fa il papa ha detto che è iniziata la terza guerra mondiale: non so se abbia ragione nel formularla in questi termini, ma indubbiamente c’è qualcosa che va in quella direzione. L’impressione è che ci sia una volontà di destabilizzazione da parte dei poteri forti. Senza cadere in una dimensione cospirativa, va detto che ciò è anche la conseguenza di un’economia finanziarizzata, che riduce per esempio il volume del commercio mondiale, creando quindi delle istanze neo-protezionistiche e contribuendo a esacerbare delle tensioni esplosive e molteplici, che hanno a che fare con questioni etniche o religiose, oltre che economiche e politiche. C’è in questo senso un precedente storico: sono i vent’anni che hanno preceduto la prima guerra mondiale. Dopo la crisi degli anni ’90 dell’800, le tensioni hanno portato le economie mondiali allo scoppio della guerra come sbocco, con i primi tentativi di keynesismo ante litteram per rilanciare l’economia a fronte dei problemi del commercio internazionale, attraverso il riarmo e questo tipo di investimenti pubblici. Sono solo esempi, che però non vanno sottovalutati. La tensione è fortissima, ci sarà di nuovo la questione della pace che rispunterà, anche se al momento tutto sembra tacere, ma non vedo come si possa non confrontarsi con questo scenario che è molto inquietante».
«Chiude l'ultimo baluardo di un glorioso passato industriale. Si chiude un’epoca, un declino spaventoso figlio di scelte industriali scellerate e lotte di potere sulle spalle di un colosso sano».
Il Fatto Quotidiano, 20 settembre 2014 (m.p.r.)
Arnad è l'ultima tappa di un percorso trentennale. Martedì scorso lo stabilimento della controllata Olivetti I-Jet, l’unico rimasto in Italia, ha annunciato che entro fine mese chiuderà l’ultima delle sue produzioni ancora operative: le testine a impatto utilizzate per le stampanti ad aghi, una tecnologia brevettata dallo storico marchio di Ivrea. Tutto finito. La produzione verrà “esternalizzata”, con la promessa di ricollocare i 38 operai rimasti nelle aziende del canavese che hanno ereditato i brandelli del Gruppo, e da dove Olivetti è fuggita a metà degli anni 2000. Fino a giugno del 2012 – quando è stata messa in liquidazione – la società impiegava 162 lavoratori, in gran parte ricercatori e “solo” 50 operai. I bilanci sempre in perdita hanno costretto la controllante Telecom (comprata proprio da Olivetti ai tempi di Roberto Colaninno né è poi diventata il contenitore) a ripianare le perdite per quasi 100 milioni dal 2005. Due anni fa, la crisi definitiva. Telecom avvia la vendita dei pezzi pregiati, l’ultima a luglio scorso: cede agli svizzeri della Sicpa i settori Manufacturing e Silicon Production( 36 addetti). L’anno prima era toccato a “Ricerca e sviluppo” (43 dipendenti). Al culmine della produzione, Arnad sfornava 10 milioni di accessori (stampanti e fax) e impiegava 300 lavoratori. «Chiude l'ultimo baluardo di un glorioso passato industriale - spiega Federico Bellono, segretario provinciale della Fiom a Torino e per anni responsabile della sezione di Ivrea - Si chiude un’epoca, un declino spaventoso figlio di scelte industriali scellerate e lotte di potere sulle spalle di un colosso sano».
Il deserto è nei numeri: negli anni ‘70 l'azienda di Ivrea impiegava quasi 70 mila lavoratori (40 mila in Italia), oggi ridotti a 682. La decisione di uscire dal mercato dell'elettronica (un “male da estirpare” secondo lo storico dirigente Fiat Vittorio Valletta) con la vendita nel 1964 di tutta la divisione alla General Electric e da quello dei personal computer (deciso nel 1997 dall'allora ad Carlo De Benedetti) ha azzoppato un’azienda che aveva sfornato oggetti di culto per il design e la tecnologia studiata nei suoi laboratori (quello Ricerche Elettroniche, per dire, nel 1965 partorì il primo Pc della storia, il P101, 12 anni prima di Steve Jobs): nel 1948 la macchina da scrivere Lexikon 80; nel 1950 la gloriosa Lettera 22; nel 1956 la calcolatrice Divisumma, disegnata da Marcello Nizzoli.
Pezzo dopo pezzo, però, i presidi industriali nati dalla vertiginosa crescita di fatturato della gestione di Adriano sono scomparsi. Gli storici stabilimenti di Pozzuoli (30 mila metri quadrati e 1.300 addetti) e Crema hanno chiuso i battenti oltre vent'anni fa. Nel Canavese, la ferita è più recente ma il segno lasciato profondo: degli impianti che davano lavoro a 25 mila addetti non è rimasto più nulla. Scarmagno, che ospitava la divisione computer (Opc) è stata abbandonata e non produce niente (ripara componenti per cellulari) mentre un incendio ha piegato la Telis, e le aziende che si erano accaparrate i resti della gigantesca struttura. A Ivrea le officine sono diventate un museo. L’ultimo a cadere è stato lo stabilimento di Agliè (400 dipendenti), chiuso nel 2004. Ad altri è toccata una sorte diversa, fatta di riconversione forzata, come lo stabilimento di Carsoli (Abruzzo), trasformato in un call center (sulla scia di quanto già sperimentato a Ivrea).
Per evitare il dissesto, negli ultimi anni Olivetti ha completamente cambiato pelle, specializzandosi in applicazioni mobili, dematerializzazione di documenti e servizi cloud. I registratori di cassa - l’ultimo settore dove è ancora leader - li produce in Cina. Nel 1999, Colaninno usò la cassa Olivetti per scalare Telecom, costringendo il gruppo a disfarsi dell’ultimo pezzo pregiato: la Omnitel-Infostrada (creata da De Benedetti), finita a Vodafone. Due anni prima fu proprio Omnitel ad aver avuto l’occasione di comprare il gruppo inglese. Ma l’opposizione di Colannino privò l’Italia della possibilità di avere il primo operatore di telefonia mobile del mondo. E di salvare la Olivetti.
 Un’analisi semplice e chiara della trasformazione di fondo del sistema economico nel passaggio dal capitalismo fordista a quello dei nostri tempi. «l rentier, per il quale Keynes invocava l'eutanasia, è di nuovo alla testa del nostro sistema economico Chi, invece, vive del lavoro è spinto verso la povertà».
Un’analisi semplice e chiara della trasformazione di fondo del sistema economico nel passaggio dal capitalismo fordista a quello dei nostri tempi. «l rentier, per il quale Keynes invocava l'eutanasia, è di nuovo alla testa del nostro sistema economico Chi, invece, vive del lavoro è spinto verso la povertà».
Sbilanciamoci.info, 19 agosto 2014
L'economia liberale usa il termine "imprenditore Sisifo" per riferirsi al fatto che l'imprenditore persegue razionalmente la massimizzazione di un profitto che però, alla fine, sarà nullo. I profitti hanno natura transitoria perché attirano concorrenti sul mercato, cosicché i margini si riducono, fino ad annullarsi. Per mantenere profitti positivi nel tempo non vi sono che due strade.
La prima è pigiare l'acceleratore sull'innovazione: se un'impresa è in grado di produrre sistematicamente innovazione, potrà sempre offrire qualcosa di meglio dei concorrenti e assicurarsi profitti anche molto elevati. La seconda è trasformarsi in rentier, ovvero in un soggetto che riceve denaro non per quello che fa, bensì per quello che possiede.
Anche per trasformarsi in rentier vi sono due strade: da un lato, è possibile ridurre la concorrenza, conquistando una rendita di posizione, operando sul mercato o a latere di esso, lecitamente o meno (si pensi a monopoli e oligopoli, ai brevetti e alle pressioni per allungarne la durata, fino alla corruzione per conseguire appalti pubblici); dall'altro, è possibile impiegare il proprio denaro per acquisire capitale finanziario o immobiliare.
L'imprenditore Sisifo che innova definisce uno degli scenari più virtuosi auspicabili di questi tempi, un'economia dinamica e creativa, che darebbe un giusto premio a coloro che perseguono il nuovo, i quali, comunque, non potrebbero dormire sugli allori e sarebbero invece spinti dalla concorrenza al continuo ampliamento della frontiera organizzativa e tecnologica. Viceversa, un'economia di rentier tende a fermarsi, perché ciascuno di essi si appropria di una parte dei beni prodotti senza dare alcunché in cambio; non a caso, a partire da Keynes si è invocata l'eutanasia del rentier , vista come strumento per liberare economia e società da un peso che ne depotenzia fortemente le prospettive. Per la stessa ragione, la tassazione della ricchezza sarebbe da privilegiare rispetto a quella sul reddito da lavoro e di impresa.
Dei due mondi descritti, la sensazione che in questa fase in Italia (ma non solo) prevalga il secondo è netta. Le difficoltà e la scarsità di prospettive sembrano avere spinto da parecchi anni molti attori economici a cercare di costruirsi un proprio recinto: imprese ex innovatrici si sono spostate in settori monopolistici o sull'immobiliare, mentre gli impieghi finanziari sono diventati superiori agli investimenti reali; professionisti di tutti i tipi (finanche i meccanici, con revisioni e bollini vari) hanno operato per costruirsi rendite di posizione sicure. Per la finanza, la crisi del 2008-2009 ha costituito, da questo punto di vista, solo una temporaneo intoppo. Anzi, le attuali dinamiche dei mercati indicano che essa ha riguadagnato il peso che aveva prima e la speculazione si è fatta ancora più aggressiva, laddove sono le economie reali a subire ancora i devastanti effetti della crisi.
In un mondo nel quale cresce l'importanza della rendita sulla produzione anche i ceti medi hanno vissuto l'illusione di poterne cogliere una parte, così da ottenere, grazie a rendite finanziarie e immobiliari, risorse adeguate a sostenere e migliorare il proprio standard di vita, malgrado la stasi dei salari. Si pensi all'illusione delle famiglie americane che fosse possibile comprare una casa senza realmente pagarla, grazie al continuo aumento dei valori immobiliari, che ha innescato la crisi nel 2008. O alla parallela illusione nostrana sul fatto che coi fondi pensione i lavoratori potessero conseguire pensioni elevate con contributi contenuti.
Ma tali illusioni sono tramontate, non senza conseguenze, e, in una società senza prospettive di crescita, la ricchezza dei ceti medi è arrivata ad assumere un ruolo di mero argine all'impoverimento. Le classi medie devono fronteggiare il fatto che nell'attuale fase si allontana sempre più non solo, se mai c'è stata, la prospettiva di promozione sociale attraverso il lavoro, ma anche quella di potersi assicurare attraverso il lavoro un'esistenza dignitosa.
Non rimane che la ricchezza, personale ma soprattutto familiare, cui votarsi per non scivolare indietro. Ritorna ad essere l'eredità, non più il lavoro, l'elemento che determina lo status. I prezzi delle abitazioni nelle grandi città rendono estremamente difficile, quando non impossibile, l'acquisto a chi dispone solo di redditi da lavoro, mentre alla ricchezza attingono un crescente numero di famiglie anche per far fronte alle esigenze di vita quotidiana. Per coloro che non hanno ricchezze cui attingere, le probabilità di sperimentare situazioni di povertà crescono a livelli che non si ricordavano più.
In tale contesto, uno Stato al testardo perseguimento del pareggio di bilancio si affanna alla ricerca di ulteriori entrate fiscali. Servirebbe un'azione forte e concertata internazionalmente per colpire drasticamente la grande rendita, contrastare la finanziarizzazione e la speculazione, punire i domicili fiscali di comodo, rilanciare un intervento pubblico in campo abitativo, incidere sul trasferimento familiare dei grandi patrimoni con un'adeguata tassa di successione. Servirebbe la volontà di distinguere fra finanza speculativa e finanza "buona". Non sarebbe impossibile, ma rentier , grandi patrimoni e finanza hanno potere e strumenti ormai tali da essere in grado di opporsi efficacemente ai pur blandi tentativi di regolazione.
Alla fine, come al solito, finisce per pagare chi ha qualcosa da parte ma non la capacità di difendersi. Così, i governi tendono non a spostare il prelievo fiscale dal lavoro alle grandi ricchezze, bensì a sommare al prelievo sul lavoro quello sulle ricchezze delle classi medie. Così è stato per le imposte sulla casa e per quelle sui conti correnti, per le quali si prefigura un ulteriore aumento. Così potrebbe essere in autunno, con la riduzione delle franchigie sulle tasse di successione.
 «Un indicatore più completo è quello per le Nazioni Unite di Amartya Sen e altri, lo Human Development Index: misura la qualità della salute e dell’istruzione». Istat ha pubblicato il "Rapporto Bes 2014: il benessere equo e sostenibile". La
«Un indicatore più completo è quello per le Nazioni Unite di Amartya Sen e altri, lo Human Development Index: misura la qualità della salute e dell’istruzione». Istat ha pubblicato il "Rapporto Bes 2014: il benessere equo e sostenibile". La
Repubblica, 6 luglio 2014 (m.p.r.)
L'economia questaquesta politica, e il 99 per cento della società paga. Se questa è l'equità...Greenreport, 3 luglio 2014
Oops, ci siamo sbagliati – ma non ditelo alla Fiom – e ora vogliamo tanto tornare in Italia, come spiega Anie sempre in modo asettico: «Nell’ambito dei cambiamenti delle dinamiche manifatturiere, stiamo assistendo ad un fenomeno nuovo, noto come back reshoring, che consiste nel riportare in patria i siti produttivi precedentemente delocalizzati all’estero. Secondo recenti studi realizzati dal professor Fratocchi e dal suo gruppo di ricerca Uni-Club MoRe Back Reshoring, l’Italia è il secondo Paese nel mondo per rimpatri produttivi, alle spalle solo degli Stati Uniti e quindi primo in Europa». Perché? Alla domanda “quali sono gli interventi di politica industriale che il Governo dovrebbe approntare per favorire il ritorno del manifatturiero in Italia”, il 30% delle aziende intervistate ritiene che la priorità sia la riduzione del cuneo fiscale, più di un quarto di esse la semplificazione della burocrazia e il 18% del campione la detassazione degli utili in Ricerca&Sviluppo.
Il comparto rappresentato da Anie Confindustria a livello nazionale vale circa il 20% dell’intero back reshoring, piazzandosi secondo alle spalle solo dell’abbigliamento e delle calzature (vedi grafico). Secondo i risultati dell’indagine realizzata presso le aziende associate, le ragioni considerate molto rilevanti dalle imprese Anie che hanno rilocalizzato i siti produttivi nel periodo 2009-2013 sono state per un terzo del campione il minore controllo qualità della produzione all’estero, seguito dalla necessità di vicinanza ai centri R&S italiani (25%) e dai costi della logistica (22,2%). Vale la pena soffermarsi anche sul perché queste aziende avessero deciso di lasciare l’Italia: secondo le loro stesse risposte, avevano infatti delocalizzato le produzioni per il minor costo totale della produzione all’estero (“molto rilevante” per l’86% delle imprese rientrate in patria) e del minore costo del lavoro (75%).
L’indagine ha confermato inoltre (e ancora una volta) la vocazione di queste aziende all’innovazione: il 60% del campione investe in R&S più del 2% del fatturato totale e una folta rappresentanza di imprese particolarmente virtuose, costituita dal 40%, investe addirittura più del 4% del fatturato. Ma sono proprio le aziende che hanno messo in atto politiche di back reshoring a dimostrarsi particolarmente aperte al cambiamento tecnologico, all’innovazione e ai nuovi modelli organizzativi. Per quanto riguarda l’avvenuta adozione di tecnologie ICT e ITS (Internet of Things and Services), tra le imprese che sono rientrate abbiamo un picco del 60% contro il 50% della totalità delle imprese Anie, e fra esse nessuna si dichiara non interessata a queste trasformazioni, che vanno verso l’adozione di nuovi modelli organizzativi (fabbrica 4.0). Inoltre, tra le aziende interessate dal fenomeno, il 90% ritiene che i nuovi standard organizzativi di impresa saranno una realtà entro un periodo che va da 1 a 3 anni.
Sulla sensibilità nei confronti dell’innovazione, appare particolarmente significativo notare come -secondo le aziende che sono rientrate – i principali meccanismi di stimolo siano tutti rivolti al miglioramento del prodotto finale: per il 90% di esse è questo lo scopo principale che spinge ad innovare (la corrispondente quota della totalità delle aziende Anie è l’80%). Tra i principali ostacoli all’innovazione, invece, la mancanza di fonti di finanziamento esterne è quella primaria a detta del 43% delle aziende in totale, con un picco del 75% tra le aziende che hanno sperimentato il back reshoring. Ma se la seconda ragione per il totale delle aziende Anie – con una quota del 40% – è il costo elevato dell’innovazione e la mancanza di risorse interne, questa percentuale scende radicalmente se si guarda solo alla segmentazione delle aziende che sono rientrate.
Tutto bene quindi? Oops, ci siamo sbagliati, ora si torna in Italia e vissero per sempre felici e contenti? C’è da rimanere senza fiato di fronte al fatto che in queste analisi non si calcolino assolutamente i costi di questo processo. Delocalizzare all’estero non è stato indolore. Il processo della finanziarizzazione dell’economia che ha tolto la terra sotto ai piedi dell’economia reale è costata vite umane e diritti e ambiente in tutto il mondo. Quanti lavoratori si sono lasciati per strada? Quanto Pil? Quanta innovazione? Quanti morti di fame abbiamo creato facendo salire in modo del tutto artificioso i costi delle commodities alimentari, con la finanziarizzazione! Facendo il percorso all’inverso è come voler rimettere tutto dentro al tubetto il dentifricio: per quanto ci provi, ben poco te ne tornerà dentro e avrai comunque speso dell’energia.
Nessun pasto è gratis, tanto che il rilocalizzare le aziende in Italia significa che si lasciano a casa i lavoratori che stanno dall’altra parte della barricata. Quindi l’azienda vince sempre, e chi se la prende in saccoccia si sa chi è. Al di là del colore della pelle. Non solo, si è andati all’estero si è sfruttato tutto il possibile e poi si torna in Italia come eroi.
Questo non per dire che sia un male, anzi, ma che se le cause sono solo quelle che “non ci si guadagna più a delocalizzare perché ora anche all’estero hanno capito che non vogliono essere sottopagati, che hanno dei diritti e che anche il loro ambiente conta”, quando queste variabili torneranno favorevoli, quelli stessi che oggi tornano, ripartiranno.
Per avere quindi un bilancio favorevole da questa operazione, o almeno il più possibile favorevole, bisogna che almeno per la manifattura si scelga di tornare per accorciare la filiera e fare con quello che si ha. Non tanto come potrebbe pensare qualcuno riscoprendo l’italico petrolio, ma ad esempio utilizzando le miniere urbane, le materie prime seconde. Quelle derivanti dal riciclo. L’innovazione deve essere questa, ovvero secondo il criterio della sostenibilità ambientale e sociale. Altrimenti non cambierà alcunché
 «L'Istat ha elaborato da qualche anno il BES o Benessere Equo Sostenibile, un tentativo di misurare il benessere delle persone e non la ricchezza materiale prodotta. Al contrario, dall’UE il PIL continua a essere l’elemento di riferimento per capire se e quanto i diversi Stati membri si comportano bene».
«L'Istat ha elaborato da qualche anno il BES o Benessere Equo Sostenibile, un tentativo di misurare il benessere delle persone e non la ricchezza materiale prodotta. Al contrario, dall’UE il PIL continua a essere l’elemento di riferimento per capire se e quanto i diversi Stati membri si comportano bene».
Sbilanciamoci!, 23 maggio 2014 (m.p.r.)
L’Istat ha comunicato che dal prossimo anno anche attività illegali quali il traffico di droga o la prostituzione andranno a formare il PIL, ovvero la ricchezza prodotta nel Paese. Tra le prime reazioni, alcuni segnalano che anche la criminalità genera un suo – cospicuo – giro d’affari, e che se bisogna rappresentare correttamente la situazione vanno quindi considerate anche tali poste. Altri insistono sul fatto che è comunque per lo meno difficile valutare con esattezza la dimensione di tali attività, al di là delle stime fatte dalle autorità preposte al loro contrasto.
Il punto di fondo è però forse un altro. Può anche avere senso, in una certa misura, inserire le attività criminali nel computo del PIL. Quello che non ha senso, e il paradosso oggi in discussione ne è unicamente l’ultimo e più evidente esempio, è prendere il PIL a riferimento unico dello stato di un dato Paese, del suo benessere, e porre la crescita del PIL come unico obiettivo delle politiche economiche.
E’ da mezzo secolo almeno che sappiamo, riprendendo le parole di un famoso discorso di Robert Kennedy, che «il PIL misura tutto, tranne ciò per cui vale la pena di vivere»: misura le armi ma non l’amicizia, sale in caso di incidenti ma non se siamo più felici, aumenta in caso di terremoti, calamità o disastri naturali.
Lo stesso Istat ha elaborato da qualche anno il BES o Benessere Equo Sostenibile, un tentativo di misurare il benessere delle persone e non la ricchezza materiale prodotta. Il problema è che tale indice non è utilizzato nelle statistiche ufficiali, non entra nei parametri nazionali o europei.
Al contrario, dall’UE il PIL continua a essere l’elemento di riferimento per capire se e quanto i diversi Stati membri si comportano bene, se e quanto devono continuare ad applicare le devastanti politiche di austerità. L’Italia in particolare, con il Fiscal Compact, è chiamata a ridurre drasticamente il proprio rapporto debito / PIL nei prossimi anni. Le possibilità per riuscire a mantenere gli impegni presi sono poche: ridurre il debito conseguendo enormi avanzi di bilancio, ma più di tanto da questo punto di vista non si può fare; sperare in una ripresa dell’inflazione che trscini il PIL al rialzo, ma l’UE è sull’orlo della deflazione.
Unica altra strada: fare aumentare il PIL a ritmi sostenuti, in modo che cali il rapporto debito / PIL. Il problema è che l’Italia si trova ancora in recessione, ed è diffcile che torni a crescere ai ritmi richiesti. A meno che, ed è l’interessante novità in arrivo, non si trovino dei nuovi aggregati che permettano di fare salire il PIL, o meglio di “drogare” la crescita del PIL. In senso letterale: inserendo le attività illegali. Finalmente un settore che non conosce crisi, e che potrebbe riportare l’Italia a crescere come richiesto dai vincoli europei. E allora, da domani, ci raccomandiamo: drogatevi di più. E’ l’Europa che ce lo chiede.
Sullo stesso argomento si veda su questo sito Metti sesso,droga e contrabbando nel calcolo del Pil
 Mentre chi patisce il disagio e la sofferenza provocati dal neoliberismo e vuole combatterlo continua a dividersi e a cincischiare, il Mostro lavora indefesso. WikiLeaks ci dice come.
Mentre chi patisce il disagio e la sofferenza provocati dal neoliberismo e vuole combatterlo continua a dividersi e a cincischiare, il Mostro lavora indefesso. WikiLeaks ci dice come.
L’Espresso, 19 giugno 2014
Si chiama Tisa (Trade in Services Agreement) il documento che l'Espresso è in grado di rivelare grazie all'organizzazione di Assange. Un trattato internazionale di lobby e governi per liberalizzare i servizi: dai dati personali alla sanità passando per le assicurazioni. Sarebbe la vittoria definitiva della finanza sulla politicaUn trattato internazionale che potrebbe avere enormi conseguenze per lavoratori e cittadini italiani e, in generale, per miliardi di persone nel mondo, privatizzando ancora di più servizi fondamentali, come banche, sanità, trasporti, istruzione, su pressione di grandi lobby e multinazionali. Un accordo che viene negoziato nel segreto assoluto e che, secondo le disposizioni, non può essere rivelato per cinque anni anche dopo la sua approvazione.
L'Espresso è in grado di rivelare parte dei contenuti del trattato grazie a WikiLeaks, l'organizzazione di Julian Assange, che lo pubblica in esclusiva con il nostro giornale e con un team di media internazionali, tra cui il quotidiano tedesco “Sueddeutsche Zeitung”. Una pubblicazione che avviene proprio in occasione dell'anniversario dei due anni che Julian Assange ha finora trascorso da recluso nell'ambasciata dell'Ecuador a Londra, come ricorda l'organizzazione .
GUARDA IL DOCUMENTO IN ESCLUSIVA
Si chiama “Tisa”, acronimo di “Trade in services agreement”, ovvero “accordo di scambio sui servizi”. E' un trattato che non riguarda le merci, ma i servizi, ovvero il cuore dell'economia dei paesi sviluppati, come l'Italia, che è uno dei paesi europei che lo sta negoziando attraverso la Commissione Europea. Gli interessi in gioco sono enormi: il settore servizi è il più grande per posti di lavoro nel mondo e produce il 70 per cento del prodotto interno lordo globale. Solo negli Stati Uniti rappresenta il 75 per cento dell'economia e genera l'80 per cento dei posti di lavoro del settore privato. L'ultimo trattato analogo è stato il Gats del 1995.
A sedere al tavolo delle trattative del Tisa sono i paesi che hanno i mercati del settore servizi più grandi del mondo: Stati Uniti, Australia, Nuova Zelanda, Canada, i 28 paesi dell'Unione Europea, più Svizzera, Islanda, Norvegia, Liechtenstein, Israele, Turchia, Taiwan, Hong Kong, Corea del Sud, Giappone, Pakistan, Panama, Perù, Paraguay, Cile, Colombia, Messico e Costa Rica. Con interessi in ballo giganteschi: gli appetiti di grandi multinazionali e lobby sono enormi.
La più aggressiva è la “Coalition of Services Industries”, lobby americana che porta avanti un'agenda di privatizzazione dei servizi, dove Stati e governi sono semplicemente visti come un intralcio al business: «Dobbiamo supportare la capacità delle aziende di competere in modo giusto e secondo fattori basati sul mercato, non sui governi», scrive la Coalition of Services Industries nei suoi comunicati a favore del Tisa, documenti che sono tra i pochissimi disponibili per avere un'idea delle manovre in corso.
Bozze del trattato, informazioni precise sulle trattative non ce ne sono. Per questo il documento che oggi l'Espresso può rivelare, pubblicato da WikiLeaks, è importante. Per la prima volta dall'inizio delle trattative Tisa viene reso pubblico il testo delle negoziazioni in corso sulla finanza: servizi bancari, prodotti finanziari, assicurazioni. Il testo risale al 14 aprile scorso, data dell'ultimo incontro negoziale – il prossimo è previsto a giorni: dal 23 al 27 giugno – ed è un draft che rivela le richieste delle parti che stanno trattando, mettendo in evidenza le divergenze tra i vari paesi, come Stati Uniti e Unione Europea, e quindi rivelando le diverse ambizioni e agende nazionali.
Segretezza. A colpire subito è la prima pagina del file, che spiega come il documento debba restare segreto anche se può essere discusso utilizzando canali non protetti: «Questo documento deve essere protetto dalla rivelazione non autorizzata, ma può essere inviato per posta, trasmesso per email non secretata o per fax, discusso su linee telefoniche non sicure e archiviato su computer non riservati. Deve essere conservato in un edificio, stanza o contenitore chiusi o protetti». E il documento potrà essere desecretato «dopo cinque anni dall'entrata in vigore del Tisa e, se non entrerà in vigore, cinque anni dopo la chiusura delle trattative».
Pare difficile credere che, nonostante la crisi senza precedenti che ha travolto l'intera economia mondiale, distruggendo imprese, cancellando milioni di posti di lavoro e, purtroppo, anche tante vite umane, le nuove regole finanziarie mondiali vengano decise in totale segretezza. Ma una spiegazione c'è: Tisa è l'eredità del “Doha Round”, la serie di negoziati iniziati a Doha, Qatar, nel 2001, e condotti all'interno dell'Organizzazione mondiale del commercio (Wto), per la globalizzazione e la liberalizzazione dell'economia, che ha scatenato proteste massicce in tutto il mondo e che è fallito nel 2011, dopo dieci anni di trattative che hanno visto contrapposti il mondo sviluppato, Stati Uniti, Giappone Unione Europea, e quello in via di sviluppo, India, Cina, America Latina.
Con il fallimento del Doha Round, gli Stati Uniti e i paesi che spingono per globalizzazione e liberalizzazioni, hanno spostato le trattative in un angolo buio (impossibile definirlo semplicemente discreto, vista la segretezza che avvolge le negoziazioni e il testo dell'accordo), lontano dall'Organizzazione mondiale del Commercio, per sfuggire alle piazze che esplodevano in massicce, e a volte minacciose e violente, proteste no global. Il risultato è il Tisa, di cui nessuno parla e di cui pochissimi sanno. Eppure questo accordo condizionerà le vite di miliardi di persone.
Cosa prevede il Tisa? Impossibile capirlo con certezza fino a quando l'intera bozza dell'accordo non sarà disponibile, ma il draft sui servizi finanziari rivelato oggi da WikiLeaks rivela un trend chiarissimo. «Il più grande pericolo del Tisa è che fermerà i tentativi dei governi di rafforzare le regole nel settore finanziario», spiega Jane Kelsey, professoressa di legge dell'Università di Auckland, Nuova Zelanda, nota per il suo approccio critico alla globalizzazione. «Il Tisa è promosso dagli stessi governi che hanno creato nel Wto il modello finanziario di deregulation che ha fallito e che è stato accusato di avere aiutato ad alimentare la crisi economica globale», sottolinea Kelsey. «Un esempio di quello che emerge da questa bozza filtrata all'esterno dimostra che i governi che aderiranno al Tisa rimarranno vincolati ed amplieranno i loro attuali livelli di deregolamentazione della finanza e delle liberalizzazioni, perderanno il diritto di conservare i dati finanziari sul loro territorio, si troveranno sotto pressione affinché approvino prodotti finanziari potenzialmente tossici e si troveranno ad affrontare azioni legali se prenderanno misure precauzionali per prevenire un'altra crisi».
Il tesoro dei dati. L'articolo undici del testo fatto filtrare da WikiLeaks non lascia dubbi su come i dati delle transazioni finanziarie siano al centro delle mire e delle agende dei Paesi che trattano il Tisa. Nel testo, Unione Europea, Stati Uniti e Panama, noto paradiso fiscale, portano avanti proposte diverse. L'Europa richiede che «nessun paese parte delle trattative adotti misure che impediscano il trasferimento o l'esame delle informazioni finanziarie, incluso il trasferimento di dati con mezzi elettronici, da e verso il territorio del paese in questione». L'Unione europea precisa che, nonostante questa condizione, il diritto da parte di uno Stato che aderisce al Tisa di proteggere i dati personali e la privacy rimarrà intatto «a condizione che tale diritto non venga usato per aggirare quanto prevede questo accordo». Panama, invece, mette le mani avanti e chiede di specificare che « un paese parte dell'accordo non sia tenuto a fornire o a permettere l'accesso a informazioni correlate agli affari finanziari e ai conti di un cliente individuale di un'istituzione finanziaria o di un fornitore cross-border di servizi finanziari». Gli Stati Uniti, invece, sono netti: i paesi che aderiscono all'accordo permetteranno al fornitore del servizio finanziario di trasferire dentro e fuori dal loro territorio, in forma elettronica o in altri modi, i dati. Punto. Nessuna precisazione sulla privacy, da parte degli Stati Uniti.
Quello che colpisce di questo articolo del Tisa sui dati è che risulta in discussione proprio mentre nel mondo infuria il dibattito sui programmi di sorveglianza di massa della Nsainnescato da Edward Snowden, programmi che permettono agli Stati Uniti di accedere a qualsiasi dato: da quelli delle comunicazioni a quelli finanziari. Ma mentre la Nsa li acquisisce illegalmente, nel corso di operazioni segrete d'intelligence e quindi la loro utilizzabilità in sede ufficiale e di contenziosi è limitata, con il Tisa tutto sarà perfettamente autorizzato e alla luce del sole.
In altre parole, il Tisa rende manifesto che la stessa Europa - che ufficialmente ha aperto un'indagine sullo scandalo Nsa in sede di 'Commissione sulle libertà civili, la giustizia e gli affari interni' del Parlamento Europeo (Libe) - sta contemporaneamente e disinvoltamente trattando con gli Stati Uniti la cessione della sovranità sui nostri dati finanziari per ragioni di business. E sui dati, i lobbisti americani della 'Coalition of services industries', che spingono per il Tisa, non sembrano avere dubbi: «Con il progresso nella tecnologia dell'informazione e delle comunicazioni, sempre più servizi potranno essere forniti all'utente per via elettronica e quindi le restrizioni sul libero flusso di dati rappresentano una barriera al commercio dei servizi in generale».
Fino a che punto può arrivare il Tisa? Davvero arriverà a investire servizi fondamentali come l'istruzione e la sanità? L'Espresso ha contattato 'Public Services International', (Psi) una federazione globale di sindacati che rappresentano 20 milioni di lavoratori nei servizi pubblici di 150 paesi del mondo. L'italiana Rosa Pavanelli, prima donna alla guida del Psi dopo una vita alla Cgil, non sembra avere dubbi che le negoziazioni del Tisa mirano a investire tutti i servizi, non solo quelli finanziari, quindi anche «sanità, istruzione e tutto il discorso della trasmissione dei dati». E per l'Italia chi sta trattando? «L'Italia, come la maggior parte dei paesi europei, ha delegato alla Commissione europea», spiega sottolineando la «grande segretezza intorno al Tisa». Daniel Bertossa, che per Public Services International sta cercando di seguire e analizzare le trattative, racconta a l'Espresso che, anche se nessuno lo ha reso noto, «per ragioni tecniche che hanno a che fare con il Wto, noi sappiamo che il Tisa punta a investire tutti i servizi e i paesi che stanno negoziando sono molto espliciti sul fatto che vogliono occuparsi di tutti i servizi». Perfino quelli nel settore militare che «sempre più fa ricorso al privato», spiega Bertossa, sottolineando quanto sia problematica la riservatezza intorno ai lavori del trattato e il fatto che sia condotto al di fuori del Wto, che,«pur con tutti i suoi problemi, perlomeno permette a tutti i paesi di partecipare alle negoziazioni e rende pubblico il testo delle trattative». Invece, per sapere qualcosa del Tisa c'è voluta WikiLeaks. Ai signori del mercato, stavolta, è andata male.
 «Il nuovo sistema europeo di contabilizzazione prevede di inserire nei dati nazionali anche stime del fatturato prodotto da traffico di sostanze stupefacenti, prostituzione e contrabbando». Se questa è l'economia: un trucco contabile e «il rapporto debito/Pil subirebbe una riduzione di 1,32 – 2,6: nell’ipotesi massima si raggiungerebbe senza alcuno sforzo economico e politico metà dell’obiettivo richiesto dal
«Il nuovo sistema europeo di contabilizzazione prevede di inserire nei dati nazionali anche stime del fatturato prodotto da traffico di sostanze stupefacenti, prostituzione e contrabbando». Se questa è l'economia: un trucco contabile e «il rapporto debito/Pil subirebbe una riduzione di 1,32 – 2,6: nell’ipotesi massima si raggiungerebbe senza alcuno sforzo economico e politico metà dell’obiettivo richiesto dal
fiscal compactLavoce,info, 10 giugno 2014 (m.p.r)
La contabilizzazione dell'economia illegale.Nella letteratura economica, l’economia illegale viene considerata una componente non osservata. L’aggregato (non-observed economy) si riferisce a quelle attività economiche che devono essere incluse nella stima del Pil, ma che non sono registrate nelle indagini statistiche presso le imprese, o nei dati fiscali e amministrativi, in quanto non osservabili in modo diretto. Rappresentano una parte consistente del Pil ed è importante quantificarne le dimensioni. Soprattutto per la funzione che il Pil ha come base per gli indicatori di stabilità finanziaria. Sulla base delle definizioni internazionali contenute nel Sistema europeo dei conti nazionali del 1995 e nell’Handbook for measurement of the non-observed economy dell’Ocse del 2002, l’economia non osservata deriva, oltre che da attività illegali, anche dal sommerso e dalla produzione del settore informale e dai limiti del sistema statistico. (1)
L’Istat ha sistematizzato in un quadro analitico le diverse componenti della non-observed economy:
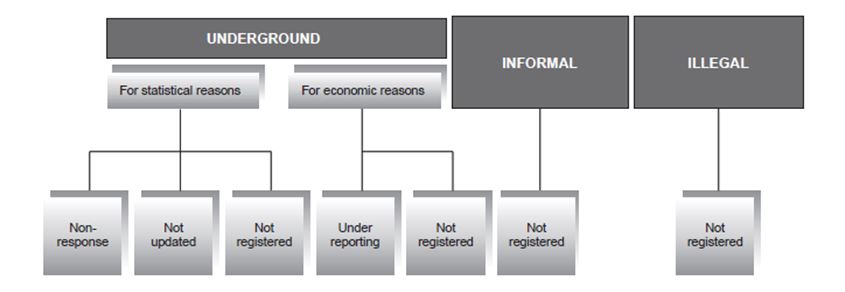
Fino ad oggi, in sede europea, si era convenuto di escludere l’economia illegale dalla contabilità nazionale in quanto la disomogeneità (alcune attività sono illegali in alcuni paesi ma legali in altri) e l’incertezza delle stime rendevano poco confrontabili i dati dei vari paesi. Solo pochi paesi dell’Ocse (Estonia, Lituania, Polonia, Slovacchia) comprendevano stime esplicite delle attività illecite nei loro dati relativi al Pil, introdotte in via sperimentale per uno o due anni. Ora, a partire da settembre 2014, gli Stati membri adotteranno il nuovo sistema europeo dei conti nazionali e regionali – Sec 2010 – in sostituzione del Sec 95. Il nuovo sistema, definito nel Regolamento Ue (549/2013) pubblicato il 26 giugno 2013, presenta alcune importanti differenze rispetto al precedente.
I Conti con il Sec 2010. Come riportato dall’Istat, sono quattro le principali novità del nuovo Sec: 1) la capitalizzazione delle spese in ricerca e sviluppo; 2) la riclassificazione da consumi intermedi a investimenti della spesa per armamenti sostenuta dalle amministrazioni pubbliche; 3) una nuova metodologia di stima degli scambi con l’estero di merci da sottoporre a lavorazione (processing), per i quali si registra il valore del solo servizio di trasformazione e non più quello dei beni scambiati; 4) la verifica del perimetro delle amministrazioni pubbliche sulla base degli aggiustamenti metodologici introdotti dal Sec 2010.
Tabella 1 – Stime provvisorie dell’impatto sul Pil dei cambiamenti metodologici
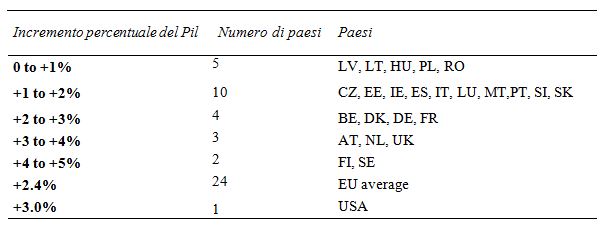
Fonte: Eurostat – The new ESA 2010
Se applichiamo le stime di crescita di Eurostat ai dati del Pil italiano 2013, otteniamo risultati molto importanti per i rapporti debito/Pil e deficit/Pil nel 2013. Il rapporto debito/Pil subirebbe una riduzione di 1,32 – 2,6: nell’ipotesi massima si raggiungerebbe senza alcuno sforzo economico e politico metà dell’obiettivo richiesto dal fiscal compact. Il rapporto deficit/Pil, invece, diminuirebbe di 0,03 – 0,05 punti, con una maggiore disponibilità di risorse da spendere tra i 15 ed i 31 miliardi secondo i dati del 2013. Si tratta dunque di un’innovazione contabile con effetti reali rilevanti. Che potrebbero essere ancora maggiori se alcune di queste attività illegali, come la vendita di droghe leggere o la prostituzione, venissero legalizzate, grazie alle tasse incassate e alle minori spese da effettuare per il contrasto.
Tabelle 2 – 3 - Stime previsionali per l’Italia 2013
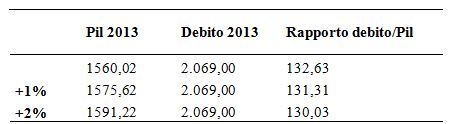
Fonte: Eurostat – ns elaborazione (dati in miliardi)
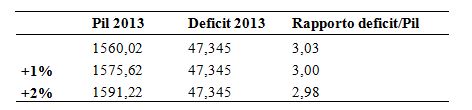
Fonte: Eurostat – ns elaborazione (dati in miliardi)
Nell’attesa di capire come si possa riuscire in brevissimo tempo a costruire e applicare metodi di rilevazione e di calcolo omogenei e credibili – rispetto a una materia che finora, per ragioni di visibilità mediatica, è stata spesso contraddistinta da improvvisazioni, ripetizione automatica di stime mai metodologicamente controllate – una strada semplice e immediata che la nuova metodologia ci consegna per far aumentare contabilmente il Pil c’è: investire in ricerca e sviluppo.
Tabella 4 – Spesa lorda in ricerca e sviluppo in percentuale sul Pil
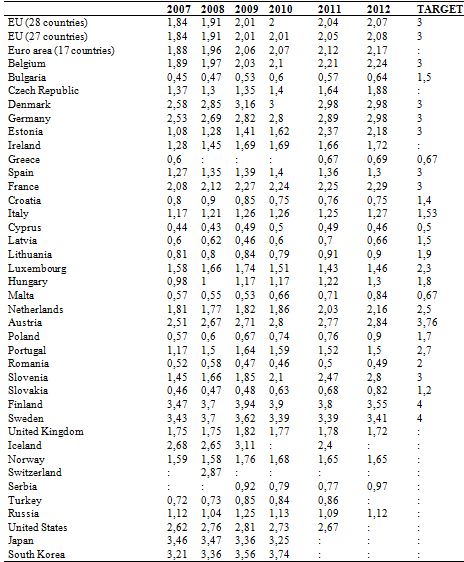
Fonte: Eurostat
(1) L’Handbook interviene con la definizione sia di un framework concettuale per la misura del Pil e sia di un framework analitico per la misurazione dell’economia non osservata.
(2) Secondo l’Scn 1993 le attività illegali devono essere incluse nel sistema di contabilità nazionale, sottolineando che “nonostante le evidenti difficoltà pratiche per ottenere dati sulla produzione illegale, tale attività è inclusa nella produzione nazionale” (Scn 1993: 6,30). L’Scn 1993 opera una netta distinzione tra le operazioni di comune accordo tra l’acquirente e il venditore (ad esempio, la vendita di droga, il traffico di merci rubate o la prostituzione), che sono inclusi nelle attività di produzione, e di altre attività dove l’accordo manca (ad esempio, l’estorsione o il furto), che sono escluse. Il Scn 1993 suggerisce che le azioni illegali per le quali non esiste un accordo possono essere interpretate come una forma estrema di esternalità, senza alcun valore aggiunto nei conti nazionali. Così è la mancanza di consenso tra le parti, piuttosto che l’illegalità a rappresentare il criterio di esclusione dalle attività di produzione (Oecd 2002).
(3) Ardizzi G., Petraglia C., Piacenza M. and Turati G. (2012), Measuring the underground economy with the currency demand approach: a reinterpretation of the methodology, with an application to Italy, Banca d’Italia, Temi di Discussione (Working Papers) Number 864.
(4) Sos Impresa 2009
(5) Fabi, F., Ricci, R. e Rossi, C. in Rey G., Rossi C. e Zuliani A. (2011) Il mercato delle droghe – Dimensione protagonisti, politiche, Marsilio
 Ecco i nuovi padroni, ecco il Mercato: è il finanzcapitalismo, baby. Lui è globale, noi ci guardiamo piangere da un recinto all’altro.
Ecco i nuovi padroni, ecco il Mercato: è il finanzcapitalismo, baby. Lui è globale, noi ci guardiamo piangere da un recinto all’altro.
La Repubblica, 19 maggio 2014
La Borsa tricolore è stata per quarant’anni una riserva di caccia con due soli protagonisti: i salotti buoni — un groviglio di patti di sindacato e partecipazioni incrociate tra banche e famiglie incaricato di gestire gli affari dei soliti noti — e le aziende di Stato. Oggi il vento è cambiato. Gli ex-poteri forti, fiaccati dallo sfarinamento delle dinastie industriali, dai prestiti in sofferenza e dalla crisi, sono a corto di quattrini. E in virtù dell’aurea legge (“Articolo quinto, chi ha i soldi ha vinto”) coniata da Enrico Cuccia, il deus ex machina di questo mondo, il listino milanese ha trovato il suo nuovo padrone: i grandi fondi esteri. Un universo magmatico a molti volti — tra cui quello delle mitiche Scottish Widows, i fondi delle parrocchie presbiteriane e i gestori dei risparmi dei professori dell’Illinois — che in un mese, con un uno-due violento quanto inatteso, ha spazzato via i cocci del capitalismo di relazione tricolore e ha messo ko all’assemblea dell’Eni e di Finmeccanica il Tesoro italiano.
La Waterloo dei salotti buoni ha una data e un luogo preciso: l’assemblea di Telecom Italia a Rozzano, 16 aprile 2014. Il copione, lo stesso degli ultimi sette anni, era in teoria già scritto:
Telco - la holding partecipata da Generali, Mediobanca e Intesa San Paolo, uno degli ultimi residuati dei salotti buoni - avrebbe voluto nominare con il 22,8% del capitale un nuovo cda a sua immagine e somiglianza. Facendo ratificare al mercato le decisioni prese nelle segrete stanze del miglio quadrato attorno a Piazzetta Cuccia. Non è andata così. Alla conta dei voti, è arrivata la sorpresa: i grandi investitori internazionali hanno battuto i vecchi padroni di Piazza Affari, nominando tre loro rappresentanti in consiglio.
Un eccezione? No, la nuova regola. La presenza dei fondi nelle assemblee delle società italiane è raddoppiata in due anni dall’11,6% al 21,6% del capitale rappresentato, dice uno studio della Fondazione Bruno Visentini. Oggi con 200 miliardi di investimenti hanno in portafoglio il 38% di Piazza Affari. Sono loro il primo azionista delle Generali (all’ultima assemblea avevano il 15,2%), di Unicredit e Intesa Sanpaolo con quote attorno al 30% e di molte altre blue chip. E dopo anni vissuti da minoranza silenziosa hanno iniziato a far sentire la loro voce nella foresta pietrificata della finanza tricolore. Ne ha dovuto prendere atto, obtorto collo, anche il governo Renzi. Palazzo Chigi e il Tesoro hanno passato giornate a limare i nuovi requisiti di onorabilità da proporre alle assemblee di Eni, Finmeccanica ed Enel. Convinti di farli approvare senza problemi. Anche loro hanno fatto i conti senza l’oste. Quando il rappresentante di via XX settembre ha messo ai voti il piano all’assemblea Eni, i grandi fondi esteri — allergici alle intrusioni dello Stato — si sono messi di traverso e la norma non è passata. Confermando così che l’Italia ha perso il controllo della maggiore (e più strategica) impresa nazionale. Lo stesso è accaduto in Finmeccanica.
L’identikit dei nuovi padroni di Piazza Affari è un’immagine insieme semplice e complessa. Semplice perché sono i gestori di quella valanga di liquidità ammucchiata negli ultimi anni (o pompata dalle banche centrali) che muove gli equilibri geopolitici del mondo, spostando masse enormi di denaro dalle star-up di Internet ai laboratori biotech, dai derivati ai titoli di stato, dai dollari all’euro, magari affondando - salvo poi reinnamorarsene in questi mesi - i paesi in odore di crisi. Complessa perché in questo mare magnum ci sono mille realtà finanziarie diverse: fondi a lungo termine, attivisti, hedge che muovono quattrini ai ritmi frenetici dei millesimi di secondo dettati dai programmi computerizzati del listini.
Speculatori? Tutt’altro, dicono loro. «Il 50% dei nostri sottoscrittori sono famiglie, tra cui migliaia di italiani, magari con solo 10mila euro da investire. Non mi pare che questi siano i fantomatici raider di cui si parla», è il mantra di Andrea Viganò, country head del fondo Blackrock, il colosso Usa che gestisce 4.300 miliardi di patrimonio (il doppio del Pil tricolore, 10 volte il valore dell’intero listino tricolore) e che negli ultimi mesi si è messo in tasca il 6% di Intesa e Unicredit, il 5% di Bpm, il 3,7% di Mps oltre a quote importanti in Generali, Fiat, Atlantia e Mediaset.
Il loro sbarco in Italia coincide, non a casa, con l’implosione del sistema dei salotti buoni. Mediobanca, fiutato il vento, ha da tempo iniziato a smontare il suo reticolo di partecipazioni per concentrarsi sul core business della banca d’affari, In pochi mesi si sono sciolti come neve al sole patti di sindacato storici e inossidabili come quelli di Pirelli, Rcs e Benetton. Oggi a questo piccolo mondo antico — che non a caso ha messo in vendita 4 miliardi delle sue quote incrociate — è venuto a mancare il collante che lo teneva unito: i soldi (spesso degli altri). «Le vecchie famiglie non li hanno. Le banche di riferimento nemmeno. Il meccanismo del do ut des, delle operazioni gestite chiamando a raccolta un gruppo ristretto di amici si è inceppato. Le aziende per crescere o per non morire sono costrette a cercarli dove ci sono: dal mercato e dai fondi», spiega Dario Trevisan, il legale milanese che da anni rappresenta i nuovi poteri forti di Piazza Affari alle assemblee delle aziende quotate. Trevisan non è un Agnelli né un Berlusconi. Eppure si è presentato all’assemblea di Generali con il 15% dei voti, in quella di Telecom con il 27% e all’Eni con il 30%, più dello Stato. «E’ un bene? Sì - sostiene lui- . I fondi non sposano interessi e non hanno miopi visioni locali».
Il rischio, dicono i critici, è che i grandi fondi seguano logiche finanziare di breve respiro. «Mi sento di dire che non è così — assicura Valerio Battista, ad di quella Prysmian che uscendo da Pirelli è diventata la prima grande public-company italiana gestita dai grandi investitori istituzionali — : la maggioranza di quelli che stanno sbarcando ora sul mercato italiano è gente seria che investe sul lungo termine. Gente che non ha paura di mettere soldi su un buon progetto. Il loro problema è la remunerazione del capitale, non la diluizione delle quote». «In America il boom pluridecennale dell’hi-tech e delle biotecnologie è stato sostenuto proprio dai loro soldi. Il mercato su questo fronte è molto più efficiente di banche e famiglie», dice Umberto Mosetti, uno dei massimi esperti italiani di corporate governance che con il fondo Amber ha combattuto con successe alcune battaglie tra cui quelle contro la gestione Besnier in Parmalat. Qualcuno, dopo il voto all’Eni, vede a rischio l’italianità del Belpaese Spa. «Rischio che non esiste - dice il “mercatista” Mosetti - visto che il totem della difesa dell’identità delle nostre aziende è stato utilizzato finora per arricchire singole persone e non nell’interesse della nazione».
Nessuno, per ora, pare aver intenzione di alzare barricate. Anche perché lo Tsunami dei fondi internazionali è stato uno dei fattori chiave per riportare lo spread italiano sotto quota 200. L’importante, dice l’esperienza del passato, è non sottovalutarne l’umoralità. Come arrivano, spesso vanno.. Alla stessa velocità. E se vogliono colpire duro, anche Vedove scozzesi, preti presbiteriani & Co. sono in grado di far male a chiunque: hanno fatto saltare i vertici di Hewlett Packard, costretto un colosso come Apple a rivedere la sua politica di dividendi, tagliato lo stipendio a un nume tutelare della pubblicità come Martin Sorrell. Il 30% di loro ha votato contro le super-buste paga dei manager italiani nell’ultima tornata di assemblee. Chi ha orecchi per intendere, intenda. La loro battaglia, nello stivale, è solo all’inizio.
Un'ulteriore stretta di vite del Finanzcapitalismo contro gli abitanti del pianeta Terra. Il TTIP (Transatlantic Trade and Investment Partnership), l'accordo intercommerciale, in discussione tra Usa e Ue, comporterà l'istituzione di un tribunale che tutela solo i privati nelle dispute tra investitore estero e Stato.
Il manifesto, 16 maggio 2014
Dopo il disastro di Fukushima, la Germania decide di uscire dal nucleare. Pochi mesi dopo, basandosi su un accordo internazionale sugli investimenti in ambito energetico, il colosso dell’energia Vattenfall chiede allo stato tedesco una compensazione di 3,5 miliardi di euro. L’anno prima la Philip Morris cita l’Australia, sostenendo che la nuova legge pensata per limitare il consumo di sigarette deprime il valore dei suoi investimenti nel Paese e ne “compromette irragionevolmente il pieno uso e godimento”.
Benvenuti nel mondo delle dispute tra investitore e Stato, o Investor-State Dispute Settlement (Isds). Semplificando, una sorta di tribunale in cui le imprese private possono direttamente citare in giudizio gli Stati, quando questi dovessero introdurre delle legislazioni con impatti negativi sugli investimenti realizzati e persino sui potenziali profitti futuri. Legislazioni in ambito ambientale, del diritto del lavoro, della tutela dei consumatori, sulla sicurezza e chi più ne ha più ne metta.
Tali «tribunali» sono parte integrante di diversi accordi commerciali o sugli investimenti, come nel caso del Nafta, siglato tra Canada, Usa e Messico. È così che la statunitense Metalclad si è vista riconoscere un rimborso di oltre 15 milioni di dollari quando un Comune messicano ha revocato l’autorizzazione a costruire una discarica di rifiuti pericolosi sul proprio territorio; o ancora che la Lone Pine Resources ha chiesto 250 milioni di dollari al Canada a causa della moratoria approvata dal Quebec sulle attività di fracking — una pratica di estrazione di petrolio dalle rocce con enormi rischi ambientali.
Tutto questo potrebbe diventare la norma nei prossimi anni anche in Italia e in tutta Europa, se passasse il Ttip o Transatlantic Trade and Investment Partnership in discussione tra Ue e Usa. Se da una parte già si moltiplicano studi e ricerche che magnificano i presunti vantaggi di una completa liberalizzazione di commercio e investimenti, dall’altra fino a oggi i contenuti dell’accordo filtrano dalla Commissione europea e dai governi con il contagocce. Quello che sembra però confermato è che uno dei pilastri del Ttip dovrebbe essere proprio l’istituzione di un meccanismo di risoluzione delle dispute tra investitori e Stati.
Tralasciando i pur enormi potenziali impatti di tale accordo in ogni attività immaginabile, per quale motivo gli investitori esteri che si sentissero penalizzati non dovrebbero rivolgersi ai tribunali esistenti tanto in Usa quanto in Ue, come un qualsiasi cittadino o impresa locale? Secondo la Commissione «alcuni investitori potrebbero pensare che i tribunali nazionali sono prevenuti». Fa piacere sapere che la Commissione si preoccupa per quello che alcuni investitori esteri potrebbero pensare più che dei cittadini che dovrebbe rappresentare. Tenendo poi conto che un singolo non può rivolgersi a tali tribunali nel caso in cui fosse danneggiato dal comportamento di un investitore estero, che giustizia è quella in cui unicamente una delle due parti può intentare causa all’altra? Ancora prima, nel momento in cui si sancisce un diverso trattamento tra imprese locali e investitori esteri, ha ancora senso affermare che «la legge è uguale per tutti»?
Con tali meccanismi si rischia di minare le stesse fondamenta della sovranità democratica. Non vi è appello possibile, così come non c’è nessuna trasparenza sulle decisioni di tre «esperti» che si riuniscono e decidono a porte chiuse, nel nome della «confidenzialità commerciale», ma che di fatto possono influenzare, pesantemente, le legislazioni di Stati sovrani.
Spesso non è nemmeno necessario arrivare a giudizio: la semplice minaccia di una disputa basta a bloccare o indebolire una nuova legislazione. In parte per il costo di tali procedimenti, in parte per il rischio di dovere poi pagare multe che possono arrivare a miliardi di euro, ma anche per un altro aspetto: un governo che dovesse incorrere in diverse dispute dimostrerebbe di essere poco incline agli investimenti internazionali. In un mondo che ha fatto della competitività il proprio faro e che si è lanciato in una corsa verso il fondo in materia ambientale, sociale, fiscale, sui diritti del lavoro pur di attrarre i capitali esteri, l’introduzione di leggi «eccessive» e l’essere citato in giudizio in un Investor-State Dispute Settlement diventano macchie inaccettabili.
O forse, al contrario, è semplicemente inaccettabile un mondo in cui la tutela dei profitti delle imprese ha definitivamente il sopravvento sui diritti delle persone. Come sostiene la campagna promossa anche in Italia da decine di organizzazioni — http:// stop -ttip -ita lia .net -, a essere inaccettabile è il Ttip nel suo insieme. E non è probabilmente necessario il giudizio di un tribunale internazionale per capire da che parte stare

Di recente un attento storico dell’economia, Thomas Piketty (autore di Capital in the Twenty-First Century, Cambridg, MA, Belknap Press, 2014), ha affermato: «Sul lungo periodo la crescita della produzione non supera mai l’1– 1,5% all’anno (…) Dobbiamo farcene una ragione e smetterla di sognare un’illusoria crescita dell’economia». Dello stesso tenore le affermazioni di Larry Summers, che hanno fatto scalpore essendo stato rettore di Harvard e segretario al Tesoro di Clinton (vale a dire uno dei maggiori responsabili della deregolamentazione del settore finanziario che ha portato al crack finanziario del 2008). Parlando alla conferenza del Fondo Monetario Internazionale nel novembre del 2013 a New York, Summers ha diagnosticato una fase di stagnazione di lungo periodo: Secular Stagnation. In verità lo aveva già detto Paul Krugman: «Sappiamo che l’espansione economica del 2003–2007 è stata guidata da una bolla — si può dire lo stesso dell’ultima parte dell’espansione degli anni ’90, e in effetti si può dire lo stesso degli ultimi anni dell’espansione Reagan» (Paul Krugman, Secular Stagnation, Coalmners, Bubbles, and Larry Summers, ’New York Times’, 16 novembre 2013). Ha commentato un giornalista di Repubblica (Maurizio Ricci, L’era della crescita Zero, ’la Repubblica’, 10 dicembre 2013): «Il lungo boom che ha accompagnato due secoli e mezzo di rivoluzione industriale si è esaurito» e dobbiamo rassegnarci a una «nuova normalità». Cioè, a uno «sviluppo stazionario». Un bella inchiesta di un giornalista nordamericano pubblicato sull’ultimo numero di Internazionale (Harold Meyerson, La fine della classe media, 7 marzo 2014) si chiede se «L’età dell’oro non tornerà più». E risponde affermando che i trenta anni successivi alla seconda guerra mondiale sono stati un «fenomeno irripetibile». Almeno per noi, per l’ex Primo mondo.
Potrei citare molti altri economisti della New Economics Foundation di Londra (Tim Jackson, Prosperità senza crescita. Economia per il pianeta reale, Edizioni Ambiente 2011; Emanuele Campiglio, L’economia buona, Bruno Mondadori 2012) e della Bioeconomia (Mauro Bonaiuti, La grande transizione, Bollati Boringhieri, 2013), per non tornare alle preveggenti, lucidissime analisi di André Gorz, che ci invitano a trovare delle vie di uscita non fondate sulla crescita e sulla espansione.
Con molta modestia e, probabilmente, con grande ingenuità mi sono fatto queste due domande a cui vorrei che il convegno di Bruxelles rispondesse. Si dice: per aumentare l’occupazione bisogna far cresce la domanda interna e le esportazioni. Ma se le merci di largo consumo (specie quelle più a basso costo) sono tutte d’importazione, una aumento della domanda interna quale occupazione accrescerebbe? Prima, evidentemente, servirebbe intervenire sulla bilancia commerciale. Ma per farlo servirebbe regolare in modo del tutto diverso i mercati (vedi i Trattati di libero scambio) e la internazionalizzazione delle imprese transnazionali (delocalizzazioni produttive). Non credo che vi siano più (né, d’altronde, sarebbe giusto) le condizioni per ottenere ragioni di scambio penalizzanti i «paesi in via di sviluppo» che ora si chiamano, non a caso, «emergenti».
Seconda domanda. Viene sempre auspicata come leva anticrisi l’aumento degli investimenti («stimoli», sgravi fiscali, opere pubbliche, ecc.) per far ripartire le imprese. Ma se i denari con cui si fanno queste operazioni li si prende a debito (emissioni di titoli pubblici, bond, project financing, ecc.) e se sul debito bisogna pagare gli interessi e se gli interessi sono più alti della crescita dell’economia «reale»… alla fine a guadagnarci non saranno mai i salari, ma le rendite finanziarie! Esattamente quello che è successo negli ultimi trent’anni: la quota dei salari sul reddito nazionale (negli SU come in tutta Europa) è diminuita a favore di quella andata ad appannaggio dei profitti e delle rendite. Se le cose stanno così, allora, condizione preliminare non è l’investimento (pubblico o privato) in sé, ma la ristrutturazione in radice del funzionamento della finanza.
Sono queste le domande che le donne e gli uomini della strada si fanno tra i banchi del mercato che vendono ormai quasi solo merci cinesi, sotto i cantieri delle «grandi opere» finanziati dalla finanza di progetto, in coda per ottenere un prestito con interessi da strozzini, alla ricerca disperata di un lavoro che non c’è quando invece di cose utili da fare ce ne sarebbero anche troppe. Domande a cui un numero sempre più grande di persone cominciano a darsi delle risposte da soli organizzandosi in gruppi di acquisto e banche del tempo solidali, in cooperative di comunità, in gruppi di auto-mutuo-aiuto per un welfare di prossimità, in gestioni condivise dei beni comuni, in scambi non monetari o con monete locali… Da cui l’ultima domanda agli economisti progressisti: che posto c’è nelle nuove teorie economiche non convenzionali per l’economia solidale o sociale o civile o morale, a dir si voglia? È possibile — almeno sul piano teorico e di visione strategica — avere queste come punto di approdo per una conversione strutturale dei rapporti sociali di produzione e di consumo? Sarà mai possibile ipotizzare almeno una via di uscita dalla crisi che non sia solo anti-neoliberista, ma anche oltre-capitalista?
Porrei un'ulteriore domanda. Quali beni ( merci o servizi) dobbiamo produrre? Più precisamente, per ottenere che cosa dobbiamo impiegare il lavoro (l'applicazioni delle energie psicofisiche degli uomini e delle donne)? Per produrre merci che non servono e sembrano indispensabili solo perchè i "persuasori occulti", al servizio della produzione capitalistica ci convincono ogni giorno che così è, oppure per rendere più umano, vivibile, bello, amichevole, equo il pianeta in cui viviamo? A chi lasciamo la scelta? al "mercato", cioè a chi trae vantaggio della mortifera economia data, o alla politica non lasciata nelle mani dei partiti asserviti al pensiero unico?