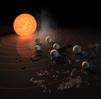«In Francia tira la stessa cattiva aria che nel resto d’Europa. Non sembra che l’opinione pubblica se l’attendesse. Emmanuel Macron, da parte sua, non sembra rappresentare un incrollabile baluardo contro l’estrema destra, al contrario».
«In Francia tira la stessa cattiva aria che nel resto d’Europa. Non sembra che l’opinione pubblica se l’attendesse. Emmanuel Macron, da parte sua, non sembra rappresentare un incrollabile baluardo contro l’estrema destra, al contrario».
Sbilanciamoci.info, newsletter n.516, 5 maggio 2017
Al secondo turno delle elezioni presidenziali tramontano i vecchi partiti e Emmanuel Macron e Marine Le Pen si contendono una Francia divisa – socialmente e geograficamente – e incerta. Le Pen ha incassato sette milioni e mezzo di voti, più del doppio di quanti ne avesse fatti suo padre nello scontro con Chirac nel 2002. […]
I risultati del primo turno delle elezioni presidenziali a Parigi sono stati un poco lugubri: al secondo turno accanto a Emmanuel Macron è uscita Marine Le Pen, con sette milioni e mezzo di voti, più del doppio di quanti ne avesse fatti suo padre nello scontro con Chirac nel 2002. Il risultato finale non è affatto sicuro.
Le cose sono andate finora così: il Partito Socialista aveva indetto le primarie per scegliere il candidato. Ma quando è uscito Benoît Hamon – uno dei leader della sinistra, l’altro era Montebourg – il Partito Socialista (PS) non è stato contento, a cominciare da Hollande. Credo sia stato Hollande medesimo a introdurre al governo Emmanuel Macron, giovane brillante economista, allievo della banca Rothschild. Senonché Macron, a un anno delle elezioni presidenziali, ha deciso per conto suo di presentarsi, contando sul fatto che il PS non si sarebbe mobilitato per Hamon.
E infatti è andata cosi: nell’aprile 2016, Macron ha fatto sapere che avrebbe concorso alle elezioni. Hollande non lo ha appoggiato, ma lui si è presentato ugualmente nel novembre 2016, lanciando a proprio sostegno non un partito ma un “movimento”, En Marche. La sua fortuna è stata fulminea, dovuta anche al fiasco del partito di destra classico, Les Républicains, il cui candidato François Fillon, già premier di Sarkozy, ha rappresentato la destra classica, ma è sprofondato in una sordida storia di compensi per moglie e figli come assistenti parlamentari. Quando questo pasticcio è uscito, ha rifiutato di ritirarsi: risultato, è rimasto escluso dal secondo turno della competizione elettorale. Emmanuel Macron può vantarsi di aver liquidato i due interlocutori classici delle elezioni post-golliste, Partito Socialista e Les Républicains.
Analizzando il voto del primo turno, la Francia appare divisa in due, socialmente e geograficamente. Socialmente, Marine Le Pen è stata votata sopratutto da povera gente: con meno di 3000 euro di reddito l’anno, e priva di istruzione medio-alta. Macron ha raccolto i voti della classe media (comprendendo anche gli operai) decisa di abbandonare la sinistra e di quelli che avevano un diploma medio-superiore. Nella competizione si è inserito anche un uomo di sinistra, Jean-Luc Mélenchon (La France Insoumise), che non ha voluto unire i suoi voti a quelli di Hamon (considerando il PS più o meno un traditore della classe operaia) ed è risultato quarto al primo turno. Ecco i risultati principali:
Emmanuel Macron: 8 657 326 voti (24,01 %); Marine Le Pen: 7 679 493 voti (21,30%); François Fillon (primo escluso): 7 213 797 voti (20,01%), cioè 450 000 voti meno di Marine Le Pen; Jean-Luc Mélenchon (secondo escluso): 7 060 885 voti (19,58%); Benoit Hamon (quinto ma con molto distacco): 2 291 565 voti (6,36%).
Geograficamente, la Francia appare divisa fra Nord-Est e Sud-Ovest, il primo tutto in preda al Front National, salvo Parigi e Lille, e il Sud-Ovest, in gran maggioranza su posizioni anti-Le Pen, con un paio di dipartimenti a sinistra e qualche altro al Fronte Nazionale. I due candidati operai, di tendenza trotzkista, molto simpatici in televisione, sono usciti quasi ultimi, Nathalie Arthaud 0,64% e Philippe Poutou 1,09%. Tutti, salvo Jean-Luc Mélenchon, hanno dato la parola d’ordine “votare contro il Front National di Marine Le Pen” (Mélenchon si riserva di interpellare prima i suoi iscritti e di far sapere la decisione venerdì prossimo).
Oltre alla differenza sociale (occupazione e cultura), c’è una ulteriore differenza fra i votanti dei due candidati. Marine Le Pen è la candidata che ha avuto più voti nella maggioranza dei comuni, che in Francia sono molto frammentati, mentre Macron prevale nelle città. Non si può essere certi – quali che siano gli appelli delle altre forze politiche – che essa sia sconfitta fin da oggi.
Nella campagna elettorale, Marine Le Pen ha mantenuto qualche differenza da suo padre (ha smentito gli attacchi di lui agli ebrei; ha però considerato responsabili del più grande rastrellamento
anti-ebraico a Parigi nel 1942 – al Vel d’Hiv – le forze di occupazione tedesche, rendendone innocente la Francia), la sua parola d’ordine è stata “Je suis le Parti du peuple”, indicando i nemici del popolo nell’Unione Europea e nella finanza, nonché impegnandosi contro i migranti, sospettati di introdurre di fatto i simpatizzanti dell’ISIS (di qui la sua richiesta di finirla con l’accogliere i migranti e di espellere tutti quelli fra di loro che sono indicati come potenzialmente pericolosi, quelli con “schede S”). In generale la sua campagna è stata realmente protezionista e populista; purtroppo abbastanza vicina a quella di Jean-Luc Mélenchon, sul quale cadono oggi i fulmini di tutti i “democratici per bene”.
Il primo turno delle presidenziali indica realmente un crollo dei partiti democratici tradizionali e in particolare dei socialisti; e ugualmente una reale affermazione del Front National che è una prima assoluta nella storia della Repubblica. La mancanza di coesione fra gli altri partiti, e sostanzialmente l’isolamento di un debole Partito Socialista, rendono possibile, almeno in via di principio, la vittoria di Marine Le Pen come Presidente. Le conseguenze politiche per la Francia e quelle per l’Europa sono evidenti.
Una risorgenza della sinistra è tutta da inventare. Non sembra che essa possa nascere dal PS e l’estrema sinistra è troppo debole. Non ci sono che poche manifestazioni antifasciste; la più grossa dovrebbe essere il primo maggio a Parigi, place de la République, ma non è un partito particolare a indirla.
Naturalmente un esito vittorioso di Le Pen creerebbe non pochi problemi per la successiva scadenza elettorale, le elezioni legislative si terranno l’11 e 18 giugno. In realtà non sembra che siano verosimili né una maggioranza di governo, né una di opposizione. In conclusione, in Francia tira la stessa cattiva aria che nel resto d’Europa. Non sembra che l’opinione pubblica se l’attendesse. Emmanuel Macron, da parte sua, non sembra rappresentare un incrollabile baluardo contro l’estrema destra, al contrario.
 La politica ridotta a tifoseria. Così anche il direttore del giornale del neoliberismo italiano cede allo spirito dei tempi. Non ammette che a qualcuno non vada bene né l’uomo della Trilateral Commission né l’apostolo della destra xenofoba e che rifiuti di appoggiare sia l’uno che l’altro.
La politica ridotta a tifoseria. Così anche il direttore del giornale del neoliberismo italiano cede allo spirito dei tempi. Non ammette che a qualcuno non vada bene né l’uomo della Trilateral Commission né l’apostolo della destra xenofoba e che rifiuti di appoggiare sia l’uno che l’altro.
la Repubblica, 4 maggio 2017
DUNQUE si può essere di sinistra e non votare contro Marine Le Pen: pur di non votare per Macron. È il nuovo mantra — “né né” — che attraversa un pezzo di elettorato francese radunato nel 19,58 raccolto da Mélenchon al primo turno, e lo assolve preventivamente mentre viaggia verso l’astensione al ballottaggio decisivo per il futuro della République, e forse dell’intera Europa. Manca il tripode con l’acqua di Ponzio Pilato per lavarsi le mani sullo spazio imperiale del Pretorio, all’ora sesta di un giorno in cui il cielo si oscurò. Tutto il resto è pronto. Intellettuali, blogger, filosofi, storici, sindacalisti hanno già fornito la giustificazione teorica a questo tradimento repubblicano che ha come posta in gioco visibile il palazzo dell’Eliseo, ma in realtà arriva a intaccare le fondamenta dello spirito democratico francese e i suoi valori di fondo ereditati dalla Rivoluzione.
Naturalmente c’è la ribellione allo strapotere della finanza, delle banche, dell’Europa, radunate in una trimurti ingigantita e resa così simbolica delle sofferenze di questi anni da diventare il nemico assoluto, ideologico, politico, culturale, addirittura morale. Basta guardarsi intorno per capire le ragioni di questo rigetto. E se non basta, si può ricordare una vecchia frase di Camus: «mai il numero di persone umiliate è stato così grande».
Ma qui, con ogni evidenza, c’è qualcosa di più. Non un progetto alternativo, un’obiezione culturale, un’idea che metta in movimento una politica diversa, di cui avremmo bisogno. C’è quasi un odio antropologico — che non ha nulla a che fare con la politica — per la figura fisica e insieme fantasmatica del tecnocrate che gioca la sfida del governo, mettendo le sue carte sul tavolo, senza camuffare la sua cultura e i suoi programmi nell’opportunismo della rincorsa populista. Così, mentre l’indebolimento degli anticorpi repubblicani e la rabbia popolare facilitano la dediabolisation di Le Pen, un moderno diavolo borghese sale sul trono vacante e diventa il bersaglio della sinistra delusa, dispersa, furiosa. È il politico che crede nella vocazione europea della Francia, nella funzione storica di guida che il Paese ha giocato nella Ue con la Germania, nei vincoli della responsabilità, nella modernizzazione post- ideologica. Tutto quello (in una versione franco-centrista) che nel malandato e diseredato lessico della sinistra italiana abbiamo provato a chiamare da anni “riformismo”, qualcosa che non c’è, e dovrebbe in poche parole coniugare la speranza dell’emancipazione sociale con la responsabilità di governo.
Tra i “né né” naturalmente Michel Onfray è in prima fila, con una vecchia patente di sinistra e una furia iconoclasta che lo ha reso popolare da anni: da Valls ad Attali, a Kouchner, a Cohn-Bendit, «sono i promotori forsennati di una politica liberale che hanno permesso a Marine Le Pen di fare il botto e arrivare al secondo turno». E lo storico Emmanuel Todd gli fa eco nell’intervista ad Anais Ginori: «Votare Front National è approvare la xenofobia, ma votare Macron è accettare la sottomissione. Per me è impossibile scegliere. Considero il lepenismo e il macronismo come due facce della stessa medaglia. Le Pen è il razzismo, Macron è la servitù alle banche e alla Germania. Per questo mi astengo con coerenza, anzi con gioia, aspettando che nasca un mondo migliore».
Con l’astensione ovviamente la sinistra pura e dura ingigantisce il rischio che Marine Le Pen riempia questa attesa accomodandosi sulla poltrona dell’Eliseo. Ma non importa più. L’odio nei confronti del riformismo ha bisogno di minimizzare i rischi del post-fascismo, per sdoganare l’astensione tranquillizzando le coscienze inquiete davanti alla xenofobia del Front. Se Macron è uguale a Le Pen, allora Marine definitivamente non viene più dall’inferno, è una nemica ma come tanti, anzi non è nemmeno la peggiore, entra nella normalità del gioco politico francese, culturalmente accettata, moralmente scusata, storicamente amnistiata. Anzi, esercita una sorta di tacita egemonia culturale, quando la sinistra per accusare la finanziarizzazione macronista usa i termini tipicamente lepenisti di “sottomissione” e “servitù”, che non hanno più al centro il cittadino come soggetto politico universale, secondo la lezione francese, ma lo spirito di Francia, collettivo, nazionalista e patriottico, che Marine vuole resuscitare, per scagliarlo contro l’Europa tiranna.
La frattura culturale e l’infiltrazione avviene anche a destra, nel campo repubblicano, con “tradimenti” singoli e furbizie isolate, come denuncia Alain Juppé, oggi sindaco di Bordeaux, che non ha dubbi: «la vittoria di Le Pen sarebbe uno scisma geopolitico, un disastro economico, una sconfitta morale. Per questo serve un appello solenne a resistere alla tentazione di rompere tutto, di rovesciare il tavolo». È il vero sentimento nazionale, per il bene della Repubblica, che affiora a destra e fatica ad emergere nella sinistra (due terzi degli elettori di Mélenchon sono per l’astensione) ipnotizzata invece dal risentimento per il nuovo nemico, al punto da perdere quel senso della responsabilità nazionale che l’ha sempre contraddistinta.
Perdendo intanto anche il senso morale delle proporzioni, quando Todd teorizza che c’è più da temere «nella fanatizzazione dei benpensanti che nella risorgenza del fascismo ». Faceva tristemente eco, nel corteo del Primo Maggio e a poche ore dalla più pericolosa sfida lepenista alla Repubblica, quello striscione sindacale in boulevard Beaumarchais che archiviava ogni criterio di distinzione, base di qualsiasi buona politica: “Peste o colera, né l’una né l’altra”. Per la sinistra, non è ancora passata l’ora sesta.

Il Fatto quotidiano, 2 maggio 2017
UNESCO, ALFANO:
“ITALIA CONTRO RISOLUZIONE SU GERUSALEMME”.
MA 22 PAESI LA APPROVANO.
ISRAELE: “VERGOGNOSO”
«La Risoluzione si intitola "Palestina Occupata" ed è stata presentata da Algeria, Egitto, Libano, Marocco, Oman, Qatar e Sudan. Critica severamente il governo israeliano per i suoi progetti di insediamento nella Città Vecchia di Gerusalemme e nei pressi dei luoghi sacri di Hebron. Tra i Paesi che si sono pronunciati a favore del testo, ci sono anche Russia e Cina»
L’Italia si è espressa contro contro la risoluzione sul riconoscimento dei luoghi santi in Israele presentata all’Unesco. Il documento, però, è stato comunque approvato grazie al voto di 22 Paesi. “Ho dato precise istruzioni di voto al rappresentante permanente dell’Italia presso l’Unesco: votare No contro l’ennesima risoluzione politicizzata su Gerusalemme, tra l’altro nel giorno di una importante festa nazionale israeliana”, aveva annunciato il ministro degli Esteri, Angelino Alfano. “La nostra opinione – dice il numero uno della Farnesina – è molto chiara: l’Unesco non può diventare la sede di uno scontro ideologico permanente in cui affrontare questioni per le cui soluzioni sono deputate altre sedi. Coerentemente con quanto dichiarato a ottobre noi, dunque, voteremo contro la risoluzione, sperando che questo segnale molto chiaro venga ben compreso dall’Unesco”.
Il testo della risoluzione, però, è stato adottato a larga maggioranza dall’Unesco. Tra i Paesi che si sono pronunciati a favore del testo, ci sono anche Russia e Cina. Tra le dieci nazioni che si sono opposte, invece, ci sono Stati Uniti, Gran Bretagna, Grecia, Ucraina, Togo, Lituania, Paesi Bassi e Germania, oltre ovviamente all’Italia. Francia, Spagna, India e altri 20 Paesi si sono invece astenuti. La risoluzione era stata presentata da Algeria, Egitto, Libano, Marocco, Oman, Qatar e Sudan. Si intitola “Palestina Occupata” e critica severamente il governo israeliano per i suoi progetti di insediamento nella Città Vecchia di Gerusalemme e nei pressi dei luoghi sacri di Hebron. Chiede inoltre la fine del blocco Israeliano su Gaza senza evocare gli attacchi sferrati da Hamas contro lo Stato ebraico.
“Il tentativo di negare il legame tra Israele e Gerusalemme non cambia il fatto che Gerusalemme è la capitale eterna del popolo ebraico. È una decisione vergognosa“, dice l’ambasciatore israeliano all’Onu, Danny Danon. Prima del voto, il premier israeliano Benyamin Netanyahu aveva duramente criticato il progetto di risoluzione. “Non c’è altro popolo – ha detto – al mondo per il quale Gerusalemme sia così importante e sacra come per gli ebrei, anche se una riunione in programma oggi all’ Unesco cercherà di negare questa verità storica. Denunciamo l’Unesco e ribadiamo quella che è la verità: attraverso la storia ebraica Gerusalemme è stata il cuore della nazione”.
Il 18 ottobre scorso i diplomatici italiani avevano scelto di non prendere posizione sul documento che definisce Israele “potenza occupante” e utilizzava solo la terminologia araba per definire posti simbolici come “il Monte del Tempio“. Una decisione definita come “allucinante” dall’allora presidente del consiglio, Matteo Renzi. E infatti, pochi giorni dopo, l’attuale premier Paolo Gentiloni aveva annunciato che l’Italia era pronta a cambiare la sua posizione sulla risoluzione. “Se ci verranno riproposte anche nel mese di aprile le stesse condizioni: passeremo dal voto di astensione al voto contrario”, aveva detto l’allora ministro degli Esteri. E infatti oggi Alfano ha confermato il pollice verso dell’Italia. CUn annuncio, quello del ministro degli Esteri, che ha raccolto il plauso di Israele. Che però non è bastato per non fare approvare la risoluzione.
la Repubblica, 3 maggio 2017
UNESCO, NO DELL’ITALIA
AL TESTO CONTRO ISRAELE
di Vincenzo Nigra
«Un anno fa Roma aveva scelto l’astensione, ora lo strappo nonostante l’ammorbidimento della risoluzione e il riconoscimento dell’importanza di Gerusalemme per le tre fedi. Netanyahu ringrazia Alfano»
IL COMITATO esecutivo dell’Unesco, l’agenzia culturale dell’Onu, ieri ha votato ancora una volta una risoluzione contro il comportamento di Israele a Gerusalemme e Gaza. Il testo è stato approvato con 22 voti, ma per la prima volta i voti contrari e gli astenuti sono la maggioranza (23 astenuti e 10 no).
Questa volta fra l’altro le pressioni di Israele e Usa hanno fatto saltare un accordo negoziato fra i paesi arabi e gli 11 paesi della Ue che sono membri del Comitato esecutivo. In cambio della garanzia di un voto positivo, gli europei sotto la guida della Germania avevano ottenuto da arabi e palestinesi alcune modifiche al testo. La mozione era diventata quindi meno aggressiva per Israele; per esempio, era stato evitato di citare soltanto con la dizione in arabo i nomi dei luoghi di Gerusalemme. Inoltre era stato inserito un riferimento al fatto che «Gerusalemme è importante per le tre religioni monoteistiche, Giudaismo, Cristianesimo e Islam», riferimento sempre assente nelle versioni precedenti.
La posizione dell’Italia ha però fatto saltare l’accordo dei paesi europei, tanto che alla fine anche Germania, Gran Bretagna e Grecia hanno abbandonato il voto positivo e si sono schierati per il “no” assieme agli Usa. La posizione italiana filo-Israele è figlia dell’ultimo voto su Israele all’Unesco, quello del mese di ottobre, quando in Italia erano scoppiate polemiche anche all’interno del governo. Allora la Farnesina aveva deciso di astenersi come aveva fatto altre volte in passato. Ma il premier Matteo Renzi aveva reagito criticando il ministero degli Esteri e impegnandosi a far cambiare voto nelle prossime occasioni. Allora Renzi aveva definito «allucinante, oltre che incomprensibile e sbagliata» l’astensione italiana: «È il momento di cambiarla».
Nel weekend il primo ministro di Israele Bibi Netanyahu aveva telefonato al ministro degli Esteri Angelino Alfano, mentre l’ambasciatore a Roma Ofer Sachs ha parlato con i consiglieri diplomatici del premier Gentiloni e con alti funzionari della Farnesina. Ieri Netanyahu ha telefonato ad Alfano dopo il voto per ringraziarlo, come rivela lo stesso ministro italiano: «Avevo annunciato al primo ministro la nostra decisione di votare contro la risoluzione, e avevo anche espresso l’auspicio che altri paesi Ue andassero verso la stessa direzione. Netanyahu ha ringraziato l’Italia per questa scelta che rappresenta un esempio per gli altri Paesi, congratulandosi per il ruolo guida dell’Italia».
postilla
Abbiamo già riportato informazioni sulla questione pubblicando l'articolo La cortina fumogena della paura, di Zvi Shuldiner, il 22 ottobre 2016. Lo avevamo pubblicato con una postilla, che riprendiamo integralmente qui di seguito:
«L'Unesco rimprovera il governo israeliano di non consentire gli interventi amministrativi, gestionali manutentori e religiosi nella Moschea di Al Aqsa, il terzo luogo sacro per i musulmani, costruito nell’anno 705. La pretesa di Netanyahu si fonda sul pretesto che sul medesimo sito esisteva, secoli prima, un tempio, sacro agli ebrei , distrutto durante la rivolta contro i romani nell’anno 70. Il lettore che voglia essere un po' più serio di Matteo Renzi legga il testo del documento dell'Unesco, disponibile qui.»
Evidentemente Renzi non l'ha letto, nè alcuno del suo vasto entourage. oppure lo ha letto, ma, poichè il merito delle questioni per lui non conta (a meno che non si tratti di accrescere il suopotere personale, e di garantiursi risorse materiali o morali che lo aumentino, si è m così come ha fatto (tramite l'obbediente Alfano) per far contento il suo feroce oppressore del popolo palestinese ma ben più potente e dovizioso

«». il Fatto Quotidiano online blog Diego Fusaro,
Il caso Alitalia, se non altro, ci dà conferma di quanto già sapevamo e che, non di meno, stenta a farsi comprendere nell’epoca delle magnificate privatizzazioni e del competitivismo sans frontières: il privato è in grado di fare peggio del pubblico. Perfino peggio del pubblico in fase di assedio, di tagli e di continue offensive ad opera della ragione liberista oggi dominante e autoproclamatasi la sola legittima. Le infinite geremiadi contro il pubblico spendaccione e incapace, inefficiente e fallimentare cantate a reti unificate dai troppi soloni del privatismo a tutte le condizioni rivelano qui tutta la loro inconsistenza: ripeto, Alitalia ci mostra che il privato è capace di fare anche peggio. E che, di conseguenza, la privatizzazione senza residui non può essere la soluzione, con buona pace delle omelie dei bocconiani e del vangelo dei sacerdoti del mondialismo come nuova teologia della disuguaglianza sociale planetaria. Non è tutto.
La tragica vicenda legata ad Alitalia ci impartisce anche un’altra lezione, non meno importante della precedente. Siamo entrati, e non da ieri, in una inedita fase di capitalismo comunistico: un capitalismo che selvaggiamente privatizza gli utili e generosamente socializza le perdite. Con l’ovvia conseguenza che a subirne tutte le conseguenze sono, guarda caso, sempre i soliti noti, i subalterni e gli sconfitti della globalizzazione. In primis i lavoratori.
La Fiat è da diversi anni l’emblema di questo capitalismo comunista tutto a beneficio dei signori del competitivismo privatistico. La vecchia domanda leniniana – che fare? – torna più urgente che mai. La soluzione, la sola soluzione praticabile, che ovviamente sarà demonizzata dagli oligarchi del privatismo e dalla casta dei loro prezzolati oratores accademici, giornalistici e televisivi, è la seguente: nazionalizzazione della ditta. Riappropriazione sociale di ciò che apparteneva alla nazione italiana e che, affidato alle magnifiche cure del privato, è precipitato al suolo. Tutto il resto è chiacchiera politicamente corretta.
 Analisi territoriale e sociale del voto. Per comprendere meglio ciò che sta accadendo in Europa, e che potrebbe accadere in casa nostra. Articoli di Anais Ginori e Guido Caldiron,
Analisi territoriale e sociale del voto. Per comprendere meglio ciò che sta accadendo in Europa, e che potrebbe accadere in casa nostra. Articoli di Anais Ginori e Guido Caldiron,
La Repubblicail manifesto, 25 aprile 2017
l
a Repubblica
LE MAPPE
di Anais Ginori
«Il Fn vince lontano dai centri urbani e tra le fasce più povere. Laureati e dirigenti scelgono il leader di” En Marche”. Città contro campagna nel Paese del “voto di classe” Le Pen conquista i delusi»
Se Marine Le Pen si fosse presentata solo nella capitale non avrebbe superato neppure la soglia di sbarramento per ottenere i rimborsi elettorali fissata al 5%. In alcuni quartieri, come il Marais e Pigalle, la leader del Front National supera appena il 3%, mentre Macron ha conquistato un parigino su tre (34,8%). Se invece la Francia fosse in miniatura quella di Brachay, comune di una sessantina di abitanti nella Marna, lontano da tutto, Le Pen sarebbe già all’Eliseo: ha ottenuto più dell’83%.
La mappa del primo turno delle presidenziali conferma un paesaggio politico destrutturato, con una netta divisione tra le grandi città e quella che il geografo Christophe Guilluy ha chiamato in un saggio la “Francia periferica”. Il divario tra voto nei centri urbani e nelle zone rurali non è mai stato così chiaro. Se a Lione il Fn prende solo l’8,86%, nella regione intera del Rhone sale fino al 16,26%. Lo stesso scarto si verifica tra Bordeaux (7,39%) e la Gironda (18,2%), Lille (13,8%) e la sua provincia (28,2%). «Il voto per il Front National si rafforza via via che aumenta la distanza da un centro urbano», spiega Guilluy. Le 588 città con più di 15mila abitanti, un terzo dell’elettorato, hanno una percentuale Fn inferiore al dato nazionale. Domenica sera lo spoglio in diretta del ministero dell’Interno metteva Le Pen in testa rispetto a Macron finché non sono arrivate le schede delle metropoli che hanno ribaltato il rapporto di forza. L’altra spaccatura che emerge dalla cartografia del voto è quella che taglia in due la Francia da nord a sud, ovvero tra la metà orientale, quasi tutta per il Front National, e quella occidentale, dominata dal voto per Emmanuel Macron. «È una divisione antica tra Francia atlantica, aperta, benestante, moderata, e un’altra continentale, più chiusa, in crisi, reazionaria», spiega il geografo Jacques Levy. Il nord-est si conferma un monocolore Le Pen. Nelle zona tra Piccardia e Nord-Pas-de-Calais, al confine con il Belgio, il Fn supera anche il 30% dei voti. La supremazia dell’estrema destra nelle zone più colpite dalla deindustrializzazione è ormai assodata, ad eccezione della regione parigina.
La fascia orientale, verso la frontiera con la Germania, registra sempre una prevalenza del Fn, con il 27,78% dei voti. Si conferma anche la forza del partito di Le Pen verso il sud-est e il Mediterraneo, fino al confine con l’Italia: nella regione Paca (Provence- Alpes-Cotes d’Azur) dove ottiene il 28,17%. La leader Fn segna anche un risultato storico in Corsica, arrivando al primo posto con il 27,88%, superando per la prima volta la destra.
La Francia del centro e quella affacciata sulla costa Atlantica ha scelto invece Macron. Il leader di En Marche ha ottenuto il 25,1% in Aquitania, il 26% nella regione della Loira e fino al 29% nella Bretagna. Macron è arrivato al primo posto in 7.175 comuni, di cui più della metà avevano votato il socialista François Hollande nel 2012. Ma il candidato centrista è riuscito anche a conquistare 2.353 città che nella precedente presidenziale avevano dato la preferenza all’ex leader della destra Nicolas Sarkozy. Macron registra il suo miglior risultato a Bigorno, comune di 85 elettori in Corsica, dove ottiene il 77,1%. Tra i francesi residenti all’estero ha ottenuto quasi metà dei voti (40,4%) rispetto al 6,4% di Le Pen.
«L’analisi sociologica conferma un voto di classe», spiega Frédéric Dabi, direttore dell’istituto Ifop. Le Pen è la candidata degli operai, degli impiegati, ma anche dei disoccupati (oltre un terzo ha votato per lei), mentre Macron ha i suoi punti di forza nei quadri dirigenti e nei professionisti (uno su tre hanno votato per lui). I due candidati al ballottaggio ottengono la stessa percentuale (32%) nelle due fasce estreme di reddito: Le Pen tra chi guadagna meno di 1.250 euro mensili, Macron tra chi ne guadagna più di 3mila. «Macron è il candidato dei laureati mentre Le Pen quella dei diplomati», conclude Dabi. Gli istituti di sondaggi avevano in parte già analizzato queste distinzioni e hanno preso domenica sera una piccola rivincita: contrariamente a quanto accaduto con Brexit ed elezioni americane, le loro previsioni sul voto si sono rivelate giuste.
il manifesto LE NUOVE GEOMETRIE
DELL’ESAGONO FRONTISTA
di Guido Caldiron
«Per Marine Le Pen un risultato comunque storico. Oltre sette milioni e mezzo le preferenze totalizzate al primo turno. Gli studiosi francesi dell'estrema destra analizzano il voto al Front national»
Un paese spaccato, diviso pressoché a metà lungo linee che disegnano per molti versi una nuova geografia politica e sociale. Per quanto inferiore alle attese, nel corso degli ultimi mesi i sondaggi l’avevano data in testa e con percentuali che sfioravano il 30% dei consensi, l’affermazione della leader del Front National, Marine Le Pen, sembra trarre prima di tutto alimento dalle nuove linee di demarcazione che stanno emergendo in seno alla società francese.
Gli oltre 7 milioni e mezzo di consensi raccolti dalla candidata dell’estrema destra, in ogni caso un record mai raggiunto prima nella storia più che trentennale del Fn, appaiono come il frutto più velenoso e inquietante della fratture che percorrono l’Esagono. E che anche nel caso della probabile vittoria di Emmanuel Macron al secondo turno delle presidenziali, continueranno a rappresentare una sfida di non poco conto in particolare per la sinistra politica e sociale.
Tra le analisi proposte nel dopo voto dagli studiosi dell’estrema destra, spicca perciò quella avanzata dal demografo Hervé Le Bras, decano della storia sociale transalpina che da tempo, il suo Le pari du Fn (Autrement) è uscito già nel 2015, invita a considerare gli exploit elettorali del Front National nell’ambito della geografia sociale del paese che ha visto emergere nuove forme di povertà e di emarginazione, non solo di natura economica. Se il primo turno della corsa all’Eliseo fotografa come circa il 30% dei disoccupati e degli operai abbia scelto Le Pen, contro una percentuale simile di appartenenti al ceto medio e alle professioni liberali che si sono invece orientati verso Macron, Le Bras sovrappone una serie di “carte” relative alla composizione sociale delle differenti regioni, all’analisi del voto. Facendo così emergere l’aspetto meno evidente, ma non per questo meno preoccupate, dei risultati.
Così, la lnea orizzontale che divide in due la Francia politica, separando nettamente le regioni dell’Ovest, che hanno votato in maggioranza per Macron, da quelle dell’Est, andate a Le Pen, corrisponde secondo lo studioso a quella che separa le zone di più forte insediamento delle classi media e alta, rispetto a aree popolari che sono poi quelle più colpite dalla deindustrializzazione e dalla paura del declassamento.
Allo stesso modo, anche il voto delle grandi città in favore dell’ex ministro dell’Economia di Hollande, con la sola significativa eccezione di Marsiglia e dei centri del Sud-Est, si spiega con il fatto che è qui che risiede prevalentemente il ceto medio e intellettuale. All’inverso, l’analisi proposta da Le Bras indica come i consensi al Fn vengano soprattutto «dai piccoli centri dove molto spesso si sono trasferite nel corso del tempo le famiglie operaie cacciate dalle metropoli dall’aumento degli affitti e del costo della vita o da quelle aree rurali i cui abitanti si sentono esclusi e dimenticati dalle scelte della politica».
Malgrado questa strategia di conquista nei territori perduti della gauche inaugurata da Marine Le Pen da alcuni anni non abbia portato ancora tutti i frutti sperati, la presidente del Fn, come nota lo storico dell’università di Monpellier, Nicolas Lebourg, che ha firnato Les extrêmes droites en Europe (Seuil, 2015), «non poteva sperare in un avversario migliore di Macron». Questo perché malgrado l’ex esponente del Ps sia quello che secondo tutti i sondaggi aveva fin dall’inizio più possibilità di battere Le Pen, è altrettanto chiaramente «colui che incarna al meglio la figura del nemico nell’ambito del progetto frontista di riconfigurazione della democrazia francese, non più secondo la dicotomia destra-sinistra, ma tra coloro che difendono l’identità nazionale (i sovranisti) e coloro che cercherebbero di distruggerla (i mondialisti)». Per questo Le Pen «martella sul fatto che Macron è un simbolo della “globalizzazione selvaggia” contro cui il Fn si presenta come l’unica difesa dei francesi e la sola alternativa politica».
Quanto alle prospettive che si aprono per il secondo turno, gran parte degli specialisti dell’estrema destra concordano sul fatto che difficilmente Marine Le Pen sarà in grado di raccogliere un numero sufficiente di consensi da poter raggiungere il 51%.
Ciononostante, il politologo Joël Gombin, autore di Le Front National (Eyrolles, 2016) e membro dell’Observatoire des radicalités politiques della Fondazione Jean-Jaurès, ricorda come «in occasione delle ultime elezioni regionali, quelle del 2015, un terzo degli elettori del centrodestra si è alla fine portato sul Fn» e che «domenica Macron e Le Pen messi insieme non hanno raggiunto neanche la metà dei consensi espressi, lasciando così aperto, malgrado le dichiarazioni in favore del candidato di En marche! pronunciate dai maggiori leader politici, almeno in linea di principio, lo scenario per il secondo turno. Una situazione decisamente inedita».

il manifesto
, 22 aprile 2017 (c.m.c.)
Non erano passate nemmeno 12 ore dall’attacco di un terrorista per fortuna isolato sugli Champs Elysées nel cuore di Parigi, subito rivendicato dall’Isis, che Marine Le Pen è volata con ferocia inusitata, come un avvoltoio, sulla bara del povero poliziotto rimasto ucciso. Anche il candidato della destra storica, il conservatore Franois Fillon, ha fatto altrettanto quasi a volere contendere la preda in palio: la paura di una popolazione che sta per eleggere il capo di una repubblica presidenziale. Ma Marine Le Pen è stata particolarmente «programmatica», parlando come fosse già il presidente
in pectore della Francia.
Modulando volta a volta richieste repressive e ideologiche, tali da delineare una trasformazione dell’assetto istituzionale francese. Stato di guerra, espulsione degli inquisiti con la sigla “S”, chiusura delle frontiere e, rinunciando «all’ingenuità, all’innocenza, al lassismo», chiusura delle «moschee islamiste» il cui finanziamento «non potrà essere in alcun caso pubblico o di provenienza straniera», niente diritto di cittadinanza all’ideologia islamista.
Sapientemente quanto irresponsabilmente mischiando terrorismo e migranti. Come se fossero la stessa cosa. Per una «guerra che non possiamo perdere», ha concluso Marine Le Pen, sguazzando naturalmente dentro i macroscopici buchi dei Servizi segreti francesi, dopo Charlie Hebdo, Bataclan e Nizza.
Che hanno dovuto, per dichiarazione del ministero degli interni, subito ammettere che l’attentatore era conosciuto, anzi su di lui era stata addirittura aperta una inchiesta.
Il giorno prima degli attacchi Marine Le Pen aveva promesso che con lei presidente sarebbe stato estirpato l’integralismo islamico dalle periferie. È così diventato immediatamente palpabile quello che da tempo si avvertiva e che solo fino a pochi giorni prima era difficile descrivere: che l’Isis vota decisamente a destra, preferibilmente Front nazional che alligna le sue dinamiche xenofobe, razziste e iper-nazionaliste proprio sulla paura e sul clima di guerra, anche interna.
Del resto il presidente statunitense Donald Trump non è stato da meno avvisando, subito dopo l’attentato, che «il popolo francese non sopporterà più a lungo cose del genere. Avrà grosse conseguenze sulle elezioni presidenziali!». Lui sì che se ne intende.
A dire il vero i primi sondaggi a poche ora dal voto del primo turno delle presidenziali, dicono una cosa diversa. Che emergerebbe il modernista di centro Emmanuel Macron, distaccando tutti gli altri candidati più accreditati. Dalla stessa Marine Le Pen, al liberal-conservatore di destra François Fillon, fino al sorprendente Jean-Luc Mélenchon che ha fin qui raccolto il difficile consenso a sinistra meglio è più del candidato socialista Benoît Hamon che pure ha portato importanti novità.
Ma se la prospettiva del risultato francese è Emmanuel Macron, quanto alimento darà questa vittoria – lungimirante per tutti gli schieramenti di centro d’Europa – ad un nuovo populismo, stavolta ancora più radicale?
Un fatto è certo. La precisione «occasionale» del terrorismo jihadista è diventata endemica. Sconquassa la società civile, contrapponendola al proprio interno. E poi ormai accade e colpisce nei momenti cruciali della verifica politica. Come dimenticare che da qui all’estate gli appuntamenti elettorali rilevanti sono almeno altri due, in Germania e ancora una volta nella Gran Bretagna appena dopo la nazional-populista Brexit?
Sullo sfondo dell’endemicità degli attacchi jihadisti qui nell’Occidente europeo e non solo, resta la scena della guerra vera e solo apparentemente lontana. Dove il jihadismo terrorista (qaedisti e Isis, volta a voltab utili per le nostre stesse operazioni belliche geostrategiche) semina stragi tra gli stessi musulmani, dentro realtà ex statuali come Iraq, Siria e Libia che le nostre guerre hanno contribuito a distruggere. In una terra desolata, disseminata dalla disperazione di milioni di esseri umani che dalla guerra fuggono e al contrario da una scia di sangue di tanti foreign fighters già usciti in libertà dall’Europa e ora di ritorno. Il Medio Oriente che non c’è più, dove il sedicente «Califfo» potrà perdere Raqqa e Mosul, ma ha ormai lanciato il seme nefasto dello «Stato islamico» per riempire il deserto storico degli Stati che abbiamo devastato.
 «Il Consiglio dei ministri riduce i poteri di intervento dell'Anac, poi di fronte alle polemiche, soprattutto dei renziani, torna indietro. Gentiloni costretto da Washington a cercare al telefono il presidente dell'Anticorruzione: rimedieremo subito». il
«Il Consiglio dei ministri riduce i poteri di intervento dell'Anac, poi di fronte alle polemiche, soprattutto dei renziani, torna indietro. Gentiloni costretto da Washington a cercare al telefono il presidente dell'Anticorruzione: rimedieremo subito». il
manifesto, 21 aprile 2017
Un’ora di colloquio ieri tra Raffaele Cantone, presidente dell’Autorità nazionale Anticorruzione, e l’ad Consip Luigi Marroni. L’Anac indaga sull’appalto da 2,7 miliardi finito nelle inchieste delle procure di Napoli e Roma, che hanno coinvolto il padre di Matteo Renzi, Luca Lotti e il cerchio magico renziano. Ma dall’ultimo Consiglio dei ministri l’Anac è uscito con le armi spuntate. Nella nuova versione del codice degli appalti, approvata in Cdm il 13 aprile, è previsto che «All’articolo 211 del decreto legislativo del 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni: il comma 2 è abrogato». Il comma 2 consentiva all’Anac di intervenire in caso di gravi irregolarità con sanzioni e tempi certi, più brevi di quelli della giustizia ordinaria. L’intervento dell’esecutivo scavalca il parlamento, sollevando polemiche e dubbi sulla legittimità dell’atto.
L’iniziativa era del tutto inattesa dall’Anticorruzione. Un caso Anac è un brutto scivolone per il governo, con Renzi che sembra di nuovo aver fretta di votare così. Nel tardo pomeriggio di ieri è arrivata la marcia indietro: «Nessuna volontà politica di ridimensionare i poteri dell’Anac – sottolineano fonti di palazzo Chigi. Il presidente Gentiloni, in missione a Washington, è stato in contatto con Cantone. Sarà posto rimedio già in sede di conversione». I primi a prendere le distanze erano stati i relatori Pd in commissione lavori pubblici del senato, i renziani Esposito e Mariani: «È un atto grave e i responsabili devono assumersene la responsabilità». Esposito aveva poi aggiunto: «Ho sentito Gentiloni e mi ha assicurato che verrà tutto ripristinato con la manovrina». La legge delega sul codice degli appalti approvata un anno fa era il frutto della stagione dei grandi scandali Expo e Mafia capitale. Ieri pomeriggio un lancio di agenzia sottolineava che i poteri soppressi in Cdm non sono finora mai stati attivati dall’Anticorruzione. Ma le indagini Consip, che dall’imprenditore Alfredo Romeo si stanno allargando ai competitor Cofely e la coop rossa Manutencoop, avrebbero potuto sollecitare interventi urgenti.
Partono all’attacco i 5 Stelle, che all’Anac hanno presentato un esposto sul salvataggio dell’Unità: «Un partito coinvolto in Trivellopoli e Mafia Capitale – commenta Luigi Di Maio – non potrà mai fare regole anticorruzione certe». E Roberta Lombardi: «Il Cdm o non ha capito nulla o è complice. Chi ha scritto quella riga è sconosciuto al momento, in l’Italia non si sa neanche chi scrive o riscrive le leggi». Il ministro della giustizia e candidato a segretario Pd, Andrea Orlando, aveva sollecitato un’ulteriore riflessione. «Se prima delle primarie ci fa sapere di quale governo è ministro e in quale Cdm siede possiamo capire cosa pensa», lo attacca il renziano Ernesto Carbone.
Chi ha cancellato la norma mettendo in imbarazzo il governo? Nel preconsiglio dei ministri la norma c’era, poi nell’ultima riunione è stata abrogata sulla base di un parere del Consiglio di Stato: fonti ministeriali ricostruiscono così la decisione, presa per evitare di assegnare «eccessivi poteri» all’Anac cioè il potere di sanzionare imprese o sospendere atti senza passare dal giudice. I renziani non vogliono passare per i mandanti e contrattaccano: «Il Consiglio di Stato è impegnato a smantellare le riforme del governo Renzi». In serata arriva il commento dall’Anac: «Il potere della “raccomandazione vincolante” che è stato soppresso è un elemento qualificante del nuovo Codice per il suo effetto di deterrenza nei contratti pubblici». Filtra, inoltre, perplessità per il fatto che la norma non sia stata discussa né ci sia stato un confronto in sede parlamentare, considerato che con le commissioni e i relatori c’era stata «una proficua collaborazione» durante l’iter del provvedimento.

«LA NATO CAMBI O NON CI RESTEREMO»
POLITICA ESTERA, I PIANI DEI 5 STELLE
«Né filo Trump, néfilo Putin. Al governo ci ritireremo dall’Afghanistan»
Fuori dalla Nato«se non cambia». E «via subito» dall’Afghanistan. Ancora non è il «programma dipolitica estera» dei 5 Stelle. Sia perché «manca ancora molto tempo alleelezioni» e quindi «dobbiamo necessariamente restare fluidi». Sia perché idieci punti votati dai 23.481 iscritti sono un elenco di argomenti spessogenerici. Ma a sentirli in conferenza stampa i parlamentari dei 5 Stelle hannoidee piuttosto chiare e decisamente in controtendenza rispetto alla politicaestera italiana degli ultimi anni.
La sovranità
Qualcuno mette indubbio il realismo politico dei 5 Stelle, ma Di Battista richiama tuttiall’ordine: «Vi invito a prenderci sul serio. Non siamo una meteora e non siamopopulisti. Il nostro programma non è utopia, come ad alcuni sembra solo perchési parla di pace e di dialogo. Voi non ci prendete sul serio, ma ambasciatori eministri degli Esteri sì: da loro stanno arrivando decine di richieste diincontri».
A chi li haaccusati di essere filo Trump, all’inizio, e poi filo Putin, Di Battistarisponde così: «Non siamo né filo Trump né filo Putin, ma è fondamentale averebuoni rapporti con entrambi. Ci avete dato dei filotrumpisti solo perchéabbiamo detto che andava rispettato l’esito del voto. Non siamo filorussi soloperché sosteniamo la necessità di un dialogo con Putin, soprattutto in chiaveantiterrorismo».
I 5 Stellerivendicano la «sovranità» come concetto chiave: sovranità politica, deiconfini, dell’economia, delle risorse energetiche. Lo slogan è: «Un’Italialibera e sovrana, amica di tutti i popoli». Facile a dirsi, ma venti di guerraspirano ovunque. E le istituzioni internazionali scricchiolano. Di Stefanoaveva scritto un post di fuoco contro la Nato. Ora è più cauto, ma non troppo:«Se la Nato cambierà, resteremo, altrimenti dovremo riflettere se continuare afarne parte oppure no». Lo stesso discorso che vale per l’Europa. Non amanodefinirsi euroscettici e a chi dice che vogliono la dissoluzione dell’Europa,ribaltano il discorso: «L’Europa si sta smantellando da sola. E nessun leaderha preso posizione sulla più grande bomba sganciata dopo Hiroshima».
L’euro
Gli iscritti nonhanno votato l’uscita dall’euro (o il referendum per deciderlo), ma una «monetafiscale», proposta dall’economista Gennaro Zedda. Di Stefano rimedia così: «Iltema dell’euro sarà affrontato nel capitolo economico. Del resto le domandesono elaborate sulla base di posizioni di esperti indipendenti e quindi nonsono nostre». Che gli iscritti abbiano votato su quelle è un dettaglio:«Dobbiamo stare fluidi e poi le nostre posizioni le abbiamo espressechiaramente in Parlamento».
Altra cosa su cuinon si è votato è il ritiro dall’Afghanistan. Ma su questo si è già deciso: «Sesaremo forza di governo — dice Di Battista — ritireremo le nostre truppe da unaguerra ignobile e ingiusta e che non è stata neanche vinta». Capitolo dirittiumani: c’è «troppa ipocrisia» e le violazioni si contestano meno se sono digoverni amici dell’Occidente, «come per l’Arabia Saudita, che sta bombardandonell’indifferenza lo Yemen». Infine la questione migranti. Gli uomini in mare,certo, devono essere salvati, «ma l’immigrazione è un business per molti, comeper i centristi».
UN’ITALIANEUTRALISTA
CON UN OCCHIO AL VATICANO
di Massimo Franco
Né con gli StatiUniti né con la Russia. Neanche con una Nato associata agli equilibri delpassato. E nemmeno con l’Europa della moneta unica. Elencare i punti dellapolitica estera del Movimento Cinque Stelle, illustrati ieri in Parlamento,significa affrontare una serie di incognite. Tutt’altro che remote: di qui a unanno potrebbero diventare il programma dell’Italia, se la formazione di BeppeGrillo avrà i numeri per chiedere la guida del governo.
L’aspetto che colpisce,nell’elenco stilato da Manlio Di Stefano e da Alessandro Di Battista, è unastrategia declinata soprattutto in negativo. L’obiettivo immediato è quello diuna disdetta dei trattati e delle alleanze internazionali, oggi in affanno; ela loro sostituzione con una nebulosa strategica che di fatto, però,candiderebbe il nostro Paese al ruolo di «nuova Grecia» al cospetto delleistituzioni di Bruxelles e della Bce.
Il troncone più consistente di quelli chevengono definiti populisti si vede come «buon interlocutore degli Usa e dellaRussia». Chiede un recupero di sovranità contro i «dettami di entitàsovranazionali». E ritiene che occuparsi di «permanenza o di alternativaall’eurozona» sia da «forza politica responsabile». Idem la decisione di fareuscire unilateralmente le truppe italiane dall’Afghanistan; e di valutare sesia il caso di rimanere o no nell’Alleanza atlantica. «Non siamo populisti,crediamo nell’autodeterminazione dei popoli, nella pace e nel disarmo», spiegaDi Battista. «All’estero ci prendono sul serio e abbiamo moltissime richiestedi incontri da ambasciatori e da ministri».
L’accusa di essere «filotrumpisti»viene respinta. Idem l’altra, di essere «filorussi solo perché sosteniamo undialogo con Putin in chiave antiterrorismo». Ma è l’antieuropeismo a seminarediffidenze. Il programma dei seguaci di Grillo ignora le obiezionicostituzionali e finanziarie legate a un tentativo di uscita dalla monetaunica: inflazione galoppante, paralisi del sistema bancario, isolamento inEuropa. Prevale l’idea di un Paese ripiegato su se stesso eppure, secondo ilMovimento Cinque Stelle, in grado di riscrivere le regole della politicainternazionale.
Il metodo col quale la strategia è stata lanciata è il solito: affidareagli iscritti la decisione online sulle priorità di politica estera. Lo schemaricalca sul piano internazionale quello usato in Italia: le vecchie ricette nonvanno, bisogna rifarle. L’offensiva non va sottovalutata.
Anche perchénell’escludere alleanze precostituite, i Cinque Stelle ritengono di avere uninterlocutore: il Vaticano di Francesco, che con la Russia di Vladimir Putinnon ha interrotto il dialogo; e che ha di fronte un’America distante dallastrategia della Santa Sede. «Siamo sull’orlo della Terza guerra mondiale apezzetti di cui parla il Papa? Sì», secondo Di Battista. In parallelo ilvicepresidente della Camera, Luigi Di Maio, del M5S, cita la Cei per attaccarei negozi aperti durante le feste. E il quotidiano Avvenire mette le sue parolein prima pagina.
 Piccoli centri e campagne paiono risultare più fragili e indifesi delle città di fronte al vento di Vandea che soffia in tutto il mondo.
Piccoli centri e campagne paiono risultare più fragili e indifesi delle città di fronte al vento di Vandea che soffia in tutto il mondo.
la Repubblica, 18 aprile 2017 (c.m.c.)
Come per la Brexit. Come per l’elezione di Trump. Come potrebbe succedere tra pochi giorni in Francia se vincesse Marine Le Pen. Erdogan ha vinto grazie al voto delle “campagne”, della periferia. Era temuto, atteso, scontato. È la ricorrente vendetta dei “dimenticati”, dai tempi della Vandea francese all’ascesa di Hitler nelle piccole città prima che a Berlino.
Ma la grande novità è che questo vento di Vandea che soffia in tutto il mondo ha avuto una battuta di arresto. È stato frenato dalle città. Erdogan è stato a sorpresa tradito dalla “sua” Istanbul, da Smirne, persino da Ankara. Le tre città più popolose e dinamiche, che gli devono lavori pubblici e prosperità, gli hanno detto no. Tanto che la sua vittoria al referendum sembra quasi una sconfitta.
Una vittoria sul filo dell’uno per cento o giù di lì è già qualcosa di arrischiato e discutibile in una democrazia normale e consolidata. Che un margine così ridotto porti ad uscire o meno dall’Unione europea suscita perplessità. E ancora più il fatto che possa diventare presidente degli Stati Uniti un candidato che ha avuto 3 milioni e mezzo meno (sì in meno, non in più) della sua concorrente. Dipende dalle regole. Se le regole non vanno si possono cambiare, e comunque mai a partita in corso. A nessuno passerebbe per la mente di contestare il referendum britannico o le presidenziali Usa. Al contrario, un margine così ridotto diventa un problema in una democrazia così e così, in un Paese come la Turchia dove fino al 1945 si votava per un solo partito, e dove per decenni si sono periodicamente alternati elezioni più o meno libere e colpi di Stato militari.
E questo indipendentemente dai sospetti e dalle accuse di brogli. Le schede immediatamente e ufficialmente contestate sono un numero pari a quelle che avrebbero potuto decidere in senso esattamente opposto la consultazione. Quelle “irregolari”, perché prive del timbro di convalida, sarebbero addirittura un terzo del totale. E quanto alla segretezza lasciava a desiderare. Siamo impressionati dagli arresti, dai licenziamenti degli oppositori. Si sa molto meno di quanto siano diventati sistematici il controllo, la sorveglianza e la delazione di massa.
Già parecchio prima del fallito golpe del luglio scorso Erdogan aveva ufficialmente invitato i sindaci dei centri minori ad istituire la sorveglianza capillare dei concittadini, su quel che fanno ma anche su quel che dicono e pensano. Bastano una battuta o un “mi piace” azzardato a una vignetta o un giudizio su Facebook per essere convocati al commissariato a spiegare l’ “insulto” al Presidente, il vilipendio della nazione turca, oppure il sostegno al “terrorismo”. Figuriamoci le conseguenze che si possono temere, specie in un piccolo centro di provincia, se si viene additati come malvotanti.
Il referendum di domenica avrebbe dovuto confermare il cumulo di tutti i poteri nelle mani del presidente della Repubblica, cioè di Erdogan: fondere presidenza e governo, consentirgli di nominare i giudici, renderlo immune a qualsiasi persecuzione giudiziaria, qualsiasi forma di impeachment o rimozione, e soprattutto togliere ogni limite alla durata del mandato. Erdogan ci teneva. È stata la sua ossessione da almeno un decennio a questa parte, forse addirittura sin da quando nel 2002 da sindaco di Istanbul era stato eletto capo del governo, certo da quando, scaduti i mandati, nel 2014 aveva dovuto accontentarsi di fare il Presidente della Repubblica, carica allora alquanto simbolica.
Era stato fermato una prima volta nel 2014, quando le urne gli avevano negato la maggioranza parlamentare. Ci aveva riprovato l’anno dopo, nel 2015, recuperando, grazie al voto nelle “campagne” una maggioranza sufficiente a formare il governo, ma non quella necessaria a far passare modifiche costituzionali. Aveva bisogno di una maggioranza di 2/3 per cambiare direttamente la Costituzione, di una maggioranza di almeno 2/5 per poter fare un referendum sulla Costituzione. Non era riuscito ad ottenere alle urne né l’una né l’altra. Per riuscire ad indire almeno il referendum ha dovuto liberarsi dei deputati curdi, togliendogli l’immunità parlamentare e mandandone decine a processo come sostenitori del “terrorismo” curdo.
Pensava a questo punto che la strada fosse spianata. Prevedeva un margine di 60 per cento o oltre. Si deve accontentare di un vantaggio in pochi decimali. Dal suo punto di vista è una sconfitta. Tanto che ha dovuto affrettarsi a dichiarare, contrariamente al suo stile, che il risultato «è una vittoria per tutti, sia quelli che hanno votato sì sia quelli che hanno votato no». In teoria, con le modifiche costituzionali a cui il referendum dà ora il via libera, Erdogan potrebbe restare ininterrottamente al potere fino al 2029. Si tratta di un problema che si era posto ad altri leader di democrazie “per modo di dire”, che ad un certo punto si erano dati regole simili a quella di democrazie consolidate come gli Stati Uniti, dove vige il limite di due mandati. Putin l’aveva risolto, come è noto, inventando l’alternanza tra presidenza e capo del governo, che ha dato vita alla staffetta con Medvedev.
La cosa che impressiona è che persino in Cina ora Xi Jingping muoia dalla voglia di estendere i suoi mandati oltre quelli regolamentari al punto di voler cambiare le regole al prossimo Congresso del Pcc. I suoi due predecessori non avevano osato e si erano lasciati regolarmente sostituire alla scadenza. Mao non ne aveva bisogno. Era presidente a vita. Deng non aveva incarichi di Stato ufficiali: gli bastava e avanzava essere il presidente della Commissione militare del partito, cioè il capo delle Forze armate. In Cina peraltro non hanno mai avuto problemi di elezioni o referendum: semplicemente da quando le loro campagne avevano preso le città, «con la canna del fucile» come soleva dire il vecchio Mao, non si vota più, e se si votasse probabilmente i risultati sarebbero plebiscitari a favore di chi è già al potere.
 «Al PAC di Milano
«Al PAC di Milano
Mea culpa dello spagnolo Santiago Sierra. Dai primi lavori di scultura alle opere land fino ai video, i temi sono gravi, il tono tragico ma asciutto. Interessante è l’ambiguità del rapporto con i disvalori del neoliberismo». il manifesto, 16 aprile 2017 (c.m.c.)
Nell’ultimo mezzo secolo l’arte ha enormemente sviluppato la sua propensione a immergersi nella realtà sociale e a riflettere sulla dimensione politica che la caratterizza nei suoi aspetti paradigmatici (trauma, abiezione, precarietà, ecc.). Lo scarto tra un’operazione artistica e una prettamente cosmetica, di design, sta proprio in questa attitudine, che in buona misura deriva dalle metamorfosi della produzione nell’era del capitalismo post-industriale.
L’arte si adegua ai mutati assetti adottando nuovi parametri estetici e l’opera, diventata contingente, relazionale, effimera e immateriale, rispecchia i cambiamenti nel mercato del lavoro. Un fenomeno tutto sommato ovvio. Ma l’incontro tra arte e politica è sempre controverso perché innesca una reciproca contaminazione: l’estetizzazione del politico rischia di offuscare gli obiettivi della lotta e quindi ridurre ogni genuina azione politica a uno spettacolo, inefficace rispetto all’ipotesi di un vero cambiamento delle cose.
D’altro canto, la politicizzazione dell’artistico può spingere l’artista negli ingranaggi di un dispositivo ideologico per cui anche l’opera di denuncia più radicale finisce per essere strumento di legittimazione del potere. C’è un’ambiguità di fondo in ogni discorso artistico sulle storture del mondo contemporaneo dovuta ai presupposti del discorso stesso; artisti e critici devono confrontarsi con la sfida di legittimare la pratica artistica dentro e contro la logica capitalista che la sostiene.
E proprio «sul terreno impervio della critica alle condizioni sociopolitiche della contemporaneità» si muove Santiago Sierra (1966), anarchico e libertario, del quale il Padiglione d’Arte Contemporanea di Milano ospita, fino al 4 giugno, Mea culpa, rassegna antologica a cura di Diego Sileo e Lutz Henke (catalogo Silvana Editoriale).
La mostra riunisce materiali dai primi anni novanta a oggi, tra cui Riga di 250 cm tatuata su sei persone retribuite (1999), Parola distrutta (2010-’12), Sepoltura di dieci operai (2010), Il graffito più grande del mondo (2012), Denti degli ultimi gitani di Ponticelli (2009), Bandiera nera (2015). In effetti si tratta perlopiù di documentazione (audiovisiva, fotografica o letteraria) di installazioni site specific e performance; ma oggi lo statuto dell’opera include la forma archivistica e consente di trasferire il valore artistico dall’azione o dall’oggetto alla loro traccia. L’allestimento è ben ritmato, elegante nella sua compiaciuta fissazione per il bianco-nero; non segue un ordine cronologico e non se ne sente l’esigenza: dalla severità dei primi lavori di scultura, alle vastità delle opere land fino ai video, i temi delle opere sono gravi, il tono è tragico seppure asciutto, minimalista.
Comunque, al di là dei connotati tecnici e concettuali, Sierra è interessante per gli interrogativi legati all’efficacia politica del suo lavoro e alla sua posizione rispetto a ciò che dichiaratamente avversa. In questo senso, è un artista emblematico dei limiti della pratica artistica odierna. Un’opera di Sierra è allo stesso tempo una violenta accusa al sistema neoliberista e una merce con un plusvalore ratificato da prestigiose istituzioni culturali e monetizzato da ricche gallerie internazionali. Soprattutto, la condanna all’alienazione e allo sfruttamento del lavoro viene spesso espressa riproducendo nel rapporto con gli occasionali performer le medesime condizioni di sfruttamento.
Non per nulla, fin dal titolo l’esposizione pone la questione della responsabilità, a cominciare da quella di chi intenda affrontare certi temi. Mettendo in scena le iniquità socio-economiche direttamente dentro lo spazio della galleria, Sierra coinvolge l’istituzione come parte attiva in un meccanismo di cui, oltre all’artista stesso, beneficiano gli spettatori, che così alimentano indirettamente il processo. La mostra è stata anche l’occasione per produrre un nuovo lavoro, organizzando una performance da documentare e quindi rielaborare in vari medium e formati in vista di future esposizioni.
La cronaca: il giorno stesso del vernissage vengono distribuiti nel centro di Milano dei coupon che promettono «alle prime 1.000 persone che parteciperanno a un progetto artistico» un compenso di 10 euro pagabili al portatore la sera stessa presso il PAC. Una lunga fila si forma davanti ai cancelli già qualche ora prima dell’apertura. Dopo un attimo di concitazione iniziale, le persone accedono al cortile del museo e si dispongono ordinatamente in riga. Nel frattempo entra anche chi è venuto soltanto per la mostra. Ha inizio la distribuzione del denaro e i detentori di coupon si avvicinano uno alla volta a un banco, dietro cui sta il conservatore del PAC che consegna loro la banconota. L’evento si svolge senza complicazioni, in sé banale e noioso come una processione di passeggeri per il check-in all’aeroporto. Ma quando le cose sono già a buon punto compare un furgone del reparto mobile della polizia, forse male informata su quanto stava accadendo.Il rapido ma inascoltato intervento di uno dei curatori (Henke) e l’intempestiva azione dei responsabili del PAC non risparmia noie gratuite a chi di problemi ne ha già tanti e i «partecipanti al progetto artistico», tra cui molti immigrati di colore, vengono trattati come molesti intrusi a una festa privata. L’incresciosa situazione si risolve solo quando gli agenti si rendono conto dell’inesistenza di reali minacce. In casi come questi, Sierra respinge le critiche affermando di limitarsi a rendere visibili le condizioni attuali. Sfruttamento dello sfruttamento

«». Lo ammette uno che è stato corresponsabile delle scelte che hanno portato a questo risultato. il manifesto
.
Ivan Cavicchi lancia l’allarme a proposito della possibilità che si verifichino ulteriori arretramenti del carattere universalistico del Servizio Sanitario Nazionale. Non ho dubbi a rispondere che è in effetti ciò che il Pd renziano propone in modo quasi ostentato. Si tratta di una presa in carico dei cittadini affidata ad un generico welfare che si dimentica di individuare nello Stato il garante della responsabilità e della risposta ai bisogni.
Il disegno, per la verità, inizia a formarsi già nei decenni scorsi quando si arena la battaglia della sinistra per definire, dopo la conquista della sanità pubblica, il carattere universalistico dell’intervento dello Stato. Gli anni delle politiche di austerità, cominciate con il governo Berlusconi-Tremonti e con i superticket, seguite poi dai pesanti tagli di Monti alla spesa sanitaria e dal sostanziale azzeramento di quella sociale, hanno finito per dare un colpo al diritto alla salute e all’assistenza nel nostro Paese.
Anche le più recenti politiche di rifinanziamento del welfare sono state caratterizzate da una scarsità di risorse e dall’idea che laddove la tutela dello Stato non può arrivare, sia allora dato spazio all’iniziativa privata, al terzo settore, al volontariato, all’impresa che con i contratti vuole “erogare” servizi ai propri dipendenti.
In questo quadro generale si è poi praticata una politica di detrazione dal costo del lavoro degli oneri per le mutue integrative, incrementando così l’idea che ognuno faccia e si salvi come può. Conta poco riaffermare – come fa Renzi – il carattere di cittadinanza del welfare sganciato dalle categorie e dal lavoro, ciò che conta è che i cittadini hanno capito che per tutelare la propria salute e ottenere un livello adeguato di protezione sociale, svolgono un ruolo sempre più importante le aziende di cui sono dipendenti, il territorio in cui vivono, le assicurazioni private che si pagano.
A completare l’opera – oltre ai ticket, ormai indispensabili per avere accesso alle prestazioni specialistiche in tempi utili – si è aggiunto il grande attacco culturale contro il SSN, che ha portato ingiustamente a identificare le grandi infrastrutture civili quali fonti di ogni male, di sprechi e di corruzione. In questo modo si è convinto molti, anche a sinistra, che solo la strada della privatizzazione fosse quella praticabile.
Colpisce ad esempio che lo Stato italiano non sia ancora in grado di garantire l’erogazione di un farmaco salva-vita come quello contro l’epatite C, capace di eradicare la malattia e quindi fondamentale per la salute pubblica.
È giusto avere consentito di poter acquistare individualmente il farmaco all’estero ma siamo di fonte a un’ulteriore conferma di una sanità fai-da-te: chi non può aspetta e resta ammalato.
Sono decenni che si è lavorato per costruire questa ideologia e trasformarla in senso comune. Renzi finisce per accettare definitivamente questa realtà e nella sua mozione pare volerla incrementare al punto di vedere la salute pubblica e il welfare solo come un bene individuale, come un sostegno alla persona per incentivare “il rischio, la sua voglia di mettersi in gioco”, dimenticando che la salute è un diritto fondamentale e anche interesse della collettività.
In effetti, come denuncia Cavicchi, la defiscalizzazione degli oneri per l’assistenza integrativa può davvero diventare la porta con cui, facendo mancare le risorse al SSN, si costruisce una “gamba” privata per l’assistenza sanitaria che finirà per scaricare le prestazioni più costose sul pubblico, relegandolo a strumento per il soddisfacimento dei livelli minimi di servizio per i più poveri.
Ancora una volta è il paradigma culturale e politico che la sinistra ha il dovere di rovesciare per fermare questa deriva anti-universalistica del welfare. Il pensiero conservatore e di coloro che vogliono trarre profitti dalla salute dei cittadini sono lì a ripetere ancora una volta il vecchio, stucchevole e stupido adagio che con i cambiamenti tecnologici, dei farmaci e delle cure e con l’invecchiamento della popolazione non riusciremo a sostenere finanziariamente il SSN.
Ma ormai, come sanno bene i cittadini che per curarsi devono mettere mano al portafogli per ben 30 miliardi all’anno, il libero mercato della salute conta di più della salute pubblica. Lo hanno imparato anche negli Stati Uniti dove un «giovane» – Bernie Sanders – ha avuto il coraggio di parlare di socialismo e di sanità pubblica. Le due cose evidentemente stanno insieme perché la sanità pubblica è l’unico elemento di socialismo che sia stato finora introdotto. A noi spetta di non farlo cancellare.
 Del resto, se hanno venduto lo Stato al Mercato, il pubblico al privato, la politica agli affari, di che si lamentano adesso? Cederanno, vedrai senatrice De Petris, cederanno, i "governanti" alle facce di bronzo. Articoli di Norma Rangeri e Andrea Colombo.
Del resto, se hanno venduto lo Stato al Mercato, il pubblico al privato, la politica agli affari, di che si lamentano adesso? Cederanno, vedrai senatrice De Petris, cederanno, i "governanti" alle facce di bronzo. Articoli di Norma Rangeri e Andrea Colombo.
il manifesto 1° aprile 2017
GLI EROI DEL MERCATONE TELEVISIVO
di Norma Rangeri
Quando si tocca il portafoglio anche le vecchie volpi gettano la maschera. Così il gran cerimoniere del senso comune televisivo, Fabio Fazio, esce allo scoperto e si fa intervistare per protestare contro le indebite ingerenze della politica negli affari della Rai. Affari nel senso proprio dei milioni di euro con cui l’azienda remunera i conduttori dei programmi. Il popolare conduttore parla di un «vulnus insuperabile, la rottura del patto di fiducia tra viale Mazzini e chi ci lavora».
Il lacerante grido di dolore denuncia poi l’inaudito, perché fissare un tetto agli stipendi pubblici «significa affermare che il settore pubblico deve rinunciare alle eccellenze professionali che il mercato può offrire».
Il tetto maledetto di cui si discute corrisponde alla miseria di 240mila euro lordi l’anno, più o meno 10mila euro netti al mese per i dirigenti Rai come per tutti i dirigenti pubblici.
Va da sé che il teleutente, obbligato a pagare il canone per assicurare un piatto di minestra a questi poveri lavoratori, sarà certamente preso da un sentimento di solidarietà verso questi dipendenti così ingiustamente colpiti da mamma Rai. E d’ora in poi guarderà ai fazio della tv come a dei poveri perseguitati.
Il coraggioso conduttore mostra finalmente il petto, e con sprezzo del ridicolo afferma di aver fatto una scoperta ancora più sconcertante dell’assalto al portafoglio, di aver cioè constatato «un’intrusione della politica nella gestione della Rai senza precedenti, chiedono di mandare via l’amministratore delegato, danno i voti ai servizi dei telegiornali…». Cose dell’altro mondo accadono alle nostre latitudini televisive e se non fosse per questa voce critica del piccolo schermo, saremmo rimasti a cuocere nella nostra italica ignoranza e non avremmo mai saputo che la politica dirige le danze del cavallo e del biscione.
Una cosa giusta, tuttavia, Fazio la dice: «Siamo pagati dalla pubblicità, non dal canone». Ecco sarebbe ora che chi è pagato dalla pubblicità andasse dove lo porta il conto in banca e che chi, invece, lavora in Rai lo facesse perché vuole offrire a chi paga il canone un servizio, informativo, culturale, di intrattenimento diverso dalla melassa che ci tocca vedere ogni giorno. A cominciare dalla domenica sera.
E non basta dire che c’è il telecomando per cambiare canale perché l’incestuoso rapporto tra partiti e televisione è semplicemente iscritto nel dna del sistema mediatico nazionale. Da Bernabei a Berlusconi la Rai è sempre stata il braccio ideologico del partito di maggioranza relativa, capace di permettersi anche qualche opposizione a sua maestà. Poi dagli anni ’80 del secolo scorso, polo pubblico e polo privato sono stati vasi comunicanti di un mercato inesistente, in un sostanziale duopolio-monopolio imperante. Alla Rai un canone e un tetto per la pubblicità, a Mediaset pubblicità senza confini, in un mercato fittizio presidiato dai partiti. Vasi comunicanti e indistinguibili nella comune rincorsa dell’audience.
In pratica Fazio sostiene che i programmi di cucina della Rai sono di ineguagliabile qualità rispetto a quelli della concorrenza e per questo è giusto che chi li conduce sia pagato anche fino a 3 milioni di euro. E che anche il suo programma, che cucina altri tipi di ingredienti, dall’ultimo presidente del consiglio all’ultimo disco, meriti di essere considerato un valore aggiunto dell’azienda pubblica. Un valore aggiunto senz’altro. Per lui e i suoi cari.
LE «STAR» DELLA RAI
SUL TETTO CHE SCOTTA
FAZIO GUIDA LA RIVOLTA
di Andrea Colombo
«Tv. Dopo il no dell’avvocatura a limiti dei compensi, la parola passa ora al governo. Il conduttore di «Che tempo che fa» contro il tetto dei compensi fissato a 240 mila euro l’anno. Giletti lo segue a ruota»
Fino a che non si arriva ai quattrini lo sfogo di Fabio Fazio su Repubblica è ineccepibile. Come si fa a negare che negli ultimi anni, non mesi come dice la star di Che tempo fa, si sia assistito a «un’intrusione della politica nella gestione della Rai che non ha precedenti»? Solo che Mr. Valium, come ebbe a definirlo Bono degli U2, non allude alla tasformazione del servizio pubblico, con il suo programma in primissima fila, in grancassa personale di Matteo Renzi. Quella non sembra creargli anzi alcun problema. La nota dolente è che «la politica si è intromessa nella gestione ordinaria di un’azienda, addirittura nei contratti tra viale Mazzini e gli artisti». Tradotto in italiano significa che la politica minaccia la sua cospicua prebenda, con l’obiettivo di tagliarla fino a 240mila euro. Una miseria.
Fazio non è solo. Sulla principale testata concorrente, il
Corriere della Sera, Massimo Giletti batte sullo stesso tasto, con una punta ricattatoria in più: «Se il tetto venisse applicato qualcuno potrebbe pensare che non è conveniente rimanere nella tv pubblica». Del resto anche Fazio, pur con l’abituale stile soave, aveva messo sul piatto della bilancia la medesima minaccia. Permanenza garantita fino a maggio. Poi si vede, anzi si conta, e dar vita a una produzione indipendente potrebbe rivelarsi un’ottima idea.
I conduttori a rischio di drastico impoverimento premono su una breccia già aperta dal parere dell’Avvocatura dello Stato, richiesto dal governo. Verdetto drastico: benissimo il tetto in questione per manager e dipendenti Rai, ma non per le star dal momento che, in forza di una norma varata con la Finanziaria del 2007, «la prestazione artistica o professionale che consenta di competere sul mercato» non deve essere soggetta a vincoli di sorta. Poco male se il risultato è un paradosso per cui i superpagati dall’azienda pubblica sono apprezzati grazie alle imperiose leggi del mercato, ma allo stesso tempo sono anche messi al riparo dalle intemperie proprie del mercato stesso.
La politica replica al j’accuse di Fazio almeno in apparenza a muso duro. Anzaldi, il renzianissimo segretario della Commissione di vigilanza, giura che «il Pd non ha smarrito la strada: non abbiamo riformato il canone per permettere a una piccola casta di sopravvivere». Brunetta compensa il noto malanimo di Forza Italia per il presentatore più apertamente Pd che ci sia chiamando in causa anche il ben più amato da Arcore Bruno Vespa: “Vogliamo chiarezza sui maxstipendi della Rai, per i dj come Fazio e per i giornalisti come Vespa. Se vogliono il mercato che vadano sul mercato». I toni più duri arrivano dall’M5S, che ironizza sul «coraggio da leone» che il solitamente mansueto Fabio scopre «solo quando gli toccano i soldi: non risulta che per lui la lottizzazione fosse un problema», e soprattutto da Sinistra italiana.
Per la capogruppo al Senato Loredana De Petris, “la rivolta delle star è scandalosa. Sarebbe però ancora più grave e invierebbe un messaggio devastante se il governo cedesse a pressioni e ricatti». Il governo farà sapere se intende cedere oppure no solo il 15 aprile. Per ora mantiene il silenzio ed evita di replicare all’intemerata di Fazio. Nel cda, dal quale proviene la delibera della discordia, ci sono posizioni diverse. Franco Siddi ammette sì che «tetto o no i compensi milionari dovranno essere valutati con grande attenzione», però boccia la strada sin qui indicata perché “ha introdotto una camicia di forza», rischia «di privare la Rai dei migliori talenti sul mercato» e «di essere un favore alle componenti commerciali del sistema».
Arturo Diaconale, anche lui consigliere Rai, è di parere opposto: «Le dichiarazioni di Fazio e Giletti sono la conferma che dobbiamo mantenere la posizione. Se vogliono stare sul mercato, allora ci stiano. Se ci sarà un intervento del governo ci atterremo, ma da solo il parere dell’Avvocatura per noi non basta. Per l’applicazione della delibera la deadline è aprile. Il governo ha un mese».
Entro il mese, quasi certamente, l’intervento del governo ci sarà. In fondo, ben prima delle star, era stato il Mef a suonare l’allarme. Urge smerciare all’estero, e di fronte a questo imperativo non c’è tetto che tenga.
«La politica continua a occuparsi di gare e appalti. La corruzione nasce qui". Il presidente dell’Autorità Anticorruzione parla di Consip e di Romeo. E sui politici sotto inchiesta dice: "Si valuti, a prescindere dagli interventi giudiziari, se sono compatibili con ruoli di responsabilità per il Paese"». la Repubblica, 13 marzo 2017
Lei è qui da tre anni. Sempre sulla ribalta. Troppo, dicono i suoi detrattori. Non è pessimista sulla corruzione in Italia. Ma come la mette con Romeo e l’inchiesta Consip?
«Non ho mai detto che il contrasto alla corruzione sarebbe stata una passeggiata e non ho neppure lontanamente pensato che potessero bastare tre anni di Anac per invertire il trend. Abbiamo avviato un percorso, che è ancora lungo, tortuoso, irto di ostacoli. Vicende come quelle di Consip non saranno certo le ultime che emergeranno in questo Paese. La corruzione è tutt’altro che vincibile domani o dopodomani».
Decine di politici nelle carte giudiziarie su Consip. Dopo averle lette lei vede ancora positivo?
«Resto ottimista e mi attengo ai fatti. C’è un’indagine molto seria tra Napoli e Roma che ha fatto emergere allo stato un unico, seppur grave, episodio di corruzione che potrebbe lasciar intravedere altro. Per parlare di sistema c’è bisogno di attendere gli sviluppi giudiziari».
Non sta sminuendo troppo?
«Assolutamente no, sono abituato a ragionare da magistrato e a pensare che i fatti sono quelli accertati giudiziariamente, mentre le ricostruzioni sono utili sul piano sociologico ».
Da quegli atti non emerge un sistema in cui corrono in parallelo appalti e politica?
«Il vero problema è che una parte della politica continua a occuparsi di appalti e gare pubbliche. Se questo non ci fosse tutto sommato avremmo una corruzione fisiologica».
Avremmo pure imprenditori che cercano sempre di corrompere...
«Contesto assolutamente quest’affermazione. Se fosse davvero così dovremmo rinunciare a qualsiasi possibilità di scardinare la corruzione. Il punto vero è garantire agli imprenditori onesti ed estranei alla politica la possibilità di accedere agli appalti importanti, quelli che contano».
Guardi Bocchino, un ex politico usato da Romeo che arriva a lamentarsi degli appalti troppo concentrati nella Consip perché le chance di dividere la torta si riducono.
«Questa storia evidenzia un’enorme ipocrisia. I grandi imprenditori hanno bisogno di utilizzare meccanismi lobbistici per promuovere la loro attività. Ma la parola lobby in Italia è sempre stata intesa in senso negativo perché non si è mai avuto il coraggio di affrontarla e regolarla».
Bocchino vuole arrivare a lei e ottenere la sua benevolenza.
«Sui giornali ho letto cose fantasiose, per esempio che mi avrebbe cercato Fini, falso perché per telefono non ci ho mai parlato, né l’ho mai incontrato tranne in un’occasione pubblica in cui ci siamo appena salutati».
La lettura delle intercettazioni di Bocchino però è chiara…
«Quello poteva essere il loro intendimento, ma non ci sono riusciti. Su questo sfido chiunque a dimostrare che il tentativo di avvicinamento a me sia anche solo iniziato».
Il sindaco di Napoli De Magistris dice di aver tolto a Romeo la gestione del patrimonio. Perché Consip non lo ha fatto?
«Romeo ha partecipato e vinto gli appalti, in molti casi oggetto di ricorsi al Tar che li ha confermati. Romeo è stato assolto con formula piena nel caso Global Service. Se non ci sono condanne, un soggetto non può essere escluso. Il singolo può decidere di non frequentare un imprenditore chiacchierato, e l’uomo delle istituzioni fa bene a non farlo, ma sul piano formale il soggetto assolto è definitivamente riabilitato».
Pure lei ha notato anomalie nelle gare Consip di Romeo. Perché non le ha fermate?
«Le abbiamo evidenziate anche pubblicamente, ma si trattava di rischi che di per sé non erano tali da far pensare alla corruzione ».
È giusto che l’ad di Consip Marroni resti al suo posto?
«I magistrati lo considerano fino a oggi un testimone attendibile. E chi collabora con la giustizia in modo corretto e leale fa il suo dovere; non spettano a me valutazioni diverse, di opportunità connesse anche alla serenità di svolgere un ruolo tanto difficile; è compito del ministro dell’Economia e dello stesso Marroni ».
Ha parlato con lui?
«Anac ha fatto accertamenti su molte gare di Consip. Ora Marroni ci ha chiesto alcuni pareri. Risponderemo analizzando le questioni giuridiche, ma non ci sostituiremo certo alle valutazioni che spettano a Consip».
E Lotti? Dovrebbe farsi da parte come Renzi aveva chiesto per Idem e Cancellieri?
«Su questo non ho nulla da dire perché sono in ballo valutazioni politiche da cui è necessario che mi tenga lontano. In generale, come ho detto tante volte, non basta un avviso di garanzia per imporre il passo indietro, ma la politica deve valutare se i fatti, a prescindere perfino da interventi giudiziari, siano più o meno compatibili con ruoli di responsabilità per il Paese».
Renzi ha puntato molto su di lei. Ora che il padre è indagato e Lotti pure, vede ricaschi negativi?
«Renzi, da premier, non ha in nessun modo interferito nella mia attività. Personalmente credo sia giusto aver rispetto per una persona che sta vivendo un momento difficile. Le valutazioni complessive sulla vicenda potranno essere fatte quando si diraderà la cortina fumogena delle chiacchiere e i fatti saranno portati all’attenzione dei giudici».
Lei è napoletano come Romeo. Come si comportava con lei?
«Non ho avuto alcun rapporto con lui che non fosse puramente formale e l’ho conosciuto quando la sede dell’Avcp passò all’Anac e avemmo l’esigenza di rescindere il contratto ».
Possibile? Per anni a Napoli senza conoscerlo?
«Ho saputo dell’esistenza di Romeo solo quando è stato arrestato per la vicenda Global Service e ho visto la sua foto per la prima volta sui giornali».
A leggere le carte dell’inchiesta risulta evidente il suo tentativo di avvicinarla. Il convegno del Cresme, la consulenza a suo fratello Bruno, le telefonate di Bocchino con Fini. Lei cosa ha fatto?
«Da quando sono magistrato sono attentissimo alle frequentazioni, non vado a feste, pranzi o cene con nessuno. I rapporti istituzionali sono sempre pubblici o passano per l’Anac. Al convengo del Cresme sono andato e ci tornerei perché si discuteva di un tema di grande interesse per l’Anac, c’erano relatori importanti, mi sono trattenuto per il mio intervento e sono andato via. Credo sia doveroso per una persona che ha la mia carica esprimere la propria opinione non certo in conventicole private ma in convegni pubblici. Quanto alla vicenda di mio fratello, Bruno ha avuto un incarico professionale per pochi mesi per aver conosciuto Romeo per via della vicinanza dei rispettivi studi, ma non si è mai occupato di vicende che neanche lontanamente interferivano con Anac. E io ne ho avuto notizia solo quando ne hanno parlato i giornali».
Una sua “nemica”, Carla Raineri, ci vede un conflitto di interesse.
«Non considero la dottoressa Raineri una mia “nemica”. A titolo personale non ho fatto nulla contro di lei. Il consiglio dell’Anac ha espresso un parere sulle modalità della nomina a capo di gabinetto che la dottoressa avrebbe ben potuto contestare in via giudiziaria o amministrative. Quelle sul conflitto di interesse sono insinuazioni prive di ogni fondamento e sull’incarico sia io che mio fratello, come fanno le persone per bene, abbiamo riferito tutto quello che c’era da dire all’autorità giudiziaria di Napoli».
Quanti Romeo ci sono in giro che cercano di circuire Cantone?
«Credo ce ne siano tanti, ma io sono tranquillo, e sono sicuro che gli eventuali tentativi non vanno da nessuna parte».
Sarà la Procura nazionale anticorruzione il suo prossimo incarico?
«Non credo che una simile struttura sia necessaria. E al mio prossimo incarico in magistratura penserò a partire dalla fine del 2019 quando si avvicinerà l’aprile 2020, mese in cui scade il mio mandato non rinnovabile all’Anac».

«di Isola di Capo Rizzuto (Crotone), considerato fra i più grandi d’Europa per estensione e potenza erogata, tra i beni per 350 milioni di euro sequestrati dai finanzieri di ». Il Fatto Quotidiano, 3 marzo 2017 (p.s.)
Ammonta a circa 350 milioni il sequestro effettuato dalla Guardia di finanza di Catanzaro alla ‘ndrangheta di Crotone. Nel mirino della Dda c’è la cosca Arena di Isola Capo Rizzuto che si è vista applicare i sigilli al parco eolico “Wind Farm”. Su richiesta del procuratore Nicola Gratteri e dell’aggiunto Vincenzo Luberto, gli uomini del colonnello Michele Di Nunno hanno eseguito il decreto emesso dal Tribunale nei confronti di Pasquale Arena, nipote del vecchio boss Nicola Arena (fino a poco tempo fa detenuto al 41 bis) e fratello di Carmine Arena, ucciso a colpi di bazooka nell’ottobre 2004. Dietro il parco eolico più grande d’Europa “ci sono i soldi e i beni accumulati in anni e anni di comportamenti mafiosi – dice Gratteri – La cosca Arena è tra le più agguerrite, una famiglia che in modo costante ha dominato il respiro sociale ed economico del territorio”.
Funzionario del Comune di Isola Capo Rizzuto, Pasquale Arena è ritenuto il gestore occulto degli affari della cosca, l’uomo che curava gli interessi economici della famiglia e che era riuscito, attraverso una fitta rete di società tedesche, svizzere e della Repubblica di San Marino, a far entrare la famiglia mafiosa nel business delle energie rinnovabili. Le società estere, infatti, detenevano formalmente le quote sociali di altre tre società con sede a Crotone e Isola. Un sistema di scatole cinesi che ha consentito a Pasquale Arena di ottenere le autorizzazioni da parte degli enti locali e di realizzare e avviare, per conto della cosca, il parco eolico “Wind Farm” con 48 aerogeneratori e diverse opere accessorie.
Il procuratore Gratteri ha ripreso una vecchia indagine e ha inferto un duro colpo all’impero che sembrava ritornato in mano alla cosca Arena. L’inchiesta delle Fiamme gialle, infatti, aveva portato alcuni anni fa già al sequestro preventivo degli stessi beni che, però, in seguito ad alcuni ricorsi, erano stati restituiti ai formali intestatari delle società coinvolte nell’indagine. La successiva attività investigativa, coordinata dal pm Domenico Guarascio, ha consentito agli investigatori del Nucleo di polizia tributaria di ricostruire i vari passaggi dell’investimento e ricondurre il parco eolico nell’impero degli Arena.
Con l’operazione di oggi, denominata “l’Isola del vento”, i finanzieri del Gico sono riusciti a svelare il sistema adottato dalla ‘ndrangheta per schermare il patrimonio. Un sistema che, secondo gli investigatori, era costituito da sofisticati e complessi reticoli societari e da strane cessioni di quote che servivano a occultare i veri padroni di uno dei parchi eolici più grandi d’Europa. In particolare il coinvolgimento della famiglia Arena nel progetto sarebbe avvenuto attraverso la partecipazione nella compagine societaria della “Purena Srl”, che deteneva partecipazione nella “Vent1 Capo Rizzuto Srl”.
Quest’ultima poi è subentrata alla società sammarinese “Seas Srl” (rappresentata da Maximiliano Gobbi) che, per prima, aveva chiesto l’autorizzazione a realizzare il parco “Wind Farm” al Comune di Isola Capo Rizzuto. Dalle indagini era emerso, inoltre, che l’agente mandatario della “Seas Srl” era Nicola Arena (nipote dell’omonimo boss) che però era “assolutamente privo – sostengono gli inquirenti – di qualsivoglia competenza tecnico-professionale, sia nello specifico settore delle energie alternative, sia, più in generale, nel campo giuridico-economico necessario alla stipula degli atti amministrativi”. Ma Nicola Arena era anche socio della “Purena Srl” a sua volta socia della “Vent1 Capo Rizzuto Srl” che ha realizzato materialmente il parco e che era amministrata dal tedesco Martin Josef Frick, personaggio chiave dell’inchiesta.
In un’intercettazione del 27 aprile 2009, infatti, i finanzieri sentono parlare al telefono Frick con un’impiegata di uno studio notarile alla quale comunicava i nominativi dei proprietari dei fondi su cui insisteva il parco. Le pale eoliche, in sostanza, erano state impiantate nei terreni riconducibili direttamente alla famiglia Arena o ai loro prestanome.
 Una nuova tempesta squassa l'edificio di potere eretto dal ragazzo di Rignano. Si tratta di grandi tangenti sugli appalti pubblici. Articoli di Adriana Pollice, Fulvio Fiano e Giovanni Bianconi,
Una nuova tempesta squassa l'edificio di potere eretto dal ragazzo di Rignano. Si tratta di grandi tangenti sugli appalti pubblici. Articoli di Adriana Pollice, Fulvio Fiano e Giovanni Bianconi,
il manifestoCorriere della sera, 2 marzo 2017
il manifesto
COS’È CONSIP
Consip è la centrale acquisti della pubblica amministrazione italiana. La legge prevede che operi nell’esclusivo interesse dello Stato e il suo azionista unico è il ministero dell’economia e delle finanze (Mef) del quale è una società in-house.
Nata nell’agosto del 1997 come Concessionaria servizi informativi pubblici per la gestione dei servizi informatici dell’allora ministero del tesoro, con la legge finanziaria del 2000 le viene affidato il compito della razionalizzazione della spesa pubblica per i beni e servizi, in sostituzione del Provveditorato generale dello Stato. Successivamente il suo compito si amplia e ne viene potenziato il ruolo di centrale di committenza nazionale. Nel 2015 Consip partecipa al programma del governo Renzi – guidato dall’allora commissario alla spending review Yoram Gutgeld – di ridurre a 35 centrali acquisti il numero di stazioni appaltanti deputate a gestire le grandi gare.
Lo scopo principale è quello di rendere «più efficiente e trasparente» l’utilizzo delle risorse pubbliche, fornendo alle amministrazioni gli strumenti per la gestione degli acquisti di beni e servizi. Le singole amministrazioni vengono supportate in tutti gli aspetti del processo di approvigionamento attraverso convenzioni.
Per legge il prezzo di riferimento per l’acquisizione di beni e servizi non può essere superato da un’amministrazione che voglia acquistare quel determinato bene o servizio o un altro di pari caratteristiche.
il manifesto
CONSIP, ARRESTATO ROMEO.
UN MEGA-LOTTO NEL MIRINO
di Adriana Pollice
Giungla d'appalto. L’imprenditore napoletano accusato di corruzione con un funzionario della Spa del ministero del Tesoro. Perquisite le abitazioni dell’ex An Bocchino e di Carlo Russo, amico di Tiziano Renzi
Carabinieri e polizia tributaria hanno bussato ieri mattina alla porta di Alfredo Romeo: il tribunale di Roma ne ha disposto la custodia in carcere, a Regina Coeli. E’ accusato di corruzione per il mega appalto Consip, la spa del ministero dell’Economia incaricata dell’acquisto di beni e servizi delle amministrazioni pubbliche. L’arresto si è reso necessario, spiega la procura, perché non sarebbe «in grado di contenere lo stimolo criminale». Nell’inchiesta sono indagati anche molti petali del giglio magico di Matteo Renzi, a cominciare dal padre Tiziano che si professa innocente (traffico di influenze è l’ipotesi di reato), poi l’imprenditore e amico di famiglia Carlo Russo, il ministro dello Sport Luca Lotti (accusato di rivelazione del segreto d’ufficio e favoreggiamento), fino al comandante generale dei Carabinieri Tullio Del Sette e al generale Emanuele Saltalamacchia.
Sono state perquisite abitazioni e uffici di Russo e Italo Bocchino (indagati anche loro per traffico di influenze). Russo e il padre dell’ex premier «sfruttando le relazioni esistenti tra Tiziano Renzi e l’ad di Consip, Luigi Marroni, si facevano promettere somme di denaro mensili come compenso per la loro mediazione verso Marroni» si legge nel decreto di perquisizione a carico di Russo. L’ex parlamentare di An è il braccio destro di Romeo: le intercettazioni ambientali ma, soprattutto, il virus Trojan infiltrato nei cellulari di entrambi hanno portato al disvelamento del «sistema Romeo», già ipotizzato dall’inchiesta Global service della procura di Napoli nel 2008 da cui poi l’imprenditore casertano è stato assolto in Cassazione, dopo due condanne.
Nell’indagine Consip Bocchino (retribuito con 15mila euro al mese) viene definito «consigliere strategico» di Romeo grazie alla sua «capacità di accedere a informazioni riservate grazie al suo trascorso di deputato e membro del Comitato parlamentare sui Servizi segreti». Attraverso Bocchino Romeo avrebbe scoperto di essere indagato già dal settembre 2016. E’ Bocchino che, intercettato nel gennaio 2016, spiega come funzionerebbe il rapporto politica-affari: gli appalti Consip «devono essere gestiti per favorire prevalentemente le cooperative in quanto rappresentano un bacino di voti dal quale poter attingere ed è anche e soprattutto un modo lecito per finanziare il politico di turno». E ancora: «Nelle audizioni il ministro diceva… questo è il motivo per cui non è esplosa Consip, è chiaro che la politica ha il problema del territorio… i mille pulitori sul territorio sono mille persone che danno 5mila euro ciascuno… sono mille persone che fanno un’assunzione ciascuno… sono mille persone che quando voti si chiamano i loro dipendenti… tu i tuoi dipendenti manco sai chi sono». Partecipare agli appalti, a detta degli indagati, «è una competizione criminale a chi corrompe meglio».
Il sistema Romeo si basa su due pilastri: i «prototipatori» e i «facilitatori». Alla prima categoria apparterrebbe il direttore Sourcing Servizi e Utility di Consip, Marco Gasparri: si tratta di un neologismo coniato da Romeo per individuare chi, all’interno della Pa, confeziona bandi di gara ad hoc per favorire un’impresa. Secondo il gip Gaspare Sturzo, Gasparri aveva il ruolo di «prototipatore di bandi Consip al servizio di Romeo». Bocchino invece era «il facilitatore degli interessi illeciti, il lobbista dedicato al traffico illecito di influenze». Gli appoggi politici servivano a «indurre i vertici della Consip ad assecondare le mire degli imprenditori». Se Romeo, Bocchino e Gasparri erano i vertici del sistema, nel mezzo secondo il gip ruotavano le altre pedine, «attivissime nel produrre accordi, veri o falsi, individuare referenti reali o supposti, stabilire tangenti effettive o ipotetiche. Romeo voleva sapere notizie riservate sui bandi in modo da avere un vantaggio competitivo basato sulla propalazione di notizie riservate».
A Gasparri sono stati sequestrati beni per 100mila euro, cioè quanto avrebbe ricevuto da Romeo come compenso dal 2012 al 2016: corruzione per asservimento della funzione è il reato contestato. Romeo, scrive il gip, gli avrebbe proposto «di costruire una comune ipotesi difensiva per impedire il normale corso della giustizia». Racconta Gasparri durante l’interrogatorio: «Tra il 2012 e il 2014 Romeo aveva perso tutte le gare Consip, avvertì così la necessità di avere un soggetto intraneo che con assoluta sistematicità gli fornisse informazioni sia sulle gare sia sulle dinamiche interne». E ancora: «Ho visto l’ultima volta Romeo il 29 novembre 2016. Era sudato e farfugliava, mi disse che gli avevano sequestrato dei foglietti, compreso un foglio dove c’era il mio nome con dei numeri accanto». Dallo scorso dicembre Gasparri ha deciso di collaborare: è lui a raccontare che per incontrare l’ad di Consip, Romeo aveva fatto intervenire «politici ad altissimo livello».
Corriere della sera
INCHIESTA CONSIP, ARRESTATO ROMEO
«C’ERA UNA GUERRA DI TANGENTI»
di Fulvio Fiano
Nel lessico corruttivo della pubblica amministrazione è un neologismo: prototipatore . Definizione coniata per l’alto funzionario Consip, Marco Gasparri, da parte di Alfredo Romeo, l’imprenditore finito ieri in carcere con l’accusa di avergli dato 100 mila euro in «una guerra imprenditoriale a suon di tangenti». La somma è stata sequestrata dai carabinieri del Roni e del Noe e dai finanzieri del comando provinciale di Napoli, che hanno anche perquisito le case e gli uffici dell’ex parlamentare Italo Bocchino e dell’imprenditore fiorentino Carlo Russo, accusati di traffico di influenze assieme a Tiziano Renzi, padre dell’ex premier Matteo.
Come riportato nel decreto di perquisizione, Russo e Renzi senior, in forza delle relazioni di quest’ultimo con l’ad di Consip, Luigi Marroni, «si facevano promettere da Romeo, che agiva previo concerto con Bocchino, suo consulente, somme di denaro mensili». Romeo ne avrebbe guadagnato l’aggiudicazione di tre lotti del mega bando da 2,7 miliardi, poi non completata. Renzi senior sarà interrogato domani. «Fatti insussistenti», dice il suo legale Federico Bagattini.
Da una parte, dunque, Romeo «intento a progettare una serie di infiltrazioni criminali in appalti pubblici». Dall’altra la sua rete di relazioni. «Mi occupo della documentazione di gara», spiega Gasparri al primo incontro tra i due, nel 2012. «Quindi lei fa progettazioni, prototazioni... un prototipatore», riassume Romeo. Cinquemila euro in contanti a Natale sanciscono l’accordo. Dal 2013 diverranno una «sistematica dazione di denaro».
Il procuratore aggiunto Paolo Ielo e il pm Mario Palazzi contestano la corruzione per asservimento e della funzione e quella su specifici episodi, tra cui il mega appalto Facility Management 4. Romeo deve rimettersi su piazza dopo l’arresto del 2008 ma manca dei requisiti tecnici e di competenza per partecipare. Gasparri lo segue passo passo nella presentazione dell’offerta, nella scrittura della proposta, nelle risposte alle obiezioni della commissione di gara. Lo agevola, dicono i pm, con informazioni «sensibili».
Quando poi finiscono sotto inchiesta, Romeo chiede a Gasparri di concordare una difesa comune. Ma questo va dai magistrati ed evita l’arresto (all’interno di Consip non ha più un ruolo «pericoloso»). La confessione trova riscontri nei pedinamenti, negli appuntamenti in agenda e nelle intercettazioni telefoniche e ambientali. In una di queste i due parlano a bassa voce ma si intuisce il rumore di fogli strappati, i «pizzini» poi ritrovati tra i rifiuti.
«L’importante è che tenimm’ la squadra giusta», dice l’imprenditore in un’altra circostanza. E il funzionario, parlando di soldi da avere: «Mi è rimasto di 40 (mila euro, ndr ) indietro. Ce la fa?».
«Ho sempre operato con trasparenza», dice Marroni. Coinvolto anche il suo predecessore, Domenico Casalino. M5S invita Matteo Renzi a rendere pubblici i finanziamenti avuti da Romeo, mentre il ministro Luca Lotti, che avrebbe rivelato le indagini a Romeo, si dice «tranquillissimo».
Corriere della sera
LE ACCUSE DEI PM DI ROMA:
COSÌ RUSSO E TIZIANO RENZI
SI FACEVANO PROMETTERE SOLDI
di Giovanni Bianconi
Il «gravissimo quadro di possibile infiltrazione criminale» nella gara d’appalto «con il più rilevante importo mai indetto in Europa», pari a circa 2 miliardi e 700 milioni di euro, era arrivato al «massimo livello politico». Parola di Alfredo Romeo, l’imprenditore che voleva conquistare a tutti i costi fette rilevanti di quella immensa torta, riferita dal dirigente della Consip Marco Gasparri che lo stesso Romeo aveva assunto «a libro paga». Una corruzione ammessa dal corrotto, che aggiunge: «Romeo non mi disse chi era il politico o i politici presso i quali era intervenuto, ma mi disse che si trattava del “livello politico più alto”; in proposito mi chiese se io avevo registrato, a seguito di tale suo intervento, un cambiamento di atteggiamento dell’amministratore delegato di Consip nei suoi confronti».
In sostanza, per avere un trattamento di favore dalla Centrale d’acquisto per i beni e servizi della pubblica amministrazione, Romeo s’era rivolto alle alte sfere del potere. Il giudice che ieri ne ha ordinato l’arresto precisa che ora gli inquirenti dovranno chiarire il ruolo di altri soggetti che risultano «attivissimi nel proporre accordi, veri o falsi, individuare referenti reali o supposti, stabilire tangenti effettive o ipotetiche», ma i pubblici ministeri sanno già in quale direzione indirizzare le loro verifiche.
Le somme di denaro
È scritto in un passaggio del decreto di perquisizione nei confronti di Carlo Russo, imprenditore trentatreenne di Scandicci e amico della famiglia Renzi, firmato dal procuratore aggiunto Paolo Ielo e dal sostituto Mario Palazzi: dagli atti dell’inchiesta emerge come «Alfredo Romeo, previo concerto con Italo Bocchino, si sia accordato con Carlo Russo (a fronte di ingenti somme di denaro promesse) affinché questi, utilizzando le proprie relazioni (di cui vi è prova diretta) e le relazioni di Tiziano Renzi (con il quale lo stesso Russo afferma di aver agito di concerto e al quale parimenti, da un appunto vergato dallo stesso Romeo, appare destinata parte della somma promessa), indebitamente interferisca sui pubblici ufficiali presso la Consip, al fine di agevolare la società di cui Romeo è dominus». Secondo l’ipotesi investigativa, le «somme di denaro mensili» che Russo e Renzi senior «si facevano promettere» erano il «compenso per la mediazione» realizzata «sfruttando relazioni esistenti tra Tiziano Renzi e Luigi Marroni, amministratore delegato di Consip».
L’alto livello politico
Il sospetto che «il livello politico più alto» raggiunto dall’imprenditore napoletano passasse proprio da Russo e dal suo rapporto con il padre dell’ex presidente del Consiglio è uno dei punti chiave dell’indagine. In virtù delle intercettazioni in cui Russo ne parla, dei pagamenti promessi da Romeo e della conoscenza dello stesso Russo con l’ex sottosegretario a Palazzo Chigi (oggi ministro dello Sport) Luca Lotti che, secondo le dichiarazioni di Michele Emiliano, avrebbe detto al presidente della Puglia che lo poteva incontrare perché «ha un buon giro...». Tra gli appunti stracciati recuperati dai carabinieri nella spazzatura dell’ufficio romano di Romeo ce n’è uno da cui risulta che a novembre 2015 l’imprenditore pagò un soggiorno a Russo e signora da 3.233 euro nell’albergo di Ischia di proprietà di alcuni suo parenti. Una struttura che, si legge in un rapporto degli investigatori dell’Arma, «insieme all’albergo di sua proprietà, viene utilizzata (da Romeo, ndr ) quale contropartita per ricompensare i pubblici ufficiali infedeli dell’opera svolta per suo conto».
La guerra e le tangenti
Nella ricostruzione dell’accusa la corruzione rappresenta una «vera e propria politica d’impresa delle società di Romeo», che l’imprenditore utilizza per provare a vincere «a suon di tangenti» una guerra con altri gruppi dai risvolti politici occulti. Dei quali il corruttore aveva una sorta di «ossessione». Ha raccontato il «funzionario infedele» Marco Gasparri nelle sue confessioni ai pubblici ministeri: «Romeo si riteneva vittima di un complotto all’interno di Consip e di essere discriminato, nel senso che riteneva che i vertici di Consip favorissero la società Cofely, capogruppo di un raggruppamento temporaneo di imprese di cui faceva parte anche una società riconducibile a tale Bigotti, imprenditore che, a suo dire, era legato all’onorevole Verdini. Per tale ragione Romeo diceva di aver operato ultimamente un intervento sull’amministratore delegato Marroni, per il tramite e attraverso “il più alto” livello politico».
È quella che il giudice dell’indagine preliminare Gaspare Sturzo chiama «legittima difesa criminale rispetto alle condotte di altri imprenditori e vertici politici e istituzionali volte all’esclusione dell’imprenditore campano»; in pratica, la corruzione di determinati soggetti per contrastare quella di altri. Quando seppero che a Napoli c’era in corso un’indagine a loro carico, Romeo e Bocchino — intercettati — auspicavano che il fascicolo fosse trasferito rapidamente a Roma, forse nella prospettiva di evitare guai; a poche settimane dalla trasmissione degli atti nella Capitale, si ritrovano uno in carcere e l’altro inquisito e perquisito.
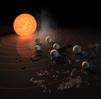
«. Le Scienze online,
Una stella non troppo distante da noi, e intorno sette pianeti di dimensioni simili a quelle della Terra, sei dei quali si trovano in una zona “temperata”, cioè in orbite tali che le temperature superficiali rimangono tra 0 e 100 gradi Celsius.
La scoperta è di Michaël Gillon, dell'Università di Liegi, in Belgio, e colleghi di una collaborazione internazionale, che la annunciano oggi sulle pagine di “Nature”, e suggerisce che nella Via Lattea questo tipo di sistema potrebbe essere comune.
Le misurazioni indicano che i sei pianeti interni hanno masse simili a quella della Terra e probabilmente hanno una composizione rocciosa. Inoltre, quelli intermedi hanno probabilmente un'atmosfera di tipo terrestre e acqua liquida sulla loro superficie.Negli ultimi decenni, la ricerca di pianeti al di fuori del sistema solare ha avuto un successo incredibile: se ne contano ormai a migliaia. Il metodo più utilizzato per la “caccia” è la fotometria di transito, basata sul fatto che la luce emessa da una stella diminuisce quando un pianeta passa di fronte al disco della stella stessa rispetto alla direzione di vista dalla Terra. La variazione è minima, ma può essere misurata con gli strumenti attuali, che consentono anche di stimare anche la massa planetaria.
Quando la stella è di limitate dimensioni, la misurazione fotometrica è particolarmente agevole, perché la percentuale della superficie stellare che viene oscurata è notevole: ciò permette di documentare il transito di pianeti di dimensioni simili a quelle terrestri. Ora, nella Via Lattea, la maggior parte delle stelle è più piccola e meno luminosa del Sole, il che ha spinto i planetologi a monitorare in modo continuativo proprio la nostra galassia.
Nel 2010, Gillon e colleghi hanno iniziato a monitorare le stelle più piccole vicine al Sole con il telescopio robotizzato da 60 centimetri di diametro TRAPPIST (the Transiting Planets and Planetesimals Small Telescope) dell'European Southern Observatory (ESO) di La Silla in Cile.
E nel maggio dello scorso anno hanno riferito la sensazionale scoperta di tre esopianeti in orbita intorno a una stella nana ultrafredda, che hanno battezzato TRAPPIST-1 ed è situata a circa 39 anni luce dal nostro Sole.
In seguito, hanno approfondito le osservazioni sia con telescopi terrestri sia effettuando un monitoraggio continuo per 20 giorni con il telescopio spaziale Spitzer della NASA. Risultato: ben 34 transiti documentati, attribuiti a un totale di sette pianeti.Ora il quadro generale è completo. Il sistema TRAPPIST-1 è estremamente compatto, piatto e ordinato. I sei pianeti interni hanno periodi orbitali tra 1,5 e 13 giorni e sono tutti “quasi risonanti”: ciò significa che nello stesso tempo in cui il pianeta più interno compie otto rivoluzioni, il secondo, il terzo e il quarto pianeta ne compiono cinque, tre e due, rispettivamente.
Questo schema fa sì che vi siano mutue influenze gravitazionali, che si manifestano in lievi variazioni nei tempi di transito osservati, che gli autori hanno utilizzato per stimare le masse planetarie.
Da queste stime, è emerso che il sistema planetario è incredibilmente somigliante a quello costituito da Giove e dai satelliti galileiani (Io, Europa, Ganimede e Callisto), anche se ha una massa circa 80 volte superiore. Le quattro lune, infatti, orbitano intorno a Giove con periodi compresi tra 1,7 e 17 giorni, anche in questo caso in condizioni di quasi-risonanza. Questa somiglianza suggerisce che i pianeti di TRAPPIST-1 e i satelliti galileiani si siano formati ed evoluti in modo simile.
Ma i dati forse più interessanti riguardano le dimensioni dei pianeti, la loro possibile composizione e il loro clima. L'analisi dei dati mostra che cinque di essi (b, c, e, f e g, secondo la sigle attribuite dagli autori, cioè il primo, secondo, terzo, quinto e sesto) hanno dimensioni simili a quelle terrestri, mentre g e h (il quarto e il settimo) hanno dimensioni intermedie tra quelle della Terra e quelle di Marte. Per i sei pianeti più interni, le stime dimensionali fanno ipotizzare che si tratti di pianeti rocciosi.Utilizzando un semplice modello climatico e considerando le temperature tipiche della stella, si è stimato inoltre che e, f e g (cioè il quarto, il quinto e il sesto) potrebbero avere un'atmosfera di tipo terrestre e persino un oceano liquido. Per i tre pianeti più interni invece si ipotizza che l'acqua liquida sia completamente evaporata a causa di un intenso effetto serra.
Nel caso del settimo e più esterno pianeta, i ricercatori non sono riusciti a determinare il periodo orbitale e l'interazione con i pianeti più interni, che saranno oggetto dei prossimi studi.
A questo proposito c'è grande attesa per le possibilità di ricerca che potrà garantire il telescopio spaziale James Webb della NASA, il cui lancio è previsto per il prossimo anno. I suoi strumenti potranno dire qualcosa sulla composizione dell'atmosfera dei pianeti e sulla loro emissione termica, ponendo dei limiti alle condizioni climatiche presenti sulla superficie.
 «La crisi nel Pd si consuma senza tensione e allarga il solco con gli elettori. Il viaggio in Usa rivela che Renzi non vive la scissione come una disgrazia la crisi del partito democratico».
«La crisi nel Pd si consuma senza tensione e allarga il solco con gli elettori. Il viaggio in Usa rivela che Renzi non vive la scissione come una disgrazia la crisi del partito democratico».
la Repubblica, 22 febbraio 2017
A MENO di tre mesi dall’elezione presidenziale, il centrosinistra francese non è meno diviso di quello italiano. Tuttavia il dibattito offre elementi concreti quasi del tutto assenti nelle cronache delle eterne convulsioni che dilaniano il Pd. Le Monde ha appena pubblicato il programma di Jean-Luc Mélenchon, rivale del candidato ufficiale del Partito Socialista, Benoit Hamon. Entrambi parlano il linguaggio di una sinistra piuttosto tradizionale e le loro ricette suscitano le riserve degli economisti. Tant’è che il pragmatico centrista Emanuel Macron, europeista convinto, li ha superati di slancio nei sondaggi. Quel che conta, però, è lo stile di un dibattito pubblico fondato su proposte chiare, benché spesso discutibili.
Mélenchon si è guadagnato la prima pagina del
Monde annunciando fra l’altro una “rivoluzione fiscale” progressiva che dovrebbe colpire i redditi alti e preservare gli stipendi fino a 4000 euro; nonché una forma di “protezionismo solidale” non del tutto chiara: si capisce che prevede una barriera doganale alle frontiere, nel palese tentativo di frenare il consenso al nazionalismo economico di Marine Le Pen. Ne deriva che il concorrente Hamon viene sollecitato a precisare al più presto le linee del suo programma, come del resto sta già facendo Macron. E al di là della guerra intestina dei candidati, si capisce che lo scontro non è astratto. Ci si sforza di fornire al cittadino le chiavi per una scelta consapevole: da un lato quanti si definiscono “keynesiani coerenti”, dall’altro i liberali/liberisti. Gli uni e gli altri tenuti a rispettare l’elettore.
Al netto della propaganda e delle semplificazioni, il conflitto fra le due sinistre in Francia ha un senso e una logica. Ci sarà poi tempo al secondo turno (niente da spartire con il ballottaggio del nostro ex Italicum) per far convergere i voti sulla figura che si ritiene meno distante dai propri convincimenti. Vale per eleggere il capo dello Stato non meno che i membri dell’Assemblea nazionale. Questa tensione è quasi del tutto assente a Roma, dove si consuma la crisi del Pd. Un rito partitico e trasformista che sembra aver allargato il fossato con l’opinione pubblica. Per cui resta sul tavolo la domanda su cui insiste Emanuele Macaluso, forte della sua conoscenza di vizi e limiti della sinistra: «Qual è l’asse politico- culturale del Pd?». Nessuno lo sa con precisione.
Dopo le giravolte e i proclami di Michele Emiliano («sarò come il Che»), nel mezzo di una stentata scissione che non entusiasma nemmeno i suoi interpreti, all’indomani del generico impegno per una “rivoluzione socialista” sottoscritto da Enrico Rossi, ecco il segretario del Pd che parte all’improvviso per la California — dove visiterà certi impianti fotovoltaici — affermando: «Siamo dispiaciuti ma andiamo avanti». Con ciò confermando di considerare la spaccatura del suo partito più un bene che una disgrazia. Certo non il “suicidio” di cui parlano Prodi ed Enrico Letta. Eppure i primi sondaggi (“Porta a Porta”) indicano che gli elettori del Pd sono parecchio delusi, se è vero che il consenso alla lista risulta in caduta al 22-23 per cento. Plausibile che non tutti i voti in fuga stiano confluendo sull’arcipelago di sigle a sinistra del partito renziano: molti elettori intendono manifestare semplicemente il loro disagio, il loro disincanto. Il che rende lo scenario ancora più oscuro.
È evidente che le macerie del Pd hanno prodotto due correnti di pensiero. Da un lato, chi ritiene irreversibile il danno e fa capire di voler cercare le vie di un “nuovo Ulivo” (ovviamente il federatore non potrà essere Renzi), pur essendo modi e tempi dell’operazione avvolti nella nebbia. Dall’altro, chi intuisce l’inizio di una nuova storia. Il segretario è il capofila di questa tendenza: vede se stesso come il Blair o il Macron italiano. Ma dovrebbe rendersi conto che la proposta del Pd è al momento poco convincente per un numero crescente di italiani. Non esiste una legge elettorale, il rapporto con l’Europa è contrastato e nella prossima legge finanziaria occorrerà raccogliere svariati miliardi di euro per tamponare le falle del bilancio. Tutto ciò mentre la capitale d’Italia è nella paralisi per la serrata corporativa dei taxi appoggiata dai Cinque Stelle.
 «Lo status economico di un individuo rappresenta uno dei maggiori determinanti della salute umana e della longevità, ma resta un fattore di rischio abitualmente ignorato dalle politiche sanitarie internazionali».
«Lo status economico di un individuo rappresenta uno dei maggiori determinanti della salute umana e della longevità, ma resta un fattore di rischio abitualmente ignorato dalle politiche sanitarie internazionali».
il Fatto Quotidiano, 20 febbraio 2017 (p.d.)
Lo stress pisco-sociale, come lo definiscono alcuni scienziati, accorcia la vita. È la tensione a cui è sottoposto chi vive in condizione di costante svantaggio socio-economico che può determinare un calo dell’aspettativa di vita di circa 2 anni, come dimostrano i risultati di uno studio appena pubblicato.
In Italia, una disoccupazione giovanile che supera il 40 per cento, come riportano i dati Istat di fine gennaio, sta condannando intere generazioni a non poter sperimentare la serenità che deriva da un reddito sufficiente e sicuro, tale da lasciar spazio alla progettualità e alla capacità di sognare. Come ha denunciato nella sua ultima tragica lettera Michele, il trentenne che si è tolto la vita a causa di una costante situazione di precariato.
Quando i farmaci non bastano
Per la salute, sperimentare una condizione socio-economica di costante svantaggio rappresenta un fattore di rischio paragonabile a fumo, alcol o obesità. “Perché curare le persone per poi riportarle nelle stesse condizioni che hanno provocato la malattia?” è la provocazione di Sir Michael Marmot, professore di epidemiologia e salute pubblica all’University College of London, nel Regno Unito, che ha dedicato la sua vita a convincere medici e politici che la salute si migliora non solo prescrivendo farmaci, ma intervenendo sulla la qualità della vita delle fasce sociali più deboli.
Lo racconta nel suo libro
“Salute diseguale”, edito in Italia da
Il Pensiero Scientifico. Per primo ha parlato di stress psico-sociale, quel fattore di rischio per la salute determinato dalla mancanza di potere sulla propria vita quando si hanno pochi mezzi economici. Le pillole possono intervenire sull’incendio ormai scoppiato - la malattia - ma non sulle cause che lo hanno scatenato, sostiene, e che lo scateneranno di nuovo, se non migliorano. Se poi peggiorano, come quando si perde il lavoro, l’ipotesi è che l’aspettativa di vita si riduca ulteriormente. Dalle intuizioni di Marmot e dai tanti studi già condotti sull’argomento, è partito il progetto europeo
Life-Path finanziato nell’ambito di Horizon 2020, gestito da un consorzio di ricercatori internazionali (molti dei quali italiani: l’Italia ha una con solida tradizione scientifica in epidemiologia), di cui è coautore anche Marmot.
Ha misurato di quanto esattamente uno status socio-economico svantaggioso riduce l’aspettativa e la qualità della vita. “È noto da tempo che sia un indicatore del calo nella speranza di vita”, spiega Silvia Stringhini, epidemiologa alla Lausanne University Hospital di Losanna, Svizzera, co-autrice dello studio. “Ma il suo impatto non era mai stato confrontato quello dovuto a fattori di rischio noti”. Fumo, tabacco, obesità, scarsa attività fisica, eccessivo consumo di sale, pressione alta e diabete sono considerati i 7 maggiori fattori di rischio legati alle malattie non trasmissibili - come quelle cardiovascolari o il cancro - che possono condurre a morte prematura. Secondo la ricerca, il fumo accorcia la vita di 4,8 anni, la mancanza di attività fisica di 2,4, il diabete di 3,9 e quasi di 1 l’eccessivo consumo di alcol. Lo status socio-economico, mostra la ricerca, è responsabile di una riduzione di 2,1 anni di vita.
I parametri della ricerca
Lo studio è stato possibile grazie ai dati raccolti da precedenti ricerche su 48 popolazioni in Europa, Stati Uniti e Australia negli ultimi 13 anni, per un totale di 1,7 milioni di persone. “Disponevamo di informazioni su parametri legati alle malattie croniche, alle cause di morte e alla classe sociale”, spiega Paolo Vineis, epidemiologo ambientale all’Imperial College of London nel Regno Unito, e coordinatore di LifePath.
Per definire lo status socio-economico, i ricercatori hanno usato come parametro la professione dei partecipanti delle persone sopra i 40 anni. Nel caso di un operaio non specializzato, per fare un esempio, si attribuisce il punteggio più basso. Per un ingegnere, quello più alto. “È un parametro che ci ha permesso di confrontare popolazioni appartenenti a culture e paesi differenti, “spiega Vineis. E che rispecchia anche altri fattori che determinano lo status, come il grado di istruzione e reddito, difficili però da paragonare da nazione a nazione. La ricerca, spiega Vineis, “ha permesso di vedere che c’è un effetto importante sulla mortalità dovuto solo alla classe sociale e non ai 7 fattori di rischio tradizionalmente considerati”.
Cosa sia quel qualcosa in più che ha un impatto sulla mortalità, che Marmot imputa allo stress psico-sociale, e che lo studio LifePath ha ora quantificato, non è ancora compreso a fondo. “Lo studieremo nei prossimi due anni,” spiega Vineis. “Abbiamo informazioni di tipo molecolare su campioni di sangue di quelle popolazioni, su cui studieremo l’impatto che l’ambiente in cui viviamo esercita sul Dna. Una componente importante e innovativa del progetto, racconta Vineis, consiste infatti in indagini epigenetiche sulla modulazione del funzionamento dei geni in diverse migliaia di persone.
Un fattore di rischio “non modificabile”
Lo status economico di un individuo rappresenta dunque uno dei maggiori determinanti della salute umana e della longevità, ma resta un fattore di rischio abitualmente ignorato dalle politiche sanitarie internazionali. Nel 2011 l’Organizzazione Mondiale della Sanità (Oms) ha lanciato un programma che mira a ridurre la mortalità causata da malattie non trasmissibili del 25% entro il 2025, puntando sulla riduzione dell’impatto che i 7 fattori di rischio noti hanno su queste patologie e dunque sulla mortalità. Ma che non considera quello costituito dall’appartenenza alle classi negli ultimi gradini della piramide sociale.
La stessa Oms considera lo status sociale un fattore di rischio non modificabile, a differenza degli altri 7. Sui quali si ritiene di poter intervenire con prescrizioni (smettere di fumare, consumare meno sale, fare esercizio fisico) e attraverso campagne di sensibilizzazione come quelle promosse anche dal Ministero della Salute italiano. “È percepito come più difficile attuare politiche che possano attenuare fattori socio-economici svantaggiosi, politiche che però aumenterebbero la resilienza dell’organismo umano alle malattie,” spiegano i ricercatori di LifePath. “Queste politiche richiedono molti più soldi”, perché prevedono di investire prima di tutto sull’istruzione di base, sul miglioramento dei quartieri disagiati, garantendo maggiori spazi di verde pubblico e una migliore rete di trasporti. “Dal punto di vista della politica, quando ci si limita a intervenire su una scelta individuale appare tutto molto più semplice,” spiegano.
Dal progetto Lifepath stanno emergendo molti articoli scientifici in pubblicazione, raccontano gli autori, ma la principale ambizione consiste nell’influenzare la politica. Per questo, il progetto prevede un gruppo di lavoro presieduto da Sir Marmot che si è riunito in questi giorni a Londra. Con l’esplicito compito di tradurre in politiche i risultati scientifici. “L’appartenenza a una bassa classe sociale nell’infanzia ha un influsso duraturo nel corso di tutta la vita,” spiega Vineis. “È un messaggio politico forte: bisogna investire nei giovani, le coppie in età fertile, contrariamente a quello che molti governi stanno facendo, e investire nell’istruzione per ottenere frutti anche nel settore della salute collettiva sul lungo periodo”.
Italia 2017. Rapporto Tecné/Fondazione Di Vittorio/Cgil. In un paese pessimista crescono le diseguaglianze. Si partecipa alla politica davanti al pc e in poltrona,
il manifesto, 12 febbraio 2017
Paura del futuro, diseguaglianze, bassi salari. Un paese dove si vive male, anche dal punto di vista abitativo, più interessato alla delega che a praticare una solidarietà e un’azione diretta. È il ritratto che emerge nel «Rapporto sulla qualità dello sviluppo in Italia» realizzato da Tecnè e dalla Fondazione Di Vittorio-Cgil. Il ceto medio è più fragile, aumenta la povertà relativa che interessa oggi più di 8 milioni di persone. Cresce la diseguaglianza che resta inferiore al Nord rispetto al Sud. Solo il 31% pensa che la situazione economica dell’Italia migliorerà nel prossimo anno (era il 44% nel 2015). appena l’11 per cento crede che la propria situazione personale registrerà un miglioramento (era il 13%). Il lavoro è sempre più instabile ed è difficile migliorare le proprie condizioni: solo il 24% pensa che l’occupazione crescerà (era il 31% nel 2015).
Si parla di politica, ma si ascoltano meno i dibattiti. Non si partecipa troppo alle manifestazioni, ma cresce l’interesse individuale per le notizie sul paese. Il 66% degli interpellati frequenta gli amici almeno una volta a settimana (era il 67% nel 2015), il 18% ha ascoltato un dibattito politico (era il 20% l’anno scorso), il 4% ha partecipato a un’iniziativa politica (5% un anno fa), l’1% ha svolto attività politica gratuita per un partito. Non va meglio sul fronte sociale e dei diritti: il 2% ha partecipato a riunioni in associazioni ambientaliste e per i diritti civili, il 9% in associazioni culturali e ricreative (ma in queste rientrano anche i concerti e le esibizioni sportive e artistiche a scopo benefico). Va meglio per quanto riguarda le attività gratuite in associazioni di volontariato (11%) che si fanno, però, più sporadiche e meno strutturate. È la politica in poltrona, l’italiano in crisi come Napalm51, la sublime maschera inventata da Maurizio Crozza nei panni di un troll di professione.
Il rapporto parla di «fiducia economica» definendola «uno dei motori più importanti della crescita». Nel complesso l’indice scenda da 100 a 76, con il nord-ovest in testa con 97 punti (120 nel 2015), seguito dal nord-est con 88 punti (erano 134), dal centro con 76 punti (86) e dal mezzogiorno con 56 punti (erano 72). La Lombardia (100 punti) guida la graduatoria, seguita dal Veneto (98) e dalla Liguria (92). Questa categoria è intrecciata a quella di fiducia interpersonale. In un paese diffidente, dove torna a farsi sentire, in rete e non solo, la xenofobia ci si fida di più delle persone vicine, non solo fisicamente ma anche socialmente. Questo ripiegamento di classe si salda con la riscoperta del senso dell’autorità identificata con le forze dell’ordine. Resta bassissima la «fiducia incondizionata».
Poco convincente è l’uso di due categorie neoliberali per indicare lo stato della cooperazione sociale e della produzione culturale: «capitale sociale» e «capitale culturale». Con il primo nel rapporto si intende le reti di relazioni socio-politiche che creano partecipazione. La seconda categoria è bifida: indica sia il patrimonio culturale italiano che potrebbe «rappresentare un grande volano di crescita economica». In pratica, la vecchia idea di Confindustria sulla «cultura come petrolio d’Italia». Singolare è la definizione della scuola intesa come un «sistema meritocratico poco premiante dei talenti». Sono giudicate positivamente la crescita delle imprese che si occupano di infrastrutture e si criticano gli investimenti molto bassi in ricerca e sviluppo (circa l’1% del Pil) e le «imprese innovatrici rappresentano appena il 34%». Un’analisi dei tagli all’istruzione e alla ricerca in Italia, unico paese Ocse che li ha praticati negli anni della grande crisi, avrebbe contribuito a una maggiore profondità.
«Emerge la fotografia di un Paese in cui la ricchezza tende sempre di più a concentrarsi» e in cui le persone vedono sempre più difficile uscire da una situazione di difficoltà – sostiene la segretaria Cgil Susanna Camusso – Dare fiducia evitando dumping e diseguaglianze. Sono questi i tratti essenziali dei due referendum Cgil contro voucher e sugli appalti e della Carta dei diritti universali, sui quali oggi, in tante piazze d’Italia, diamo voce ai diritti del lavoro».
 «Sinistra. Il diritto dei cittadini di andare a votare con leggi costituzionali non è scambiabile con il congresso di un partito. Il rischio del centrosinistra aperto a destra».
«Sinistra. Il diritto dei cittadini di andare a votare con leggi costituzionali non è scambiabile con il congresso di un partito. Il rischio del centrosinistra aperto a destra».
il manifesto, 9 febbraio 2017
Pare che finalmente manchi poco alla pubblicazione delle motivazioni che hanno condotto la Corte Costituzionale ad esprimersi sull’Italicum. Giovedì prossimo i 13 giudici leggeranno la sentenza approntata dal relatore, che verrà resa nota pochi giorni dopo. Se l’essenziale è già stato scritto nel comunicato del 25 gennaio - bocciato solo il ballottaggio mentre restano l’abnorme premio di maggioranza e gli indigeribili capilista bloccati -, le motivazioni potranno forse indirizzare la discussione verso lidi meno incerti e melmosi. Ove allignano ogni sorta di accusa e di mercanteggiamento. Il tutto fa parte di quel clima di restaurazione che si vorrebbe imporre dopo la grande vittoria popolare – non populista - del 4 dicembre.
Il tentativo è quello di derubricare un obbligo/diritto democratico – quello di avere al più presto un parlamento eletto con una legge costituzionalmente legittima – in una querelle politica su chi trarrebbe maggiore profitto da una interruzione della legislatura o dal suo contrario. Così si perpetua la logica politicista e a-democratica che ha guidato le ultime riforme elettorali finite sotto la tagliola della Consulta.
Emergono ora i guasti profondi provocati dal non scioglimento del parlamento dopo la sentenza 1/2014 della Consulta sulla incostituzionalità del Porcellum.
Quest’ultima considerava sì le elezioni avvenute in base a norme illegittime “un fatto concluso”; ribadiva il principio fondamentale della continuità dello Stato e quindi dei suoi organi costituzionali, ma quando si spingeva a esemplificazioni citava solamente la proroga delle camere fintanto che non vengono convocate le nuove (art. 61 Cost.) e nel caso della conversione di decreti – legge già in vigore (art. 77 Cost.). Casi limitati temporalmente che avrebbero dovuto sconsigliare la prosecuzione per ben tre anni dell’attuale parlamento, che ha votato, con l’apposizione della questione di fiducia, una legge elettorale ancora peggiore e la manipolazione del dettato costituzionale. Ma Napolitano aveva altro per la testa, cioè la revisione della Costituzione la cui paternità Renzi gli ha attribuito.
La sonora sconfitta non è bastata. Ora riparte la girandola. Renzi vuole le elezioni a giugno soprattutto perché teme i rimbalzi negativi di una nuova manovra restrittiva nella prossima legge di Bilancio. I suoi messi corrono dalla minoranza del Pd, come da Alfano e Berlusconi per vedere se si può scambiare un voto anticipato a giugno con un premio di maggioranza ad una coalizione anziché ad una lista, con il che si vorrebbe resuscitare il cadavere di un centrosinistra aperto a destra. Davvero lungimirante! Franceschini ha fatto sapere che ci sta. Gli altri della minoranza dem nicchiano, memori del precedente bluff dell’intesa Renzi – Cuperlo.
Rilanciano chiedendo il congresso. Come se il diritto dei cittadini di andare a votare con leggi costituzionali fosse scambiabile con un appuntamento congressuale interno a una forza politica. Ma proprio l’Italicum ha reso di difficile applicazione le regole sulle coalizioni che pure sopravvivono nella normativa elettorale del Senato. La strada del poco astuto mercimonio è irta di difficoltà difficilmente sormontabili. Se si vuole l’armonizzazione tra le due camere, essa non può avvenire che abbattendo le soglie di ingresso troppo alte previste al Senato, che rendono diseguali gli effetti del voto tra i due rami del parlamento e quindi sono incostituzionali.
Ma soprattutto, se si ha a cuore il principio dell’uguaglianza e della libertà del voto (art. 48 Cost.), non si può che eliminare il premio abnorme conferito ad una minoranza del 40% e il sistema dei capilista bloccati (il sorteggio non tura la falla). La Consulta li ha lasciati in piedi, venendo meno alla coerenza con la sua stessa giurisprudenza.
Di un parlamento come quello attuale vi è poco da fidarsi, se lasciato a sé stante. Quindi la lotta non è finita.
I Comitati del 4 dicembre devono restare e sono in campo per una legge elettorale proporzionale priva di distorsioni, che attui il principio della rappresentanza giubilato in questi anni da quello della governabilità, peraltro praticata in modo pessimo con guasti enormi per il Paese.

. Articoli di Bernardo Valli e Michele Giorgio. la Repubblica, il manifesto, Internazionale, 8 febbraio 2017 (c.m.c.)
la Repubblica
NELLE COLONIE FUORILEGGE DOVE ISRAEELE SFIDA IL MONDO
di Bernardo Valli
«Il reportage.proteste ONU e UE dopo il sì del parlamento all’espropriazione diterritori palestinesi»
Forse la storia sta cambiando ancora. Ma accade troppo spesso e pochi ci fanno attenzione. La città era impassibile. Sulla Ben Juda, cuore della metropoli israeliana, le radio diffondevano a tutto volume la cronaca del mattino alla Knesset. Dei giovani coloni, col mitra a tracolla, hanno applaudito quando hanno udito che il loro insediamento, nella Samaria, non era più un accampamento di fuorilegge, ma una cittadina legale. Così ha deciso il Parlamento. Parlavano russo e nessuno gli ha dato retta. Più tardi, alla Porta di Jaffa, scendendo verso il Santo Sepolcro, i mercanti arabi, indaffarati con comitive giapponesi, non ascoltavano quel che le radio dicevano.
Legittime o non legittime le colonie, attorno a Gerusalemme, si moltiplicano come funghi. Il voto eccezionale della Knesset che le promuove, le legittima, non scuote la città araba. Per i palestinesi di Gerusalemme la storia non è cambiata. Loro non hanno sentito l’“effetto Trump”. Eppure alla Knesset c’è stato. Ed è stato provocatorio come il linguaggio del neo presidente. È come se tutto avvenisse ai piedi della Casa Bianca e si udisse la sua voce. Anche se in realtà lui si è ben guardato dall’incoraggiare e ancor meno dal dare la benedizione alla decisione del parlamento israeliano. L’influenza che esercita va oltre le sue parole. È dettata dalle sue virutali o supposte intenzioni.
Con Barack Obama alla Casa Bianca 60 deputati (contro 52) avrebbero esitato ad approvare una legge definita provocatoria in molte capitali anche amiche di Israele. E infatti ne ha tutte le caratteristiche poiché, con valore retroattivo, quella legge legalizza migliaia di edifici costruiti su proprietà private di palestinesi, che sorgono in sedici colonie israeliane di Cisgiordania. Si tratta di insediamenti approvati, protetti quando necessario dall’esercito israeliano, anche se i coloni (circa 700mila tra Cisgiordania e Gerusalemme) sono armati, ma la cui espropriazione di fatto non era mai stata approvata da una legge del parlamento. Erano quindi formalmente illegali. Da ieri mattina non lo sono più.
Ma non si capisce fino o quando saranno legali. La Corte suprema sarà presto investita del caso e potrebbe dichiarare incostituzionale la legge appena approvata dal parlamento. Il procuratore generale ha già fatto sapere che si guarderà bene dal difenderla. Per cui il voto della Knesset appare un colpo di mano ispirato dall’avvento di Trump. Un colpo di mano accompagnato dal dubbio che la legge approvata possa essere applicata. Vale a dire che diventi di fatto un primo serio passo verso una annessione definitiva dei territori occupati da Israele nel 1967, durante la guerra dei Sei Giorni.
L’opposizione internazionale è per ora forte. Il voto dei sessanta deputati israeliani riporta ai momenti peggiori i rapporti tra le due comunità, quella degli occupati e quella degli occupanti. Situazione che dura da mezzo secolo. Quest’anno si potrebbe celebrare il cinquantenario.
Il dinamico Yair Lapid, che punta al posto di Benjamin Netanyahu, ha definito il voto della Knesset «ingiusto, non elegante, dannoso per Israele e la sua sicurezza». Saeb Erekat, il negoziatore palestinese al momento senza lavoro, ha parlato di «un saccheggio della pace che ne affossa le possibilità di realizzarla e cancella la soluzione dei due Stati, uno israeliano e uno palestinese». Altri hanno denunciato il tentativo di annessione della Cisgiordania.
Ad affrettare l’approvazione della legge non è stata soltanto la speranza di poter contare sul Donald Trump, in più occasioni dichiaratosi in favore di Israele, al punto da dare l’annuncio (poi ritrattato o ritardato) di spostare l’ambasciata Usa da Tel Aviv e Gerusalemme, che potrebbe provocare una sollevazione degli arabi, già in aperta tenzone con Trump. Ad accelerare i tempi parlamentari è stata anche la decisione di sfrattare quaranta famiglie di coloni e di demolire le loro case ad Amona, perché da dieci anni giudicate illegali. Per evitare la distruzione di quell’insediamento è stata votata la legge retroattiva di gran fretta.
Benjamin Netanyahu era esitante. Dopo avere accolto con entusiasmo la partenza di Obama e l’arrivo di Trump il primo ministro ha capito che il neo presidente, pur sostenitore della destra israeliana, non poteva inimicarsi il mondo arabo. Ne aveva bisogno nella guerra contro lo Stato islamico e per questo era diventato vago sul trasloco dell’ambasciata Usa da Tel Aviv a Gerusalemme, e aveva invitato a non estendere gli insediamenti in Cisgiordania per non impedire la ripresa del dialogo israelo-palestinese.
Durante la visita a Londra, al primo ministro britannico che insisteva sulla formazione dei due Stati, Netanyahu non ha risposto. Ha sorvolato sul problema. Non ha parlato della possibile creazione di due entità indipendenti. Il silenzio è stato interpretato come un tentativo di non apparire contrario al colpo parlamentare che si stava preparando a Gerusalemme. Fino ad allora, senza manifestare entusiasmo, adottando una accurata riservatezza, il primo ministro non aveva ripudiato del tutto la possibilità remota di creare due Stati. In realtà si adattava alla volontà di larga parte della società internazionale. Al tempo stesso era prigioniero della forte contraddizione di cui era ed è prigioniera la sua società, quella israeliana.
Da un lato, ad ogni sondaggio i cittadini dello Stato ebraico non si dichiarano contrari alla nascita di un Stato palestinese alle porte di casa. Ma i meccanismi politici, alimentati da una classe politica sempre più a destra e sempre più votata, porta in un’altra direzione. La situazione viene descritta in modo irriverente da un intellettuale di Tel Aviv: la soluzione dello Stato palestinese è considerata ineluttabile come la morte, nessuno può negarla, ma tutti la vogliono ritardare. In mille maniere, non sempre confessandolo.
Il caos mediorientale, il mosaico di guerre ai confini, il livello del terrorismo che non decresce, l’instabilità delle frontiere nazionali in tutta la regione, sono tutti fattori che conducono a radicalizzare le posizioni. Non a caso si è praticamente spento il Movimento della Pace che ha avuto un ruolo di rilievo nella vita politica israeliana degli ultimi decenni. Un tempo i giovani scendevano in piazza, anche in divisa militare, per invocare la pace. Oggi pacifista viene spesso tradotto disfattista.
Esitante, preoccupato di non turbare Donald Trump, di cui sarà ospite il 15 febbraio alla Casa Bianca, Benjamin Netanyahu è ritornato da Londra a Gerusalemme lasciandosi alle spalle la finzione dei due Stati e deciso ad adeguarsi alla provocazione che si stava preparando alla Knesset. In parlamento si stava celebrando con il voto retroattivo della legalizzazione di tante colonie l’avvento di Trump alla presidenza americana.
Anche se Trump non è affatto d’accordo con quel voto, che accresce l’inimicizia degli arabi, già furiosi per l’annullamento dei visti, ma necessari come alleati per combattere lo Stato islamico in Siria e in Iraq. La guerra dei Sei Giorni, che nel 1967, portò all’occupazione della Cisgiordnia e di Gerusalemme Est, fece nascere il sogno del grande Israele. Il sogno è diventato un progetto. Alla Knesset, di primo mattino. Si è tentato di realizzarlo almeno in parte.
il manifesto
HANAN ASHRAWI:«LA CORTE DELL’AJA UNICA VIA PER I PALESTINESI»
di Michele Giorgio
«Israele/Territori Palestinesi Occupati. Intervista ad Hanan Ashrawi del Comitato esecutivo dell'Olp e storica portavoce palestinese sull'approvazione della legge che regolarizza gli avamposti coloniali. "Il colpo più duro è l'indifferenza internazionale verso le politiche di Israele"».
La sottovalutazione, se non il disinteresse, dell’Europa per la legge approvata lunedì sera dalla Knesset che ha regolarizzato retroattivamente circa 4.000 case in decine di avamposti coloniali, amplifica la soddisfazione del governo Netanyahu e della destra religiosa alla guida del paese. Il ministro Bennett, leader del partito dei coloni “Casa ebraica”, ha vinto la sua storica battaglia in fondo senza penare troppo.
Ha solo dovuto aspettare qualche anno, l’uscita di scena di Barack Obama (che in verità la colonizzazione l’ha solo frenata e mai fermata), l’ingresso nella Casa bianca dell’alleato Donald Trump e la paralisi della comunità internazionale messa a nudo il mese scorso dall’insulsa dichiarazione finale della Conferenza di Pace di Parigi alla quale il ministro degli Esteri italiano Alfano ha dichiarato con orgoglio di aver dato il suo fattivo contributo.
«È una rivoluzione», ha commentato Bennett. Ha ragione. In due settimane Israele ha autorizzato la costruzione di quasi 6.000 case nelle colonie in Cisgiordania e a Gerusalemme est, annunciato un nuovo insediamento e legalizzato 4.000 case in decine di avamposti.
E il voto della Knesset apre la strada alla estensione della sovranità israeliana alla Cisgiordania. Non su tutta, sulle colonie ma non sui centri abitati palestinesi, per evitare uno Stato binazionale con ebrei e arabi insieme, ha spiegato il ministro Ofer Akunis.
L’apartheid, avvertono anche diversi israeliani, è dietro l’angolo. Ormai è solo cronaca giornalistica il clamore suscitato a dicembre dal “colpo di coda” di Obama che non bloccò con il veto l’approvazione da parte del Consiglio di Sicurezza Onu della risoluzione 2334 che ha riaffermato lo status di territori occupati per Cisgiordania, Gaza e Gerusalemme Est e condannato la colonizzazione. La leadership palestinese intanto è debole, balbetta, non è in grado di elaborare una strategia politica degna di questo nome.
«Questa legge israeliana è inaccettabile», dice Nabil Abu Rudeina, portavoce del presidente Abu Mazen. Un po’ poco.
Non sorprende l’amarezza sul volto di Hanan Ashrawi, membro del Comitato esecutivo dell’Olp e, più di tutto, storica portavoce palestinese durante la prima Intifada e la Conferenza di Madrid.
Scuote la testa Ashrawi: «Il colpo più duro – ci dice – è l’atteggiamento internazionale verso tutto questo».
Cosa potrebbero fare i palestinesi?
Dobbiamo ridefinire la nostra politica e ripensare alle relazioni con Israele. Sappiamo che questo potrebbe costarci caro ma non possiamo rimanere con le mani in mano. E se gli Usa e l’Europa non faranno la loro parte per fermare l’escalation messa in moto dal governo Netanyahu, la strada da percorrere è quella della giustizia internazionale e del ricorso alla Corte penale dell’Aja.
Appaiono però rituali gli appelli che i palestinesi lanciano ogni volta alla comunità internazionale. Non sembrano produrre un granché.
Non possiamo che continuare a rivolgerci all’Onu e invocare la giustizia internazionale. Non dobbiamo stancarci di reclamare i nostri diritti anche se il mondo volge lo sguardo da un’altra parte. I nostri diritti non sono meno importanti di quelli degli israeliani.
Alcuni dirigenti palestinesi hanno minacciato l’annullamento del riconoscimento di Israele fatto dall’Olp venti anni fa. È una possibilità che ritiene concreta?
Tutto è possibile, questa e altre opzioni. Dobbiamo mettere insieme un piano che contempli le diverse possibilità a nostra disposizione e, a mio avviso, dovranno essere discusse pubblicamente.
Queste opzioni includono la fine della cooperazione di sicurezza con Israele?
Anche questa è una possibilità, assieme a molte altre.
Quanto l’ingresso di Donald Trump alla Casa Bianca è stato determinante per l’azione del governo israeliano?
L’elezione a presidente di Trump è stato l’evento scatenante. Netanyahu non parlava d’altro prima del 20 gennaio, nonostante Barack Obama sia stato un presidente molto generoso con Israele, forse il più generoso dal punto di vista politico, finanziario e militare. Il governo israeliano si sente incoraggiato a portare avanti la sua politica da Trump e dalle persone che il nuovo presidente ha scelto per determinati incarichi. A cominciare dal nuovo ambasciatore Usa a Tel Aviv \[David Friedman, aperto sostenitore delle colonie israeliane, ndr\]. Ora abbiamo coloni nel governo israeliano e, di fatto, coloni in quello statunitense.
Il quotidiano israeliano Haaretz ha riferito di avvertimenti dell’amministrazione Trump ai palestinesi: se denunceranno Israele alla procura internazionale perderanno il sostegno finanziario degli Usa e l’Olp tornerà nell’elenco delle organizzazioni terroristiche. È vero?
Non sono in grado di rispondere. Ciò che so è che queste minacce fanno parte di una posizione adottata dal Congresso americano.
È delusa dalla Ue?
Sì, moltissimo. Ci sono voluti ben 30 anni solo per arrivare all’etichettatura diversa dal Made in Israel per le merci delle colonie ebraiche nei territori palestinesi occupati dirette in Europa. E nel frattempo Israele resta un partner privilegiato della Ue, sotto tutti i punti di vista, nonostante le sue politiche nei nostri confronti. L’Europa parla ma poi fa molto poco per difendere concretamente i diritti dei palestinesi.
Internazionale online
PERCHÉ LA NUOVALEGGE ISRAELIANA
SULLE COLONIE FA DISCUTERE
Il 6 febbraio il parlamento israeliano ha approvato in maniera definitiva, con 60 voti favorevoli e 52 contrari, una legge che permette a Israele di legalizzare retroattivamente 3.800 alloggi in Cisgiordania costruiti su terreni di proprietà di palestinesi. Secondo la norma i proprietari non possono opporsi, ma possono chiedere un risarcimento.
Considerata un ostacolo alla soluzione a due stati del conflitto israelo-palestinese, la legge è stata duramente criticata dall’Organizzazione per la liberazione della Palestina (Olp), dalla Lega araba, dalla Turchia, dalla Giordania e dall’opposizione israeliana guidata dal laburista Isaac Herzog, che ha parlato di una possibile incriminazione di Israele da parte della Corte penale internazionale. Il 7 febbraio le autorità europee hanno rimandato un incontro con il premier israeliano Benjamin Netanyahu previsto per il 28 febbraio, che avrebbe dovuto sancire il disgelo nei rapporti tra Israele e l’Unione europea.
Cosa prevede la nuova legge?
La nuova legge, spiega il quotidiano israeliano Haaretz, permette a Israele di espropriare i terreni privati palestinesi in Cisgiordania dove sono già stati costruiti insediamenti o avamposti. Inoltre permette ai coloni ebrei di restare nelle loro case, anche se non diventeranno i proprietari della terra su cui vivono. Impedisce ai palestinesi di rivendicare la proprietà dei terreni o di prenderne possesso finché “non arriverà una soluzione diplomatica che determini lo status dei territori”.
Come si chiama la legge?
La legge è stata chiamata in un modo che può essere fuorviante, scrive Haaretz, perché il nome ebraico può essere tradotto in diversi modi. La traduzione più usata è “legge della regolarizzazione”. L’obiettivo è “disciplinare gli insediamenti in Giudea e Samaria, permettere il loro mantenimento e il loro sviluppo”. Secondo il quotidiano israeliano progressista, un nome più adatto potrebbe essere “legge dell’esproprio”.
Perché tanto clamore?
La Cisgiordania non è comunque sotto occupazione?
La nuova legge supera un limite che Israele non aveva mai oltrepassato. Anche secondo politici conservatori come Dan Meridor, che è stato a lungo membro del Likud, la knesset (il parlamento israeliano) non ha mai affrontato il tema dei diritti di proprietà dei palestinesi in Cisgiordania perché “gli arabi di Giudea e Samaria non votano per la knesset, che non ha l’autorità di approvare leggi in loro nome”. Meridor sostiene che se Israele vorrà esercitare la piena sovranità sulla Cisgiordania dovrà garantire ai palestinesi in quella regione la cittadinanza israeliana e il diritto di voto.
Il procuratore generale di Israele cosa ne pensa?
È d’accordo con Meridor. Avichai Mandelblit ha dichiarato che se qualcuno farà causa contro la legge, lui non la difenderà perché viola la Quarta convenzione di Ginevra. Questo non ha impedito alla ministra della giustizia Ayelet Shaked, del partito di estrema destra Habayit hayehudi (Casa ebraica), di promuovere la legge. Shaked ha detto che, se necessario, incaricherà un avvocato privato di rappresentare il governo in tribunale.
Quanti sono gli insediamenti tutelati dalla legge?
Secondo l’ong Peace Now, saranno legalizzati retroattivamente cinquanta avamposti e insediamenti costruiti con il consenso dello stato di Israele o da coloni che non sapevano di trovarsi su terre private. Tra questi, sedici sono interessati da ordini di demolizione che, in base alle nuove regole, saranno congelati per un anno mentre si valuterà se lo stato può appropriarsi di quei terreni.
La legge autorizza futuri insediamenti?
In teoria, sì. La misura permette al ministro della giustizia di aggiungere altri nomi alla lista degli insediamenti e degli avamposti espropriati, ma solo con l’approvazione della commissione parlamentare Costituzione, legge e giustizia.
In che modo saranno risarciti i palestinesi?
Avranno la possibilità di scegliere, se possibile, un lotto di terra alternativo oppure si vedranno versare ogni anno dei diritti d’uso di quei terreni. A meno che non venga raggiunto un accordo di pace tra Israele e Palestina che risolva anche la questione della proprietà terriera.
Com’è stato l’iter legislativo?
La norma ha ottenuto le prime approvazioni a novembre e a dicembre, ma in seguito il voto è stato spostato varie volte. La ragione principale era la preoccupazione del primo ministro Benjamin Netanyahu riguardo alle ultime mosse dell’amministrazione Obama, tra cui il mancato veto a una risoluzione di condanna del Consiglio di sicurezza dell’Onu, e il timore di cominciare con il piede sbagliato i rapporti con la nuova amministrazione Trump. La legge, però, è stata promossa aggressivamente dal ministro dell’istruzione Naftali Bennett.
Perché la legge è stata rilanciata e votata in tutta fretta la sera del 6 febbraio?
Gli Stati Uniti avevano chiesto a Netanyahu di non fare mosse importanti prima dell’incontro con Donald Trump previsto per il 15 febbraio. Ma Bennett e Shaked, fortemente pressati dalla loro base dopo lo smantellamento dell’avamposto di Amona, hanno respinto ulteriori rinvii. Non potendo fermare l’iter, Netanyahu ha informato rapidamente Trump, nello stesso giorno in cui la premier britannica Theresa May aveva detto al presidente statunitense che la legge era controproducente.
Secondo il New York Times, «mentre i sondaggi mostrano che gli israeliani sostengono ancora la soluzione a due stati, i loro leader e la realtà sul terreno puntano nella direzione opposta: a cinquant’anni dall’occupazione della Cisgiordania e di Gerusalemme Est, molti politici israeliani di destra dicono che ora che i negoziati con i palestinesi sono fermi, è arrivato il momento per Israele di decidere in che direzione procedere».
 «Abbiamo preso alla gente dell’Africa infinitamente più di quanto ci sia chiesto oggi di dare. Non si può ignorare tutto questo quando parliamo di immigrazione: la miseria dell’Africa dipende anche da noi».
«Abbiamo preso alla gente dell’Africa infinitamente più di quanto ci sia chiesto oggi di dare. Non si può ignorare tutto questo quando parliamo di immigrazione: la miseria dell’Africa dipende anche da noi».
il Fatto Quotidiano online, 6 febbraio 2017, (p.d.)
Trovo questa immagine in un archivio. Non posso credere a quello che dice la didascalia: “Congo belga 1904, un padre osserva i piedi e le mani del figlio di cinque anni, tagliati perché non aveva raccolto abbastanza gomma“.
E’ una foto che non si riesce nemmeno a guardare. Sembra impossibile, viene da sperare che sia falsa. Ma ce ne sono altre, tante, di mutilazioni inflitte in Congo dagli europei. Allora forse è giusto riportarla (da
www.rarehistoricalphotos.com) perché non si può dimenticare. Non si devono tacere i disagi che l’immigrazione oggi ci porta. E bisogna affrontarli. Ma questa immagine – come le altre sul Congo di inizio ‘900 – ci costringe a essere obiettivi: ci sono stati decine di milioni di schiavi deportati dai mercanti (europei, anche italiani) e uno sfruttamento selvaggio delle colonie africane compiuto dagli europei (anche da noi italiani). Abbiamo compiuto dei genocidi. Abbiamo cancellato intere generazioni.
Abbiamo preso alla gente dell’Africa infinitamente più di quanto ci sia chiesto oggi di dare: ricchezze, ma soprattutto vite (solo in Congo ci sono stati 10 milioni di morti). Non si può ignorare tutto questo quando parliamo di immigrazione: la miseria dell’Africa dipende anche da noi. Più di mille parole vale questa foto.
Dopo, se ci resta qualcosa da dire, discutiamo.

«La Repubblica
Donald Trump e Paolo Gentiloni si sono parlati per la prima volta al telefono: una breve conversazione, mezz’ora circa, per conoscersi e avviare la discussione su alcune questioni di interesse comune. Il tema più sentito, che ha occupato un terzo della telefonata, è stato la Libia, anche in chiave di lotta al terrorismo. Un argomento su cui Trump ha insistito particolarmente nel corso della conversazione. Gentiloni gli ha illustrato i termini dell’accordo appena stipulato con Tripoli per la lotta contro il traffico di esseri umani e per le politiche dell’accoglienza e la regolazione dei flussi migratori nel rispetto dei diritti umani. Poi hanno discusso della commessa degli F-35, del vertice di Taormina del G7 a maggio, del ruolo della Nato e dell’Unione europea.
I due leader hanno ribadito l’importanza dell’alleanza e della cooperazione tra Italia e Stati Uniti su problemi regionali e globali.Non è ancora chiaro, ovviamente, se si nasconda dell’altro dietro questo giudizio ufficiale. Nelle precedenti telefonate con altri capi di Stato e di governo, infatti, il neopresidente americano aveva dimostrato di voler adottare un stile più battagliero e meno diplomatico: con il premier australiano Malcolm Turnball, ad esempio, si era irritato a tal punto su un accordo per i rifugiati, da buttargli giù il telefono. L’obiettivo di Trump, secondo gli osservatori, è sempre lo stesso: conquistare una posizione negoziale più forte nei confronti degli interlocutori, cercando di metterli sulla difensiva.
È successo così anche con Gentiloni? Certo Trump ha accolto con piacere l’invito di Gentiloni a venire a Taormina con la moglie Melania, in primavera. Il presidente americano, ha detto, sarà felicissimo di partecipare perché l’Italia occupa un bel posto nel suo cuore, grazie anche ai tanti elettori italoamericani che lo hanno votato.
 il manifesto, 22 aprile 2017 (c.m.c.)
il manifesto, 22 aprile 2017 (c.m.c.)








 Piccoli centri e campagne paiono risultare più fragili e indifesi delle città di fronte al vento di Vandea che soffia in tutto il mondo.
Piccoli centri e campagne paiono risultare più fragili e indifesi delle città di fronte al vento di Vandea che soffia in tutto il mondo.