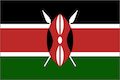Il manifesto, 18 aprile 2015
La tragedia che insanguina la Nigeria da anni rappresentata su un gommone di disperati che rischiano di affondare e pregano il loro dio. Un dio che invece di unirli li divide.
Il gommone barcolla, il «nemico» è al tuo fianco, ti sfiora, mentre invoca il suo dio, non serve nemmeno il machete, basta una spinta e un «kafir» (miscredente) finisce tra le onde. Le minacce non servono: di fronte alla morte chi ha un dio lo prega. E i cristiani del gommone, come i musulmani continuano a pregare. Altri finiscono tra le onde… Dodici muoiono, vittime non del mare, o per mancanza di soccorsi, ma per un proseguimento della guerra che li ha costretti a lasciare il loro paese. Quasi una rappresentazione plastica di un conflitto terribile. Orribile. Ancora di più se avviene su un gommone, perché non hai scampo.
Ma non l’hanno avuto nemmeno le duecento donne rapite da Boko Haram in Nigeria, un anno fa.
La tragedia del gommone avrà delle conseguenze, non solo per i quindici musulmani accusati della strage. La reazione in Italia è stata immediata: la guerra di religione è qui tra noi. Un nuovo motivo per respingere i disperati del mare, per rimandarli indietro, per non lasciarli nemmeno partire, dalla Libia. Ovvero condannarli tutti a morire se non di religione, di fame o di guerra.
Un ulteriore imbarbarimento, tra di noi, non solo in Libia o in Nigeria, ma in Europa. Come se l’Europa non avesse mai conosciuto le guerre di religione, il nazismo, il fascismo (perché questo è il fanatismo di chi fa della religione la legge per eliminare tutti i diversi, anche coloro che credono nello stesso dio, per opprimere le donne) e ora si chiama fuori, mancano le risorse. In nome del dio denaro si lasciano al loro destino i fedeli di Allah, di Dio e quelli che un dio non ce l’hanno nemmeno. Ma l’Italia è immersa nel Mediterraneo e da millenni meta di chi lo attraversa, questa è stata la sua ricchezza non una condanna

Granello di Sabbia , "Fermate il mondo: voglio scendere!", marzo/aprile 2015
Il primo step della difficilissima trattativa che vede protagonisti la Grecia e la Ue si è concluso con un compromesso che dà via libera alla sostanza delle richieste greche. Il confronto è del tutto asimmetrico, per questo molto arduo per la Grecia. La Germania può contare sul sostegno aperto, in qualche caso più realista del re, di diversi paesi. La Spagna e il Portogallo, e finanche l’Irlanda, preoccupati che una vittoria negoziale della Grecia spiani la strada all’affermazione elettorale delle sinistre nei loro paesi afflitti dalla cura dimagrante impostagli. La corona dei paesi nordici, poiché fanno parte del sistema produttivo allargato tedesco. I paesi dell’ex blocco sovietico, spaventati che le riforme greche – come l’aumento del salario minimo - creino un effetto di traino per analoghe rivendicazioni al loro interno. Altri, come l’Italia – che pure Tsipras ha ringraziato come deve fare un buon negoziatore - hanno dispensato sorrisi ma giocato per i tedeschi, mentre la Francia si è mossa troppo tardi lungo una linea timidamente mediatrice.
Ma il fronte dell’austerity non è compatto né invincibile, anche se ancora largamente prevalente. In Germania si è aperta una frattura. La Spd ha preso le distanze almeno dal ministro Schauble. Probabilmente ha pesato su questo atteggiamento l’esito elettorale di Amburgo, negativo per la Merkel, e le pressioni dei sindacati tedeschi, dei quali la Spd deve pure tenere un qualche conto. Contemporaneamente oltreoceano giungono messaggi assai diversi. Obama ha preso con maggiore nettezza la distanza verso le politiche pro-austerity che si conducono in Europa, in coerenza con misure di interesse sociale e contro gli eccessi di ricchezza assunte nel proprio paese.
E’ chiaro che la mossa di Obama va anche letta in chiave elettorale interna. Dopo la sconfitta nelle elezioni di medio termine ha deciso di spingere sull’acceleratore e sta preparando la strada al nuovo o alla nuova candidata democratica alle prossime presidenziali. Ancora più forte è probabilmente per il Presidente Usa la preoccupazione geopolitica. La stessa che lo spinge ad essere estremamente aggressivo sul fronte della questione ucraina, con frizioni con la Germania. Lo preoccupa la crescita di forza e di attrazione della Russia. Non gli sfugge la possibilità che un pericolo molto ravvicinato di default della Grecia o addirittura l’uscita dall’Euro e dalla Ue di quest’ultima, potrebbe spingerla direttamente nelle braccia di Putin.
Come si vede - anche se qui non c’è lo spazio necessario per poterne parlare nel modo dovuto - la vicenda greca e quella ucraina sono molto più legate tra loro di quanto non si creda, pur essendo diversissime tra loro. Entrambi i paesi occupano posizioni geopolitiche ai confini fra occidente e oriente, politicamente più che geograficamente intesi. Si trovano in una posizione di faglia entro quel processo epocale di transizione egemonica tra ovest ed est, che viene accelerato – ma non causato – da questa lunga crisi economica dell’occidente capitalistico, ma che covava da tempo nel contemporaneo decadere del primato economico mondiale degli Usa e nella crescita dei cosiddetti Brics. I primi cercano ovviamente di resistere al loro declino, i secondi spingono con decisione, anche se con tempistiche differenziate. Guerre commerciali e monetarie, accordi vessatori (si pensi al TTIP), guerre civili etero dirette, minacce di estensioni di queste ultime alla dimensione di una vera e propria guerra totale, ne sono la conseguenza più evidente.
L’Europa, a causa delle politiche in essa dominanti, dove grandi sono le responsabilità tedesche, gioca un ruolo negativo in questo quadro, mentre avrebbe ben altre potenzialità. Se torniamo al caso greco, la cosa risulta evidente.
Nella trattativa in corso il governo greco ha guadagnato tempo e ossigeno finanziario, seppure ridotto a quattro mesi. Era questo il principale e più urgente obiettivo per evitare il default e la fuga dei capitali dalle banche greche. La lista di riforme inviata a Bruxelles non contiene tutto il programma di Syriza, ma non lo contraddice e avanza diversi suoi contenuti, specialmente in campo sociale. Lo si vede sui temi dei buoni pasto, dell’energia elettrica e della sanità per i poveri. Nello stesso tempo si parla di estendere il sistema pilota del salario minimo e di progressiva introduzione della contrattazione collettiva. Basta ricordare l’email giunta a dicembre dalla Ue, che conteneva ulteriori tagli alle pensioni e stipendi pubblici, nonché l’abolizione di ogni diritto sindacale, per vedere l’enorme differenza fra il programma della Troika e quanto l’Eurogruppo, non senza scetticismi al proprio interno, ha accettato martedì 24 febbraio.
Tutto bene quindi? No, è solo l’inizio di un lungo braccio di ferro. La Grecia dovrà intanto ottenere quei risultati in termini di lotta al contrabbando di combustibile, alla corruzione e soprattutto alla enorme evasione fiscale, da cui si attende 7 miliardi di euro di entrate, per riaprire il fronte dei prestiti da parte europea che può permettere l’avvio di un nuovo programma economico antiausterity.
E’ evidente che i margini di autonomia decisionale dentro questa Europa sono molto stretti. La crepa aperta dalla Grecia deve perciò allargarsi. E’ quello che le élites neoliberiste europee temono. Sta qui la ragione di tanto accanimento contro un paese il cui debito non supera il 3% di quello dell’eurozona. Una bazzecola quindi. Ma se la linea della Grecia dovesse prevalere si dimostrerebbe che un'altra via è possibile per affrontare il tema del debito. Il fiscal compact e il sistema di governance della Ue crollerebbero miseramente. Non solo. Ma si dimostrerebbe che la Unione europea non può sopravvivere senza darsi degli organismi realmente democratici ed effettivamente decisionali, attraverso i quali la volontà popolare può farsi valere. Se avvenisse sarebbe la sconfitta storica del neoliberismo in Europa. Per questo lo scontro è tanto duro e ci riguarda in prima persona.
La Grecia ha fatto molto, ma non può vincere da sola. E’ indispensabile la coesione interna e la connessione sentimentale fra quel popolo e il suo nuovo governo. Ma altrettanto decisiva è la crescita della solidarietà internazionale, la affermazione dei movimenti e delle sinistre anche in altri Paesi. A cominciare dalla Spagna nel prossimo autunno.

Il manifesto, 16 aprile 2015
Siamo alla conta finale? L’appello delle opposizioni a Mattarella contro il ricorso alla fiducia per la legge elettorale usa parole molto pesanti. Ma non è dubbio che l’arrogante testardaggine del governo, nel lasciar intendere che alla questione di fiducia potrebbe giungersi, ha creato una situazione di straordinaria gravità. In tale ipotesi non saremmo più di fronte a una normale dialettica politica, dura quanto si vuole, ma ad una patente e voluta violazione del regolamento parlamentare. Per questo è bene che il Presidente raccolga l’appello, e dia ad esso seguito nei modi che riterrà opportuni.
Sulla legge elettorale il governo non può porre la fiducia, se viene richiesto il voto segreto (già da alcuni preannunciato). Ce lo dicono con chiarezza gli artt. 49 e 116 del regolamento Camera. Per l’art. 49 il voto è palese, salvo che per alcune materie enumerate in cui è necessariamente segreto, e per alcune altre in cui è segreto a richiesta di almeno 30 deputati (art. 51). Tra queste ultime – voto segreto a richiesta – troviamo appunto la legge elettorale. Per l’art. 116 la questione di fiducia non può essere posta «su tutti quegli argomenti per i quali il Regolamento prescrive votazioni per alzata di mano o per scrutinio segreto». Il che è ovvio, visto che la fiducia si vota per appello nominale. La domanda dunque è: lo scrutinio segreto a richiesta sulla legge elettorale ex art. 49 si configura come voto segreto “prescritto” ai sensi dell’art. 116? O deve considerarsi “prescritto” solo il voto “necessariamente” segreto, e cioè segreto anche in assenza di richiesta?
La risposta è chiara. Anche il voto segreto a richiesta – beninteso, una volta che la richiesta sia stata avanzata – deve considerarsi “prescritto” ai sensi dell’art. 116, e dunque idoneo a determinare la preclusione della questione di fiducia. Bisogna partire dalla considerazione che la modalità di votazione in ambito parlamentare non è mai oggetto di valutazione discrezionale da parte di chicchessia. Che il voto sia segreto o palese non discende da una scelta di opportunità, ma dal dettato regolamentare. Ciò per ovvi motivi di garanzia dei singoli parlamentari e delle forze politiche, in specie di minoranza.
Ci può essere un «dubbio sull’oggetto della deliberazione», cioè un dubbio interpretativo se una fattispecie rientri o meno nelle materie per cui il voto è segreto o palese. Ma, sciolto il dubbio da parte della presidenza dell’assemblea, il voto è obbligatoriamente determinato dalla norma regolamentare. Quindi, la modalità di votazione è sempre «prescritta».
Nel caso, non c’è alcuna possibilità di dubbio interpretativo, poiché la legge elettorale è esplicitamente inclusa nell’elenco delle materie per cui il voto è segreto a richiesta. E pertanto la questione di fiducia rimane preclusa ai sensi dell’art. 116, laddove richiesta di voto segreto vi sia. Spetterà alla Presidenza dell’Assemblea impedire ogni prevaricazione a danno dei diritti dei singoli deputati e delle forze politiche. Essendo chiaro che la Presidenza non si oppone a una scelta politica del governo, ma solo applica — come deve — una inequivoca norma regolamentare.
Dunque, niente fiducia. Si tratta di regole, e non di bon ton politico e istituzionale, che pure vieterebbe in modo assoluto a un governo di vincolare la propria sopravvivenza — attraverso la fiducia — al testo in discussione. In tal modo si certifica infatti che la legge in discussione non è neutrale, ma entra nella dialettica politica distribuendo vantaggi e svantaggi decisivi. Né si tratta di buon senso, che ovviamente dovrebbe trattenere un segretario capo di governo dall’usare la fiducia per mettere la mordacchia a un pezzo del suo stesso partito. Né, ancora, si tratta di dignità politica, che pure richiederebbe, una volta naufragato lo sciagurato patto del Nazareno, di smettere la finzione per cui le riforme da esso generate siano nell’interesse del paese. Né si tratta di correttezza e sensibilità costituzionale, che imporrebbero di non forzare un parlamento già sostanzialmente illegittimo per una sentenza del giudice delle leggi a normare approfittando dei numeri determinati da quella illegittimità.
Né infine si tratta di valutazioni di merito, anche se Napolitano definisce ora un grave errore aver abbandonato il Mattarellum, con ciò lasciando intendere per implicito che l’errore si perpetua quando non si esce dal Porcellum tornando al Mattarellum ma andando all’Italicum, pur necessitato.
Mentre Scalfari afferma su Repubblica che l’approvazione delle riforme renziane uccide la democrazia parlamentare. Due autorevoli testimoni del nostro tempo, che si guadagnano la tessera di gufo onorario.
Abbiamo capito che a Renzi più che il monopoli piace la battaglia navale, soprattutto per la formula «colpiti e affondati». La sinistra Pd ha qui probabilmente la sua ultima occasione. Certo, per loro Renzi è come il meteorite che 65 milioni di anni fa colpì la terra provocando l’estinzione dei dinosauri. Ma vogliamo ricordare a quel che resta della componente Ds nel Pd che i dinosauri lottarono per sopravvivere.
Noi vorremmo almeno che si rispettassero le regole. In un sistema democratico è una premessa indispensabile, senza la quale tutto si riduce a vuota parola. Di forzature e strappi ne abbiamo avuti già troppi, per un nuovismo che in tal modo nulla promette di buono per il futuro. Anche per questo il renzismo non ci piace. E non è affatto questione di fiducia
La Repubblica, 16 aprile 2015
LA PAROLA genocidio pronunciata da Francesco e la reazione turca hanno fatto precipitare questioni cruciali. C’è un problema comune alla definizione del genocidio e della tortura. C’è un’affinità fra il modo in cui la Turchia reagisce all’imputazione di genocidio e l’Italia all’imputazione di tortura. C’è un legame decisivo fra la ferita aperta del 1915 e la persecuzione dei cristiani di oggi. C’è un rapporto fra una disputa che si vuole irriducibile su un genocidio di cento anni fa, e il modo in cui si tratta un genocidio di oggi.
1.
È paradossale che lo sterminio degli armeni, sul quale è stata coniata la nozione di genocidio, non possa chiamarsi genocidio. Il genocidio degli ebrei ha un nome, Shoah, quello degli zingari, Porrajmos, quello degli armeni, Meds Yeghern — ma agli armeni manca il riconoscimento del genocidio. Non so se Francesco avesse messo in conto per intero la reazione turca: il suo discorso è comunque un complemento della denuncia angosciata della persecuzione dei cristiani. Dopo aver esitato, il Papa ha preso una via dalla quale non si torna indietro. Non c’è mai stata una ragione più stringente per non poter non dirci cristiani.
2.
La Corte europea ha condannato l’Italia. Lo farà più inesorabilmente sulla caserma di Bolzaneto, dove si attuò una tortura metodica, prolungata, sessista e fascista. La Corte, all’unanimità, ci ha condannati per il crimine di tortura. Credo che abbia superato i propri precedenti, e che potesse sanzionare le nefandezze di polizia alla scuola Diaz come “trattamenti inumani e degradanti”, rientranti anch’essi nell’art.3 della Convenzione, imprescrittibili al pari della tortura. Per la Corte la sensibilità sulla tortura si affina col tempo, e le minacce — il terrorismo islamista, i venti di guerra — non devono attenuare i principii inderogabili che vietano la tortura e i trattamenti inumani e degradanti. Ha scelto la sanzione più severa — non negli effetti pratici, che si equivalgono, ma in quello morale — rinunciando a una determinazione più specifica della tortura (una violenza individuata e distillata e non collettiva e improvvisa, il fine di ottenere confessioni, il ricorso a tecniche di distruzione della resistenza…) per assicurarne il peculiare marchio di infamia. Ha mirato al paradosso di un Paese, l’Italia, che per trent’anni ha rifiutato di riconoscere tortura e trattamenti inumani o degradanti nel suo codice, mandando impuniti gli autori di crimini per i quali la legge internazionale impone l’imprescrittibilità. Fatte le proporzioni, l’Italia si è comportata con la tortura come la Turchia col genocidio.
3.
Tuttavia è dubbio che allargando le maglie della definizione di tortura se ne rafforzi la sanzione: può derivarne una banalizzazione. Qualcosa di simile avviene con la nozione di genocidio. Il genocidio sta agli altri “crimini di guerra e contro l’umanità” come la tortura sta ai “trattamenti inumani e degradanti”. Anche l’evocazione del genocidio segna un incomparabile marchio di infamia, benché i crimini che “tecnicamente” non vi rientrino siano a loro volta imperdonabili. Il crescente ricorso generico al nome di genocidio sta in proporzione inversa alla sua persecuzione là dove materialmente avviene: lo banalizza.
L’affinità fra tortura e genocidio è più profonda, intima. Sono ambedue difficili da definire con esattezza; ad ambedue è indispensabile il superamento di una soglia di gravità, di dimensione, ma non sufficiente. Che cosa fa della Shoah un genocidio, e dello sterminio dei kulaki no? (La discriminazione “di classe” fu espunta dalla Convenzione sul genocidio del 1948). Che cosa fa dello sterminio dei tutsi in Ruanda un genocidio e dello sterminio delle tribù del Darfur da parte del Sudan e delle milizie Janjaweed “solo” un crimine contro l’umanità? Il genocidio, avvertiva Antonio Cassese, è diventato un “ Magic Word ” cui non si vuole rinunciare, benché i crimini di guerra e contro l’umanità siano atroci a loro volta e abbiano le stesse sanzioni. Per lo sterminio degli armeni si impiega la formula “G-Word”: la parola G. Un tabù proibisce di pronunciarlo intero: come il divieto di nominare Dio, alla rovescia. A questo “G-Word” sono appesi i rapporti fra la Turchia e il resto del mondo.
4.
C’è una montagna, fra Mosul e il Kurdistan, l’abbiamo nominata tante volte, si chiama Sinjar. Vi hanno cercato scampo dopo un’odissea tremenda, decine di migliaia di yazidi. È un popolo antico che ha subito infinite persecuzioni di invasori, così superstiziosi da chiamarlo adoratore del demonio. Il cosiddetto Stato Islamico ha mirato a finire l’opera, uccidendo gli uomini, rapendo violando e commerciando bambine e donne. Era inevitabile, ascoltando i racconti degli scampati, citare I 4-0 giorni del Mussa Dagh, l’epopea degli armeni cristiani rifugiati su quel massiccio montagnoso, scritta da Franz Werfel. Da noi uscì nel 1935, nella Medusa Mondadori: generazioni di italiani conobbero là la tragedia armena.
Oggi i cristiani subiscono le persecuzioni più vaste. Minoranze come gli yazidi subiscono un tentativo di annientamento che non lascia dubbi sulla definizione, per quanto la si setacci, di genocidio. C’è una diaspora yazida che vivrà per vedersi riconosciuta la propria catastrofe. Che non è avvenuta cento anni fa: sta avvenendo. L’abbiamo documentata, abbiamo visto e ascoltato le ragazze fuggite dalla prigionia jihadista, come la bambina di nove anni incinta di cui due giorni fa ancora dicevano le cronache.
Ebbene, a Dohuk, provincia estrema del Kurdistan gremita di profughi, due magistrati hanno costituito una Commissione d’inchiesta per il crimine di genocidio. Sono Sail Khider Khalaf, procuratore, e Ayman Mostafa, giudice. «Vogliamo impedire che il tempo confonda le tracce. Raccogliamo le testimonianze, sugli stupri, i suicidi, gli ammazzati e scomparsi, la compravendita di esseri umani. Un australiano venuto a unirsi all’Is con la famiglia ha comprato 7 persone a Raqqa per 15 mila dinari — 13 euro! Cataloghiamo le fosse comuni man mano che si riconquista il Sinjar; un testimone ha seppellito 64 persone; un altro ha raccontato di averne dovuto coprire 70 col suo bulldozer. Intendiamo portare le prove al Tribunale penale dell’Aia, e riportare da noi la giustizia. Lavoriamo anche coi video dell’Is, e coi selfie che gli uomini di Daesh si fanno sopra le vittime, e li ritroviamo sui loro cadaveri. Manchiamo di risorse e competenze: per la mappatura satellitare, le indagini genetiche, com’è avvenuto in Argentina, a Srebrenica… Voi avete periti, e strumenti adeguati, sappiano che li aspettiamo. Abbiamo a malapena un ufficio. Non c’è un team forense. Ma noi proveremo la volontà genocida, e il mondo dovrà riconoscerla».

«Il furbissimo partito renziano ha colto l’opportunità che gli si offriva per restaurare una nuova età democristiana dove la carità prevarica sulla giustizia e la misericordia ha la meglio sui diritti: provate un po’ a parlare di moschee da costruire o di diritti di cittadinanza per chi vive e lavora da noi». Left, 14 aprile 2015
Come ha osservato di recente Thomas Piketty, i partiti di centrosinistra al governo hanno cessato da tempo di difendere le classi popolari: davanti alla crisi della deindustrializzazione, invece di rafforzare le istituzioni pubbliche e i sistemi di protezione sociale esistenti, i partiti di governo hanno scelto di abbandonare le classi popolari e i ceti medi.
Noi italiani lo sappiamo bene. Scomparso da tempo perfino lo spettro verbale della “patrimoniale”, da noi si fanno avanti ricette come quella di colpire le “pensioni d’oro” e ridisegnare la curva delle pensioni. Sulla pelle dei lavoratori si è abbattuta la cancellazione dell’art. 18, ultima fondamentale conquista della politica dell’abbandono delle tutele e dei servizi pubblici essenziali – si pensi alle ferrovie, alla sanità, alla scuola pubblica e all’università, ai beni culturali e al paesaggio.
Si capisce perché le classi popolari votino per le destre, osserva Piketty pensando al caso francese. Ma in Italia le cose vanno in altra direzione: un partito che si definisce ancora di centrosinistra continua a riscuotere la maggioranza dei consensi, almeno di coloro che ancora pensano di partecipare alle elezioni.
Quella italiana è una variante che non si spiega con la miseria delle destre nostrane ma chiede di essere analizzata. E qui bisogna ricorrere alla celebre formula di Tomasi di Lampedusa: bisogna che tutto cambi perché tutto resti com’era. Formula suggestiva e persuasiva quanto misteriosa. Quel che resta com’era è l’ingiustizia sociale, il rapporto di sopraffazione dei vincitori sui vinti, le classi popolari: quel che cambia è la retorica. Renzi ne offre un buon esempio nel colorare di rosa la realtà.
Si pensi alla storia della ripresa dovuta al Jobs act: una vera invenzione della politica parlata. Secondo Renzi, a inizio 2015 avremmo avuto 82.000 posti di lavoro in più: un segno di speranza. Ma la realtà dei dati Istat ha calato la suo gelida carta: la disoccupazione è salita di nuovo sfiorando il 13% complessivo mentre quella giovanile tocca la cifra terrificante del 42,3%. Comunque, bando alla realtà, l’ottimismo di Stato è necessario. Perché da noi lo stato d’animo diffuso è lo scoramento. Una volta l’orgoglio nazionale scattava quando Coppi e Bartali vincevano il Tour de France. Oggi che la Ferrari è un’azienda in mani non italiane è difficile rivitalizzare l’esultanza del tifo.
Ma c’è nella retorica della comunicazione pubblica qualcosa che è cambiato, contribuendo a che tutto resti com’era. Parliamo di Chiesa e religione. Col papato argentino di Francesco è caduto in desuetudine lo sfacciato legame delle gerarchie ecclesiastiche con gli affari della destra finanziaria più feroce e gaudente incarnata da Berlusconi. Oggi la denunzia delle sofferenze ha trovato un grande amplificatore nell’uomo che fa affluire torme umane in piazza San Pietro; ma si è anche aperta la possibilità di trasformare la protesta in un dolce e gratificante lamento devoto sulla malvagità umana.
Le classi popolari sono ridiventate i poveri del mondo preindustriale. La parola dominante è misericordia. Ci sarà un giubileo col suo nome. Il consenso universale che circonda ogni uscita di Francesco ha molto di ambiguo e di strumentale: se ieri, in mezzo a una massa di indifferenti più o meno credenti, c’era anche qualche laico (magari devoto), oggi ci sono solo devoti, non importa se credenti o meno.
Il furbissimo partito renziano ha colto l’opportunità che gli si offriva per restaurare una nuova età democristiana dove la carità prevarica sulla giustizia e la misericordia ha la meglio sui diritti: provate un po’ a parlare di moschee da costruire o di diritti di cittadinanza per chi vive e lavora da noi.

Il manifesto, 14 aprile 2015
La spesa militare italiana, calcolata al tasso di cambio corrente dollaro/euro, è salita da 65 milioni di euro al giorno nel 2013 a circa 70 nel 2014.
Anche nell’ipotesi che resti invariata nel 2015 (cosa impossibile perché la Nato preme per un aumento), la spesa annuale del 2014 equivale, all’attuale tasso di cambio, a 29,2 miliardi di euro, ossia a 80 milioni di euro al giorno.
Ciò emerge dai dati sulla spesa militare mondiale, pubblicati ieri dal Sipri. Più precisi di quelli del Ministero della difesa, il cui budget ufficiale ammonta nel 2014 a 18,2 miliardi di euro, ossia a circa 50 milioni di euro al giorno. Ad esso si aggiungono però altre spese militari extra-budget, che gravano sul Ministero dello sviluppo economico per la costruzione di navi da guerra, cacciabombardieri e altri sistemi d’arma e, per le missioni militari all’estero, su quello del Ministero dell’economia e delle finanze. L’Italia è al 12° posto mondiale come spesa militare
Nettamente in testa restano gli Stati uniti, con una spesa nel 2014 di 610 miliardi di dollari (equivalenti, all’attuale tasso di cambio, a 575 miliardi di euro).
Stando ai soli budget dei ministeri della difesa, la spesa militare dei 28 paesi della Nato ammonta, secondo una sua statistica ufficiale relativa al 2013, ad oltre 1000 miliardi di dollari annui, equivalenti al 56% della spesa militare mondiale stimata dal Sipri. In realtà la spesa Nato è superiore, soprattutto perché al bilancio del Pentagono si aggiungono forti spese militari extra budget: ad esempio, quella per le armi nucleari (12 miliardi di dollari annui), iscritta nel bilancio del Dipartimento dell’energia; quella per gli aiuti militari ed economici ad alleati strategici (47 miliardi annui), iscritta nei bilanci del Dipartimento di stato e della Usaid; quella per i militari a riposo (164 miliardi annui), iscritta nel bilancio del Dipartimento degli affari dei veterani. Vi è anche la spesa dei servizi segreti, la cui cifra ufficiale (45 miliardi annui) è solo la punta dell’iceberg.
Aggiungendo queste e altre voci al bilancio del Pentagono, la spesa militare reale degli Stati uniti sale a circa 900 miliardi di dollari annui, circa la metà di quella mondiale, equivalenti nel bilancio federale a un dollaro su quattro speso a scopo militare.
Nella statistica del Sipri, dopo gli Stati uniti vengono la Cina, con una spesa stimata in 216 miliardi di dollari (circa un terzo di quella Usa), e la Russia con 85 miliardi (circa un settimo di quella Usa). Seguono l’Arabia Saudita, la Francia, la Gran Bretagna, l’India, la Germania, il Giappone, la Corea del sud, il Brasile, l’Italia, l’Australia, gli Emirati Arabi Uniti, la Turchia. La spesa complessiva di questi 15 paesi ammonta, nella stima del Sipri, all’80% di quella mondiale.
La statistica evidenzia il tentativo di Russia e Cina di accorciare le distanze con gli Usa: nel 2013–14 le loro spese militari sono aumentate rispettivamente dell’8,1% e del 9,7%. Aumentate ancora di più quelle di altri paesi, tra cui: Polonia (13% in un anno), Paraguay (13%), Arabia Saudita (17%), Afghanistan (20%), Ucraina (23%), Repubblica del Congo (88%).
Ogni minuto si spendono nel mondo a scopo militare 3,4 milioni di dollari, 204 milioni ogni ora, 4,9 miliardi al giorno
I dati del Sipri confermano che la spesa militare mondiale (calcolata al netto dell’inflazione per confrontarla a distanza di tempo) è risalita a un livello superiore a quello dell’ultimo periodo della guerra fredda: ogni minuto si spendono nel mondo a scopo militare 3,4 milioni di dollari, 204 milioni ogni ora, 4,9 miliardi al giorno. Ed è una stima per difetto della folle corsa alla guerra, che fa strage non solo perché porta a un crescente uso delle armi, ma perché brucia risorse vitali necessarie alla lotta contro la povertà.
Il manifesto, 14 aprile 2015
<img src="http://ilmanifesto.info/wordpress/wp-content/uploads/2014/03/11/italicum-parita.jpg" />
CONDIVIDI
Può un paese, che ha appena ricevuto la condanna della corte di Strasburgo, permettersi di giocare sulle delicate materie elettorali e costituzionali affidandosi alla giuliva esuberanza di Boschi e di Renzi, che scommettono sull’adozione in ogni angolo del continente delle loro splendide riforme illiberali?
Per ora l’Europa, nel campo del diritto pubblico, ha ricevuto dalla politica italiana solo la riesumazione della tortura di Stato, la fioritura delle leggi ad personam, la comparsa della giustizia penale con ben scolpito un volto di classe. Un’ennesima legge elettorale di segno illiberale e completo sarebbe il quadro della deriva dell’ordinamento.
Al posto di tante chiacchiere di ministri e relatori incompetenti chiamati a redigere le nuove norme per il voto, il parlamento dovrebbe confezionare una legge elettorale non sulla base dei sogni di successo del leader attuale, ma avendo un qualche disegno di sistema. I calcoli di intascare una vittoria certa, manovrando a piacimento le tecniche elettorali, peraltro non portano bene.
Ne fece le spese già un De Gasperi minore, che pagò la forzatura illiberale della legge truffa (premio del 65 per cento dei seggi al “polipartito” coalizzato) con una sconfitta, che accelerò il tramonto di un leader.
In nome della democrazia protetta e dello Stato forte, aveva sospinto il paese nelle incertezze di un conflitto radicale (clima di stato d’assedio a Roma, incidenti alla camera, Ingrao fu manganellato dalla celere, i deputati d’opposizione abbandonarono l’aula cantando l’inno della repubblica). E anche la strana coppia Occhetto-Segni, che aveva ottenuto il permesso di scrivere la nuova legge elettorale sotto dettatura referendaria, uscì di scena con le prime consultazioni maggioritarie. All’ingegneria elettorale di Calderoli non andò meglio.
Una democrazia malata che scrive tre leggi elettorali in vent’anni, e che da dieci lustri convive con una formula giudicata dalla Consulta incostituzionale, dovrebbe muoversi con ben altra responsabilità e cultura delle regole.
Il tempo per un consenso allargato del parlamento dovrebbe essere un imperativo irrinunciabile. E invece il mestiere delle riforme è appaltato a politici dell’improvvisazione che pretendono, con il 25 per cento dei voti, di imporre ad ogni costo, al restante 70 per cento, la regola del gioco fondamentale, quella elettorale escogitata per vincere.
Qualche solerte giurista all’odor di regime incoraggia il premier ad affrontare lo scontro in campo aperto, non esitando a ricorrere al voto di fiducia, che sarebbe un passaggio legittimato dal precedente della legge truffa, quando peraltro il parlamento aveva altri regolamenti. E’ vero che De Gasperi in aula pose la questione di fiducia ma, con il suo gesto (si appellò a «impellenti ragioni di calendario» e a «circostanze straordinarie»), provocò una crisi istituzionale lacerante, che nessuno statista lungimirante può permettersi di scatenare. Lo stesso presidente del consiglio riconobbe che «la fiducia su un disegno di legge non appartiene alla procedura usuale». Il presidente del senato Paratore lo interruppe scandendo: «e non costituisce precedente!».
Colpito dalle accuse del governo, in merito ai suoi sforzi di mediazione, e anche ai suoi cenni di apertura all’ipotesi di un referendum ventilata da Togliatti (si avviò la raccolta di 500 mila firme per la richiesta del referendum, da abbinare alle elezioni politiche con la scelta affidata agli elettori tra l’attribuzione dei seggi secondo la nuova o la vecchia legge), Paratore rassegnò le dimissioni.
Secondo il governo d’allora, il senato avrebbe dovuto limitarsi a prendere atto della legge che riguardava solo le modalità di elezione della camera dei deputati. Ma, come rammentò Umberto Terracini, i precedenti storici smentivano la fretta del governo. Nel 1881–82 il senato non solo discusse i ritocchi alla legge elettorale ma votò emendamenti di cui fu tenuto conto. Le opposizioni si scagliarono contro la pretesa dell’esecutivo centrista di stabilire una data per l’approvazione del testo.
Il senso illiberale della legge truffa, disegnata per arginare quelli che Scelba chiamava «i massicci partiti totalitari», lo colse in pieno il giurista Vittorio Emanuele Orlando che stigmatizzò un’arbitraria propensione del potere in carica, quella di inventare le nuove regole a ridosso delle consultazioni elettorali (il progetto di legge fu presentato solo il 21 ottobre del 1952, con elezioni previste nella primavera del 1953), che purtroppo farà scuola. In una lettera Orlando ammonì: «Considero come disonesta ogni legge elettorale che sia precedente immediatamente le elezioni». E aggiunse: «Ora siccome il governo attuale vuole questo atto disonesto, precede la mia ribellione su questo punto».
I riscontri storici mostrano che non può esserci il sospetto, in un sistema democratico appena decente, di scrivere le regole “disoneste” della contesa sull’abito delle convenienze del detentore congiunturale del potere.
Le riforme, soprattutto se varate da un parlamento illegittimo quanto alla sua composizione alterata dal premio di maggioranza, non si definiscono seguendo le sirene del trionfo annunciato ma ipotizzando anche argini alla banalità del male. In un sistema tripolare, con partiti liquidi e forze a vocazione antisistema, è segno di pura incoscienza contemplare la possibilità che dal ballottaggio esca con i galloni del comando una formazione con il 20 per cento o anche meno dei consensi.
Nell’attuale sistema tutto si è sciolto e non esistono le condizioni reali per una competizione bipolare. Per questo la trovata del ballottaggio di lista perde ragionevolezza, efficacia. Lo scivolamento plebiscitario del Pd, che invoca i presunti mandati imperativi scaturiti dai gazebo, rivela un deterioramento del quadro istituzionale.
Costituisce «un pensiero aberrante», ha scritto Gianfranco Pasquino, l’idea di invocare la disciplina parlamentare sulle riforme, come hanno fatto Renzi, Boschi, persino i giovani turchi. «La disciplina di partito –spiega Pasquino– può essere richiesta ai parlamentari esclusivamente sulle materie inserite nel programma che il loro partito ha sottoposto agli elettori».
Se non una deriva autoritaria, un grave clima di degenerazione dello spirito costituzionale è già operante. Non c’è specialista di sistemi elettorali che non abbia mostrato i limiti strutturali dell’Italicum. Anche tra i giuristi non ostili verso il riformismo di Renzi si riconosce che l’Italicum «è molto simile al Porcellum» e non supera «le obiezioni sostanziali» mosse dalla Consulta, che anzi nel quadro tripartitico «risultano forse aggravate» (A. Marrone, “Il Mulino”, 2014 n. 4, p. 555).
Senza partiti funzionanti, in grado cioè di censurare il leader, di sfidarlo alla pari e di non essere dei passivi nominati agli ordini di chi ha lo scettro, l’Italicum oscilla tra cadute assembleari e velleità cesaristiche. All’elezione diretta del capo di governo, il congegno aggiunge anche il controllo del 55 per cento della camera delineando così un premierato illimitato. Una postmoderna repubblica delle banane con la leadership creata dai salotti della tv.
In questo quadro, è indispensabile la vigilanza critica del Colle, che dovrebbe essere allertato dal costoso precedente della mancata censura preventiva che nel 2006 consegnò il Porcellum viziato dai guasti illiberali denunciati dalla Consulta.
Non si tratta della consueta arte di tirare per la giacca il presidente coinvolgendolo nel gioco politico.
E’ invece l’attesa della rigorosa copertura del ruolo tracciato dalla Carta e che implica l’esercizio del rinvio per regole che emanano il solo dubbio di incostituzionalità. Dinanzi alla volontà di potenza di un partito (diviso) del 25 per cento, che ripropone una legge con antichi vizi (nessuna soglia è prevista per l’accesso al ballottaggio), tocca al Quirinale ripristinare le condizioni minimali di un confronto democratico così gravemente alterato.
«L’impoliticità di papa Francesco mette a nudo l’imbarazzante cinismo degli Stati e dei governi refrattari a assumere la priorità dei diritti umani quando in gioco ci sono interessi economici, militari e geopolitici». La Repubblica, 14 aprile 2015
L’OSTINAZIONE con cui Ankara proibisce ai suoi cittadini di fare i conti con lo sterminio armeno si scontra con il candore di Francesco. Cioè il papa che meno di qualunque altro fra i suoi predecessori si concepisce capo di Stato, assoggettato come tale ai vincoli della realpolitik.
Quasi tutti gli storici concordano nel ritenere la cifra delle vittime, persone uccise o morte di stenti nel corso della deportazione di massa che nel 1915 le ha strappate alle loro case, ampiamente superiore al milione. È altrettanto incontestabile che quel massacro sistematico di un popolo intero, svolse una funzione decisiva nell’ispirare Adolf Hitler: gli fece cioè balenare la possibilità concreta, anche nell’età contemporanea, di concepire una “soluzione finale” di sterminio industrialmente pianificato. A partire dal 1951, dopo un ampio dibattito, le Nazioni Unite hanno deliberato che crimini di questo tipo, miranti all’eliminazione fisica di un’intera popolazione, debbono essere definiti con il termine “genocidio”. Fu un avvocato ebreo di Leopoli, prima ancora che la sua famiglia scomparisse nel gorgo della Shoah, a coniare la parola “genocidio” che gli venne ispirata dalla fine degli armeni nell’indifferenza della comunità internazionale. Lemkin condusse per decenni, in solitudine e con pochissimi mezzi, la sua battaglia per un diritto internazionale adeguato al ripetersi di crimini di Stato. Trovò udienza solo al termine della seconda guerra mondiale, dopo che quella tragedia si era replicata, su scala ancora maggiore, nel cuore dell’Europa.
L’impoliticità di papa Francesco e la reazione furiosa delle autorità turche, stanno provocando un sano cortocircuito. A dimostrazione del fatto che le ferite della storia non si rimarginano mai spontaneamente, che l’atavica legge del più forte non basta più a seppellire la memoria dei vinti. È orribile l’insinuazione di Ankara, secondo cui a influenzare Bergoglio sarebbe stata niente meno che la “lobby armena” insediatasi a seguito della diaspora novecentesca in Argentina. È il solito bieco argomento rivolto contro le vittime che non accettano di rassegnarsi in silenzio, alle quali viene attribuito subdolamente chissà quale potere e volontà sopraffattrice.
Ma l’impoliticità di papa Francesco mette a nudo anche l’imbarazzante cinismo degli Stati e dei governi refrattari a assumere la priorità dei diritti umani quando in gioco ci sono interessi economici, militari e geopolitici. Per fortuna ieri sera il ministro Gentiloni è intervenuto, sia pure con estrema cautela, a rettificare l’infelice sortita di un sottosegretario che non aveva trovato di meglio che bacchettare le parole di Francesco. Rivendicando l’opportunità che il governo italiano, per quieto vivere, releghi il genocidio armeno a mera controversia storica. Niente male per un Paese come il nostro che ha appena introdotto con voto parlamentare il (discutibilissimo) reato di negazionismo storico.
Sappiamo bene quanto sia delicato il tema delle nostre relazioni con la Turchia, soprattutto oggi che l’offensiva jihadista divampa sulle coste del Mediterraneo. Il genocidio armeno fu portato a termine da un regime che stava assumendo il nazionalismo più esasperato come nuova politica di potenza, in sostituzione del Califfato islamico morente, quando ormai stava venendo meno la secolare funzione imperiale del Sultano di Istanbul.
Di nuovo oggi Erdogan aspira a disseppellire il miraggio dell’impero ottomano. Fallito il tentativo di presentarsi come riferimento di nuovi modelli statali islamici, fondati sull’integralismo dei Fratelli Musulmani sconfitti in Egitto e Tunisia, il presidente turco non rinuncia a proporsi come leader del mondo sunnita. Fino al punto di avere intrattenuto una relazione ambigua con l’Is, che troppo a lungo ha potuto utilizzare la penisola anatolica come retrovia. Anche l’inusitata durezza con cui Ankara reagisce alle parole di Francesco, sembra mirata a trasformare la questione armena in fattore di contrapposizione religiosa fra mondo islamico e mondo cristiano.
Evitare di cadere in questa trappola, non ci esime dal tenere duro sui principi su cui si fonda la nostra civiltà occidentale. La quale, per sua natura, di fronte a un genocidio si fa carico del punto di vista delle vittime. Opponendosi alla pretesa di chi vorrebbe rimuovere con la prepotenza una memoria insanguinata. Anche chiamando col suo nome un genocidio.
La candida potenza di Francesco, il vescovo di Roma che rimette in discussione le logiche statuali con cui si è mossa per secoli la Chiesa cattolica, è una potenza davvero inerme. Ma è un richiamo di verità cui neanche la più machiavellica delle diplomazie europee può sottrarsi.

COMINCIO con una citazione dello storico francese Jacques Julliard ne “Le Monde” di venerdì scorso: «Que serait une gauche sans le peuple? Le socialisme, certes, c’est une moral mais doublée d’une empathie populaire. Or une partie du peuple des gauche fait sécession et exprime un vote de désaffiliation. Il y a surtout 50 pour cent d’abstensions, c’est-à-dire une gigantesque crise du politique, un incontestable malaise dans la représentation. Les professionnels de la politique ont rongé la vie democratique».
Non si poteva descrivere meglio quello che sta accadendo in Francia: «Un paysage bouleversé» che anche in Italia presenta esattamente la stessa crisi: i professionisti della politica stanno distruggendo la democrazia, la sinistra sta perdendo l’appoggio popolare e la sinistra senza il suo popolo non esiste più.
Ed ora citerò un grande discorso che De Gasperi tenne in Parlamento il 17 gennaio del 1953, alla vigilia del voto sulla legge elettorale che pochi mesi dopo fu battuta dalle opposizioni di destra e di sinistra. Fu chiamata legge truffa, ma non lo era affatto; dava un premio al partito o alla coalizione che aveva ottenuto il 50,1 per cento dei voti. «Questa legge non trasforma la minoranza in maggioranza. Se così facesse sarebbe un tradimento della democrazia. Si limita a rafforzare la maggioranza affinché sia più solida e possa governare come è suo diritto. Ma se perdesse il 50 meno un voto sarebbe sconfitta da chi invece prendesse due voti di più. Vi sembra che questa sia un’intollerabile sopraffazione?».
COSÌ diceva De Gasperi. Mettete insieme questi concetti espressi cinquantuno anni fa e quelli de Le Monde di tre giorni fa e vedrete una perfetta identità di ragionamento che descrive in tutta la sua evidenza lo stato della democrazia nel nostro Paese, aggravato in più da altri due fatti salienti: l’abolizione del Senato e una legge elettorale che non solo trasforma in maggioranza una minoranza cui mancano dieci punti percentuali per arrivare al 50 più uno, ma che è anche una legge di «nominati».
Le conseguenze di queste decisioni che stanno per essere approvate tra pochi giorni sono di fatto l’abolizione della democrazia parlamentare. Un Parlamento di «nominati» in un sistema monocamerale è una «dependance» del potere esecutivo che fa e disfà senza più alcun controllo salvo quello della magistratura se dovesse trovare un reato contemplato dal codice penale.
Resta naturalmente la Corte costituzionale ma anch’essa può finire con l’essere una Corte nominata dall’esecutivo se desse troppa noia all’autoritarismo d’un governo a sua volta sottomesso alla decisione d’un autocrate e del suo cerchio magico. Gli interessati si sono assai doluti perché avevamo usato il termine di democratura per descrivere l’essenza di quanto rischia di accadere. Ma quale altra parola lo descriverebbe in modo più appropriato?
Aggiungeteci la ciliegina che riguarda la dipendenza della Rai dal governo che sta per essere decisa tra poche settimane e avrete una gustosissima torta che saranno in pochi a gustare.
Detto questo ci sono questioni economiche e sociali altrettanto urgenti e importanti da affrontare. Comincerò spiegando che cosa è e da dove proviene quel cosiddetto tesoretto di un miliardo e 600 milioni che improvvisamente il presidente del Consiglio ha estratto venerdì scorso dal cilindro tra la sorpresa del Consiglio dei ministri che stava esaminando la legge di stabilità presentata dal ministro dell’Economia.
A leggere la maggior parte dei giornali le madri del tesoretto sarebbero il miglioramento del Pil, la ripresa dell’occupazione, il mutamento delle aspettative e gli effetti che questo determina sui consumi e sulla domanda. Ebbene, non è così. Il tesoretto viene dagli effetti della manovra monetaria di Mario Draghi che come primo risultato ha prodotto un ribasso consistente del rendimento dei titoli pubblici e quindi una diminuzione di circa due miliardi di euro negli oneri che il Tesoro sopporta per pagare gli interessi sui titoli in circolazione.
Due settimane fa avevo chiuso il mio articolo scrivendo «meno male che Draghi c’è». Non voglio ripetermi, del resto i fatti stanno a provarlo e non solo per quanto riguarda l’Italia ma l’Eurozona nel suo complesso.
Un altro problemino da chiarire riguarda il Jobs act e il ministro Poletti, che chiacchiera molto e spesso a sproposito. Quale giorno fa, citando fonte Istat e interpretandola a suo modo, informò la pubblica opinione che il primo bimestre di quest’anno, paragonato al corrispondente bimestre dell’anno scorso, registrava una crescita dell’occupazione di oltre 79 mila unità. Poco ma buono, un inizio d’anno comunque confortante.
Gli fu obiettato che doveva tener conto dei contratti stipulati sulla base del Jobs act ma non aveva tenuto conto dei licenziamenti che erano stati nel frattempo effettuati. E così si scoprì che, fatte le debite sottrazioni, il saldo tra nuove assunzioni di precari e licenziamenti era di 44 mila occupati in più.
Molto poco ma pur sempre una cifretta positiva e comunque un indizio confortante che sarebbe certamente aumentato con rapidità. Ma poi, impietosamente, ieri sono usciti i dati dell’Inps sull’occupazione nel suo complesso. Va infatti chiarito che i contratti sulla base del Jobs act non sono vere e proprie assunzioni ma semplicemente un consolidamento di alcune forme di precariato con contratti a tempo indeterminato per tre anni, salvo la facoltà di licenziamento alla scadenza del triennio.
L’Inps invece parla di occupazione e disoccupazione vera e propria, chi lavora sotto qualunque forma contrattuale e chi non lavora affatto. Anche qui il saldo è positivo e sapete qual è la cifra: 13 persone in più. La scrivo in lettere per esser sicuro che la lettura sia corretta: tredici persone in più. Una cifra che percentualmente è espressa con il numero zero perché non è matematicamente percepibile come percentuale.
Questo fatto conferma che Jobs act è una buona legge se e quando riprenderanno investimenti e domanda, ma finché questo non accadrà il Jobs act è un oggetto esposto in vetrina. Gli imprenditori lo guardano ma in vetrina rimane.
Salvo un punto: ha abolito l’articolo 18 per i lavoratori che saranno assunti con quella legge. Proposta da un partito che si proclama di centrosinistra mi ricorda la citazione poc’anzi riportata di Julliard: la sinistra senza popolo è morta. Renzi sostiene che si tratta di una sinistra nuova, moderna, cambiata e forse è vero. Però a me ricorda alcuni personaggi che provenivano tutti dal socialismo e che instaurarono qualche cosa che somiglia molto alla democratura. Si tratta di Crispi, Mussolini, Craxi. E chiedendo scusa ai tre precedenti (come ho già detto tutti e tre provenienti dal socialismo) mi viene anche da aggiungere Berlusconi che ai tempi del suo sodalizio con Bettino si proclamava socialista anche lui.
Io speriamo che me la cavo, è un vecchio detto sempre attuale di fronte a rischi di tal genere.
In questi ultimi venti giorni sono accaduti fatti orrendi nel mondo: la strage di massa del cosiddetto Califfato che avviene in tutto l’agitatissimo Medio Oriente ma anche in Europa; il fondamentalismo nelle religioni, la strage-suicidio nell’aereo della Lufthansa voluta da un pazzo; il massacro di un altro pazzoide al tribunale di Milano, il tema della tortura e quello della corruzione.
Secondo me c’è stata una sola stella in un cielo così denso di nuvole nere: la stella è papa Francesco, il solo in grado di gestire il presente con lo sguardo verso il futuro. Chi vive il presente e non vede il tempo lungo, chi ama il potere per il potere e non guarda al bene dei figli e dei nipoti, rischia di annaspare in una palude di acque morte.
È quello il rischio, è quello il pericolo che ci sovrasta e neppure Francesco riuscirà ad evitarlo.
Noi abitiamo un Paese di grandi individui e di grande civiltà ma pochi ne hanno goduto. Una aristocrazia di geni che ha educato attraverso i secoli un popolo di persone consapevoli e responsabili, un popolo sovrano ma minoritario in patria. Il resto era plebe fatta di poveri, di deboli, di esclusi, ma anche di corrotti, di tiranni, d’avventurieri, di buffoni e di voltagabbana.
Questo avviene in tutto il mondo, la violenza, la cupidigia, l’avidità, l’avarizia di sé sono dovunque è l’animale uomo, bestia pensante che oscilla di continuo tra l’istintoanimalesco e la coscienza, il bene suo e il bene degli altri. Stiamo attraversando un fine d’epoca dominata dall’egoismo. Non potrebbe essere altrimenti, quando un’epoca tramonta e la nuova non ha ancora preso forma e creato nuovi valori.
Ho scritto molte volte queste riflessioni e mi scuserete se le ripeto. Non sono certo un oracolo e spero sempre di sbagliarmi, ma i fatti purtroppo mi danno ragione o almeno così mi sembra.
Può darsi che la comunicazione di massa che mai prima d’ora aveva raggiunto questa intensità, sottolinei le cattive notizie e trascuri le buone. Comunque suscita nuovi istinti e nuovi pensieri.
L’elemento dominante nel mondo di oggi è la società globale. Questo è il tema del quale tutti dovremo tener conto. Facciamolo questo sforzo: è già il presente ma richiede tempo lungo per essere costruito a misura dell’uomo e non della bestia dalla quale proveniamo.
La Repubblica, 9 aprile 2015
Quale onta peggiore per uno Stato della condanna per aver torturato suoi cittadini? E cos’altro deve accadere per affermare un elementare principio di responsabilità? Quale azienda, quale gruppo sociale lascerebbe ai suoi vertici chi era alla guida del corpo che ha scritto una pagina così vergognosa da procurare la più infamanti delle censure? Per questo il j’accuse di Matteo Orfini verso De Gennaro non dovrebbe destare scalpore. Essendo se mai il minimo sindacale già all’indomani dei terribili fatti di Genova, e tanto più oggi dopo la vergogna nazionale subita con la condanna della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo.
Non si tratta qui di responsabilità penale, visto che De Gennaro è stato assolto con l’applicazione degli strumenti a disposizione dei giudici. Si tratta, ben più semplicemente, di responsabilità senza aggettivi. Se guido un corpo dello Stato che può essere anche il più meritevole, e se pure io stesso fossi il più medagliato dei funzionari, e quel corpo si rende attore di una così grave nefandezza, non ci sono alternative, la mia responsabilità deve essere pubblicamente riconosciuta al di fuori e a prescindere da ogni profilo civilistico, penalistico o contabile. Responsabilità, appunto, senza aggettivi. È una regola che dovrebbe valere per tutti.
Non solo: la Corte di Strasburgo ha messo all’indice anche l’inqualificabile condotta successiva della polizia, di autentico ostruzionismo nella individuazione delle responsabilità dei “torturatori”. I giudici europei hanno infatti censurato come la mancata identificazione degli autori dei pestaggi sia derivata dalla «mancanza di cooperazione della polizia», essendo costretta la Corte ad aggiungere il suo autentico stupore «che la polizia italiana abbia potuto rifiutarsi impunemente di apportare alle autorità competenti la cooperazione necessaria all’identificazione degli agenti suscettibili di essere implicati negli atti di tortura».
Anche di questa clamorosa omissione di collaborazione con lo stesso Stato che la polizia rappresenta, è possibile che nessuno debba pagare? Matteo Renzi dice che la risposta sarà l’approvazione della legge sul reato di tortura. Ma si tratta di risposta a metà perché abbandona del tutto il campo del principio di responsabilità che Stato e Governo dovrebbero mettere al primo posto, per non perdere ogni credibilità nei confronti dei cittadini. Peraltro anche la legge, dopo inaccettabile ritardo, rischia di nascere claudicante con il testo uscito dalla commissione della Camera che appare confondere quello approvato dal Senato, allungando peraltro i tempi del varo definitivo. Già a Palazzo Madama infatti si trovò un punto di equilibrio tra la iniziale proposta di Luigi Manconi, che voleva una fattispecie dedicata esclusivamente all’abuso di violenza delle forze dell’ordine, e le esigenze manifestate dai sindacati di polizia di evitare una sommaria criminalizzazione.
Ora però la commissione di Montecitorio chiede all’Aula di condizionare l’accertamento del reato ad una indagine sulle finalità della “tortura” (per estorcere dichiarazioni ovvero per irrogare una impropria punizione), con il rischio paradossale di lasciare fuori la peggiore delle ipotesi che è quella dell’accanimento sadico fine a se stesso, della violenza puramente bestiale. Esattamente come quella avvenuta a Genova. Rischiamo quindi dopo il danno, la beffa di varare una legge che avrebbe difficoltà a punire proprio vicende come quella sanzionate da Strasburgo. Dipende tutto dal Pd che alla Camera può molto semplicemente approvare il testo così come uscito dal Senato, dando almeno una delle risposte che non solo l’Europa ma una elementare coscienza civica ci impone. È lecito attendersi qui da Renzi una determinazione almeno analoga a quella che manifesta sul ben più controverso Italicum.
È il minimo che possiamo pretendere dallo Stato dopo che si è troppo a lungo aspettato, troppo a lungo negato. Affidandoci ancora una volta solo alla supplenza della magistratura peraltro privata di strumenti e ostacolata nei suoi accertamenti, come Strasburgo ha dovuto infine censurare. E pure sarebbe bastato, davanti alla clamorosa evidenza dei fatti, dire «lo Stato chiede scusa ai suoi cittadini, rimuove e non promuove chi aveva posti di responsabilità ». Ed essere per una volta conseguenti. Sarebbe stata a ben vedere anche la migliore autentica difesa dello Stato e della sua Polizia.
l manifesto, 9 aprile 2-15
Ad Auschwitz, uno dei monumenti più notevoli tra quelli dedicati alle varie comunità degli internati è il cosiddetto «Memoriale Italiano». Un paio di anni or sono le autorità polacche decisero di chiuderlo al pubblico, nel silenzio del governo italiano, e dell’Aned, in teoria proprietaria dell’opera. Pochi mesi fa la sovrintendenza del campo, ormai museo, ha deciso di procedere alla rimozione del Memoriale. La sua colpa? Quella di ricordare che nei lager non furono soltanto deportati e sterminati gli ebrei, ma gli slavi, i sinti, i rom, i comunisti insieme a socialdemocratici e cattolici, gli omosessuali, i disabili. Quel Memoriale opera egregia, alla cui ideazione, su progetto dello studio BBPR (Banfi Belgiojoso Perussutti Rogers, il prestigioso collettivo milanese di cui faceva parte Ludovico Belgiojoso, già internato a Buchenwald) collaborarono Primo Levi, Nelo Risi, Pupino Samonà, Luigi Nono…, ha dei «torti» aggiuntivi, come l’accogliere fra le sue tante decorazioni e simbologie anche una falce e martello, e una immagine di Antonio Gramsci, icona di tutte le vittime del fascismo.
Ora, ai governanti polacchi, desiderosi di rimuovere il passato, disturbano quei richiami, agli ebrei il fatto che il monumento
metta in crisi «l’esclusiva» ebraica relativa ad Auschwitz. Ed è grave che una città italiana, Firenze, si sia detta pronta ad accoglierlo. Contro questa scellerata iniziativa si sta tentando da tempo una mobilitazione culturale, che si spera possa avere un riscontro politico forte e oggi su questo si svolgerà nel Senato italiano una iniziativa di denuncia promossa da Gherush 92-Committee for Human Right e dall’Accademia di Belle Arti di Brera. Spostare quel monumento dalla sua sede naturale, equivale a trasformarlo in mero oggetto decorativo, mentre esso deve stare dove è nato, per il sito per il quale fu pensato, a ricordare, proprio là, dietro i cancelli del campo di sterminio, cosa fu il nazismo e il suo lucido progetto di annientamento, che, appunto, non concerneva solo gli ebrei, collocati in fondo alla gerarchia umana, ma anche tutti gli altri popoli, giudicati essere «razze inferiori» come gli slavi, o i nemici del Reich, comunisti in testa, o ancora gli «scarti» di umanità, secondo le oscene teorie degli «scienziati» di Hitler.
Insomma, la rimozione del Memoriale, è una rimozione della memoria e un’offesa alla storia. Ebbene, l’atteggiamento dell’Aned e delle Comunità israelitiche italiane, che o hanno taciuto, o hanno approvato la rimozione del Memoriale (in attesa della sua sostituzione con un bel manufatto politicamente adattato ai tempi nuovi), appare grave.
E in qualche modo richiama le polemiche di questi giorni relative alla manifestazione romana del 25 aprile.
Premesso che la cosa «si svolgerà di sabato», e dunque, come ha pretestuosamente precisato il presidente della Comunità israelitica romana, gli ebrei non avrebbero comunque partecipato, la denuncia che «non si vogliono gli ebrei», è un rovesciamento della verità: non si vogliono i palestinesi. Ed è grave l’assenza annunciata dell’ANED, per la prima volta, anche se la bagarre si è scatenata sull’assenza della «Brigata Ebraica». La quale ha le sue origini remote niente meno in Vladimir Jabotinsky, sionista estremista di destra con legami negli anni ’30 mai smentiti con Mussolini, che convinse le autorità britanniche, nella I guerra mondiale, a dar vita a una Legione ebraica. Nel II conflitto mondiale, fu Churchill a lasciarsi convincere a organizzare un Jewish Brigade Group, inquadrato nell’esercito britannico: 5000 uomini che operarono in particolare nell’Italia centrale, contribuendo alla liberazione di Ravenna e di altri borghi. Ebbe i suoi morti, e le sue glorie. Bene dunque celebrarla. Ma non fu né avrebbe potuto avere un ruolo eminente, come sembrerebbe a leggere certe dichiarazioni. Ma il fuoco mediatico supera il fuoco delle armi. E che dire di ciò che avvenne dopo? Come storico ho il dovere di ricordarlo. Quei soldati divennero il nucleo iniziale delle milizie dell’Irgun e del Haganah — quelle che cacciarono i palestinesi nella Nakba — e poi dell’esercito del neonato Stato di Israele, al quale offrirono anche la bandiera.
Si capisce l’imbarazzo dell’Anpi di Roma, tra l’incudine e il martello. Ma quando leggo che il suo presidente afferma che «i palestinesi non c’entrano con lo spirito della manifestazione», mi vien voglia di chiedergli se gli amici di Netanyahu c’entrino di più. Altri hanno dichiarato in questi giorni che bisogna lasciar parlare solo chi ha fatto la guerra di liberazione; ma se così intanto andrebbero cacciati dai palchi tanti tromboni in cerca di applausi; e soprattutto se si adotta questa logica è evidente che tra poco non ci sarà più modo di festeggiare il 25 aprile, perché, ahimè, i partigiani saranno tutti scomparsi.
E allora — visto l’articolo 2 dello Statuto dell’Anpi che rivendica un profondo legame con i movimenti di liberazione nel mondo — come non dare spazio a chi oggi lotta per liberarsi da un regime oppressivo, discriminatorio come quello israeliano, rappresentato ora dal governo di destra di Netanyahu? Chi più dei palestinesi ha diritto oggi a reclamare la «liberazione»? E invece temo si vada verso questo (addirittura in queste ore in forse a Roma) e i prossimi 25 Aprile ingessati e reistituzionalizzati.

Il manifesto, 4. aprile 2015
Abbiamo raggiunto al telefono negli Stati uniti Noam Chomsky. Linguista, anarchico e filosofo del Massachusettes Institute of Technology, Chomsky è autore di pietre miliari del pensiero moderno e teorico per una profonda critica del sistema mediatico. Memorabile è il suo dibattito sulla natura umana con Michel Foucault (1971). Abbiamo discusso con Chomsky dell’intesa preliminare sul programma nucleare iraniano, raggiunta giovedì a Losanna e della situazione del Medio Oriente.
Che ne pensa di questa danza sul nucleare iraniano, andata avanti per dodici anni?
L’Iran sospetta che nonostante l’accordo, i Repubblicani si rifiuteranno di cancellare le sanzioni. E così l’obiettivo principale delle autorità iraniane è che le sanzioni non siano sotto il controllo del Congresso: questa sarebbe una tragedia. Vedremo se questo punto ci sarà nel testo definitivo. La mia sensazione è che tutto il negoziato sul nucleare sia una farsa. Non c’è nessun motivo per cui l’Iran non possa avere un programma nucleare secondo il Trattato di non proliferazione (Tnp) che ha sottoscritto.
Perché parla di farsa in riferimento ai colloqui sul nucleare?
Gli Stati uniti e i suoi alleati affermano che la comunità internazionale ha chiesto all’Iran di fare delle concessioni per arrivare a un’intesa. Ma i Paesi non allineati, che rappresentano il 70% della popolazione mondiale, hanno sempre sostenuto gli sforzi nucleari iraniani. Eppure la propaganda occidentale è uno strumento potente, per questo è andata avanti per tanto tempo questa farsa.
La soluzione della controversia potrebbe disinnescare il settarismo che infiamma il Medio Oriente?
La questione centrale è che gli stati sunniti sono i principali alleati degli Stati uniti. Gli amici degli Usa sono i fondamentalisti più estremisti e vogliono dominare la regione. L’Iran è un grande paese, e come la Cina, aspetta per avere un’influenza nella regione. Ma l’Arabia Saudita non vuole mai e poi mai un antagonista, un deterrente. Anche se l’Iran avesse l’atomica, quale sarebbe la preoccupazione per gli Stati uniti? Si tratterebbe solamente di un deterrente. Nessuno pensa che mai e poi mai l’Iran potrà fare uso dell’arma nucleare, perché il paese sarebbe vaporizzato all’istante e gli ayatollah di certo non vogliono suicidarsi. Un Iran con il nucleare sarebbe solo un deterrente contro l’aggressività di Israele nella regione. È questo che gli Stati uniti non vogliono.
Ma Netanyahu non passa giorno che non gridi contro l’intesa con l’Iran e ora la respinge?
Israele persegue una politica sistematica di conquista di tutto quello che vuole per integrarlo nella Grande Israele in violazione dei trattati di Oslo. Gaza è devastata. Queste politiche sono appoggiate dagli Stati uniti e, se continueranno a sostenere Israele, non cambieranno mai. In queste settimane, tutta la stampa mainstream Usa ha pubblicato articoli in cui si chiedeva agli Stati uniti di attaccare l’Iran. Perché la stampa iraniana non fa lo stesso? Il presupposto occidentale è l’imperialismo. In nome di questo principio all’Occidente tutto è permesso.
Esistono due posizioni opposte tra Repubblicani e l’amministrazione Obama nei conflitti in Medio oriente?
I Repubblicani sono un partito fascista. Lo stesso Barack Obama è terribile ma meno dei Repubblicani. Il principale errore di Obama però è la sua campagna con i droni. Se l’Iran facesse lo stesso contro gli ufficiali citati negli articoli della stampa Usa, come reagirebbero gli Stati uniti? La guerra dei droni è la più grande operazione terroristica mai esistita: programmata per uccidere chiunque sia sospettato di poterci danneggiare. Le operazioni con droni in Pakistan faranno crescere il numero dei jihadisti. Quando hanno iniziato, al-Qaeda era solo nelle zone tribali di Afghanistan e Pakistan ora è in tutto il mondo. Ma di questo non si può parlare nei media occidentali.
Crede che bisogna temere l’avanzata degli Houthi in Yemen?
In Yemen è vero che l’Iran dà sostegno agli Houthi, lo stesso fa l’Arabia Saudita con i suoi, sebbene alla fine si tratti di un conflitto interno. Nella propaganda occidentale però se gli Stati uniti sostengono una forza quella è legittima. In Iraq, l’Iran sostiene il governo eletto. I consiglieri iraniani formano la classe dirigente irachena e sono protagonisti delle principali battaglie nel paese. Il governo iracheno ha chiesto l’aiuto iraniano e ringrazia le sue autorità. Ma gli Stati uniti condannano l’influenza iraniana in Iraq: è davvero comico.
Crede che questo atteggiamento occidentale alimenti il terrorismo dello Stato islamico?
Lo Stato islamico è una mostruosità, ma non è niente di più che una società off-shore dell’Arabia Saudita che propaga una versione estremista, wahabita, dell’Islam. Da Riad arrivano tonnellate di soldi e l’ideologia per diffondere il fondamentalismo nel mondo arabo. Certo a questo punto neppure ai sauditi piace quello che hanno creato. Questa è la conseguenza diretta dei devastanti attacchi degli Stati uniti in Iraq del 2003 e degli attacchi della Nato in Libia del 2011 che hanno esasperato il conflitto sunniti-sciiti diffondendolo in tutta la regione. In Libia questo ha comportato l’incremento del numero di milizie e una quantità di armi senza precedenti che provengono da Africa e Medio oriente. I bombardamenti della Nato hanno fatto aumentare il numero delle vittime di dieci volte, hanno distrutto la Libia. In Yemen ora Arabia Saudita ed Emirati stanno uccidendo una grande quantità di persone nei campi profughi. Ma anche questa guerra è destinata a fallire e non può comportare altro che la diffusione del jihadismo.
Pochi mesi fa non parlavamo di terrorismo ma di «primavere». Esiste un rapporto tra i movimenti sociali europei e le rivolte in Medio Oriente?
Ci sono delle similitudini. Il maggior esempio del passato è l’America latina: completamente sotto il controllo degli Stati uniti che imponevano dittatori dappertutto. Ora il Sud America è abbastanza libero dal controllo straniero. Questo è uno sviluppo di grande importanza. Molti politici latino-americani sono legati ai partiti Podemos in Spagna e Syriza in Grecia. Combattono tutti la stessa battaglia contro il neo-liberismo. Ma la reazione tedesca alla vittoria di Tsipras in Grecia è selvaggia, ipocrita. Nel 1953 l’Europa concesse alla Germania di tagliare gli interessi sul debito. Ma ora impone misure repressive alla Grecia dopo che Berlino l’ha devastata nella seconda guerra mondiale.
Mentre i movimenti in Medio Oriente sono finiti con il ritorno dei dittatori, come il presidente egiziano al-Sisi?
Stati uniti ed Europa hanno sostenuto i più brutali dittatori in tutto il mondo. In questo momento in Egitto si vivono i giorni più bui della sua storia moderna. Questo è l’imperialismo tradizionale, il potere della propaganda non è cambiato. I giornali in Europa lo descrivono come un modello nonostante sia un assassino brutale, un dittatore duro che ha represso la popolare organizzazione dei Fratelli musulmani mentre nel Sinai si continua a consumare una guerra.

Il manifesto, 3 aprile 2015
RIPENSIAMO ALL’IRI
di Valentino Parlato
La notizia economica e politica di queste settimane è che la Cina (quella una volta rossa di Mao Tse Tung) è diventata padrona della nostra storica e famosa Pirelli. La nostra stampa, dopo aver cercato di assicurarci che la Cina sarà rispettosa dei nostri interessi, conclude rassegnata: è la globalizzazione. Come a dire: è il destino, la storia, guardandosi bene dal precisare che siamo al capitalismo globale. Anche la Cina “rossa” ha un suo capitalismo che dice di governare, ma chissà se è vero.
L’acquisto della Pirelli da parte della Cina, oltre che un po’ di paura, ha suscitato anche l’invidia del capitalismo nostrano, che si è subito affrettato a dire che anche noi capitalisti italiani facciamo acquisti all’estero. Così il
Corriere della Sera di lunedì 30 marzo, nelle sue pagine economiche, fa un titolo preoccupato nella prima riga («Made in Italy in vendita?») per poi rassicurarci nella seconda riga («Ma c’è chi compra all’estero»). Ci dice che anche noi italiani facciamo acquisti all’estero e spiega: è vero che i cinesi si sono comprati la grande e storica Pirelli, ma imprese italiane come Campari, Recordati, Luxottica, Brembo, Ampliphon e Ima hanno a segno ben 85 operazioni di acquisto all’estero. Insomma, leggere sulla nostra stampa che non siamo da meno della Cina mi pare piuttosto patetico. Ma ci sono ancora due obiezioni. La prima è che i nostri investimenti non sempre ci fanno padroni delle imprese nelle quali sono stati messi i soldi. La seconda obiezione mi pare ancora più seria: nella situazione di crisi della nostra economia la Campari, invece di investire all’estero i soldi guadagnati in Italia, avrebbe dovuto investirli nel nostro paese per alleggerire la disoccupazione degli italiani, il cui lavoro ha fatto guadagnare alla Campari i soldi che poi è andata a spendere all’estero. In ogni modo complimenti per il Campari Soda.
Ma torniamo all’attuale grave crisi, che né il calo del prezzo del petrolio, né la svalutazione dell’euro hanno frenato. La globalizzazione è cosa troppo grande e complessa per le nostre imprese in difficoltà e che hanno bisogno di soldi, come afferma anche Matteo Renzi. E i soldi (nonostante le difficoltà di bilancio, può darli solo lo Stato, anche attraverso la Banca centrale europea (il bravo Draghi un po’ di soldi li sta dando, ma non basta).
Ci vuole un serio e forte intervento pubblico, mandando al diavolo l’austerità della Troika e di quant’altri. Altrimenti – va detto ad alta voce – anche l’Italia seguirà la Grecia, il cui governo sta facendo una lotta disperata per salvare il paese. La questione di un serio e deciso intervento pubblico va messa all’ordine del giorno.
Quando si parla di serio intervento pubblico il pensiero va subito all’Iri, nato nel 1933 e morto nel 2002. L’Iri (Istituto ricostruzione industriale) salvò l’industria italiana dalla crisi del 1929 e produsse, nel secondo dopoguerra, il famoso «miracolo italiano». Ripensiamo all’Iri e vediamo se si può aprire una seria discussione sull’opportunità o meno di rimetterlo in campo. A tal fine, sono di grande utilità i sei volumi sulla storia dell’Iri pubblicati da Laterza. Ultimamente sono arrivati in libreria il quinto, a cura di Franco Russolillo, con interventi di numerosi autori, e “L’Iri nell’economia italiana” di Pierluigi Ciocca, al quale soprattutto faccio riferimento perché libro costituisce una conclusione di tutto il lavoro di ricerca sull’Iri e, ancora di più, per la sua esperienza nel Direttorio della Banca d”Italia e la sua seria conoscenza dell’economia italiana.
Vengo al capitolo finale del libro di Ciocca, che già nel titolo pone il problema che vorrei porre ai lettori: «Una nuova Iri?» Riporto di seguito le prime parole, per me assai significative, di questo capitolo: «Avrebbe giovato conservare l’Iri? Ovvero, avrebbe giovato — potrebbe giovare una nuova Iri? La risposta è positiva, qualora si spinga l’immaginazione a un controfattuale che includa l’Iri nella sua migliore stagione: l’Iri meccanismo e non strumento, l’Iri dotato di capitale del suo principale azionista e ampiamente partecipato da privati in minoranza, l’Iri compreso dalla politica e accettato nella sua autonomia, l’Iri capace di contribuire allo sviluppo industriale del Mezzogiorno, l’Iri impegnato nelle attività di R&S, fonte di innovazione e progresso tecnico diffusi nella filiera del sistema produttivo».
Su queste parole di Pierluigi Ciocca vorrei concludere. La situazione è brutta. Si dovrebbe provare a mettere in campo l’Iri. Vorrei aggiungere che converrebbe anche a Matteo Renzi, ma sarebbe un progetto troppo complesso per le sue semplificazioni di breve periodo. Vogliamo discuterne
FINANZCAPITALISMO ALLA PROVERA
di Enrico Carucci
Globalizzazione. Le strategie finanziarie del manager italiano e le prospettive della vendita ai cinesi
A pochi giorni dall’annuncio dell’acquisto di AnsaldoSts e AnsaldoBreda da parte di Hitachi, un altro pezzo importante dell’industria Italiana passa in mani straniere: la Pirelli ha infatti reso noto l’accordo per il passaggio di proprietà al colosso cinese ChemChina. Si tratta dell’ennesima acquisizione di aziende italiane da parte di gruppi stranieri, un fenomeno che investe la totalità del sistema industriale, dal tessuto di piccole medie imprese ai grandi marchi. Parmalat, pastificio Luciano Garofalo, Pernigotti, Ducati, Indesit, Loro Piana, Krizia: solo qualche esempio, preso in ordine sparso ma non a caso, per mostrare come tutti i settori chiave dell’economia italiana ne siano interessati, dall’agroalimentare alla meccanica ai prodotti di lusso.
Se si presta fede al mantra del «è necessario attirare capitali stranieri», si potrebbe concludere che ci troviamo di fronte a un fenomeno positivo: il nostro Paese è in grado di attrarre finanziatori stranieri. Bene, siamo competitivi e ciò ci permetterà di riprendere il sentiero della crescita sostenuta. Altre voci, più scettiche, vedono in queste acquisizioni l’impoverimento e lo smembramento del tessuto industriale italiano.
Pur non entrando in questo dibattito, ci limitiamo a far notare che il passaggio di proprietà (o della maggioranza delle azioni) a una società in mano straniera ha delle implicazioni innegabili per quanto riguarda i flussi finanziari a livello paese. A un’entrata una tantum nel momenti della cessione, fa seguito infatti un’uscita continuativa di flussi finanziari tramite i profitti rimpatriati.
La differenza tra investimenti e acquisizioni è cruciale. Non si sta parlando di flussi di denaro che entrano per aumentare la capacità produttiva della nostra economia, bensì di un cambio di proprietà. Inoltre, nell’ipotetico caso di un governo che decidesse di riprendere a fare politica industriale, confrontarsi con partner stranieri o italiani non sarebbe chiaramente la stessa cosa in termini di agenda e priorità.
Chiaramente la nuova leadership cinese presenta della potenzialità da non sottovalutare, come la possibilità di allargare significativamente il mercato di Pirelli, aprendolo ai paesi asiatici. La questione chiave, tuttavia, sarà capire che parte di questi benefici rimarrà in Italia.
All’annuncio di Pirelli sono seguite alcune (poche in realtà) critiche sulla pressoché totale assenza di un’adeguata politica industriale da parte del governo, una considerazione fatta tra gli altri non solo dalla leader della Cgil Susanna Camusso, ma anche da una figura non esattamente vicina ai sindacati come Cesare Romiti. Questa critica è stata liquidata come «nazionalismo di maniera» da Marco Tronchetti Provera, il Presidente nonché amministratore delegato della Pirelli, tra le altre cose uno dei manager più pagati di Italia.
Per capire la figura di Provera, è utile far riferimento a un termine in voga nella teoria economica: la finanziarizzazione dell’economia. Si tratta di un concetto non semplice da spiegare, che ha confini poco chiari anche all’interno del dibattito accademico. In poche battute, è un processo che porta la sfera finanziaria dell’economia a prevalere su quella reale: la finanza, la borsa, la speculazione che prevalgono sulla industria, l’imprenditoria e la produzione. Da un punto di vista manageriale, ci si focalizza più sul valore di borsa delle azioni che sulle performance commerciali dell’azienda. Questo significa avere un orizzonte temporale assai limitato. La finanza, è risaputo, corre molto, ha tempi brevi e poco si adatta a complessi progetti imprenditoriali di lungo respiro.
La linea manageriale di Provera si è mossa in questo solco. Provera controlla la Pirelli tramite un sistema piramidale (con del capitale crea una società che si indebiterà e potrà comprare una società più grande che si indebiterà, potendo a sua volta comprare una società più grande e così via) e ha concentrato tutti i suoi sforzi sul valore di Borsa dell’azienda, indubbiamente con qualche successo.
Le azioni di Pirelli hanno incrementato considerevolmente il loro valore da quando ne ha assunto la Presidenza. Il lato imprenditoriale è stato però messo in secondo piano. Gli investimenti sono diminuiti, cosi come le spese in ricerca. Ciò, unito alla compressione salariale, può aver favorito la reddittività di Pirelli nel breve termine ed aver quindi facilitato la distribuzione di dividendi, contribuendo a determinare il valore di borsa di un titolo, ma senza coniugarsi a una concorrenza industriale in mercati sempre più aperti e competitivi.
Perché le aziende e l’economia italiana possano fare fronte alle sfide e alle opportunità dell’economia globale e dei mercati emergenti, è fondamentale avere una classe imprenditoriale capace e lungimirante, nonché una finanza paziente che sia funzionale all’impresa. E ci vorrebbero governi capaci di fare vera politica industriale.
Le scatole cinesi all’italiana, il capitalismo da salotto, una finanza basata sulle relazioni, i Tronchetti Provera non sono adatti ai mercati mondiali, perché non ne sono all’altezza. A vederli decidere di sottrarsi ai mercati globalizzati e vendere un pezzo importante dell’industria italiana dopo essersi arricchiti spropositatamente, verrebbe da pensare a Schettino e urlare «torni a bordo, cazzo». Ma probabilmente è meglio di no.
È meglio che i manager di corto respiro, quelli che spolpano le aziende — si veda anche il caso Telecom — e che andavano di moda tra i venti e i trenta anni fa negli Stati Uniti (si pensi al Gordon Gekko di Wall Street di Oliver Stone), si levino di torno. In un paese con una lunga storia di produzione manifatturiera come il nostro, bisognerebbe che i bonus dei manager non fossero pagati sulla base di obiettivi finanziari, come nel caso di Marchionne, ma sulle performance industriali e gli obiettivi di lungo periodo.
In assenza di una classe imprenditoriale all’altezza, ci si dovrebbe poter rivolgere a un governo che intervenga tramite politiche industriali. Ma avrebbe senso aspettarsi ciò da un esecutivo che si rifà a strategie che erano in auge in Inghilterra vent’anni fa.
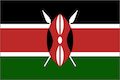
La Repubblica, 3 aprile 2015
L’ATTACCO rivendicato dagli Shabab nel campus universitario di Garissa, di certo il più micidiale da loro compiuto, è un atto d’accusa non solo contro la loro deriva criminale, ma anche contro la spaventosa irresponsabilità dei governanti keniani. Partiti in guerra contro gli islamisti somali nell’ottobre 2011, con l’intento dichiarato di proteggere i propri confini dalle incursioni lanciate nel remoto nord-est del Paese a partire dal territorio confinante, essi si ritrovano tre anni e mezzo dopo con la guerra in casa.
Hanno imposto di recente a un Parlamento in subbuglio leggi antiterrorismo considerate da molti liberticide, ma appaiono incapaci di proteggere i propri cittadini dalla minaccia di attacchi armati, o disinteressati a farlo. Hanno coltivato un sogno di egemonia regionale costruita anche con le armi, e sono finiti in uno scacco mortale in casa propria. Nel campus di Garissa il rettore aveva addirittura messo in guardia gli studenti, invitandoli a rientrare a casa per le festività: c’era qualcosa nell’aria, ma le autorità di polizia non avevano preso alcun provvedimento. Viceversa, soltanto l’altro ieri, il presidente Uhuru Kenyatta se l’era presa contro le allerta lanciate ai turisti australiani e britannici dai governi di Canberra e Londra: un imperdonabile autogol.

La parabola degli Shabab somali è unica nella galassia del terrorismo islamico perché, nati e lungamente cresciuti nella Somalia della guerra civile attraverso una serie di spaccature e scissioni sempre più radicali, essi appaiono ormai sconfitti e residuali in quel Paese — dove tuttavia ancora sono in grado di mettere a segno azioni militari, l’ultima all’hotel Makka Al Mukarama di Mogadiscio il 27 marzo, 14 morti e numerosi feriti — mentre la loro azione si va facendo più minacciosa in Kenya. Anche i Taliban si muovono da sempre a cavallo della frontiera afgano- pachistana; ma in Pakistan erano nati, negli anni 1980, prima di arrivare a prendere il potere a Kabul. Viceversa la matrice degli Shabab è puramente somala.
Durante i lunghi anni della guerra civile somala, attraverso l’ultima decade del secolo scorso e la prima di questo, mentre i signori della guerra combattevano tra di loro un conflitto per bande motivato sostanzialmente dalla brama di controllo territoriale e di guadagno, il movimento islamista cresceva lentamente, a sua volta originato dalla variegata galassia di organizzazioni, partiti e singoli esponenti fondamentalisti, in un processo di continue scissioni e ricomposizioni. Cristallizzatosi nelle cosiddette Corti Islamiche, approfittò dell’estenuazione degli abitanti, ormai stremati dalla costante insicurezza, per imporre il proprio controllo e la sharia sulla quasi totalità del sud somalo. Legge, ordine e mani mozzate. Così le Corti amministrarono per qualche anno Chisimaio e dintorni, poi nel 2006 giunsero fino a Mogadiscio. Ma la conquista della capitale causò l’intervento militare etiopico e l’inizio della loro fine.
Da quella rotta e dalla dissoluzione delle Corti Islamiche emersero gli Shabab, “i giovani”, un movimento più radicale, militarizzato e feroce, sul modello qaedista. Infatti nel febbraio del 2012 annunciarono l’affiliazione ad Al Qaeda, anche se — a differenza di Al Qaeda, portatrice di una visione di “guerra globale” — l’orizzonte degli Shabab è sempre stato somalo. Finché, accusandoli di essere i responsabili di incursioni oltre confine che avevano preso di mira turisti e operatori umanitari, il Kenya non è a sua volta intervenuto in armi in Somalia.
L’operazione Linda Nchi (“proteggere la patria” in swahili) fu lanciata nell’ottobre 2011. Sulle prime rischiò la catastrofe. Poi il coordinamento con gli etiopici e soprattutto con il contingente internazionale dell’Unione Africana che sosteneva il governo provvisorio somalo, fece rapidamente migliorare la situazione. Gli Shabab furono presto in ritirata ovunque, costretti ad abbandonare un centro abitato dopo l’altro. Passati dal controllo territoriale al terrorismo puro, cominciarono a colpire in Kenya, in un crescendo di attentati culminati nell’attacco al centro commerciale Westgate di Nairobi (21-24 settembre 2013, almeno 68 morti). E, oggi, all’università di Garissa.

La Repubblica, 2 aprile 2015
C’È POCO da aggiungere a quello che ha dichiarato nei giorni scorsi Raffaele Cantone, le norme approvate al Senato sono utili ma solo una parte di quel che sarebbe necessario. Non c’è da attendersi miracoli insomma da norme varate dopo un iter tormentatissimo. Difficile nascondersi poi un altro aspetto: non è più rinviabile il risanamento radicale e drastico di un partito che troppo spesso, da Roma a Ischia, a quel futuro sembra attentare più che contribuire. Forse l’indagine svolta nella capitale per il Pd da Fabrizio Barca andrebbe conosciuta meglio ed estesa ad altre realtà: solo per iniziare.
Un iter di oltre due anni e con il governo spesso in grave rischio. Norme, comunque: torna — per un soffio — il falso in bilancio cancellato negli anni berlusconiani ma sono state escluse le intercettazioni per le società non quotate in Borsa. E aumentano le pene per i reati di mafia e per la corruzione nella pubblica amministrazione, e al tempo stesso i poteri dell’Authority. Forse era difficile aspettarsi di più e in questo Parlamento poteva davvero andare peggio, con il Nuovo centrodestra di Alfano (Angelino, lo stesso del lodo) obbligatoriamente all’interno del governo e un Movimento cinquestelle perso nelle sue onnipotenti impotenze.
È evidente la sproporzione fra quel che è rimasto del testo originario e il salto di qualità, lo scatto morale e legislativo che sarebbe necessario. Sulle misure legislative possibili pesano ancora una volta i risultati delle elezioni del 2013, un caso probabilmente unico: con il partito di maggioranza che perde più di sei milioni di voti e il partito di opposizione che non ne guadagna neppure uno ma ne perde a sua volta oltre tre milioni (conseguenza quasi inevitabile di una campagna elettorale totalmente incapace di rivolgersi agli italiani).
Per il Partito democratico, costretto ad innaturali alleanze (anche — di nuovo — per il nullismo grillino), erano le condizioni peggiori per ripartire e non è possibile dimenticarlo.
Anche per questo, leggi inevitabilmente monche devono esser accompagnate e integrate dal centrosinistra con scelte nettissime e costanti sul terreno della moralità e delle regole della politica. Scelte generalissime ma innervate da decisioni quotidiane, da gesti limpidi e da comportamenti coerenti, in un Paese travolto periodicamente da ondate di spaventosa corruzione. È difficilissimo oggi anche solo indicare gli ambiti risparmiati sin qui dai miasmi. O ricordare quanto spesso riemergano quelli già noti, a partire dalle Regioni o dal mondo delle cooperative.
In questo scenario anche le scelte meno rilevanti sono significative, e se ne consideri una non proprio marginale: è una vera indecenza la candidatura in Campania del condannato De Luca, che in base alla legge Severino non potrebbe neppure esercitare il suo mandato. In Campania, luogo non irrilevante nella guerra alle corruttele: e la vicenda suona al tempo stesso come irrisione all’abituale “decisionismo” di Renzi, che in questo caso è apparso afasico e in balia degli eventi. È difficile chiedere disciplina di partito quando si tollera un vulnus così grave, e si consideri anche il coinvolgimento di alcuni sottosegretari in differenti indagini.
Certo, nella normalità della democrazia l’avviso di garanzia non è una condanna (eppure un avviso di garanzia segnò la fine del regno craxiano) ma l’Italia vive da anni una situazione totalmente anomala. È sommersa quotidianamente da scandali che crescono costantemente di intensità. Una anormalità normale, e non ha avuto sufficiente rilievo una notizia di cronaca che sembra segnare negativamente un cambio d’epoca (e speriamo davvero che non sia così): un giudice ha appena assolto i consiglieri regionali della Valle d’Aosta perché... non sapevano di commettere reato usando denaro pubblico per ragioni privatissime (feste, viaggi di familiari, divise da calciatore, cene, modesti gioielli e così via). Andrebbe riletto ogni giorno un lucidissimo articolo di qualche anno fa di Roberto Saviano che indicava proprio nella “corruzione inconsapevole” il salto di qualità che si era compiuto: corruzione inconsapevole, praticare la anormalità come se fosse normale. Smarrire l’idea stessa di confine. Non è una bella notizia che un tribunale della Repubblica la assolva.
Lo storico di domani farà qualche fatica a comprendere le differenti fasi della perversa escalation che abbiamo vissuto: dall’apparente ritorno alla normalità dopo Mani pulite sino al riemergere e all’esplodere di fenomeni che hanno offuscato quelli precedenti. Fenomeni che evocano una colossale e diffusa metastasi nazionale, quasi senza rimedio agli occhi di molti cittadini. Questa era la prima realtà che Renzi doveva “rottamare” e anche su questa base aveva costruito il suo consenso, ma da tempo quella battaglia sembra sbiadita e appannata. Inadeguata. Non assente, certo, e corroborata da scelte importanti come quella dell’Authority anti-corruzione. Non sostenuta però da un tessuto quotidiano di decisioni, dalla riconquista continua dei cittadini alla fiducia nella democrazia: eppure essa è un obbligo assoluto in un Paese che ha visto crollare la partecipazione al voto e quasi trionfare guitti di quart’ordine. Il crescere dell’astensione e il poco declinante credito di Beppe Grillo dovrebbero essere per Renzi un drammatico segnale di sconfitta. Dovrebbero imporre una decisa volontà di rivincita su questo terreno, ma troppo spesso essa sembra latitare: eppure proprio su questo, non sulle preferenze, si gioca il futuro della democrazia italiana.
Il manifesto, 2 aprile 2015
Reddito minimo garantito, questo sconosciuto. Lo si confonde con il reddito di cittadinanza, oppure con il salario minimo. In Italia, in realtà, non si sa ancora cos’è. Anche questo è il segno dell’arretratezza sociale in cui affoga questo paese, mentre questa misura elementare di lotta contro la povertà e la precarietà esiste in tutta Europa, tranne che in Grecia. E da noi. Negli ultimi mesi l’infosfera si è fatta trarre in inganno dalla confusione concettuale creata dai Cinque Stelle. Per il movimento, infatti, la sua proposta di 600 euro mensili (e non i mille promessi da Grillo) sarebbero un «reddito di cittadinanza». Si tratta invece di un reddito minimo che corrisponde al 60% del reddito mediano previsto dalla risoluzione del Parlamento europeo del 10 ottobre 2010. Non è una misura incondizionata e universale – come il reddito di cittadinanza che viene erogato a tutti i residenti – ma è condizionata e selettiva, per di più poco garantista della libertà dell’individuo e non del tutto congruente con i parametri europei sul rispetto della dignità personale.
Nella commissione lavoro al Senato sono in corso le audizioni sulle tre proposte di legge presentate da M5S, dal Pd e da Sel. Quest’ultima ha raccolto l’eredità della proposta di legge di iniziativa popolare che ha raccolto più di 50 mila firme grazie allo sforzo di più di 170 associazioni e movimenti da tempo impegnati nella lotta per il reddito minimo garantito. Nel frattempo Libera, il Basic Income Network-Italia e il Cilap hanno promosso la campagna «reddito per la dignità». La petizione ha raccolto fino ad oggi 75 mila firme e punta a raggiungerne 100 mila. Chiede che il parlamento discuta e approvi una legge sul reddito minimo (e non di cittadinanza) entro 100 giorni. La petizione è stata firmata anche da esponenti dei Cinque Stelle come Luigi Di Majo, oltre che dalla Fiom di Maurizio Landini. Si tratta di una proposta di mediazione, considerata anche la dicitura “reddito minimo o di cittadinanza”.
L’espressione è destinata a produrre altri equivoci. In compenso propone quattro principi per un accordo tra le parti in causa: il reddito dev’essere individuale, sufficiente, congruo e riservato a tutti i residenti. Per queste ragioni non va considerato come una misura alternativa al sussidio di disoccupazione (la «Naspi» o il «Dis-Coll» nel Jobs Act). Non è un sussidio contro la povertà assoluta e non è un salario minimo, cioè la paga oraria più bassa, giornaliera o mensile, che i datori di lavoro corrispondono agli impiegati o agli operai. Il reddito minimo non va ristretto ad un periodo entro il quale un lavoro «purché sia» dev’essere accettato, ma al miglioramento complessivo della situazione individuale. Come dimostrano le esperienze europee, si rischia sempre di adottare misure vessatorie che danneggiano i beneficiari.

Interessante analisi delle diverse forme, ragioni e dinamiche dei movimenti di protesta. «Se i movimenti del 2012 erano quelli dei precari, negli anni seguenti a scendere in piazza è stata la classe impoverita. Le ampie ondate di protesta hanno un carattere costitutivo, e sospendendo vecchie regole ne creano di nuove. In questo modo la democrazia si è evoluta nelle strade». sbilanciamoci.info, 25 marzo 2015
Gli studi sui movimenti sociali hanno sviluppato un insieme di strumenti utile ad affrontare l’azione collettiva durante periodi normali – ovvero periodi ordinati. I sistemi a cui si sono principalmente rivolti sono le cosiddette democrazie avanzate, aventi forme di welfare sviluppate. Le teorie proposte si sono principalmente orientate verso la spiegazione dell’impatto di queste strutture sui movimenti collettivi. La principale aspettativa è che le proteste coinvolgano opportunità e risorse.
In realtà, sappiamo molto meno delle questioni che sono di fondamentale importanza per analizzare il tardo neoliberalismo ed il relativo malcontento, come:
- Movimenti in periodi di crisi, i.e. quando la protesta è scatenata più da minacce che da opportunità
- Movimenti in periodi straordinari, ovvero movimentati, quando l’azione cambia le relazioni
- Movimenti come processi, i.e. come produttori delle proprie risorse e fonte di empowerment
L’attività di ricerca in economia politica ha indicato alcune caratteristiche generali del neoliberalismo: l’emergenza di un libero mercato come ideologia, che indirizza le politiche non verso il ritiro dello stato dal mercato, bensì verso la riduzione degli investimenti nei servizi sociali che diminuiscono le disuguaglianze, e porta protezione al posto del capitalismo finanziario; la privatizzazione dei beni pubblici ed il salvataggio delle banche; la flessibilizzazione del mercato del lavoro, affiancato però a forti attività di regolamentazione, che aumentano le opportunità di trarre vantaggi speculativi.
Questi sviluppi hanno chiare conseguenze sulle basi sociali della politica del conflitto contemporanea. Entrambe le ondate di protesta del 2011 e del 2013 hanno infatti causato nuove tensioni nelle basi sociali della politica del conflitto. Nel 2011, i manifestanti sono stati generalmente considerati, per la maggior parte, come membri di una nuova classe precaria, che era stata fortemente colpita dalle politiche di austerità. Diversamente da quelli del 2011, le proteste del 2013 sono state interpretate come fenomeni del “ceto medio”.
Le informazioni collezionate sul background sociale dei manifestanti non hanno confermato in modo inequivocabile ne’ la tesi della mobilitazione di un nuovo precariato, ne’ quella di un movimento della classe media. In tutte le manifestazioni sono rappresentati una vasta gamma di background sociali: dagli studenti ai lavoratori precari, dai lavoratori manuali e non manuali alla piccola borghesia e ai professionisti. Maggiormente popolate da giovani e figure di elevata istruzione, le manifestazioni hanno anche osservato la partecipazione di altre coorti di età.
Le varie proteste coinvolgono diverse classi sociali, ma non sono un fenomeno tra classi. Tendono piuttosto a riflettere alcuni cambiamenti nella struttura delle classi sociali che hanno caratterizzato il neoliberalismo e la sua crisi: in particolare, la proletarizzazione delle classi medie e la precarizzazione dei lavoratori. Quanto al primo fenomeno, molti studi indicano il declino del potere della classe media, con le tendenze alla proletarizzazione di
a) la piccola borghesia indipendente (come ad esempio la trasformazione delle strutture commerciali che portano all’eliminazione dei negozianti indipendenti a favore delle multinazionali);
b) i liberi professionisti (attraverso processi di privatizzazione dei servizi, creazione di aziende oligopolistiche e de-professionalizzazione attraverso la Taylorizzazione dei compiti);
c) i dipendenti pubblici (attraverso la riduzione dello status e del salario, e attraverso la flessibilizzazione del contratto, etc.).
Per quanto riguarda quest’ultima, la precarizzazione colpisce i dipendenti privati nei settori industriali (attraverso la chiusura dei tradizionali settori fordisti, oltre alla flessibilizzazione delle condizioni lavorative), come nel settore terziario, con l’aumento del lavoro informale, di lavori scarsamente retribuiti, e di condizioni di lavoro precarie.
In sintesi, anziché mobilitare una singola classe sociale, le manifestazioni hanno mobilitato cittadini con diversi background sociali. I movimenti degli anni 2000 sono stati infatti visti come segni di comune opposizione alla mercificazione degli spazi pubblici, in un tentativo di costituzione comunitaria.
Nella mobilitazione di queste vaste e variegate basi sociali, i movimenti sociali in tempi di crisi devono far fronte a specifiche sfide, tra cui la simbolica sfida della costruzione di un nuovo soggetto; la sfida materiale di mobilitare risorse limitate; la sfida strategica di influenzare un sistema politico estremamente chiuso.
Anche se non totalmente limitate da esse, le risposte del movimento alla crisi sono infatti strutturate sulla base delle risorse materiali esistenti (come succede nelle reti di movimento), e anche da risorse simboliche (espresse come cultura del movimento). Questo implica una limitazione delle opzioni disponibili, ma scatena un processo di apprendimento in termini di lezioni dal passato.
Anche se certamente limitati dalle strutture esistenti, una caratteristica dei movimenti nei periodi di crisi è la loro capacità di creare risorse attraverso l’invenzione di nuove strutture, nuovi sistemi organizzativi e nuove forme di azione. In questo senso, per capire le condizioni per l’azione di conflitto, l’attenzione deve spostarsi a ciò che è stato individuato come divenire: non esistono ancora le identità, né sono state costituite; le reti si sono riformate attraverso il superamento di vecchie scissioni. In periodi straordinari, a causa della rottura di vecchie identità e di vecchie aspettative, emerge un nuovo spirito: i movimenti sociali esprimono allora, prima di tutto, il diritto di esistere.
Lo sviluppo di uno spirito nuovo è stato osservato nelle piazze occupate, che hanno caratterizzato il nuovo repertorio di proteste. Esse rappresentano infatti spazi per la formazione di una nuova soggettività, basata sulla ricomposizione di precedenti scissioni e l’emergenza di nuove identità. Le manifestazioni sono quindi da vedere come produttrici di entità emergenti, che vanno al di là dei propri elementi costitutivi. L’attenzione sul divenire affiora attraverso le pratiche che sottolineano l’importanza degli incontri – infatti, viene celebrata nelle varie piazze la diversità delle persone.
In questo senso, come indicato dal percorso evolutivo di Grecia e Spagna, anche se apparentemente in ritirata, le ampie ondate di protesta hanno un carattere costitutivo, e sospendendo vecchie regole ne creano di nuove. In questo modo la democrazia si è evoluta nelle strade.
(traduzione di Alessandro Castiello D'Antonio)
La Repubblica, 29 marzo 2015
DI FATTI politici ed economici ne sono in questi giorni avvenuti quantità innumerevoli ed anche di fatti di cronaca, uno dei quali, quello dell’aereo caduto sulle Alpi francesi, ha trascinato l’opinione pubblica di tutta l’Europa nel mondo dell’orrore e della disperazione.
Insieme ai fatti ci sono i personaggi protagonisti, quelli che non sono identificabili con un solo avvenimento ma con una serie che copre un periodo, guida un percorso, adotta una strategia. Quelli che più ci interessano operano sulla scena italiana ed europea. Non sono molti, è ovvio: i protagonisti tengono la scena riducendo gli altri al ruolo di comprimari o addirittura di comparse. Per capire il meglio possibile ciò che sta avvenendo dobbiamo dunque identificarli, per scriverne pregi e difetti, eventualmente proporre i possibili rimedi, cercando a nostra volta un possibile Virgilio che ci aiuti nel viaggio.
Io quel Virgilio lo indicai già domenica scorsa. Si discuteva del rapporto tra governo e pubblica amministrazione e feci il nome di Marco Minghetti. Visse e scrisse (e governò) 150 anni fa, e credo che come tutti i maestri sia ancora di attualità. Tra le tante cose che disse c’è una frase che trovo molto significativa: «Napoleone governò per vent’anni la Francia e il suo fu un governo che ammodernò il Paese e tutelò l’eguaglianza ma non la libertà e perciò ebbe più difetti che virtù». Ecco, già queste righe mi confermano nell’idea che è un buon Virgilio.
Il personaggio che oggi mi sembra opportuno esaminare è Matteo Renzi. In poco più di due anni è passato dal ruolo di comparsa a quello di protagonista.
Quindi ha se non altro i pregi dell’innovazione, del coraggio e della volontà. Queste doti gli hanno consentito d’essere alla testa del Partito democratico, di farne il più forte partito italiano e portare lui alla guida del Paese. È ispirato dal desiderio d’essere giovevole agli italiani, molti dei quali ripongono in lui la fiducia e quell’obiettivo ha già cominciato a realizzarsi e in tempo breve lo raggiungerà pienamente.
Naturalmente ha anche molti avversari e ancora di più molti perplessi che attendono risultati che ancora non vedono.
Attendendo si astengono dal voto o lo danno ad un movimento (quello di Grillo) che equivale da tutti i punti di vista ad un’astensione fortemente critica. Se si sommano insieme i grillini e gli astenuti così come sono registrati dai vari sondaggi, si astiene più o meno il 60 per cento degli elettori. Quindi la partita che Matteo Renzi sta giocando ha come terreno il 40 per cento degli aventi diritto al voto, ma di quelli che andranno alle urne, ivi compresi i grillini che votano ma non giocano.
Questa è dunque la situazione. Dimenticavo però di dire che un altro elemento fondamentale di Renzi è il suo Narciso. L’amore per se stessi c’è in tutti gli umani e particolarmente in quelli che si occupano professionalmente della conquista del potere. Qualunque potere, quello politico e quello economico in particolare e spesso quei due poteri sono affiancati.
Renzi ama molto se stesso, ma questo è normale. Resta solo da sapere se quest’amore non disturba il suo desiderio di giovare agli altri.
Il mio Virgilio a questo proposito dice che «l’uomo mira all’utile proprio e non all’altrui, anzi è pronto a immolare questo a quello. L’uomo singolo, come l’unione di molti e ogni classe della società e ogni corporazione tendono sempre a esorbitare, uscendo fuori dalla sfera dei loro diritti per invadere gli altrui ». Ma poi concede che questo principio illegittimo può essere contenuto dall’intelligenza di chi governa e vuole essere di giovamento agli altri sicché tiene per la briglia il suo Narciso affinché gli altri gli rinnovino la fiducia e rafforzino il suo ruolo di protagonista.
* * *
Io credo che questo progetto corrisponda alla politica di Renzi e quindi possa essere di qualche giovamento anche al Paese. Ma è dunque indispensabile per produrre questi effetti per lui positivi che il potere effettivo si concentri nelle sue mani. Questo spiega molte cose, la prima delle quali è un progressivo indebolimento dei vari ministeri e la costruzione di uno staff a palazzo Chigi capace di determinare le linee concrete dell’azione governativa. La prova più recente è quella del suo interim al ministero delle Infrastrutture e Trasporti che doveva durare pochi giorni e durerà invece più a lungo, almeno fino a quando Renzi non lo avrà completamente disossato; lo scheletro rimane ma la polpa se la porta alla presidenza del Consiglio.
Così si spiega anche l’abolizione del Senato e soprattutto dei senatori che non saranno scelti dal popolo ma dai consigli regionali. L’effetto come più volte abbiamo sottolineato è la costruzione d’un sistema monocamerale con una Camera in gran parte “nominata” dal segretario del partito di maggioranza, il che significa che il governo ha la Camera a propria disposizione e non viceversa come in teoria la democrazia parlamentare prevede.
Questo sistema risulta ulteriormente aggravato dal fatto che la legge elettorale denominata Italicum è dominata dal principio della governabilità mentre non trova spazio alcuno il principio di rappresentanza; l’effetto di tutto il sistema che abbiamo considerato è evidentemente quello di evocare la tentazione dell’autoritarismo. Non è detto che si ceda a questa tentazione ma certo ne esistono tutte le condizioni perché il solo freno a questa deriva resta il capo dello Stato. Un freno tuttavia limitato ai poteri arbitrali di cui il presidente della Repubblica dispone, basati certamente sulla Costituzione come principio ma in pratica sulla legislazione ordinaria la quale ultima è in larga misura nelle mani del presidente del Consiglio date le tante circostanze qui ricordate.
In questo quadro si iscrive anche l’eventuale conquista della Rai. Che una riforma della maggiore istituzione culturale del Paese sia opportuna, se non addirittura necessaria, è evidente ma non dovrebbe avere come elemento fondamentale il passaggio dei poteri dal Parlamento e quindi dai partiti al governo. La nomina dell’amministratore delegato dell’azienda, dotato di poteri quasi assoluti, è formalmente del consiglio d’amministrazione ma nella pratica non è così anche perché quel consiglio è di fatto nominato — come del resto è giusto che sia — dal governo e in teoria dal ministro dell’Economia che ha la completa proprietà dell’azienda. L’ideale sarebbe affidare la scelta dei consiglieri d’amministrazione e dell’amministratore delegato ad una Fondazione composta da persone non politiche ma autorevolissime per i meriti acquisiti nei vari campi del loro interesse culturale. La Bbc inglese è per l’appunto sotto la tutela di una fondazione di questo tipo che le consente piena libertà d’azione. È sperabile che la legge opti per questa soluzione, ma è un auspicio che sicuramente non sarà raccolto.
* * *
Il tema della corruzione è un altro con i quali il governo dovrà misurarsi, anzi ha già cominciato. Il mio Virgilio ne sa assai poco di questo tema: lui fu uno dei dirigenti della Destra storica e nella fase in cui fu la destra a governare la corruzione era pressoché assente dalla società e dallo Stato. Oggi la corruzione è un malanno molto diffuso, dovunque nel mondo e in Italia in particolare. Su questo tema mi dovrò ripetere perché non solo io ho già scritto più volte ma altri come e meglio di me: intellettuali “disorganici”, operatori, esperti e politici di buon conio (rari).
La prima distinzione da fare è tra il reato penale (le cui pene sono state aumentate nel disegno di legge in discussione) e il codice etico che dovrebbe essere applicato dalla pubblica amministrazione attraverso le necessarie inchieste effettuate anzitutto sulla medesima pubblica amministrazione e poi anche dal consiglio della magistratura per quanto lo riguarda e dal governo sui suoi membri. Quello che abbiamo chiamato codice etico si può anche chiamare con più chiarezza un peccato e la distinzione è dunque fra il peccato e il reato. La punizione del peccato non può prevedere restrizioni della libertà personale ma semplicemente sospensione o rimozione dall’incarico e relativa denuncia, ove ne ricorrano gli estremi, alla magistratura. Per il reato vale il principio della presunta innocenza fino a sentenza definitiva, per il peccato questo principio non vale e quindi una volta acquisiti i risultati delle varie inchieste, la punizione può e deve avvenire subito, come del resto è avvenuto nel caso Lupi. Si continua dunque a non comprendere le ragioni per le quali nel governo esistano ancora quattro persone che mantengono la loro attività governativa nonostante siano oggetto di indagine giudiziaria. E non si comprende neppure perché esistano dei candidati del Partito democratico per i quali ricorrono tutti i requisiti del “peccato” (ovviamente anche i partiti debbono indagare sugli eventuali peccati dei loro membri).
* * *
Un altro rimedio per diminuire il rischio d’un governo che abbia una vocazione autoritaria riguarda la creazione di corpi intermedi e su questo tema il mio Virgilio la sapeva lunga: «Ministri, senatori, deputati e uomini politici di ogni sorte hanno una tendenza ad insinuarsi nella giustizia e nell’amministrazione per trarne profitto per se medesimi e per gli aderenti ai loro partiti per mantenere il governo nelle proprie mani. Codesto pericolo che spunta sempre dove il governo di partito cresce e giganteggia si svolse storicamente per una serie lunga e non interrotta di ampliamenti e di adattamenti. Ma il vero rimedio è quello di creare o favorire le istituzioni autonome, gli enti morali e le associazioni che tengano insieme una parte dei cittadini. Con cittadini disgregati ogni conato di resistenza sarà vano ed è per questo che le democrazie sgranate si acconciano facilmente ad un padrone e purché egli rispetti l’eguaglianza, calpesti a suo talento la libertà. L’associazione, organizzandole, raddoppia le forze dei singoli che la compongono, le disciplina e le prepara a resistere ad ogni usurpazione. Ho sovente considerato quanto poco ci siano istituzioni del genere in Italia rispetto a tutti gli altri Paesi d’Europa ».
Questi corpi intermedi che il Minghetti auspicava poiché ne sentiva la mancanza già all’epoca sua, dovrebbero dare oggi in Italia maggior peso alle forze sindacali che rappresentano gli interessi di categorie e le tutelano attraverso i contratti ma hanno anche un interesse politico per rafforzare i diritti dei lavoratori. A questo proposito è interessante la nascita della Coalizione sociale la quale ha promosso ieri una manifestazione nelle strade di Roma per iniziativa del sindacato Fiom e alla quale ha partecipato anche tutta la segreteria della Cgil. Quell’associazione si propone di rappresentare i lavoratori non più per categorie né per luoghi di lavoro né con modalità contrattuali ma di fare in modo che la politica generale del Paese tenga conto del lavoro e dei lavoratori come del resto è previsto addirittura nel primo articolo della nostra Costituzione.
D’altra parte i sindacati hanno sempre partecipato alla politica generale dai tempi di Lama, di Trentin, di Cofferati e dei loro successori. Da questo punto di vista la concertazione costruita da Amato, da Ciampi e da Prodi fu uno dei passaggi fondamentali che consentì la creazione della moneta comune europea con la partecipazione fin dall’inizio dell’Italia. Era stata ottenuta attraverso una politica di moderazione salariale che fu riconosciuta più volte nelle conclusioni finali che ogni anno il governatore della Banca d’Italia legge nell’assemblea generale dell’istituto.
Bisognerebbe dunque che questi corpi intermedi e in particolare quelli dei lavoratori fossero sviluppati e opportunamente riconosciuti.
C’erano alcuni altri temi molto importanti da trattare fin da oggi, di politica estera, di terrorismo, dell’andamento dell’economia e della congiuntura. Ne parleremo nel prossimo futuro. Per ora mi limito ad attirare l’attenzione su quello che sta accadendo sul mercato monetario. Draghi sta portando l’Europa fuori dalla deflazione e sta favorendo in ogni modo una ripresa del finanziamento delle banche alla clientela, un aumento della domanda interna e delle esportazioni e quindi dell’occupazione. L’ho già scritto una volta ma lo ripeto. Meno male che Draghi c’è.

Il manifesto, 29 marzo 2015
Se la misura della piazza serve a far capire la forza delle opposizioni sociali di un paese, si può dire senza dubbio che piazza del Popolo a Roma ha dato un grande segnale. Con qualche novità rispetto a molte manifestazioni degli ultimi anni. La presenza di tanti giovani, e quindi non solo dei valorosi pensionati della Cgil che di solito riempiono i cortei sindacali; il ritorno di molte bandiere rosse, non del vecchio Pci e tantomeno di quelle sbiadite del Pd, ma della Fiom; l’entusiasmo della gente che si è ritrovata per esprimere un punto di vista che oggi non ha la necessaria rappresentanza politica.
Naturalmente una piazza non fa primavera, anche se la giornata era piena di sole e Maurizio Landini, il protagonista della manifestazione, con la segretaria generale della Cgil, Susanna Camusso a fare da potente spalla dell’iniziativa, ha voluto sottolineare che una «nuova primavera per il paese è iniziata».
Ma la “protesta” di ieri forse rappresenta l’inizio di un processo trainato da un’idea forte di rinnovamento delle forze sociali e sindacali, politiche e di movimento, un’idea riassunta dallo slogan della manifestazione, «Unions», traducibile in un ritorno alle radici del sindacalismo. Che il segretario della Fiom, nel suo discorso conclusivo, ha riassunto con i ripetuti rimandi all’idea fondativa della Cgil di Di Vittorio: di un sindacato delle Confederazioni, così diverso da un sindacalismo corporativo, basato sulla competizione dei lavoratori.
E’ la spinta verso un ripensamento profondo della natura del sindacato, dettata sia dalle sconfitte subite con il progetto confindustriale che marcia spedito sotto le ali del governo, sia dalla perdita di rappresentatività prodotta da una crisi economica che ha allargato il mare della disoccupazione e prodotto un esercito di precari fuori da ogni tutela e diritto. Così chi oggi ha ancora un lavoro deve subire il comando pieno dell’impresa (abolizione dell’articolo 18, demansionamento, contratti nazionali polverizzati dalla catena perversa del sistema degli appalti), e chi un lavoro lo cerca è merce di scambio e manovalanza per la feroce guerra tra poveri.
Più che una fantasia, una velleità o una scorciatoia, la coalizione sociale è una necessità vitale per ricostruire la figura del cittadino lavoratore (come appunto indicava Di Vittorio quando negli anni ’50 già parlava di uno statuto del «cittadino lavoratore»). E coalizione sociale vuol dire una cosa semplice: ricostruire le basi di una partecipazione democratica, dunque politica, ai destini dell’Italia.
Perché chi oggi accusa il segretario della Fiom di voler fare l’ennesimo partitino dovrebbe piuttosto domandarsi come è stato possibile arrivare a questo disastro sociale, a un così forte ridimensionamento del ruolo del sindacato, alla negazione dei diritti. E anche interrogarsi sulla subalternità, questa sì politica, verso governi o partiti amici di quel «giaguaro» che nessuno ha smacchiato e in molti hanno nutrito.
Ritrovare una soggettività politica diventa un bisogno naturale e l’alleanza con tutte le realtà associative che non si rassegnano è una via maestra per rafforzare l’opposizione a un governo ricco di slogan almeno quanto è povero di un innovativo progetto di sviluppo. Perché mettere in pratica la linea di Squinzi, o una riforma costituzionale ed elettorale di regressione verso forme di plebiscitarismo mediatico non sembra davvero una grande novità. Né in Italia, né in Europa. Come direbbe Landini «non raccontiamoci di balle». Che fa traballare la sintassi, ma si capisce.
Domani è il compleanno di Pietro Ingrao. Cento anni applauditi da tutto il popolo della piazza quando Landini ha ricordato il giorno in cui, da presidente della Camera, si recò, come primo atto pubblico, alle Acciaierie di Terni per rivolgersi agli operai chiamandoli «i costituenti». Un messaggio a chi ha scarsa memoria del paese che pretende di governare
La Repubblica, 29 marzo 2015
Le mille bandiere che colorano di rosso piazza del Popolo garriscono più forte al vento, quando Maurizio Landini lancia la sua scomunica, l’accusa dalla quale non si può più tornare indietro: Renzi è peggio di Berlusconi. E’ lui, il leader del Pd, il vero nemico dei lavoratori. Perché è il presidente del Consiglio, e non gli industriali metalmeccanici, l’obiettivo numero uno di questa adunata generale convocata a Roma del leader della Fiom, un fiume di gente che ancora continuava ad arrivare in una piazza già strapiena quando già avevano parlato i primi tre oratori. E infatti è a Renzi, che Landini grida che «ci siamo stancati degli spot elettorali, delle slide e delle balle ». E’ a Renzi, anzi «a questi giovani ragazzi che stanno al governo», che manda a dire che «pensiamo di avere più consenso di quello che hanno loro». E’ a Renzi, che rivolge l’accusa di «aver adottato la logica padronale», e poi anche quella di «mettere a rischio la nostra democrazia». Ed è a Renzi, che lancia la sua sfida contro il Jobs Act: «Noi non ci fermeremo finché non avremo cancellato questa legge sbagliata».
Portare in piazza gli italiani che non ci stanno: che fosse questa, la vera parola d’ordine della manifestazione organizzata dai metalmeccanici della Cgil con un titolo anglosassone, «Unions!», l’avevano capito tutti, a cominciare dal gruppone milanese che è arrivato per ultimo in piazza della Repubblica per l’inizio del corteo, e mentre saliva le scale mobili della metropolitana cantava a squarciagola, tra bandiere rosse e campanacci, «Abbiamo un sogno nel cuore/ Renzi a San Vittore» (lo stesso coro che a suo tempo veniva dedicato a Bettino Craxi). E per quanto Su- sanna Camusso — accolta con un bacio di Landini ma tenuta lontana dal microfono — si sforzi ora di minimizzare l’impatto politico dell’evento, e precisi gelidamente dai gradini del palco che «in questa piazza ci sono i lavoratori metalmeccanici iscritti alla Cgil, che giustamente sono in lotta perché la legge delega sul lavoro riduce i diritti», si avvicina di più alla verità Nichi Vendola, guest star del corteo, quando spiega la vera ragione che ha spinto queste diverse anime del popolo di sinistra, queste cinquanta sfumature di rosso, a convergere su Roma nel primo sabato di primavera: «E’ ora che tutti coloro che non si adeguano all’idea che ci sia un uomo solo al comando, e che non si rassegnano a una deriva autoritaria, facciano massa critica».
E mentre il corteo passava davanti al Grand Hotel, sfidando gli sguardi curiosi ma stupiti dei suoi ospiti, sembrava di fare un viaggio indietro nel tempo risentendo gli stessi cori che — forse cantati dalle medesime voci — risuonavano quasi mezzo secolo fa, «Il potere dev’essere operaio», o ascoltando le canzonette anni Settanta del rivalutato Rino Gaetano che il furgone di testa mandava a palla, a cominciare da Nuntereggaepiù: «I ministri puliti/ i buffoni di corte/ ladri di polli/ super pensioni/ ladri di stato e stupratori/ il grasso ventre dei commendatori/ diete politicizzate/ evasori legalizzati/ auto blu/ sangue blu/ cieli blu/ amore blu/ rock and blues/ nuntereggaepiù!».
Ma se il canto che animava quel variopinto e allegro serpentone in cui si mescolavano anziani militanti e studenti barricaderi era «Bella ciao» — l’inno che tutta la piazza canterà alla fine della giornata — il vero segno unificante è la bandiera rossa. Accanto a quelle della Fiom sventolano le bandiere rosse di Rifondazione, le bandiere rosse della lista Tzipras e persino qualche bandiera rossa del Pci, tirata fuori da chissà quale armadio. Un coraggioso metalmeccanico modenese temerariamente prova ad alzare la bandiera del Pd, ma è subito circondato da gente che gli urla minacciosamente «Via, via, quella bandiera! ». E lui, sia pure protestando («Intolleranti, vergognatevi ») deve ripiegarla e rimettersela nello zaino.
Landini, intanto, marcia dietro lo striscione della Fincantieri. Cosa significano tutte queste bandiere rosse? Lui prima finge di ignorare il senso della domanda: «Significano che il lavoro vuole essere rappresentato ». Poi però sorride, e aggiunge: «A me le bandiere rosse mettono il buonumore». E allora alle sue spalle parte partito il coro: «Avanti o popolo/ alla riscossa/ Bandiera rossa/ Bandiera rossa!».
Adesso quelle bandiere rosse punteggiano piazza del Popolo, salutate dallo speaker che annuncia: «Noi siamo le persone perbene, siamo il Paese reale!». Sventolano per salutare Rodotà, salito sul palco nonostante una recentissima frattura alla gamba, che usa l’ironia per attaccare Renzi: «Non sono un professorone pigro. Sono qui con le stampelle». In piazza ci sono anche parlamentari del Pd, testimoni di un dissenso sempre più evidente. «Sono qui per colmare un deficit di rappresentanza, visto che il governo è molto più vicino ai poteri forti» dichiara Stefano Fassina, mentre Pippo Civati ricorda che lui il Jobs Act non l’ha votato e Rosy Bindi avverte che «anche chi è contro il governo deve essere ascoltato».
E’ il battesimo di un nuovo soggetto politico? Landini lascia tutti nel dubbio, ripetendo alla fine del suo comizio che lui non vuol fare un partito «ma il sindacato deve avere una sua soggettività politica». Poi conclude citando, significativamente, papa Giovanni XXIII: «Quando sei per strada e incontri qualcuno, non gli chiedere da dove viene ma chiedigli dove va, e se va nella stessa direzione, cammina insieme a lui». E chi vuole intendere intenda.
La Repubblica, 28 marzo 2015
Spaccarsi per una piazza che non ti vuole. È il paradosso che imbriglia il Pd di lotta, in corteo con la Fiom e contro i democratici di governo. Toccherà a Stefano Fassina, Rosy Bindi, Pippo Civati e forse Gianni Cuperlo manifestare oggi per le vie di Roma, fino al comizio finale di Maurizio Landini. Dichiarerà guerra a Palazzo Chigi, si intesterà la battaglia per abolire il Jobs act con un referendum. Ma i riflettori sono già puntati sul futuro, quando la Coalizione sociale tenterà di scalare la Cgil e, chissà, anche la sinistra.
Due settimane dopo la prima riunione a porte chiuse in un seminterrato di corso Trieste, la struttura di Landini inizia a prendere forma in piazza del Popolo. Arriveranno in migliaia. Trecento pullman, bandiere dei metalmeccanici e i colori dei poster della prima campagna presidenziale di Obama. L’obiettivo è radunare cinquantamila persone, provando a immaginare nuove “Unions”, che è anche lo slogan dell’evento. La colonna sonora, neanche a dirlo, seguirà lo spartito degli storici canti operai del gruppo “Il muro del Canto”. Sul palco interverranno rappresentanti di Libera (con il suo “reddito di dignità”) e delegati Fiom, insegnanti della Cgil, studenti e i movimenti per la casa. Sarà proiettato un saluto di Gino Strada (Emergency) e letto un messaggio di Gustavo Zagrebelsky. E parlerà anche Stefano Rodotà.
Su un punto, però, il leader non transige: braccia aperte ad associazioni e movimenti (Arci, Giustizia e libertà) porte sprangate per le vecchie sigle. Certo, ci sarà Nichi Vendola nonostante il gelo degli ultimi mesi. E pure, come detto, frammenti della minoranza dem. «Visti da fuori - li ha massacrati Landini sull’Espresso - alcuni esponenti sembrano interessati soprattutto alla ricandidatura». Previsioni impietose. L’altra faccia della medaglia, quella renziana: «Hanno visto i dati positivi sull’occupazione? - domanda il vicesegretario dem Lorenzo Guerini - Quanto ai nostri, manifestano con chi si oppone al governo guidato dal loro segretario... Fatico a comprendere, lo ammetto».
Fuori dalla Coalizione sociale, in effetti, è tutto un rebus targato Pd. Con Matteo Renzi che ridimensiona - «è una manifestazione contro il governo, “no news”, non c’è titolo» -, la pattuglia bersaniana che si sfila e un altro pezzo di minoranza dem che spera di costruire un ponte. «Sarò lì per ascoltare - spiega Bindi - E anche un grande partito di centrosinistra dovrebbe ascoltare». Non che tutto fili liscio, anzi: «Sento la contraddizione - ammette Stefano Fassina - e mi preoccupa che tanti lavoratori avvertono il Pd lontano».
La tabella di marcia delle “Unions” di Landini è serrata: ad aprile un appuntamento per stilare il programma, poi le prime sedi territoriali e a maggio la convention nazionale. Una corsa senza respiro, mentre la sinistra politica antirenziana arranca. Fino a dove? Fino all’opa sulla Cgil, che Susanna Camusso proverà a contrastare affacciandosi in piazza del Popolo (l’intervento dal palco, invece, è ancora in bilico). E soprattutto fino a una nuova forza politica, nonostante l’estenuante pretattica: «Io resterò nel sindacato - giura Landini - ma chi partecipa al percorso risponderà al vuoto di rappresentanza ». Un partito, appunto. «Il dilemma lo risolverà Maurizio», taglia corto Civati. «Noi sforziamoci di non dividere la sinistra».
L'Espresso, 2 aprile 2015 (m.p.r.)
Lo scorso autunno una delegazione libica sbarca a Roma per discutere della Coastal road. È l'autostrada che il governo italiano ha promesso al fu Muhammar Gheddafi nel 2008, con Silvio Berlusconi premier e Altero Matteoli ministro delle Infrastrutture, per compensare i danni della colonizzazione sabaudo-fascista. Lo schema dell'accordo, mantenuto anche dopo la caduta del Colonnello, prevede che la società pubblica Anas international enterprise, controllata al 100 per cento dall'Anas, si occupi del progetto e della direzione lavori. La Libia può scegliere le imprese, purché siano di preferenza italiane (Salini-Impregilo, Cmc, Condotte, Pizzarotti). L'incontro romano si svolge in un'atmosfera surreale. I libici si sentono dire che alla direzione lavori sulla Ras Ejdyer-Emssad Motorway parteciperà anche la Ingegneria Spm di Stefano Perorti. No problem, rispondono. Sanno bene che in questo momento la costruzione di un'autostrada è più probabile su Marte che nella Libia devastata da tre anni di guerra civile e dall'attacco dello Stato Islamico. Ma conoscono gli italiani e sanno stare al gioco. E in gioco per adesso non ci sono i 2,3 miliardi di euro della Motorway costiera ma i 12.5 milioni di euro di consulenze tecniche e amministrative bandite a gara dall'ambasciata di Tripoli ma pagate con fondi degli ex colonizzatori.
L'inchiesta "Sistema" della Procura di Firenze rivelerà che la Spm è stata imposta da Ercole Incalza, il burattinaio del Mit, arrestato insieme all'ingegnere Perotti. Per l'autostrada libica è finito sotto inchiesta anche il direttore generale di Anas international, Fabrizio Averardi Ripari, che oggi si difende dicendo di avere subito le pressioni di Incalza per inserire Spm nel business libico. E la stessa tesi che ha rilanciato in termini generali Pietro Ciucci, dominus uno e trino dell'Anas secondo la definizione del capogruppo Pd al Senato Luigi Zanda. Secondo Ciucci, intervistato da Repubblica, i general contractors, ossia i grandi costruttori, sono appoggiati dai politici o dai grand commis del ministero e l'Anas è loro ostaggio.
Si potrebbe eccepire che un ostaggio, al contrario di Ciucci, non riceve ricchi emolumenti e non può dimettersi quando vuole. Ma la questione esiste, e da parecchi governi. II Partito democratico nemmeno era alle viste nel 2003 quando il senatore dell'Ulivo Zanda e i suoi colleghi Paolo Brutti e Anna Donati presentavano la prima interrogazione parlamentare sul "Sistema" che accentra progettazione e direzione lavori delle opere pubbliche nelle mani di un oligopolio. Nell'ultimo decennio giovani e meno giovani leoni dell'ingegneria hanno prosperato. I contraenti generali li nominavano come progettisti o direttori dei lavori, spesso con l'intermediazione interessata di sponsor politici. L'effetto è stato l'asservimento della tecnica al profitto.
Dalla Legge obiettivo di Berlusconi (2001) il settore è stato lottizzato a vantaggio di imprenditori privati dell'engineering e a scapito delle professionalità interne di società pubbliche come la stessa Anas o l'Iralferr (gruppo Fs) guidata un tempo da Giulio Burchi, un altro indagato di "Sistema". Ha fatto comodo a tutti. Alle imprese di costruzione, che guadagnano con le perizie di variante concesse dalla committenza pubblica su imbeccata dei tecnici. Ai controllori pubblici che, invece di controllare, si sono arricchiti con i collaudi. Ai tecnici che sono nominati dai contraenti generali, che incassano fra lo 0,7 e l'1 per cento dell'importo lavori e che hanno spesso una filiale straniera per smistare il nero. Ai politici, che fabbricano consenso con le inaugurazioni e ricevono favori sotto varie forme, dal versamento estero su estero all'assunzione dei figli, com'è accaduto all'ex ministro delle Infrastrutture Maurizio Lupi.
Nelle carte dell'inchiesta fiorentina sono citati vari progettisti di primo piano. Alcuni non sono indagati. Nel Sistema non è necessario commettere un reato. Basta che ognuno sappia trovare il suo posto in una lottizzazione dove i grandi hanno un giro d'affari a sette zeri e i meno grandi ricavano comunque 4-5 milioni di euro l'anno.
L'infinita metro C
Di Perotti si è detto che la sua specialità sono le vie ferrate, metropolitane o treni. Con il completamento della linea dell'alta velocità (Torino-Milano-Napoli) la Spm ha allargato il perimetro verso il settore stradale prendendo tre lavori sulla Salerno-Reggio. Tecnico molto apprezzato da Incalza, Perotti ha diretto il macrolotto 2 in Basilicata (200 milioni di euro di extracosti) per conto del consorzio italo-spagnolo Sis guidato da Claudio Dogliani. Con Pizzarotti ha gestito il macrolotto 4h e con la cooperativa Cmc il tratto Atcna Lucana-Sicignano. Poco prima che l'ingegnere romano venisse arrestato, un altro intervento sulla Salerno-Reggio (macrolotto 3.2) ha creato qualche problema alla Spm, con il crollo del viadotto Italia e la morte di un operaio.
Una vera maledizione visto che Spm è subentrata nella direzione lavori dopo l'esclusione di Giuseppe Marascio ingaggiato dalla Technical di Alessandro Mazzi, arrestato per l'inchiesta sul Mose. Marascio, un tempo molto vicino agli ambienti di An e all'ex ministro Matteoli, oggi indagato per il Mose, sta valutando se presentare ricorso contro la decisione dell'Anas attraverso il figlio Francesco, avvocato amministra-tivista e autore di un testo giuridico sulla revisione prezzi nei lavori pubblici con prefazione dello stesso Matteoli. Nel curriculum di Perotti spicca la direzione lavori della tratta Colosseo-San Giovanni della metro C di Roma (Astaldi, Caltagirone, Ansaldo Sts e Lega coop). In ritardo di anni, esplosa nei costi, la Metro C ha una delle commissioni di collaudo più care della storia per un totale di oltre 7 milioni di euro pagati da Roma metropolitane ai tre commissari Giuseppe Ricceri (3,3 milioni), ex presidente del consiglio superiore dei I.avori pubblici e consulente per il Mose, Andrea Monorchio (1,9 milioni di euro), ex Ragioniere generale dello Stato, e Dario Zaninelli (1,9 milioni di euro), citato nell'inchiesta sulla Cricca per la consulenza alla Scuola dei marescialli di Firenze.
Quadri e vigneti
L'ascesa di Perotti è avvenuta quando Antonio Bevilacqua detto Nino, 52 anni, era già il numero uno grazie alla quantità di incarichi accumulati dalle sue società: la Sis e la A&S prima, e oggi l'Italconsult. L'ingegnere palermitano è passato indenne dalla decadenza dei suoi protettori forzisti, dall'ex viceministro dell'Economia Gianfranco Miccichè a Denis Verdini. Per lui c'è stato il sostegno bipartisan di Lupi e del democrat Giuseppe Lumia, mentre il suo riferimento in Anas è Ugo Dibennardo, proconsole della spa pubblica in Sicilia dal 2008 al 2013. Sotto il profilo economico, Bevilacqua è il più forte del settore. Può vantare un fatturato di oltre 30 milioni di euro all'anno con Italconsult. In aggiunta, ha due alleati di peso nell'azionariato. Uno è Intesa, il colosso bancario che Burchi si vantava di rappresentare nel mondo delle infrastrutture lombarde (Teem, Brebemi e Pedemontana). L'altro è Tecnoholding, la società che riunisce le camere di commercio italiane. Appassionato di arte moderna e vitivinicoltore part-time (Terrazze dell'Etna), Bevilacqua è stato nominato presidente del porto di Palermo nel 2001 dal sindaco forzista Diego Cammarata. Si è dimesso nel 2013.
Oltre alla Catania-Siracusa con Pizzarotti, Bevilacqua ha gestito il raddoppio della statale 640, divisa in due lotti da oltre 1,5 miliardi di euro. Nel primo è stato progettista con la Sintel di Giandomenico Monorchio (figlio e Andrea) alla direzione lavori. Nel secondo ha diretto i lavori del consorzio Empedocle (Cmc, Ccc e Tec nis). Oltre alla statale 640, Bevilacqua ha fatto la parte del leone anche con la statale 106 Jonica (Reggio Calabria-Taranto). I maxilotti 1 e 2 sono suoi. Nel maxilotto 3 l'ingegnere siciliano ha soltanto la progettazione mentre la direzione lavori è di Monorchio.
Ci pensa papà
Classe 1970, Monorchio junior ha fondato Sintel engineering nel settembre 1998, tre mesi dopo essersi iscritto all'albo professionale e tre anni prima che il padre iniziasse a occuparsi di lavori pubblici alla guida di Infrastrutture spa (Ispa), la holding di Stato creata nel 2002. Prima di essere assorbita nella Cassa depositi e prestiti (2005), Ispa ha finanziato il Quadrilatero Marche-Umbria, i lotti 2 e 3 dell'A3, l'alta velocità ferroviaria Torino-Milano-Napoli (Sintel ha lavorato sulla Firenze-Bologna) e il Tay Milano-Genova dove la Sintel ha avuto la direzione lavori dal contraente generale Cociv, passato dal controllo del gruppo Gavio a Impregilo-Condotte. Sintel ha inoltre progettato il laboratorio del centro sperimentale dell'Anas a Cesano e l'impiantistica per il nuovo palazzo del cinema di Venezia, mai realizzato ma costato 37 milioni di euro.
Nel settore strade, Monorchio ha avuto la Torino-Novara dalla Sina del gruppo Gavio. A Sud ha diretto i lavori del macrolotto 6 dell'A3 per conto di Impregilio-Condotte. In entrambi i casi, le opere sono andate avanti fra ritardi e spese fuori controllo. Anche peggio è finita sulla Palermo-Agrigento, con lo smottamento del viadotto Scorciavacche. La Sintel era responsabile della direzione lavori con Fulvio Giovannini, rimosso dopo l'incidente su richiesta del presidente dell'Anas. Monorchio ha tentato la carriera politica presentandosi alle ultime comunali di Roma nella lista del collega ingegnere Alfio Marchini. l suoi 537 voti non sono bastati per un seggio.
Transoceanica
Con i suoi 86 anni appena compiuti e una transoceanica in barca a vela portata a termine nel 2010 è il decano del settore. Ma non si limita a navigare e ad esibirsi ai fornelli durante le serate Masterchef al circolo Canottieri Aniene. Dopo che Perotti è stato estromesso dalla direzione lavori sul macrolotto 3.2 della Salerno-Reggio, dove è sprofondato il viadotto Italia, tocca a Beomonte seguire un'opera che in fase di progettazione esecutiva ha già ottenuto un ritocco economico consistente. I lavori sono passati da 425 a 495 milioni di euro. Oltre che con la sua Cilento ingegneria, Beomonte ha spesso collaborato con un'altra primaria società di engineering, la 3Ti di Alfredo Ingletti e Giorgio Casciani. 3Ti ha ricavi superiori ai 20 milioni di euro e ha lavorato sull'A3 (macrolotti 5 e 6), sugli aeroporti di Bologna e di Fiumicino, nei paesi della penisola arabica, in Romania e in Sierra Leone.

Sbilanciamoci.info, 25 marzo 2015
La nuova inchiesta della Procura di Firenze sulla corruzione nelle grandi opere pubbliche, con 51 indagati, che ha portato all’arresto tra gli altri di Ercole Incalza ed alle dimissioni del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Maurizio Lupi, rende purtroppo evidente il cronico ed endemico legame tra realizzare infrastrutture, distorsione delle regole e malaffare. Numerose sono le grandi opere nel mirino delle inchieste: tratte ad Alta velocità come il terzo valico Milano-Genova, il sottoattraversamento AV di Firenze, l’AV Brescia-Verona, o le grandi autostrade come la Orte-Mestre, la Pedemontana Veneta e quella Lombarda, la Cispadana. Ma anche linee metropolitane come la linea C di Roma, e la M4 ed M5 a Milano. Incredibilmente dieci di queste grandi opere avevano lo stesso direttore dei lavori, ora arrestato nell’ambito dell’inchiesta.
Sarà la magistratura a stabilire le responsabilità personali di tutti i soggetti indagati nel Sistema degli appalti pubblici, mentre sul piano politico ed istituzionale abbiamo l’obbligo di un cambio deciso di passo sul sistema delle grandi opere. Sugli effetti distorsivi della Legge Obiettivo, sulla sterminata lista di opere che si vorrebbe realizzare di nessuna utilità collettiva, sulle deroghe e proroghe che diventano la regola nel sistema degli affidamenti, sulla mancanza di una credibile Politica dei Trasporti sostenibile. Così, nel caso più macroscopico delle scelte per mobilità e trasporti, non si è mai valutata la qualità del servizio da offrire ai cittadini dando priorità al trasporto pendolare e nelle città, ma piuttosto si sono privilegiati gli investimenti ad alta intensità di cemento, asfalto e consumo di suolo.
E’ il 9° rapporto sullo Stato di Attuazione della Legge Obiettivo, elaborato dal Servizio Studi Camera, Cresme ed Autorità Anticorruzione che espone i numeri esatti. Dal 2001 al 2014 le grandi opere strategiche sono diventate 419 ed il costo presunto pari a 383 miliardi di euro. Di queste quelle inserite nell’Allegato Infrastrutture 2014 del Governo valgono 285 miliardi di euro, ma quelle che effettivamente hanno un progetto preliminare o definitivo approvato al Cipe sono pari a 153 miliardi di Euro. Secondo il rapporto le opere completate si fermano a 6.5 miliardi di euro pari al 4,3% del totale. Se si considerano i singoli lotti ultimati questa percentuale sale all’8,4% del totale. Per quanto riguarda la tipologia di opere il 95% del totale riguarda infrastrutture nei trasporti: tra queste ben il 52% sono strade ed autostrade, gli investimenti ferroviari il 35% e le metropolitane poco più del 6%.
Più che evidente che se le liste sono sterminate, le risorse pubbliche assai scarse, le risorse private un miraggio sventolato per farsi approvare i progetti, i sistemi di decisione accentrati e semplificatori, in assenza di valutazioni Costi Benefici accurate e senza Valutazione Ambientale Strategica sulle grandi opere, l’unico criterio di selezione diventano le pressioni debite e soprattutto quelle indebite per fare avanzare e finanziare un’opera invece di un’altra al Cipe.
Da notare che una buona parte di grandi opere sono realizzate in concessione senza gara, (vi è solo un obbligo di porre una quota dei lavori a gara sul mercato), come il Mose, le grandi Autostrade private e pubbliche in concessione, l’Alta velocità ferroviaria: ne deriva un sistema bloccato e dei soliti noti, sia sul piano delle imprese che dei referenti politici.
La legge Obiettivo, voluta dal Governo Berlusconi nel 200, nel corso del tempo è stata anche peggiorata, con la possibilità di realizzare lotti funzionali e poi ancora “lotti costruttivi” tradendo quindi completamente la logica dei “tempi certi e costi certi” per le infrastrutture. E poi le semplificazioni procedurali, la Struttura Tecnica di Missione e le decisioni al Cipe, l’esclusione degli Enti locali, il General Contractor che diviene un soggetto privato impossibile da vigilare, le Valutazioni di Impatto Ambientale addomesticate.
A questo si aggiunga un Codice Appalti del 2006 con un doppio regime tra opere ordinarie e opere strategiche, con continue modifiche normative che rendono ormai impossibile comprendere cosa e come applicare le procedure, rendendo ancora più facile la vita a chi le regole le vuole evadere per i propri interessi privati.
Ed in continuità con queste distorsioni è stata anche l’approvazione nel 2014 del Decreto Sblocca Italia, dove con l’articolo 5, il Governo vuole prorogare la scadenza delle concessioni autostradali allungandogli la vita per realizzare le grandi autostrade, nonostante che robuste proroghe siano a suo tempo già state assicurate alle Concessionarie, evitando quindi le gare. Con tanto di aiuti fiscali retroattivi all’Autostrada Orte-Mestre ed ampie garanzie pubbliche verso i privati, come ben descritto nel testo di denuncia Rottama Italia. Perché lo Sblocca Italia è una minaccia per la democrazia ed il nostro futuro.” (Altreconomia Edizioni, 2015). Non a caso il Presidente dell’Autorità Anticorruzione Raffaele Cantone, si è scagliato contro queste proroghe delle concessioni ed ha definito la Legge Obiettivo “criminogena”.
Noi ambientalisti abbiamo contestato da sempre e duramente la Legge Obiettivo, ed ancora prima la logica dei grandi eventi come Mondiali ‘90 e Colombiane ‘92, o il sistema delle Ordinanze della Protezione Civile, delle ricostruzioni post terremoto e delle grandi emergenze, vere false o presunte, invocate per evitare gare ed una selezione trasparente gli investimenti utili. Ma fino ad oggi è stato impossibile vincere la battaglia delle "opere utili" con i mezzi delle razionali analisi tecniche su costi e benefici, della discussione aperta e democratica su cosa sia davvero necessario per realizzare trasporti e infrastrutture efficienti. E’ stato impossibile perché la commistione fra irresponsabilità politica, strapotere di funzionari pubblici inamovibili, appetiti di imprenditori senza scrupoli, “deregulation” che ha fortemente ridotto le garanzie sulla trasparenza amministrativa, la mancanza di politiche dei trasporti, hanno impedito un processo decisionale pubblico e scelte razionali nell’interesse collettivo.
Questo sistema ha di certo complicato anche la vita e l’attività delle imprese sane, quelle capaci di progettare e lavorare seriamente, di realizzare investimenti complessi e promuovere l’innovazione, che spesso per sopravvivere nel mercato, ancora di più in tempi di crisi dell’edilizia, si sono dovute “adattare” al Sistema distorto degli appalti pubblici.
Adesso è il momento di voltare pagina. E’ necessario abolire la Legge Obiettivo, il suo elenco di opere spesso inutili e insostenibili e di procedure che scavalcano procedure e regole a difesa delle finanze pubbliche e dell'ambiente: bisogna rivedere le norme sulla valutazione di impatto ambientale, permettendo un vero “dibattito pubblico” che consenta una valutazione ponderata e partecipata su cosa serva davvero al territorio, alle città e alla comunità.
Va poi rivisto il Codice Appalti del 2006, introducendo norme chiare e semplici per garantire gare trasparenti e piena concorrenza nel mercato dei lavori pubblici, impedire ogni genere di proroga o deroga rispetto alle vie ordinarie, rafforzare i poteri d’intervento dell’Autorità Anticorruzione.
È indispensabile eliminare quelle disposizioni contenute nel Decreto "Sblocca Italia" e nell’ultima Legge di Stabilità che nel solco della Legge Obiettivo aprono la strada a una nuova ondata di opere di nessuna utilità pubblica (trivellazioni petrolifere, inceneritori di rifiuti) ed elargiscono inaccettabili “favori” a lobby potenti con la proroga delle concessioni ai “signori delle autostrade”.
Insieme a tutto questo, è urgente riconsiderare le scelte su opere in corsa – dal tunnel per l’alta velocità Torino-Lione, al “terzo valico Milano-Genova, ai progetti di nuove autostrade (Lombardia e Veneto, Orte-Mestre, Autostrada della Maremma) - che a fronte di un costo per la collettività esorbitante, non servono a risolvere i problemi di mobilità dei cittadini/e ed hanno un elevato impatto ambientale.
Per scegliere le opere utili, grandi e piccole che siano, serve invece adottare un Piano dei Trasporti e della Logistica Sostenibile, applicando alle grandi opere le procedure previste dalle Direttive Europee per la Valutazione Ambientale Strategica. E’ dal 2001, quando fu messo rapidamente nel cassetto il PGTL del Ministro Bersani ed approvata dal centrodestra la Legge Obiettivo, che parliamo solo di liste e di grandi opere, senza una politica dei trasporti strategica, sostenibile e capace di futuro. Una politica di non solo infrastrutture, ma fatta di servizi di trasporto per i pendolari e le città, dove si muovono due terzi dei cittadini e che oggi non hanno un sistema di trasporto adeguato ed efficiente.
La corruzione è furto di bene comune, furto di diritti e di speranze, di opportunità e di lavoro. Per sconfiggerla occorrono innanzitutto leggi all’altezza: rapida approvazione del 416ter e della legge sugli ecoreati; confisca dei beni ai corrotti; pene adeguate per "reati civetta" come il falso in bilancio, l'autoriciclaggio, l'evasione fiscale; norme rigorose sul conflitto d’interessi. Ma le leggi da sole non bastano: serve anche l'impegno di tutti - a cominciare da quanti hanno titolo nelle decisioni pubbliche - a farle vivere attraverso le scelte e i comportamenti quotidiani.
Infine, è decisivo che la scelta del/la nuovo/a Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti - che il Presidente del Consiglio Renzi si appresta a scegliere - risponda a un radicale cambio di rotta negli indirizzi e nei metodi delle politiche pubbliche in materia di infrastrutture. Occorre un/a Ministro consapevole che le grandi opere essenziali per l’Italia sono quelle dettate dall’interesse generale di tutti, non quelle imposte dalla convenienza privata di pochissimi: sono, dunque, rimettere in sesto il nostro territorio, assicurare una mobilità pubblica efficiente nelle città e rimediare allo stato arretrato del trasporto regionale, puntare sul ferro e sul cabotaggio costiero per il trasporto delle merci smettendo di favorire con regali milionari il settore dell’autotrasporto.
Questo gli ecologisti reclamano inutilmente da anni. Se il Governo vuole davvero demolire la “cupola” che da anni governa i grandi affari delle grandi opere, l’occasione è oggi.
Il manifesto, 26 marzo 2015 (m.p.r.)
La nuova direttiva europea sugli Organismi geneticamente modificati (2015/412) è appena stata pubblicata sulla Gazzetta ufficiale europea. A una prima lettura sembrerebbe una norma in difesa della biodiversità e dell’agricoltura sostenibile poiché prevede la possibilità per gli stati dell’Unione europea di vietare la coltivazione di Ogm. Anche i dati relativi al 2014 pubblicati dall’International Service for the Acquisition of Agri-biotech Applications (Isaaa) non sono incoraggianti per le multinazionali biotech: con un ulteriore calo del tre per cento la superficie coltivata a Ogm in Europa si è ridotta a 143.016 ettari di mais Bt coltivati in 5 paesi su 28 (si coltiva in Spagna il 90% delle superficie totale). Il resto sono briciole sparse tra Portogallo, Romania, Slovacchia e Repubblica Ceca. In Italia, nell’immediato, non dovrebbero aprirsi scenari allarmanti: è in vigore un divieto temporaneo che impedisce la coltivazione dell’unico Ogm autorizzato per la coltivazione in Europa, il mais Mon810 di Monsanto.
Battaglia vinta? Tutt’altro. La nuova legge europea presenta alcune criticità. Una in particolare. Il governo che volesse bandire gli Ogm dal suo territorio non potrà addurre motivazioni che contrastano con la valutazione di impatto ambientale condotta dall’Efsa (Autorità europea per la sicurezza alimentare). «Significa che i governi - spiega Federica Ferrario di Greenpeace - non possono basare i bandi su specifici impatti ambientali o evidenze di possibili danni da parte delle coltivazioni Ogm a livello nazionale nel caso in cui questi rischi non siano stati presi in considerazione da parte della valutazione dell’Efsa».
Quindi i paesi non potranno utilizzare argomentazioni di carattere ambientale per giustificare il divieto di coltivazione. Inoltre, la nuova direttiva rimette in moto l’attività della Commissione europea sempre molto disponibile ad autorizzare nuovi Ogm (il primo in esame è il mais 1507, inventato per resistere all’erbicida glufosinato che nel 2017 sarà vietato in Europa per la sua tossicità). Ma anche di fronte a un Ogm buono autorizzato dalla Ue e certificato dall’Efsa non sarebbe scongiurato il fattore di rischio più pericoloso per coltivatori e consumatori: la contaminazione. Secondo uno studio di Greenpeace, condotto con il gruppo di ricerca inglese GeneWatch e pubblicato dalla rivista
International journal of food contamination, dal 1997 al 2013 si sono verificati circa 400 casi di contaminazione.
Ma la vera trappola che potrebbe vanificare un decennio di lotte condotte dagli ambientalisti europei e stravolgere le regole della produzione del sistema agroalimentare del vecchio continente - non solo per l’insidia Ogm - si chiama Transatlantic Trade and Investment Partnership, meglio (s)conosciuto ai più con la sigla Ttip. Si tratta di un accordo semi segreto per «facilitare» gli scambi economici tra Europa e Stati Uniti. L’obiettivo dichiarato è agevolare la circolazione delle merci armonizzando le diverse normative che esistono in Europa e negli Stati Uniti. Cosa succederà per quanto riguarda agricoltura e cibo? Il mistero è fitto. Le trattative febbrili.
I catastrofisti ritengono che le nuove regole del trattato favoriranno le aziende a stelle e strisce. Le conseguenze? Cibi Ogm difficilmente rintracciabili, maggior utilizzo di pesticidi, predominio dei grandi cartelli agroindustriali, scarsa tutela dei prodotti tipici, etichettature e tracciabilità meno approfondite e delocalizzazione della produzione alimentare dove costa meno. Non è la “pistola fumante” ma poco ci manca: su quasi 600 incontri di consultazione realizzati dalla Commissione europea - di cui ci sono pochi documenti in circolazione - circa 500 si sono svolti alla presenza di potenti aziende del settore (sementi, allevamento e mangimi, biotech, produttori di bevande e cibi).
Lo scontro è tra un paese con un sistema agricolo che punta sulla quantità e uno che sta sul mercato grazie alla qualità della sua produzione. Un sistema a maglie larghe contro uno con normative più rigide. Per le associazioni ambientaliste e dei consumatori l’esito è scontato: «l’armonizzazione» delle leggi per l’Europa si tradurrà in una cessione di sovranità in termini di sicurezza.
Marco Zullo, parlamentare europeo del M5S (commissione agricoltura) non ha dubbi. «La qualità dei cibi che arriveranno sulle nostre tavole è a rischio - ha spiegato - perché perderemo la tutela derivante dalle informazioni presenti sulle nostre etichette. Gli Usa non hanno un sistema di etichettatura ferreo come quello europeo e non hanno certo intenzione di introdurlo con il Ttip. In Europa le procedure di controllo per ottenere un’autorizzazione sulla sicurezza alimentare sono più complesse. Negli Usa sono permesse sostanze vietate in Europa, come cereali Ogm, antibiotici, carne derivata da animali clonati e sostanze chimiche. In nome del libero mercato tutte queste informazioni non saranno a nostra disposizione nelle etichette post-Ttip».
Questo è vero in particolare quando si parla di Ogm. Mentre in Europa, nonostante i tentativi delle
lobby, esiste un quadro giuridico che si basa sul principio di precauzione (procedure rigide per l’autorizzazione ampia valutazione del rischio, consultazione pubblica obbligatoria), negli Stati Uniti gli Ogm non devono essere sottoposti ad autorizzazione. Non esiste nemmeno un registro pubblico degli Ogm autorizzati. Per non parlare della trasparenza. In Europa, dove non esiste un solo prodotto Ogm destinato all’alimentazione umana, è obbligatorio segnalare sull’etichetta una quantità geneticamente modificata superiore allo 0,9 per cento. Negli Stati Uniti, invece, l’etichettatura è volontaria. Ma anche nella patria di Monsanto&Co. i consumatori cominciano a chiedere più trasparenza: lo stato del Vermont ha deciso che dal luglio 2016 sarà obbligatorio segnalare una quantità di Ogm superiore allo 0,9%, una legge che è stata impugnata da una potente associazione che raggruppa produttori e distributori alimentari.
La consapevolezza del rischio per il settore agro alimentare dell’Europa è documenta anche da uno studio specifico realizzato per il Parlamento europeo dalla Direzione generale delle politiche interne. Secondo il dossier, «se il commercio fosse liberalizzato senza una convergenza normativa, i produttori europei potrebbero subire gli effetti negativi della concorrenza in alcuni settori… Questo è particolarmente rilevante per quanto riguarda i vincoli dell’Ue in merito all’uso degli Ogm, dei pesticidi e alle misure di sicurezza alimentare nel settore della carne».
Il gioco d’azzardo degli americani non è un mistero per nessuno. «Nei negoziati relativi al Ttip - si legge nel dossier - una facilitazione nell’approvazione e nel commercio degli Ogm è un’importante richiesta dei coltivatori e delle imprese statunitensi. Essi sono sostenuti dalle autorità Usa, che lamentano la lentezza e le poche autorizzazioni alla vendita e al commercio di organismi geneticamente modificati. Il governo americano, inoltre, ritiene che l’etichettatura obbligatoria degli Ogm discrimini ingiustamente questi prodotti». Come se ne esce? Secondo Dan Mullaney, uno dei negoziatori statunitensi per il Ttip, dovrebbe essere la scienza a fare da arbitro: «Se l’Unione europea ha un processo scientifico per le biotecnologie, questo deve essere seguito», ecco il suggerimento. Quindi, «le decisioni in materia di sicurezza alimentare dovrebbero essere basate sulla scienza e sulla valutazione d’impatto». Traduzione: che decida l’Autorità europea per la sicurezza alimentare (l’Efsa) e che gli stati europei facciano un passo indietro davanti a un parere scientifico favorevole all’introduzione di un Ogm sul mercato. Che si siano già accorti delle criticità (o trappole) della nuova direttiva europea?