


Ora che il momento della deposizione del presidente Napolitano al processo sulla “trattativa Stato-mafia” è arrivato, è giusto chiarire ai lettori del Fatto Quotidiano, italiani fortunati a essere stati costantemente informati di questo processo oscurato dai media, cosa è lecito attendersi da questa udienza che si svolgerà in pompa magna nientedimeno che al Quirinale, sede della più alta carica dello Stato. E credo di poter rivendicare, per la mia storia e il ruolo che in quel processo ho svolto, il diritto di poter dire la mia in virtù di un doppio vantaggio.
Io non sarò in quella sala del Quirinale trasformata in aula di udienza perché non sono più pm della Procura di Palermo, e non lo sono più anche perché ho ritenuto non vi fossero più le condizioni per un pieno accertamento della verità. E credo che la sorte di questa udienza ne sarà una riprova, così come la distanza fra le domande che avrei voluto fare io e quelle che i pm potranno fare al Presidente Napolitano.
La prima domanda che farei al Presidente Napolitano sarebbe: perché quando il senatore Nicola Mancino la cercò al telefono direttamente, e anche indirettamente tramite Loris D’Ambrosio, Lei non ritenne di astenersi dal mantenere rapporti e contatti con il senatore Mancino, che si sapeva essere in quel momento coinvolto nell’indagine sulla trattativa? Perché, anzi, assicurò il suo interessamento, facendo intendere a Mancino che avrebbe assecondato il suo disegno di sottrarre alla Procura di Palermo la direzione dell’indagine sulla trattativa? Lo fece solo per non dispiacere un vecchio amico e collega, o piuttosto lo fece per una superiore ragion di Stato? E quale, di grazia, era questa ragion di Stato? Peccato che questa domanda oggi sarebbe inammissibile, grazie alla politica, le ragioni della politica che l’hanno indotta, signor Presidente, a sollevare un conflitto di attribuzione contro la Procura di Palermo. Le stesse ragioni della politica che poi hanno “indotto” la Corte costituzionale a darLe ragione, così coprendo di una malintesa immunità presidenziale tutte le Sue attività intorno a quella vicenda. Domanda respinta perché non consentita.
La seconda domanda, collegata, sarebbe di chiederLe perché non ritenne di contattare i pm palermitani per informarli dei contatti impropri attraverso i quali Mancino cercava di interferire sulle indagini in corso. Ma immagino che anche questa domanda mi sarebbe inibita dal presidente della Corte d’Assise in virtù di quella stessa sentenza politica della Corte costituzionale. Domanda respinta perché non consentita.
E ancora peggior sorte avrebbero le mie domande sulle telefonate “indicibili”, essendomi sempre chiesto perché Napolitano, se fosse stato davvero convinto che le telefonate intercettate con Mancino non contenessero nulla di inquietante e indicibile, non ha fatto nulla per sgombrare il campo da malignità e dietrologie, facendo in modo che quelle telefonate diventassero pubbliche, anziché addirittura imporne la distruzione. Domanda respinta perché non consentita.
E ancora: è certo, signor Presidente, che il conflitto di attribuzione sollevato davanti alla Corte costituzionale contro la Procura di Palermo abbia aiutato la ricerca della verità e non l’abbia invece ostacolata? Domanda respinta perché non consentita. E infine: è certo che il tentativo di sottrarsi alla testimonianza dichiarandola preventivamente inutile sia stato un modo per aiutare la ricerca della verità? Domanda respinta perché non consentita.
Ma avrei insistito. Del resto, mi è già accaduto a Palazzo Chigi, quando andai a interrogare Silvio Berlusconi nel corso del processo Dell’Utri, di provare a insistere con le domande nonostante Berlusconi, come oggi Napolitano, avesse fatto sapere alla Corte di non avere notizie utili da riferire, e alla fine venne costretto ad avvalersi della facoltà di non rispondere. Facoltà invece non consentita al Presidente Napolitano. E perciò, insistendo, avrei chiesto al Presidente quali fossero i segreti su certi “indicibili accordi” che Loris D’Ambrosio aveva rivelato solo a lui e mai ai magistrati, come lo stesso D’Ambrosio scrisse nella lettera del 18 giugno 2012 indirizzata a Napolitano. Quel segreto che aveva così tanto tormentato un uomo di Stato come D’Ambrosio da farlo morire di crepacuore (se solocrepacuore fu, visto che non è mai stato disposto alcun accertamento medico-autoptico). Un segreto che solo Lei, sig. Presidente, può rivelare alla Corte.
Le mie domande sarebbero impertinenti? Forse. Ma sono le domande di chi ha giurato sulla bara di Paolo Borsellino che avrebbe fatto di tutto per scoprire tutta la verità sulla morte sua e di tante altre vittime innocenti, e oggi sappiamo anche della trattativa. Di tutto. Anche a costo di uscire dalla magistratura, e quindi a costo della propria carriera. A qualsiasi costo. Provando a emulare l’irriducibilità e l’intransigenza di un vero uomo come Paolo Borsellino.
Legge di stabilità. La manovra avrà conseguenze distributive inique e ulteriormente depressive sulla crescita. Renzi fa scelte economiche e sociali omogenee agli interessi dei settori del Paese funzionali ai suoi obiettivi di sfondamento nel centrodestra.
Il manifesto, 23 ottobre 2014
La politica economica dell’illusionismo praticata dal governo Renzi fin dal suo insediamento viene confermata e accentuata dalla legge di stabilità. L’evoluzione della crisi globale — e specificamente di quella europea — dà conto di un contesto niente affatto favorevole a tentativi approssimati come quelli messi in opera dal nostro per curare la grave situazione italiana.
L’errore di fondo della manovra sta nel reiterare un approccio inadeguato alla natura della crisi. Che tende a migliorare solo alcune condizioni d’offerta del settore produttivo (ridurre il costo del lavoro e aumentarne la flessibilità).
Senza curarsi della decrescente capacità innovativa alla base del nostro declino; ma non affronta in modo efficace il problema più urgente, le carenze della domanda.
Renzi ha detto agli industriali «vi tolgo l’art. 18 e i contributi, vi abbasso l’Irap, ora assumete»; ma la manovra riduce i costi (e aumenta i profitti) per le imprese che già dispongono di una domanda che, tuttavia, è insufficiente a impegnare le risorse produttive esistenti e non aumenterà significativamente con la riduzione di imposte e contributi. Anzi, i dati confermano che, pur riducendo il cuneo fiscale e aggiungendo 80 euro in busta paga — ma aumentando la precarietà dei posti di lavoro — i consumi e gli investimenti non crescono.
Dal punto di vista dello stimolo alla crescita, tagliare (spending review) di 15 miliardi la spesa pubblica e pensare di compensarne gli effetti riducendo di 9,5 miliardi i contributi a carico dei lavoratori (per tramutarli negli 80 euro in busta paga), di 5 miliardi l’Irap e di 1,9 miliardi i contributi a carico delle imprese per incentivare i contratti a tempo indeterminato, è un’operazione con effetto complessivo negativo perché riduce la domanda effettiva. I tagli di spesa si traducono in calo della domanda, che è accresciuta solo in piccola parte dalla riduzione dei contributi. In più con i tagli ai beni e servizi primari, una loro conservazione almeno parziale richiederà un aumento della tassazione locale.
Dal punto di vista distributivo, la manovra beneficia le imprese, soprattutto dei settori meno dinamici (su 36 miliardi, solo 300 milioni a ricerca e sviluppo); in via diretta (riducendo imposte e contributi e concedendo nuovi incentivi) e indiretta per gli effetti di traslazione sia degli sgravi contributivi sia dell’eventuale trasferimento in busta paga del Tfr. L’aspetto determinante è la debolezza contrattuale dei lavoratori. Queste «riforme» hanno accorciato i tempi di rinnovo dei contratti a tempo determinato; ora eliminano l’art. 18 nei contratti a tempo indeterminato; questi ultimi paradossalmente garantiranno minori certezze temporali dei primi. In questo contesto tutti gli interventi di riduzione del cuneo fiscale, anche quelli immaginati per aumentare la busta paga (80 euro e Tfr), saranno riassorbiti a vantaggio delle aziende. Succede sempre di più che i lavoratori siano costretti a firmare buste paga superiori a quelle effettive. E questo fa capire quanto le imprese, specie quelle piccole, possano utilizzare la normale contrattazione per dirottare a loro vantaggio le misure che dovrebbero aumentare le buste paga. E tutto ciò è accompagnato dalla truffa ideologica secondo cui il «nuovo verso» renziano aumenterebbe la libertà di scelta dei lavoratori, ad esempio sul Tfr; tralasciando che certi bisogni, come quelli di tipo previdenziale, sono meglio percepiti e corrisposti se organizzati in modo collettivo e con obbligo assicurativo.
Presto la «modernità» liberista (e renziana) vorrà convincerci ad eliminare il sistema pensionistico pubblico, quello sanitario, le norme per la sicurezza nei luoghi di lavoro e tutte le norme che hanno segnato l’avanzamento civile.
La legge di stabilità, nonostante i suoi scarsi effetti espansivi e le negative conseguenze distributive (inique e ulteriormente depressive sulla crescita), crea anche motivi di contrasto con Bruxelles che potrebbero risolversi in misure penalizzanti.
Quando, nel luglio 2012, Mario Draghi, disse in un famoso intervento rivolto ai mercati finanziari, che la Bce avrebbe difeso l’Euro con tutte le sue forze, la speculazione internazionale si fermò, comprendendo che era troppo rischioso andare oltre se la Bce si comportava come una banca centrale normalmente deve fare, cioè difendere l’intera economia di cui è uno strumento di politica economica. I tedeschi e i loro solidali del rigore «stupido» non ne furono lieti, ma dovettero constatare che questo ridava fiato all’intera Ue. Per oltre due anni l’avvertimento di Draghi ha retto.
Nel frattempo è aumentata l’offerta di moneta sia della Fed statunitense sia della Bce; l‘economia reale non ne ha beneficiato (in assenza di mutamenti strutturali della politica economica), ma sono aumentate le munizioni della speculazione finanziaria. Se questa si convincerà che l’opposizione tedesca alla linea della Bce arriverà a bloccarne l’attuazione, l’attacco alle economie più deboli ripartirebbe alla grande. Quella italiana sarebbe tra le prime a farne le spese. Dunque, anche per questa evenienza, l‘Italia dovrebbe massimizzare l’effetto espansivo delle politiche: solo una maggiore crescita del Pil può migliorare i nostri indicatori finanziari. Ma Renzi fa scelte economicamente e socialmente omogenee agli interessi dei settori del Paese meno dinamici (le imprese non innovative), politicamente funzionali ai suoi obiettivi di sfondamento nel centrodestra e di emarginazione dei suoi oppositori di sinistra. I quali, peraltro, anche criticando queste politiche, non hanno la capacità di unire le loro forze per difendere gli interessi e le prospettive che pure riguardano l’intero Paese.
La distrazione di massa dai problemi effettivi praticata dalle politiche di Renzi, il suo illusionismo, si accomoda alla politica tedesca che frena l’economia e il processo unitario dell’Ue. È indispensabile un’inversione di rotta; questo è l’appuntamento storico che la sinistra sta mancando
 «E' più urgente costruire un’autostrada o mettere in sicurezza una regione e la vita di quasi due milioni di persone? Questo è il grande compito della politica: decidere, scegliere le priorità, guardare al futuro».
«E' più urgente costruire un’autostrada o mettere in sicurezza una regione e la vita di quasi due milioni di persone? Questo è il grande compito della politica: decidere, scegliere le priorità, guardare al futuro».
Il Fatto Quotidiano, 20 ottobre 2014
L’acqua si ritira da Genova. Per fortuna. Anche l’indignazione. Purtroppo. Finiremo ancora una volta per affidarci alla sorte e alle preghiere, che sono più utili delle previsioni meteo. Eppure è proprio questo il momento per cominciare a lavorare perché non accada più. Chissà se il premier Renzi ci leggerà. Probabilmente no, e forse è giusto così. Magari, verrebbe da dire, è troppo impegnato a scrivere tweet ed sms, ma lasciamo da parte le polemiche. Ha davvero compiti e responsabilità da far tremare i polsi. Però proviamo a far arrivare qualche dubbio fino a chi ci governa e quindi ha in mano letteralmente la nostra vita.
Il Governo ha recentemente annunciato il lancio di nuove grandi opere come occasione di modernizzazione e motore dell’economia. Facciamo un esempio: l’autostrada Mestre-Orte, che costerà oltre dieci miliardi. Un’opera voluta da tutti: dal presidente Giorgio Napolitano a Pierluigi Bersani, passando per Vito Bonsignore, politico Pdl con amici a destra e a sinistra, nonché imprenditore impegnato nel progetto. Ecco, prima di realizzare un’opera tanto discussa non sarebbe il caso di investire un ventesimo delle risorse per salvare l’intera Liguria intrisa di acqua e di cemento?
La domanda è secca: è più urgente costruire un’autostrada o mettere in sicurezza una regione e la vita di quasi due milioni di persone? Questo è il grande compito della politica: decidere, scegliere le priorità, guardare al futuro.
Ancora: il decreto Sblocca Italia (come ha spiegato Tomaso Montanari anche nel libro Rottama Italia scaricabile dal sito altraeconomia.it) introduce novità insidiosissime per il nostro ambiente. Non vogliamo negare - anche se abbiamo molti dubbi - che lo spirito sia quello di dare un impulso all’economia. Non ci interessa affermare che si vogliano favorire le lobbies del cemento e dell’asfalto. Ma di fatto il risultato rischia di essere devastante: in nome di un malinteso criterio di speditezza nella sostanza si eliminano i controlli, si riduce a semplice simulacro il ruolo di amministrazioni locali e Soprintendenze. Così, al di là di tante belle e facili parole, si preparano le alluvioni di domani.
Non basta: se non vogliamo recuperare il territorio per salvare delle persone e vivere meglio, facciamolo perché ci conviene. Bonificare e recuperare le zone a rischio sarebbe occasione di lavoro per migliaia di imprese. Di più. Il paesaggio è la materia prima della nostra più grande industria: il turismo, che vale l’11% del pil e tre milioni di posti di lavoro (e potrebbero essere molti di più, perché oggi siamo quinti nella classifica del turismo, con trenta milioni di presenze meno della Francia).
Evitare le alluvioni, vivere meglio e dare insieme impulso all' economia si può.
 «E' forse un caso che questa polemica viene innescata durante le consultazioni segrete per l’approvazione del Ttip, il trattato commerciale fra Usa e Ue che, guarda caso, ha fra i suoi obiettivi proprio quello di sbarazzarsi del principio di precauzione europeo?».
«E' forse un caso che questa polemica viene innescata durante le consultazioni segrete per l’approvazione del Ttip, il trattato commerciale fra Usa e Ue che, guarda caso, ha fra i suoi obiettivi proprio quello di sbarazzarsi del principio di precauzione europeo?».
Il manifesto, 14 ottobre 2014 (m.p.r.)
Anche in Italia si sta svolgendo un serrato e avvincente dibattito intorno al tema degli ogm a cui stanno partecipando personalità di spicco del mondo accademico, della politica e del settore principale di riferimento che è quello agricolo. È importante riconoscere l’utilità del dibattito e il valore delle posizioni di tutti gli attori coinvolti. In molti casi, come ha sostenuto giustamente Carlo Petrini, le posizioni dei cosiddetti stakeholders, i portatori di interessi, rimangono nella penombra come è il caso delle stesse multinazionali che molto volentieri si sottraggono al dibattito pubblico, interessate come sono maggiormente ad occuparsi di influenzare direttamente la politica attraverso le loro lobby piuttosto che informare i cittadini. In molti altri casi, come quello del New Yorker, il dibattito scade a livello di attacchi personali, sospetti, illazioni, velate e non, nei confronti di uno dei rappresentanti più significativi del movimento ambientalista globale: Vandana Shiva. Un dibattito, in cui ognuno mette a disposizione dell’opinione pubblica la propria diretta esperienza e conoscenza, è invece utile alla vita democratica dei paesi.
Navdanya significa nove semi e la fondazione, diretta da Vandana Shiva, si occupa prevalentemente di riconoscere, tutelare e valorizzare il patrimonio sementiero tanto importante per l’umanità quanto la disponibilità di acqua. La questione degli ogm è dunque una questione che potremmo definire come “aggregata” alla mission principale dell’associazione ed è trattata proprio dal punto di vista della difesa della biodiversità.
Gli ogm non sono i soli nemici della nostra biodiversità, che negli ultimi anni è stata erosa in maniera quasi irreparabile, ma, in questa sede, è utile discutere proprio del loro impatto sulle nostre vite e su quella del pianeta. La prima cosa da sottolineare è questo interessante riferimento al paradigma scientifico. Chi è a favore degli ogm è in linea con l’evoluzione scientifica, un progressista; chi non lo è, diventa invece un retrogrado, un conservatore. Questa visione manichea presenta aspetti paradossali.
Gli ogm sono stati dapprima introdotti negli Usa secondo il cosiddetto principio della “sostanziale equivalenza”. In altre parole, se un’invenzione è sostanzialmente equivalente a qualcosa di già esistente non ha bisogno di particolari sperimentazioni e può essere lanciata sul mercato. A pensarci bene è la stessa tesi espressa dal professor Veronesi. Il dna ha una struttura estremamente semplice che può essere facilmente manipolata senza necessità di preoccuparsi più di tanto. Ora, questo approccio all’americana all’esistente, e soprattutto al commerciabile, non è accettato dall’Unione Europea dove vige il principio di precauzione. In altre parole, se un’azienda inventa un nuovo prodotto deve essere dimostrato che non è nocivo prima di essere immesso sul mercato. La posizione dell’Ue è chiara: non esistendo un consenso scientifico, gli ogm non possono essere dichiarati sicuri. Nel dubbio, vige il principio di precauzione che dovremmo difendere perché protegge le nostre vite da invenzioni che sono spesso più indirizzate a fare profitti sul mercato piuttosto che perseguire il bene comune.
Ogni parte porta, d’altro canto, le sue argomentazioni a riguardo. Anche Navdanya ha pubblicato un rapporto sull’argomento raccogliendo gli studi di moltissimi ricercatori che dimostrano la nocività degli ogm. Vi sono nel mondo studi similari che dimostrano l’esatto contrario. L’Ue ha concluso che non esiste possibilità di dichiarare gli ogm sicuri fuori da ogni ragionevole dubbio. Ed ha applicato il principio di precauzione per salvaguardare i suoi cittadini. La polemica sugli ogm comprende anche questo sacrosanto principio. Allora viene da pensare: è forse un caso che questa polemica viene innescata durante le consultazioni segrete per l’approvazione del Ttip, il trattato commerciale fra Usa e Ue che, guarda caso, ha fra i suoi obiettivi proprio quello di sbarazzarsi del principio di precauzione europeo? È forse un caso che le multinazionali dell’agribusiness siano i maggiori lobbisti per l’approvazione dell’accordo? Come possiamo allora costruire un’opinione razionale e condivisa su questo argomento? Soprattutto quando i promotori degli ogm ci dicono che la nuova tecnologia potrebbe rappresentare la panacea di ogni male al mondo?
Uno degli aspetti che sembra mancare nell’analisi di Veronesi è quello della contestualizzazione, quasi che il mondo finisse sulla soglia dei laboratori. Gli ogm non vengono fuori dal nulla, o per nessun motivo. Non sono liberamente a disposizione di tutti e la loro applicazione, al di là della diatriba scientifica, comporta contraccolpi ambientali, economici e sociali notevoli. Possiamo allora dire con sicurezza che i semi e i prodotti ogm nel campo dell’agricoltura hanno un impatto devastante sul settore. Gli ogm sono infatti proprietà delle multinazionali che, attraverso la loro immissione sul mercato, rimodellano i sistemi agricoli di tutto il mondo. A farne le spese sono i piccoli produttori che con le loro colture tradizionali non possono tenere il passo delle produzioni industriali sovvenzionate. Con i metodi di coltivazione intensiva la necessità di manodopera viene inoltre ridotta. Non i profitti però. Cosa succede agli agricoltori nel frattempo?
Quello che è accaduto in Sud America e in India è, per esempio, emblematico. Centinaia di migliaia di persone si muovono dalle campagne alla città andando ad ingolfare fetide baraccopoli. In altre parole, il rischio è quello di alimentare il sistema dei grandi latifondi e inondare le città con una massa di disperati. Un danno economico, sociale e anche culturale considerando la perdita delle antiche conoscenze di cui le popolazioni rurali sono depositarie. La favola che gli ogm possano rispondere al problema della fame nel mondo e del sovrappopolamento è, per l’appunto, una favola. Quello che importa sono i contraccolpi di un sistema industriale basato sugli ogm sulle economie, sulle popolazioni e sulle culture locali. E questo impatto risulta essere, secondo gli studi effettuati da Navdanya e da molte altre organizzazioni che lavorano fuori dai laboratori e direttamente sul campo, non equo, non ecologico, non sostenibile. A guadagnarci sono ancora una volta i pochi, a perderci i molti.
Questa schematica analisi vuole solo dimostrare quanto i fenomeni siano interconnessi e come leggere un articolo sulla valenza della ricerca scientifica transgenica può essere interessante in se stesso ma non esaustivo. La ricerca scientifica deve essere al servizio dell’umanità e non viceversa. Quando ciò accadrà anche nel settore agricolo, a beneficio di contadini e consumatori e non delle multinazionali, Vandana Shiva sarà, con tutta probabilità, la prima persona ad esultarne.
 Organizzati, comunicativi e con una nuova leadership. Questo occorre oggi per costruire una nuova sinistra e scongiurare il disastro dell'Italia. Un ragionamento basato sulla valutazione critica dell'esperienza "movimentista".
Organizzati, comunicativi e con una nuova leadership. Questo occorre oggi per costruire una nuova sinistra e scongiurare il disastro dell'Italia. Un ragionamento basato sulla valutazione critica dell'esperienza "movimentista".
Il manifesto, 11 ottobre, con postilla
All’indomani del «patto degli Apostoli» e dell’invito di Norma Rangeri a una nuova unità a sinistra, Tonino Perna invita alla prudenza e sollecita «una grande tessitura sociale e culturale di parole in grado di costruire la visione del futuro desiderabile e credibile». Ha ragione: il disastro renziano ha radici antiche e l’alternativa non può certo stare in una rivincita (seppur la cercasse) dell’establishment del Pd di ieri, che di quel disastro ha posto le premesse politiche e culturali (a cominciare dall’elevazione a stelle polari «delle leggi di mercato e della crescita economica senza se e senza ma»).
Ma questa necessaria tessitura deve accompagnarsi a una iniziativa politica immediata: perché il rischio di una desertificazione del tessuto sociale e istituzionale è sempre più forte e sul deserto è difficile anche ricostruire. Nello stesso tempo, non siamo all’anno zero ché i tentativi degli ultimi tempi, seppur improduttivi sul piano elettorale, non sono stati avari di elaborazione culturale. Una rinnovata iniziativa politica, che abbia l’ambizione di diventare egemone (e non solo di superare il quorum delle prossime elezioni, sperando che non sia troppo alto…), deve, peraltro, misurarsi con alcune questioni, troppo spesso eluse o esorcizzate e che stanno alla base degli insuccessi degli ultimi anni. Provo a indicarne alcune.
Primo. In tutte le recenti esperienze alternative e innovative ci si è mossi, talora teorizzandolo e comunque nei fatti, sul presupposto che le buone idee sono di per se sole, proprio perché buone, capaci di produrre in modo automatico l’organizzazione necessaria (e sufficiente). Non è così. Lo dico pur consapevole, da vecchio movimentista, delle degenerazioni burocratiche e autoritarie che spesso si annidano negli apparati. Contro queste derive va tenuta alta la guardia ma la sottovalutazione del momento organizzativo (e della sua legittimazione) è stata una delle cause principali della rissosità e della inconcludenza di molte aggregazioni politiche ed elettorali dell’ultimo periodo. Posso dirlo per esperienza diretta con riferimento a “Cambiare si può” (paralizzato dalla mancanza di luoghi di decisione e, per questo, facile preda di una nefasta e alienante occupazione). Ma lo stesso dimostrano le difficoltà in cui si dibatte la lista Tsipras.
Secondo. La bontà delle idee non ne garantisce, di per se sola, neppure la capacità di autoaffermarsi e di aggregare consensi. Il fatto nuovo della società dell’immagine – affermato da tutti ma non ancora compiutamente metabolizzato – è il primato della comunicazione sui valori. Sempre più persino chi è subalterno o marginale combatte battaglie non proprie, mobilitandosi e votando su parole d’ordine altrui più che a sostegno dei propri bisogni e interessi. Si spiegano così i successi di Berlusconi e di Renzi, che – modernizzando un copione antico – hanno attinto consenso e voti in maniera massiccia in strati popolari. La comunicazione, poi, ha oggi regole e modalità semplificatorie, assertive, spesso demagogiche. Non ci piacciono (o non piacciono a me). Ma da esse non si può prescindere, almeno oggi. Meglio, in ogni caso, adottarle – con il necessario distacco critico – per veicolare buoni progetti piuttosto che subirle con il loro carico di cattivi progetti… Nella odierna comunicazione fast food le parole contano più della realtà che rappresentano: occorre cambiare questa spirale perversa, ma per farlo bisogna saper usare le parole.
Terzo. Se questo è vero lo sbocco è conseguente. Abbiamo buone idee e buoni progetti ma continueremo, ciononostante, ad essere sconfitti e saremo ridotti all’irrilevanza (non solo alla minorità) se non sapremo esprimere nuovi linguaggi, semplificati e ripetitivi, ma capaci di dare concretezza a una prospettiva di eguaglianza e di emancipazione (la mancanza di una promessa attendibile di reddito decente per tutti ha fatto vincere chi ha dato a molti una mancia di 80 euro, pur sottratta con l’altra mano).
E lo stesso accadrà se non sapremo esprimere un personale politico radicalmente diverso da un ceto responsabile di sconfitte seriali (non scopro l’acqua calda se dico che nella resistibile ascesa di Renzi è stato determinante il contributo, miope quanto comprensibile, di chi lo ha votato «perché è il solo che può farci vincere»). E un nuovo personale politico dovrà avere un punto di riferimento riconoscibile e mediaticamente forte: non un uomo della provvidenza circondato da nullità che ne esaltano la funzione salvifica (come è stato ed è da due decenni), ma un uomo, o una donna, in grado di aggiungere un personale carisma a un gruppo autorevole e coeso. Anche questo provoca in noi (o almeno in me) non poca diffidenza. Ma il terreno e le modalità dello scontro non li decidiamo noi. Dovremo cambiarli, epperò – qui e ora – non possiamo prescinderne.
Arrivo così alla parte più difficile. Esiste oggi in Italia la possibilità di dar corpo a una prospettiva siffatta (come sta accadendo altrove: dalla Grecia alla Spagna)? Esiste, ma per costruirla bisogna uscire dal generico e avanzare proposte concrete, anche venendo meno al politically correct. Dunque ci provo.
Il nucleo forte della proposta politica non può che essere il lavoro, con le sue condizioni e i suoi presupposti, di cui riappropriarsi sottraendolo a chi lo distrugge ma, insieme, lo declama presentandosi come il suo vero e unico difensore. C’è chi può rappresentare questa prospettiva in modo non personalistico e con un riconoscimento diffuso, verificato in centinaia di piazze e – particolare non meno importante, secondo quanto si è detto – in centinaia di confronti televisivi. È – non devo certo spiegare perché – Maurizio Landini.
Lo so. Landini ha detto più volte che il suo posto è il sindacato e non la politica. È un atteggiamento fino a ieri comprensibile e apprezzabile. Ma oggi c’è una ragione aggiuntiva per chiedergli di farle il salto: il lavoro non lo si può più inventare, creare e difendere solo o soprattutto a livello sindacale. E le occasioni per ribaltare il quadro non si ripetono
postilla
Certamente il tema del lavoro è centrale per operare da subito un ribaltamento del percorso lungo il quale l'Italia corre verso il baratro. Ma il Lavoro non è difendibile se esso non è collegato, fin dalla sua prima enunciazione, ad altri due grandi temi che, con esso, costituiscono i tre pilastri di un nuovo sviluppo: Ambiente e Democrazia. Per ora ci limitiamo qui ad asserirlo. Proveremo presto ad argomentarlo meglio.
 «In assenza dell’apertura di vie legali di ingresso e senza una modifica del Regolamento Dublino III,
«In assenza dell’apertura di vie legali di ingresso e senza una modifica del Regolamento Dublino III,
Mos Maiorum potrebbe costringere i migranti a rivolgersi ancor più ai trafficanti di terra, rafforzando il ricatto delle reti criminali”. Dal sito L’altra Europa con Tsipras, 09 ottobre 2014
Nello stesso momento in cui i governi europei fingono di piangere i morti di Lampedusa, a un anno dalla strage del 3 ottobre, si sta preparando in tutta l’Unione un’autentica retata di migranti, promossa dal governo italiano nelle vesti di presidente di turno del Consiglio. Sono felice che il nostro gruppo si mobiliti, e un grande grazie a chi, nello staff del Gue-Ngl, sta cercando di costruire iniziative in vista della prossima plenaria assieme al gruppo dei Verdi. (1)
L’operazione, battezzata Mos Maiorum, si svolgerà dal 13 al 26 ottobre, ed è stata decisa dal Consiglio dei ministri dell’Interno e della Giustizia il 10 luglio scorso. Ne siamo venuti a conoscenza tardi: in parte perché come Parlamento non siamo stati avvisati, in parte perché non siamo stati attenti. Sarà condotta dentro lo spazio Schengen e, con la scusa della lotta alla tratta di esseri umani, intende rintracciare il più gran numero possibile di migranti cosiddetti irregolari: il più delle volte richiedenti asilo senza documenti, perché in fuga da zone di guerre cui noi stessi abbiamo contribuito.
Mos maiorum – già il nome inquieta, rimanda a tempi di imperi e schiavi – sarà assistita dall’agenzia Frontex, che in teoria controlla le frontiere dell’Unione, non il suo spazio interno. Avviene inoltre quando l’agenzia Frontex è più contestata, per non rispetto del divieto di respingimento sancito dalla Carta europea dei diritti fondamentali, oltre che dalla convenzione di Ginevra. Sono numerosi i casi di respingimento collettivo dai porti dell’Adriatico, e dagli aeroporti siciliani di Comiso (Ragusa) verso l’Egitto e di Palermo verso la Tunisia.
La mancanza di canali legali di ingresso in Europa ha prodotto una crescita esponenziale di fuggitivi, costretti ad entrare (e poi spostarsi nell’area Schengen) senza documenti. Il Regolamento Dublino III, mal congegnato, prevede tempi lunghi delle procedure per il riconoscimento della protezione internazionale e produce movimenti secondari di richiedenti asilo verso il Nord Europa, attraverso canali irregolari. Queste persone rischiano di essere le prime vittime di un’operazione di polizia che, a parole, vuol contrastare il crimine che fa profitti sui migranti, sia quando entrano nell’Unione sia quando circolano al suo interno.
Si potrebbe verificare il contrario esatto di quel che si dice di voler ottenere: una criminalizzazione non delle mafie ma delle loro prede: cioè di chi sarà trovato senza regolari documenti di ingresso e soggiorno. Si estenderà la loro possibile reclusione nei centri di detenzione. Saranno ancor più svalutati gli istituti della protezione internazionale.
In assenza dell’apertura di vie legali di ingresso e senza una modifica del Regolamento Dublino III, Mos Maiorum potrebbe costringere i migranti a rivolgersi ancor più ai cosiddetti trafficanti di terra, rafforzando il potere di ricatto delle reti criminali. I meccanismi di emarginazione prodotti dalla fuga nella clandestinità, sostiene il docente di diritto d’asilo Fulvio Vassallo Paleologo, sono una manna per le reti che forniscono servizi e beni primari in cambio non solo di denaro, ma dell’affiliazione a correnti politiche e religiose radicali. Le retate non abbattono le mafie. Le tengono in vita e le nutrono.
1) Su Mos Maiorum, il gruppo Gue-Ngl ha successivamente deciso, nel pomeriggio del 9 ottobre, di inviare subito una lettera al Consiglio dei ministri degli Affari interni e della Giustizia, riuniti nella stessa giornata a Lussemburgo, e di preparare una "richiesta di dichiarazione" del Consiglio durante la prossima plenaria del Parlamento europeo. Alla richiesta aderirà il gruppo dei Verdi.
«Il manifesto, 9 ottobre 201425 ottobre. Le parole di Maurizio Landini chiamano insieme a una grande manifestazione ma anche ad attivare un movimento sul controllo da parte dei lavoratori dei processi della crisi in atto, a partire dalle crisi aziendali
«Questo Parlamento non serve a niente, siamo pronti ad occupare le fabbriche»: Maurizio Landini non poteva essere più esplicito e «storico», anche nel riferimento alle occupazioni di fabbriche che hanno contrassegnato nel secolo breve la storia del movimento operaio, non solo italiano. Qualcuno ci ha letto una sorta di candidatura «politica», altri l’hanno vista come «narrazione» agli iscritti sindacali, la Confindustria l’ha giudicata come una minaccia.
Ma le parole del segretario della Fiom non sono una suggestione, corrispondono in pieno alla precipitosa crisi italiana finita nelle mani, improprie, dell’apprendista stregone Matteo Renzi. Siamo infatti con la fiducia sul cosiddetto Jobs Act, all’ennesima riduzione degli spazi di democrazia, dopo la cancellazione dell’elezione diretta del Senato e l’accumulo di decretazione come mai prima nessun governo della Repubblica. Ma se sui temi del lavoro si cancellano le difese degli stessi lavoratori, è legittimo o no che si alzi la loro voce e di chi legittimamente li rappresenta?
Rendendo così evidente che ormai la questione non è più solo sindacale, ma politica perché chiama in causa contenuti di rappresentanza e di potere. Nella convinzione che la mancanza di lavoro e di investimenti, non sia dovuta al peso delle tutele fin qui faticosamente conquistate dai lavoratori con straordinarie stagioni di lotta che si vogliono azzerare, e che non dipende dalla mancata riforma del mercato lavoro tanto cara alla fallimentare destra neoliberista. Ma al contrario proprio dalla mancata riforma del mercato dei capitali. Vale a dire dal fatto macroscopico, che questo governo misconosce, che la crisi finanziaria del capitalismo ha devastato risorse e umanità. E che ora, come assai timidamente avviene negli Stati uniti per effetto della possibilità di soccorrere con la moneta domanda e investimenti, è necessario un ruolo di controllo e imprenditorialità del governo e dello Stato.
Mentre in Italia e in Europa, irresponsabilmente, invece si avvia l’itinerario opposto delle privatizzazioni, smantellando aziende tutt’altro che in rosso e con capacità di guida e indirizzo dell’intera economia italiana e continentale, privata, pubblica e cooperativa.
Ora — ed è la riflessione che come manifesto vogliamo rilanciare, anche perché è parte della nostra cultura fondativa — le parole di Maurizio Landini chiamano insieme ad una grande manifestazione il 25 ottobre ma anche ad attivare un movimento sul controllo da parte dei lavoratori dei processi della crisi in atto, a partire dalle crisi aziendali. Convinti che dalla crisi si esce con più democrazia non con meno, come vogliono Matteo Renzi e il nuovo Pd. Se tra le pieghe del Jobs Act compariva a gennaio una specie di fantasma di cogestione — tutti uniti tutti insieme, il lavoro subalterno che subisce il disastro dell’impresa capitalistica e il padrone protagonista del crollo — la crisi in corso pone all’o.d.g. ancora una volta il ruolo centrale dei lavoratori.
Si dirà: ma se le fabbriche non ci sono più? Non è proprio vero, ma quando tragicamente lo è, proviamo a capovolgere lo sguardo: non ci troviamo forse da anni di fronte a drappelli di lavoratori protestatari che insistono a trovare un padrone che ripristini mercato e sfruttamento? Oppure, all’opposto, a fabbriche dismesse, considerate inadeguate o obsolete, occupate e riattivate dagli stessi lavoratori? E ancora ai «nuovi lavori» precari o ai senza lavoro spesso in conflitto sordo con chi il lavoro ancora ce l’ha, ma sempre più incerto? Trasformiamo questa protesta che rischia di apparire come routinaria in un presidio di fronte al fantasma del ruolo del «capitalista». «Siamo pronti ad occupare le fabbriche» chiama a ruolo perfino la funzione del governo Renzi che, con l’austerity Ue, adesso siamo costretti a subire in una convivenza forzosa.
 La produzione di cemento è in calo. Un governo responsabile non può lasciare che sia il mercato ad occuparsene «perché il mercato non è mai pienamente libero, come dimostrano i finanziamenti pubblici arrivati a Cementir e Italcementi per “ristrutturare” e trasformare in co-inceneritori di rifiuti gli impianti di Taranto e Rezzato (BS)”».
La produzione di cemento è in calo. Un governo responsabile non può lasciare che sia il mercato ad occuparsene «perché il mercato non è mai pienamente libero, come dimostrano i finanziamenti pubblici arrivati a Cementir e Italcementi per “ristrutturare” e trasformare in co-inceneritori di rifiuti gli impianti di Taranto e Rezzato (BS)”».
Altreconomia.it, 9 ottobre 2014
Se le proiezioni saranno confermate, nel 2014 il consumo di cemento nel nostro Paese scenderanno sotto le venti milioni di tonnellate. Secondo i dati presentati dal centro studi dell'AITEC, l'Associazione confindustriale che riunisce le principali aziende che producono cemento in Italia, il nostro Paese non è mai sceso “così in basso” dal 1961, da prima del boom economico. Se misuriamo la variazione rispetto al 2007, che è l'anno principe della “bolla immobiliare” nel nostro Paese, accanto al segno meno c'è scritto 56,13%: oltre la metà della produzione pro capite di cemento è andata perduta. Peggio di noi, dal 2010 ad oggi, ha fatto solo la Spagna, un altro Paese in cui nei primi anni Duemila si è costruito, costruito, costruito, aumentando a dismisura l'offerta di case, senza badare all'effettiva esistenza di una domanda, o alimentandola in modo fittizio garantendo mutui troppo facili, che oggi -complice la disoccupazione- sono diventati un grave problema sociale.
Di fronte a questi numeri, però, l'unica scelta possibile per il governo Renzi, che avrebbe dovuto cambiare verso al Paese, è quella di (provare a) governare il settore: secondo le informazioni de Il Sole 24 Ore, dal 2008 ad oggi sono stati chiusi 21 dei 60 impianti a ciclo completo presenti sul territorio nazionale, anche se in molti casi non si tratta di chiusure definitive, e il governo dovrebbe aprire un tavolo di concertazione con i produttori di cemento, per pianificare -insieme- il futuro del settore (e dei suoi 8.600 addetti). Non è pensabile, infatti, che la produzione di cemento ritorni ai livelli del 2006-2007, come ha ben evidenziato la scelta di Italcementi di chiudere nell'arco di un triennio quasi la metà dei propri stabilimenti, ma un governo responsabile non può lasciare che sia il mercato a decidere. Perché il mercato non è mai libero pienamente, come dimostrano -ad esempio- i finanziamenti pubblici che attraverso la Banca europea degli investimenti sono arrivati a Cementir e Italcementi per “ristrutturare” e trasformare in co-inceneritori di rifiuti gli impianti di Taranto e Rezzato (BS).
Anche perché, nel caso dei cementifici, stiamo parlando di un'industria insalubre, di uno dei settori le cui emissioni sono monitorate dall'Unione Europea nell'ambito del programma europea di riduzione legato al Protocollo di Kyoto. Così, non dev'essere solo la magistratura amministrativa a dire che cosa si può e non si può fare nei cementifici e coi cementifici, quando i cittadini -o le amministrazioni comunali- si rivolgono ai giudici del TAR per verificare la legittimità di un singolo atto. C'è bisogno della politica, e anche di un po' di buon senso. Quello che vorrebbe, ad esempio, che l'immagine di alcune delle aree più belle del Paese non venisse “sporcata” dalle ciminiere di un cementificio, né che quest'impianti continuino ad esistere nelle nostre città, a ridosso di zone densamente abitate. Partiamo da qui, dalla chiusura dei cementifici di Pederobba, Fumane in Valpolicella, Monselice ed Este, all'interno del Parco dei Colli Euganei, Taranto, Pescara, Piacenza e Barletta.
Così tanto cemento non serve più, prendiamone atto.

L‘affermazione “la scienza ha sempre ragione” non è scientifica. È ideologica. Lo è tanto quanto il pregiudizio reazionario per il quale ogni mutamento del modo di produrre, consumare, nutrirsi, avviene nel nome di interessi inconfessabili, e a scapito della salute della collettività umana.
«Dà un’impressione di ascoltare, se per ascoltare intendiamo non tanto sviscerare, ma il mero prendere in considerazione. Una dialettica hegeliana fatta di tesi, finta attenzione all’antitesi, sintesi».
Il Post, 2 ottobre 2014
Nelle ultime settimane Matteo Renzi è stato sempre al centro del dibattito pubblico: il viaggio in America, Marchionne, i Clinton, l’inglese strampalato, l’intervista da Fazio, il bailamme sull’articolo 18, lo sberleffo dei sindacati, la direzione PD, la polemica con la minoranza, le critiche da parte di Corriere eRepubblica, etc… Anche chi non fosse interessato alle questioni del Partito Democratico o agli affari del governo quando entrano nell’occhio di bue, non può evitare di incrociare un affondo di Renzi, una sua dichiarazione, un intervento – che sia all’Onu o allo stadio, un tweet o un’interpellanza. È una forma di ubiquità che vuole significare attenzione, presenza; un dinamismo in perenne accelerazione che è il segno di una condizione di permanente attualità. Stare sempre sul pezzo, questo è il diktat.
Ma cos’ha di diverso, di specifico, la retorica renziana?
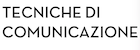 «Il discorso assertivo afferma, dichiara, definisce, prevede e prescrive, senza preoccuparsi di spiegare a chi ascolta né il perché, né il come, né il quando, né con quali mezzi e risorse. E’ un tipo di discorso che fa coincidere nome e cosa, affermazione e fatto».
«Il discorso assertivo afferma, dichiara, definisce, prevede e prescrive, senza preoccuparsi di spiegare a chi ascolta né il perché, né il come, né il quando, né con quali mezzi e risorse. E’ un tipo di discorso che fa coincidere nome e cosa, affermazione e fatto».
Il Fatto Quotidiano, 6 ottobre 2014
Si parla con…, si parla a… Vuol dire che parlare è innanzi tutto comunicare. Ma se la comunicazione non arriva perché chi ascolta non capisce la lingua di chi parla? E viceversa? Be’, smetteranno di parlarsi. E se non possono smettere perché hanno interessi, bisogni, pretese in comune? La situazione che si determina in questi casi è stata descritta per la prima volta nella Bibbia e prende il nome dalla città in cui avvenne: Babilonia. E le conseguenze furono talmente tragiche che tutti, contemporanei e discendenti, furono d’accordo che, dopo il Diluvio, la confusione delle lingue era la punizione più severa che Dio potesse infliggere all’umanità. Non credo che Dio c’entrasse, ma per quanto riguarda la gravità delle conseguenze, non ho dubbi.
Per questo mi preoccupa – e non da oggi – il fatto che il discorso pubblico in Italia si stia svolgendo su due registri diversi, lontani l’uno dall’altro fino al punto di far pensare a due lingue diverse, mentre sono entrambi in italiano.
Nella comunicazione politica italiana si fronteggiano interlocutori che utilizzano il discorso argomentativo e interlocutori che utilizzano il discorso assertivo. E anche i loro ascoltatori (gli italiani) sembra che si dividano tra chi capisce e ama il primo tipo di discorso e chi capisce e ama il secondo. Per discorso argomentativo intendo quel tipo di discorso che, rispettando i principi logici di causa ed effetto e di identità e non contraddizione, si svolge secondo il filo del ragionamento, esplicitando le premesse da cui parte, chiarendo i perché della scelta delle premesse e dei fatti che ne conseguono e concludendo con previsioni di risultati anch’esse razionalmente argomentate. E’ un discorso che non confonde la parte con il tutto, il singolare con il plurale; è un discorso basato su una corretta coniugazione dei verbi, sicché non confonde il presente con il desiderabile futuro; è un discorso che tiene conto del fatto che, quando si vuol cambiare qualcosa, bisogna intervenire anche sulle cause che hanno prodotto quella cosa.
Il discorso assertivo è tutt’altra cosa: afferma, dichiara, definisce, prevede e prescrive, senza preoccuparsi di spiegare a chi ascolta né il perché, né il come, né il quando, né con quali mezzi e risorse. E’ un tipo di discorso che fa coincidere nome e cosa, affermazione e fatto.
Spesso i politici di professione usano il linguaggio assertivo: è semplice da capire, diretto, immaginoso, tocca le corde profonde degli ascoltatori e consente con facilità di camuffare contraddizioni, di evitare rendicontazioni, in una parola di eludere i conti con la realtà. Mussolini era un maestro del linguaggio assertivo, che piaceva molto a molti italiani; fino alla tragica e grottesca conclusione, quel «Li fermeremo sul bagnasciuga» con cui annunciò agli italiani cosa intendeva fare quando gli Alleati fossero sbarcati in Sicilia.
Ma, ripeto, non c’è politico che non faccia ricorso ogni tanto al linguaggio assertivo, agli slogan: “Bandiera rossa trionferà” di contro a “ “I comunisti distruggono la famiglia”. Però ci sono state stagioni della vita politica italiana in cui il discorso assertivo fu utilizzato prevalentemente nei comizi, nei manifesti elettorali, magari nelle feste dell’Unità o nelle adunanze dell’Azione cattolica. Non nelle interviste, nelle conferenze stampa, nelle tribune politiche in tv. E nemmeno per illustrare proposte di legge da discutersi in Parlamento.
Le cose sono cambiate dalla discesa in campo di Berlusconi, altro maestro del linguaggio assertivo. Il milione di posti di lavoro, l’abolizione delle tasse, le grandi opere e il Ponte sullo stretto, la ricostruzione più rapida al mondo della città terremotata, i ristoranti pieni e i voli aerei tutti prenotati, per non ricordare che le asserzioni più celebri. Abilissimo utilizzatore della tv, Berlusconi asseriva anche con le immagini: ricordate l’edificante album di famiglia con cui si presentò in pubblico il patron delle cene eleganti?
Renzi si inserisce bene nella tradizione assertiva. Ha cominciato con l’affermazione dell’esigenza di rottamare (Chi? Perché?) onde realizzare il cambiamento (Quale? Come?) e prosegue con immaginose affermazioni, che raramente rispettano il principio di non contraddizione o chiariscono i rapporti di causa ed effetto.
Come già Berlusconi, anche Renzi ha successo. Il discorso argomentativo annoia, il discorso assertivo eccita, galvanizza. E’ un fatto, il discorso argomentativo è compreso e usato da un numero di persone in costante diminuzione; quello assertivo è sempre più apprezzato e praticato, anche nella sua forma che consiste nel dare sulla voce all’interlocutore (vedi i talk-shows). Questo sì che è un cambiamento, già in atto. E, che piaccia o no, va spiegato e capito. Cosa che tenterò di fare nel prossimo testo.
 «Per aumentare l’intensità di lavoro remunerato delle famiglie occorrono sia politiche di investimento sociale dirette ai più svantaggiati, giovani e meno giovani, sia politiche di conciliazione famiglia-lavoro: proprio quelle oggetto di drammatici tagli in periodi di austerity».
«Per aumentare l’intensità di lavoro remunerato delle famiglie occorrono sia politiche di investimento sociale dirette ai più svantaggiati, giovani e meno giovani, sia politiche di conciliazione famiglia-lavoro: proprio quelle oggetto di drammatici tagli in periodi di austerity».
Lavoce.info, 3 ottobre 2014 (m.p.r.)
Sistema troppo frammentato
In un rapido accenno nella discussione sul Jobs Act, Matteo Renzi ha annunciato una riforma complessiva del welfare. Che il welfare italiano abbia un urgente bisogno di essere riformato è indubbio, stante che si tratta di uno dei sistemi più frammentati, più pieni di buchi, più esposti a manipolazioni e imbrogli tra quelli europei. Di ambizioni di riforma si parla almeno da venti anni, dalla commissione Onofri istituita dal primo Governo Prodi, senza che se ne sia fatto nulla, salvo i ritocchi a margine, spesso dolorosissimi, varati via via dai vari Governi, che hanno ulteriormente aumentato la frammentazione e i rischi di iniquità. Le analisi e le proposte sono tante e forse, nonostante la sua idiosincrasia per gli intellettuali, non sarebbe male che Renzi e i suoi consiglieri ne prendessero atto, per evitare di inventare l’ombrello, ma anche per comprendere che il sistema di welfare è, appunto, un sistema, che deve (dovrebbe) avere una logica coerente, non un ammasso di frammenti spesso tra loro incoerenti.
La questione dei lavoratori poveri
Senza queste due misure, l’impianto del welfare che il presidente del Consiglio sembra avere in mente rischia di non aggredire la questione della povertà, che pure, specialmente quella assoluta, in questi anni è drammaticamente aumentata in Italia: nel 2013 coinvolgeva il 7,8 per cento delle famiglie e il 10 per cento degli individui, una percentuale quasi tre volte più alta di quella rilevata nel 2007. Può sembrare un giudizio paradossale. Che cosa c’è di più efficace del lavoro (remunerato) per far uscire dalla povertà? Eppure le cose non sono così semplici. In primo luogo, occorre pensare anche a chi non trova lavoro – e per questo non matura il diritto alla indennità di disoccupazione – perché la domanda è scarsa, perché non ha le qualifiche adeguate, perché ha un carico di lavoro famigliare pesante. È certo opportuno incentivare le persone ad attivarsi, a effettuare la formazione necessaria per collocarsi nel mercato del lavoro, posto che vi sia domanda. Ma, mentre cercano e si danno da fare e aspettano che la domanda di lavoro aumenti, bisognerà o no pensare a come aiutare loro e le loro famiglie a sopravvivere, specie se chi è senza lavoro è anche chi, in famiglia, sarebbe teoricamente responsabile del mantenimento?
Riferimenti bibliografici
Cantillon B. e F. Vandenbrouke (eds), Reconciling work and poverty reduction, Oxford, Oxford University Press, 2014
Chi comanda l'Italia oggi non è né re né principe, né duca né marchese, e neppure barone: è solo un baro. Ecco perchè Il manifesto, 1 ottobre 2014
La Repubblica, 2 ottobre 2014
Che l’episodio più clamoroso si sia consumato proprio in provincia di Taranto, una città messa in ginocchio dai compromessi della politica, è forse emblematico, forse casuale. Ma dice molto su una riforma che doveva condurre all’abolizione delle province in Italia, e che in alcuni casi ha invece portato a listoni pigliatutto all’insegna delle larghe intese.
Per fare tutto questo, a Taranto, Vibo Valentia, Ferrara, Genova, Torino, i partiti si sono lasciati andare ad intese che da larghe sono diventate larghissime. In realtà - ufficialmente - nella città dell’Ilva il listone non c’è stato. Centrosinistra e centrodestra erano concorrenti, perché l’accordo cui stavano lavorando il deputato democratico pugliese Michele Pelillo e il consigliere regionale Michele Mazzarano (già indagato per aver avuto a che fare con Giampaolo Tarantini) a sostegno del sindaco forzista di Massafra Martino Tamburrano, era saltato in un tormentato congresso straordinario del Pd locale in cui il segretario regionale Michele Emiliano aveva giurato che mai avrebbe appoggiato alcun inciucio. I democratici avevano quindi candidato il sindaco di Laterza Gianfranco Lopane, tradito però nel segreto dell’urna. A vincere alla fine è stato infatti Tamburrano, nonostante sulla carta la maggioranza fosse tutta a sinistra. Perché gran parte del Pd lo ha votato. E perché quella che è in corso è una battaglia durissima, con lo sfidante di Emiliano alle primarie regionali Guglielmo Minervini che accusa il suo avversario di aver fatto «un inciucio di dimensioni massicce e organizzate». Ovvero, di tramare sottobanco per avere più consensi possibili in vista delle regionali.
È andata molto più tranquillamente a Ferrara per quello che è stato definito «il patto dei cappellacci ». A vincere è stata infatti la lista che aveva come candidato presidente il sindaco della città estense Tiziano Tagliani, e che teneva dentro Pd, Forza Italia, Lega e perfino 5 stelle con il sindaco di Comacchio Marco Fabbri. Quest’ultimo non avrebbe dovuto correre (Grillo lo aveva vietato impedendo una lista unitaria anche al sindaco di Parma Pizzarotti), ma non ha obbedito, ed è perfino risultato il secondo degli eletti (i consiglieri 5 stelle che avevano annunciato l’astensione devono aver cambiato idea all’ultimo momento). Per ora non risponde a chi gli chiede se non abbia paura di essere cacciato dal Movimento, si limita sommessamente a far notare che era una regola un po’ strana, quella che impediva di correre in provincia e lo rendeva possibile invece nelle città metropolitane (ci sono un eletto 5 stelle a Bologna e uno a Firenze).
Altrettanto serena la grande intesa di Genova, dove - addirittura - il sindaco Marco Doria (destinato a guidare la città metropolitana) ha fatto correre la sua lista insieme a Forza Italia, Pd e Nuovo centrodestra, dimostrando che anche Sel, in alcuni casi, è pronta a fare strappi alla regola. Mentre è corso più veleno a sud, nella provincia di Vibo Valentia, dove si sono spaccati un po’ tutti con richieste incrociate di dimissioni e accuse reciproche di candidature poco pulite. A vincere è stata la lista “Insieme per la Provincia di Vibo Valentia Adesso” (detta “l’accorduni”), che vedeva i renziani del Pd con esponenti del Nuovo Centrodestra, Forza Italia e Fratelli d’Italia.
Il prossimo 12 ottobre toccherà a Torino, dove il Pd ha fatto un accordo con Forza Italia, Nuovo Centrodestra e Moderati. L’hanno chiamato «patto costituente » in vista della nascita della città metropolitana, lo hanno fatto - spiegano i democratici - per poter rappresentare meglio il territorio, visto che col meccanismo del voto ponderato il capoluogo rischiava di schiacciare realtà come Ivrea o la Valsusa. Il capogruppo di Sel in comune Michele Curto però la racconta diversamente: «I motivi sono solo due. Piero Fassino vuole scegliersi i suoi 18 consiglieri, e l’attrazione delle larghe intese è stata irresistibile».
La Repubblica, 29 settembre 2014
Matteo Renzi ha dichiarato guerra ai “poteri forti”. Alla domanda di un giornalista che gli chiedeva in cosa consistessero i poteri forti, e cosa intendesse fare, il nostro premier ha preferito glissare. Non sappiamo perciò cosa abbia in mente, oltre forse il sindacato e la battaglia sull’articolo 18. Vorremmo allora suggerirgli due poteri davvero forti che può fortemente ridimensionare senza bisogno di alcun passaggio parlamentare. Gli basterà utilizzare la forza datagli dal voto delle primarie e dal voto europeo.
 L'intervento con il quale l'europarlamentare del gruppo della sinistra europea replica all'intervento del sottosegretario Gozi esprimendo il proprio dissenso in particolare per la fine di Mare Nostrum. Bruxelles,
L'intervento con il quale l'europarlamentare del gruppo della sinistra europea replica all'intervento del sottosegretario Gozi esprimendo il proprio dissenso in particolare per la fine di Mare Nostrum. Bruxelles,
Listatsipras.eu, 24 settembre 2014
Ringrazio il sottosegretario Gozi per il suo intervento, e mi limito a riassumere in tre punti il mio dissenso.
Primo punto: l’immigrazione, che con l’estendersi delle guerre attorno a noi assumerà aspetti sempre più drammatici. Lei ha parlato di “phasing out” dell’operazione Mare Nostrum, che a parere dei maggiori esperti nell’Unione europea ha salvato un gran numero di profughi a rischio naufragio. Consiglierei di non usare parole inglesi ma italiane, e di dire a chiare lettere che di altro si tratta. Si tratta della “fine” di Mare Nostrum, dal momento che nessun’operazione è prevista che sia veramente sostitutiva, e che si occupi dell’essenziale: cioè di cercare e salvare i migranti in fuga (search and rescue). Frontex Plus ha un’altra missione – ormai è chiaro a tutti – e nemmeno sappiamo se potrà disporre di risorse adeguate e quali saranno gli Stati che contribuiranno.
Secondo punto: a proposito della Conferenza sull’occupazione dell’8 ottobre, confermata dal sottosegretario, vorrei citare le sue stesse parole. La conferenza non si occuperà tanto della disoccupazione dei giovani, quanto dell’”ambiente economico e sociale, in modo tale da garantire le riforme strutturali”. Siccome sappiamo quel che significano ai tempi d’oggi le riforme strutturali – riduzione della spesa e degli investimenti pubblici, restrizione dei diritti nella gestione del mercato del lavoro – ne deduco che la Conferenza di ottobre si occuperà in linea prioritaria del piano sul lavoro del governo Renzi più che di vera crescita e veri investimenti, in continuità sostanziale con la politica del rigore e dell’austerità chiesta dalle attuali autorità europee.
Terzo punto: il sottosegretario Gozi ha sostenuto che “si ritrova pienamente” nella scelta della nuova Commissione di Jean-Claude Juncker. Al tempo stesso, ha ricordato che la “difesa della legalità” è, per la presidenza italiana, un tema “centrale”. Le due affermazioni sono quantomeno contraddittorie. Se davvero il governo Renzi “si ritrova” nella Commissione appena designata, non vedo come possa accettare un esecutivo che annovera due membri con forti conflitti di interesse, come Arias Cañete e Jonathan Hill, un commissario come Alenka Bratušek, autocandidatasi utilizzando il suo ruolo di ex Premier in Slovenia, e – non per ultimo – il commissario Tibor Navracsics, noto in Ungheria per essere l’uomo di fiducia di Viktor Orbán, il premier che nel luglio scorso ha attaccato, senza mai smentirsi, i principi della democrazia liberale su cui l’Unione europea è fondata.
x

Sono bastati una riunione dell’Ecofin e l’ammonimento di Draghi per far abbassare la cresta a Francia e Italia, e ridurre a zero le ambizioni della campagna elettorale di Hollande e della non campagna di Renzi. Altro che investimenti produttivi per i quali i due leader si impegnavano a tenerli fuori dai vincoli di bilancio europeo: ambedue si sono orientati a premere esclusivamente sulla riduzione non solo del costo del lavoro ma dei salari (magari come ulteriore riduzione degli occupati). Hollande non ha bisogno di leggi ad hoc, annuncia che rifarà il massiccio codice del lavoro e viene da settimane di fuoco: prima ha licenziato in tre ore il ministro della crescita produttiva Arnauld Montebourg, seguito da Hamon e Filippetti, messi fuori dal governo in quattro e quattr’otto; poi ha dovuto incassare trenta voti contrari della sua maggioranza in Parlamento, mantenendo la propria per un solo seggio. Ma questo non lo ha fatto deviare dalla strada intrapresa: il presidente ha preso la parola per una conferenza stampa nella quale ha assicurato che non avrebbe cambiato di una virgola la sua rotta disastrosa. Fra non molto, ci saranno le elezioni regionali e prestissimo quelle del Senato; di questo passo sarà un’altra tempesta che si addensa sui socialisti ma sia Hollande sia Valls tengono fermo, forse sperando, come confermano alcuni personaggi a loro vicini, in una benevola “curva di Kondriatev”, l’”onda lunga” del ciclo economico che assicurerebbe una ripresa naturale della crescita entro la fine del mandato.
In Italia, Renzi ha parzialmente scoperto le carte dell’ormai famoso Jobs Act. E ha affrontato a muso duro lo scandalo di un’ennesima messa fuori campo dell’articolo 18, quello che impediva il licenziamento “discriminatorio”. L’intera stampa italiana si è schierata con lui, eccezion fatta del manifesto, argomentando soprattutto che il famoso articolo avrebbe soltanto un valore simbolico, in quanto viene raramente usato – è noto che la maggior parte dei licenziamenti si fa per vere o presunte ragioni economiche, che non riguardano crisi di bilancio delle aziende ma un mutamento delle strategie, soprattutto in direzione delle delocalizzazioni. Mentre viene sottovalutato quel che a me pare il maggior scandalo, e cioè il dispositivo per cui nei primi tre anni di impiego “a tempo indeterminato” qualsiasi lavoratore sarebbe soggetto al licenziamento. Perché tre anni? Qualsiasi operaio vi dirà che per imparare a menadito la mansione che gli è richiesta basta al massimo una settimana; dunque anche a metterne due l’azienda è in grado di rendersi rapidamente conto se egli è in grado o no di inserirsi nel piano produttivo. Perché consentire al padrone ben tre anni di “flessibilità” gratis? Nessuno lo spiega. È un sistema per prolungare il precariato – non so come potrebbe essere definito differentemente – rendendo tutti precari fin dall’inizio del cosiddetto “impiego a tutele crescenti”: tre anni a tutele zero.
Salvo Luciano Gallino e Pierre Carniti, tutta la stampa ha dato rilievo positivo alla scelta di Renzi, accompagnata, come sua abitudine, da insolenze verso il sindacato. La stampa presunta di centrosinistra, come Repubblica, si è distinta nella crociata contro il conservatorismo di chi vorrebbe conservare qualche diritto al lavoro: fra questi una parte del Pd considerata vecchia e conservatrice. Non solo i giovani Fassina e Civati, ma il vecchio Bersani. Vedremo per quanto tempo la minoranza dell’area ex comunista resisterà all’attacco, ma è certo che se molla sarà scomparsa anche l’ombra dell’abominato Pci e resterà da constatare che cosa ne assumerà il cambio senza confondersi col centrismo vero e proprio, peraltro rappresentato in primo luogo dal giovane premier. È in corso la trasformazione finale della scena politica italiana. Quella francese non ne ha neanche più bisogno, se si considera che al posto dell’irruente ministro Montebourg è stato nominato un dirigente della banca Rotschild. In più, in Italia, naturalmente, resta – avvinto a Renzi – l’evergreen Berlusconi. Per chi pensava di aver diritto diritto a un lavoro, pieta l’è morta.

«». Il manifesto
Le analisi di Joseph Stiglitz, presentate nelle pagine precedenti, che interamente condivido, sono un ottimo punto di partenza per capire che cosa occorre fare oggi in Italia e in Europa. La prima cosa da sottolineare è che le politiche di austerità sono autolesioniste e essenzialmente dannose. Esse producono un’inevitabile caduta del Prodotto interno lordo (Pil) e dell’occupazione, ed hanno come risultato un aumento del rapporto fra debito e Pil, cioè proprio quella frazione che si intende ridurre! Ciò per effetto delle dimensioni del «moltiplicatore» : un taglio della spesa pubblica di un euro riduce il prodotto nazionale molto più di un euro.
Non si tratta di effetti collaterali o di breve periodo, ma di effetti strutturali delle politiche di austerità in presenza di una crisi di domanda. Se è così, come ormai è riconosciuto dalla maggior parte degli economisti a livello internazionale, il dibattito che sta andando in scena in Italia in merito alla possibilità di “sforare” di una frazione di punto percentuale i vincoli di bilancio europei appare alquanto patetico: somiglia ad una discussione sulla quantità giusta da prendere di un veleno di cui è perfettamente nota la tossicità. Al contrario, la discussione sulla crisi economica in Italia sta proseguendo come se ci trovassimo nel mezzo di una crisi da offerta. E in più, tale crisi da offerta viene associata alla dimensione eccessiva dei costi, con un esplicito riferimento ai costi del lavoro, il cui peso starebbe scoraggiando gli investimenti. L’ovvia conclusione è che riducendo i costi del lavoro si favorirebbe lo sblocco degli investimenti. Si tratta di una lettura profondamente errata, senza alcun fondamento empirico: gli investimenti sono essenzialmente determinati dalla domanda e dalle opportunità innovative. Intervenire sulle opportunità innovative è importantissimo, ma gli effetti richiedono tempo.
Sulla domanda si può intervenire subito. Invece in Italia si continua a discutere in modo scellerato di abolizione dell’articolo 18, misura che, se attuata, e se efficace nell’aumentare ulteriormente la flessibilità del mercato del lavoro, avrà effetti negativi sull’economia. Effetti che oltre alla loro dimensione economica - identificabile in un ovvio impatto di riduzione dei consumi - hanno anche una dimensione sociale almeno altrettanto importante in termini di insicurezza sociale e senso di dignità e identità del lavoro.
Ma se l’austerità fa male, che cosa si potrebbe invece fare? Stiglitz ha illustrato le politiche diverse che occorrerebbe realizzare in Europa. Sarebbero misure essenziali, ma noi non siamo tedeschi e non abbiamo diritto di voto in Germania, dove fino ad ora si sono decise le politiche per tutta l’euro-Europa. Allora che cosa è possibile fare qui?
La prima cosa da fare è quella di non considerare più il vincolo del 3% nel rapporto deficit/Pil come una specie di inviolabile legge di natura. Ma smettere di accettare il vincolo implica una volontà credibile di contemplare la possibilità di ristrutturare il nostro debito pubblico, sia in termini di allungamento delle scadenze, che di hair cutting (cioè di taglio sul valore del capitale da restituire alla scadenza). Una reale credibilità della minaccia di ristrutturazione unilaterale del debito pubblico italiano potrebbe fungere da stimolo all’adozione di quelle misure - come l’introduzione degli Eurobond o un programma di investimenti pubblici - che appaiono indispensabili ma sotto veto tedesco. Si tratterebbe di una minaccia credibile perché le dimensioni del debito pubblico italiano renderebbero una sua brusca e unilaterale ristrutturazione capace di portare l’intero sistema finanziario internazionale nel precipizio.
L’Italia è “too big to fail” e, inoltre , occorre ricordare che l’Italia ha un attivo primario (cioè al netto degli interessi pagati, il bilancio pubblico è in attivo e quindi senza impellenti necessità di rivolgersi ai mercati finanziari).
Dove andrebbero spese le risorse pubbliche volte alla ripresa dell’economia europea? Keynes sosteneva che piuttosto che abbandonarsi all’inazione meglio sarebbe stato scavare delle buche per poi riempirle. Più strategicamente, quello che sarebbe necessario oggi in Europa è un vasto piano di politica industriale composto da grandi progetti “mission oriented”. Allo stato attuale sembra che l’unico progetto “mission oriented” esistente in Italia vada a sostenere l’industria bellica americana con il programma di acquisto dei cacciabombardieri F35 (che peraltro sono anche un fallimento tecnologico-militare). Invece occorrerebbe iniziare ambiziosi progetti nel campo dell’ambiente, della sanità, del welfare.
E la tassazione? Occorre smitizzare l’idea che la tassazione è mediamente troppo alta. E’ insopportabilmente alta sui redditi medio-bassi, ma la media non è niente di scandaloso. E’ necessario un piano di tassazione, sia sui redditi che sulle transazioni finanziarie, volto alla redistribuzione e non alla restituzione del debito. Misure redistributive di questo tipo avrebbero anche un evidente impatto positivo sui consumi, la crescita e l’occupazione.
Vi sono infine cose che non vanno assolutamente fatte. Una di queste è l’Accordo transatlantico di libero scambio tra l’Europa e gli Stati Uniti (TTIP). Accordi come questo minano la capacità politica degli stati, in particolare in materia di politica sociale, industriale e dell’ambiente. Di fatto si tratta di accordi che privatizzano la politica. Accordi di questo tipo sono tossici quanto lo sono le politiche di austerità che si stanno portando avanti in Europa.

« ». Adistaonline.it
Lo Sblocca Italia serve. Serve tantissimo. Serve a restituire l’esatta “cifra ambientalista” di questo governo, del Partito Democratico e della nuova corte che circonda il segr. pres. del Cons. Matteo Renzi. Con buona pace per Ecodem, malpancisti vari che comunque continuano ad albergare e ad allearsi con quel partito beneficiando della grande asta democratica utile a superare ogni asticella di sbarramento, il “Nazareno” mostra la propria natura anti-ecologista.
L’Italia cambia verso… Regioni come la Basilicata diventeranno finalmente dei piccoli Texas. Novelli Jr (lo ricordate il mitico petroliere di “Dallas”?) scorrazzeranno per le campagne lucane a bordo di Hummer H1 6000 cc. Grazie allo Sblocca Italia, appena firmato dal Capo dello Stato e che presto sarà convertito in legge dal Parlamento Italiano, le attività di prospezione, ricerca e coltivazione d’idrocarburi e quelle di stoccaggio sotterraneo di gas naturale rivestiranno carattere d’interesse strategico e saranno di pubblica utilità, e quindi urgenti e indifferibili. Finalmente qualcuno ha detto basta ai comitatini che intralciano la corsa al petrolio e le trivellazioni e impediscono al nostro Paese di dotarsi di “bomboloni” sotterranei per fronteggiare le crisi energetiche.
Grazie alla dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza dell’opera, si partirà veloci con l’esproprio e ogni opposizione sarà rimossa, ogni contestazione tacitata, e se gruppi di cittadini e associazioni ambientaliste si ostinano a mettersi di traverso, saranno guai!
Libertà è Partecipazione. Bellissime le parole di Giorgio Gaber che troviamo spesso nei convegni elettorali dei democratici e agli ingressi delle Feste de L’Unità: sfondi rassicuranti. Ok, belle parole, buone per prendere voti e accontentare la base, ma se sei di intralcio al “manovratore del fare”, interviene la celere. Peggio della Legge Obiettivo (Lunardi-Berlusconi) che per realizzare opere strategiche (come il TAV) ha azzerato ogni forma di partecipazione dei cittadini e di coinvolgimento delle istituzioni locali nelle scelte che interessano territori e comunità.
Nel 1787 Goethe descriveva così il territorio polesano nel suo viaggio in Italia: «Il tragitto, con un tempo splendido, è stato piacevolissimo; il panorama e le singole vedute, semplici ma non senza grazia. Il Po, dolce fiume, scorre fin qui attraverso pianure estese; ma non si vedono che le sue rive a cespugli e a boschetti».
Nel 1948, la Costituente stabiliva, per preservare la bellezza unica italiana: «La Repubblica tutela il paesaggio ed il patrimonio storico e artistico della nazione».
Nel 2013, l’ISPRA ha certificato in 8 mq al secondo la quantità di terra italiana seppellita sotto il cemento e l’asfalto.
Nel 2014, il governo Renzi accentua ulteriormente la già grave “deregulation” edilizia che ha saccheggiato e devastato territorio e paesaggio di cui tanto ci vantiamo (e che ha romanticamente ispirato poeti e viaggiatori), rimette il turbo a tante grandi opere inutili e dannose che segneranno irreversibilmente le linee del nostro paesaggio e rilancia la svendita di patrimonio demaniale presentandolo all’opinione pubblica come agognata “valorizzazione”.
Tra le pieghe, poi, oltre al danno c’è anche una bella beffa. La mirabolante Autostrada Orte-Mestre, 10 miliardi per 400 km di asfalto in territori fragili e bellissimi, densi di Zone a Protezione Speciale e Siti di Interesse Comunitario, da realizzarsi tramite la bacchetta magica chiamata “Project Financing”, aveva un problema: non stava in piedi. Almeno senza la defiscalizzazione. Ed infatti, per questo, la Corte dei Conti aveva imposto uno stop. Ma qui arriva in soccorso lo Sblocca Italia: la defiscalizzazione (che equivale a quasi 2 mld di euro che evidentemente non entreranno nella casse dello Stato) si applicherà anche alla Orte- Mestre. Chissà cosa direbbe Goethe di fronte a cotanta fantasia al potere!
Nel decreto del governo Renzi infine non poteva certo mancare l’accelerata sugli inceneritori che saranno così sbloccati e imposti al pari delle altre opere ritenute strategiche e senza alcun vincolo di bacino. Tradotto: laddove si riducono rifiuti, si ricicla e si riusa, arrivano rifiuti freschi freschi da altri territori. Con tanti complimenti ad amministrazioni locali e cittadini virtuosi…
Spazzando via slides e buone intenzioni di chi predica la sostenibilità, lo Sblocca Italia sarà un utilissimo spartiacque. Infatti, da una parte ci saranno i dirigenti ed i fiancheggiatori del partito del cemento, delle privatizzazioni, delle emissioni, della crescita “costi quel che costi”; gli esecutori degli interessi di lobbies, profittatori di ciò che appartiene a tutti.
Dall’altra parte, da questa parte, ci saranno le forze che non accettano né mai accetteranno che ambiente, salute e beni comuni siano sacrificati insieme agli altri diritti dei cittadini per soddisfare l’avidità di poche persone, di pochi gruppi di potere. Occorre una nuova resistenza, un’alleanza di cittadini, ambientalisti, comitati e comitatini… Occorre unirsi con urgenza.
 «Crisi dell’euro: cause e rimedi. La miscela esplosiva: un modello che mescola declino economico e speculazioni, produzione all’osso e controllata dalle grandi imprese, risparmi familiari che finanziano consumi impoveriti, società disuguale, frammentata e disorientata».
«Crisi dell’euro: cause e rimedi. La miscela esplosiva: un modello che mescola declino economico e speculazioni, produzione all’osso e controllata dalle grandi imprese, risparmi familiari che finanziano consumi impoveriti, società disuguale, frammentata e disorientata».
Il manifesto, 26 settembre 2014
Non ho bisogno spiegare quanto sia drammatica la situazione economica in Europa, e in Italia in particolare. L’Europa è in quella che può definirsi una «triple dip recession», con il reddito che è caduto non una, ma tre volte in pochi anni, una recessione veramente inusuale.
Così l’Europa ha perso la metà di un decennio: in molti paesi il livello del Pil pro capite è inferiore a quello del 2008, prima della crisi; se si estrapola la serie del Pil europeo sulla base del tasso di crescita dei decenni passati, oggi il Pil sarebbe del 17% più alto: l’Europa sta perdendo 2000 miliardi di dollari l’anno rispetto al proprio potenziale di crescita.
Oggi abbiamo a disposizione una grande quantità di dati sull’impatto delle politiche di austerità in Europa. I paesi che hanno adottato le misure più dure, ad esempio chi ha introdotto i maggiori tagli al proprio bilancio pubblico, hanno avuto le performance peggiori.
Non solo in termini di Pil, ma anche in termini di deficit e debito pubblico. Era un esito previsto e prevedibile: se il Pil decresce anche le entrate fiscali si riducono e questo non può far altro che peggiorare la posizione debitoria degli stati.
Tutto ciò avviene non perché questi paesi non abbiano realizzato politiche di austerità, ma proprio perché le hanno seguite. In molti paesi europei siamo di fronte non a una recessione, ma a una depressione. La Spagna, ad esempio, può essere descritta come un paese in depressione se si guardano gli impressionanti dati sulla disoccupazione giovanile di quel paese. La disoccupazione media è al 25% e non ci sono prospettive di miglioramento per il prossimo futuro (…).
Quali sono le cause? Devo dirlo con molta franchezza: l’errore dell’Europa è stato l’euro.
Quando faccio questa affermazione voglio dire che l’Euro è stato un progetto politico, un progetto voluto dalla politica. Robert Mundell, premio Nobel per l’economia, sosteneva fin dall’inizio che l’Europa non presentava le caratteristiche di un’«area valutaria ottimale», adatta all’introduzione di un’unica moneta per più paesi. Ma a livello politico si riteneva che la moneta unica avrebbe reso l’Europa più coesa, favorendo l’emergere delle caratteristiche proprie di un area valutaria ottimale. Questo non è successo; l’euro, al contrario, ha contribuito a dividere e frammentare l’Europa.
Vediamo gli errori concettuali alla base del progetto dell’euro (…). Quando si crea un’area monetaria si vanno ad eliminare due meccanismi di aggiustamento, i tassi di cambio e i tassi di interesse. Gli shock sono inevitabili e in assenza di meccanismi di aggiustamento si va incontro a lunghi periodi di disoccupazione. I 50 stati federati degli Usa hanno un bilancio unitario a livello federale e due terzi della spesa pubblica negli Stati Uniti sono a livello federale. Quando uno stato come la California ha un problema, può contare ad esempio sull’assicurazione pubblica contro la disoccupazione, che è finanziata da fondi federali. Se una banca in California è in crisi, viene attivato un fondo di emergenza anch’esso dotato di risorse federali. Un’altra differenza di fondo tra gli stati che compongo gli Usa e quelli dell’Unione Europea è che nessuno negli Stati Uniti si preoccuperebbe per lo spopolamento del Sud Dakota a seguito di una crisi occupazionale, anzi, l’emigrazione è vista come un meccanismo fisiologico. Ma in Europa un’emigrazione come quella che ha caratterizzato la componente più giovane e istruita della popolazione del sud Europa - dove la disoccupazione giovanile è a livelli elevatissimi - ha effetti negativi di impoverimento di quei paesi, con tensioni sociali e frantumazione delle famiglie. Sono costi sociali che non sono calcolati dal Pil. Tutto ciò era stato in qualche modo previsto nel momento in cui si è deciso di introdurre l’euro (…).
Quali altri errori sono stati compiuti? Innanzi tutto l’idea che le cose si sarebbero risolte se i paesi avessero mantenuto un basso rapporto tra deficit o debito pubblico e Pil. È l’idea che sta dietro al Fiscal compact. Ma non c’è nulla nella teoria economica che offra un sostegno ai criteri di convergenza adottati in Europa. Anzi, la realtà ci mostra come quei criteri fossero sbagliati: Spagna e Irlanda avevano un bilancio pubblico in avanzo prima del 2009, non avevano sprecato risorse. Eppure hanno avuto delle crisi gravissime. Il debito ed il disavanzo di questi paesi si sono creati successivamente, per effetto della crisi, e non viceversa. Il fatto di aver introdotto un Fiscal compact che impone vincoli ferrei al disavanzo e al debito non risolverà i problemi, né aiuterà a prevenire la prossima crisi.
Un altro elemento che non è stato valutato appieno è che quando un paese si indebita in euro, piuttosto che in una moneta emessa dal paese che contrae il debito, si creano automaticamente le condizioni per una crisi del debito sovrano. Il rapporto debito/Pil negli Stati Uniti è analogo a quello europeo ma gli Usa non avranno mai una crisi del debito sovrano come quella che ha investito l’Europa. Perché? Perché l’America si indebita in dollari, e quei dollari verranno sempre rimborsati perché il governo degli Stati Uniti può stampare i propri dollari.
La crisi che ha colpito i debiti sovrani di numerosi paesi europei negli ultimi anni è simile a quanto ho visto molte volte quando ero capo economista della Banca Mondiale: paesi come l’Argentina o l’Indonesia hanno vissuto profonde crisi causate proprio dal fatto che si erano indebitati in valute che non potevano controllare. Quando questo avviene c’è sempre il rischio di una crisi del debito, e in Europa le condizioni per questo tipo di crisi sono state create con l’introduzione dell’euro. L’unica soluzione possibile nell’attuale situazione europea è piuttosto semplice e si chiama Eurobond. Tuttavia, sembrano esserci ostacoli politici a questa soluzione che la rendono impraticabile, ma questa sembra l’unica via d’uscita logica.
Inoltre, con l’euro si è creato un sistema fondamentalmente instabile. L’obiettivo iniziale era quello di favorire la convergenza tra gli stati europei, attraverso la disciplina fiscale dei paesi membri. Il sistema che è stato creato in realtà produce divergenza. Il mercato unico, la libera circolazione dei capitali in Europa sembrava essere la strada verso una maggiore efficienza economica. Ma non ci si rese conto del fatto che i mercati non sono perfetti. Negli anni ottanta c’erano alcuni economisti convinti del perfetto funzionamento dei mercati, mentre oggi siamo consapevoli delle innumerevoli imperfezioni che li caratterizzano. Ci sono imperfezioni da lato della concorrenza, imperfezioni sul versante del rischio e dell’informazione. I mercati non sono quelli descritti dai modelli economici semplificati (…).
Oggi si insiste molto sulle riforme strutturali che i singoli stati dovrebbero introdurre (…) Quando si sente la parola riforma si è portati a pensare a qualcosa dagli esisti sicuramente positivi, ma sotto quest’etichetta possono nascondersi misure dagli esiti profondamente negativi. Le riforme strutturali in realtà sono quasi tutte viste dal lato dell’offerta, con obiettivi come l’aumento dell’offerta o della produttività. Ma, è realmente questo il problema dell’Europa e dell’economia globale? No. I problemi oggi sono legati a una debolezza della domanda, non dell’offerta. Le riforme strutturali sbagliate aggraveranno, attraverso la riduzione dei salari o l’indebolimento degli ammortizzatori sociali, la debolezza della domanda aggregata, con ovvie conseguenze su disoccupazione e dinamica macroeconomica. E’ necessario anche riflettere sul momento in cui si possono adottare tali riforme.
Senza scendere nel merito delle riforme del mercato del lavoro nei diversi paesi europei, vorrei farvi notare che i paesi caratterizzati da un mercato del lavoro fortemente flessibile non hanno evitato le gravi conseguenze della crisi. Gli Stati uniti erano apparentemente il paese con il mercato del lavoro più flessibile, ma hanno avuto una disoccupazione al 10%. E anche oggi, quando viene propagandata la grande ripresa dell’economia statunitense, con una disoccupazione ridotta al 6%, bisogna pensare che c’è una fetta della popolazione americana sfiduciata al punto tale da aver smesso di cercare un’occupazione. Il tasso di disoccupazione reale degli Stati Uniti è attorno al 10% (…).
Quello che l’Europa non deve fare è sottoscrivere il Trattato transatlantico sul commercio e gli investimenti (Ttip). Un accordo di questo tipo potrebbe rivelarsi molto negativo
Che cosa dovrebbe dunque fare l’Europa? Sembra veramente difficile che si possa risolvere la crisi intervenendo con riforme nei singoli paesi senza riformare la struttura dell’eurozona nel suo complesso. Su alcuni di questi interventi strutturali sembrerebbe esserci un discreto consenso.
In primo luogo, una vera Unione bancaria, fatta di vigilanza e di assicurazione comune sui depositi, faciliterebbe la risoluzione congiunta delle crisi. Si tratta di misure urgenti, e l’urgenza è data dai numerosi fallimenti di imprese e banche, che possono danneggiare seriamente le prospettive di crescita future.
In secondo luogo, è necessario un meccanismo federale di bilancio in Europa che potrebbe prendere, ad esempio, la forma degli Eurobond, una soluzione pratica e facile che consentirebbe all’Europa di utilizzare il debito in funzione anticiclica, come hanno fatto gli Stati Uniti in questi anni. Se l’Europa potesse indebitarsi a tassi di interesse negativi come stanno facendo gli Stati Uniti potrebbe stimolare molti investimenti utili, rafforzare l’economia e creare occupazione. E i soldi che oggi vengono spesi per il servizio del debito dei singoli paesi potrebbero essere utilizzati per politiche di stimolo alla crescita.
In terzo luogo, l’austerità va abbandonata e va adottata una strategia articolata di crescita. I paesi europei sono molto diversi tra loro, ad esempio in termini di produttività. Sono dunque necessarie politiche industriali che favoriscano la crescita della produttività nei paesi più deboli, ma tali politiche sono precluse dai vincoli di bilancio imposti agli stati membri. Un ostacolo ulteriore è rappresentato dalla politica monetaria. Negli Stati Uniti la Federal Reserve ha un mandato articolato su quattro obiettivi: occupazione, inflazione, crescita e stabilità finanziaria. Oggi il principale obiettivo della Federal Reserve è l’occupazione, non l’inflazione. Al contrario la Banca Centrale Europea ha come unico mandato l’inflazione, si concentra unicamente sull’inflazione. Questo viene da un’idea che era molto di moda, benché non comprovata da alcuna teoria economica, quando lo Statuto della BCE è stato redatto.
L’idea consisteva nel considerare la bassa inflazione come l’elemento di traino fondamentale e quasi esclusivo per la crescita economica. Nemmeno il Fondo Monetario Internazionale condivide più questa convinzione, ma l’Europa non sembra in grado di abbandonarla. Questa politica monetaria sbagliata, può produrre e sta producendo conseguenze economiche gravi. Se gli Stati Uniti mantengono bassi i loro tassi di interesse per stimolare la creazione di nuovi posti di lavoro, mentre in Europa i tassi continuano a mantenersi più elevati, in una logica anti-inflazionistica, questo favorisce l’afflusso di capitali e l’apprezzamento dell’euro. E questo, ovviamente, rende ancora più difficile esportare le merci europee con un evidente impatto negativo sulla crescita. Quando gli Stati uniti hanno cominciato ad adottare un politica monetaria fortemente espansiva ricorrendo al «Quantitative easing», l’esito positivo di questa politica è stato facilitato dal fatto che l’Europa non ha fatto lo stesso.
Se l’Europa avesse abbassato i propri tassi di interesse nello stesso modo in cui l’ha fatto la Federal Reserve, la ripresa negli Stati Uniti sarebbe arrivata molto più lentamente. Il paradosso, dunque, è che gli Stati Uniti dovrebbero ringraziare l’Europa per aver aiutato la ripresa dell’economia americana tramite le sue politiche monetarie sbagliate. Ci sono altri aspetti da considerare. Viviamo oggi in un economia fortemente legata all’innovazione tecnologica e alla conoscenza. Ma per favorire l’innovazione sono necessari investimenti costanti e di grandi dimensioni in comparti come l’istruzione e le infrastrutture. Si tende a pensare agli Stati Uniti come a un’economia innovativa. Questo è vero, ma è necessario ricordare negli Stati Uniti le innovazioni più importanti, come Internet ad esempio, sono state sostenute e finanziate attivamente dal governo. C’è stata una politica attiva dell’innovazione. Quando ero a capo del Gruppo dei consiglieri economici della Casa bianca, verificammo che i benefici degli investimenti pubblici in innovazione erano superiori a quelli prodotti dagli investimenti privati. Si tratta di esempi di politiche attive per la crescita che avrebbero effetti molto positivi e che vanno in una direzione opposta a quella del rigore che sta strangolando l’Europa.
Infine, dobbiamo renderci conto che sia l’economia europea che quella statunitense erano affette da un patologia ancor prima dell’esplosione della crisi. Fino al 2008 l’economia europea e quella americana erano sostenute da una bolla speculativa che interessava principalmente il settore immobiliare. In assenza di quella bolla si sarebbero visti tassi di disoccupazione molto più elevati. Ovviamente non vogliamo tornare a una crescita fondata su bolle speculative (…). È necessario comprendere, dunque, quali sono i problemi di fondo che colpivano le nostre economie già prima della crisi e che, oltre a non essere stati affrontati sino ad oggi, sono peggiorati durante la recessione. Il primo problema sono le disuguaglianze crescenti nelle nostre società. La crisi ha contribuito ad aumentarle ovunque, negli Stati uniti i benefici della ripresa sono andati quasi completamente all’1% più ricco della popolazione. Negli Usa il valore del reddito mediano (quello che vede metà degli americani con redditi più alti e l’altra metà con redditi inferiori) al netto dell’inflazione è oggi più basso di 25 anni fa. Questo fa si che la famiglia americana media non abbia soldi da spendere e, di conseguenza, la domanda aggregata rimane debole. Il secondo elemento è legato alla necessità di una trasformazione strutturale verso l’economia della conoscenza. Una trasformazione che i mercati non sono in grado di gestire. Il ruolo di guida e di stimolo di tali trasformazioni dev’essere esercitato dei governi i quali, a causa della crisi attuale, non hanno in alcun modo svolto questo compito (…)
La politica industriale sarà senz’altro uno degli strumenti fondamentali per uscire da questa situazione. È necessario un Fondo europeo per la disoccupazione e un Fondo europeo per le piccole imprese, investimenti che vadano molto oltre quello che fa oggi la Banca europea degli investimenti.
Oltre alle cose che andrebbero fatte vi sono, però, anche cose che non vanno fatte. Per quanto riguarda il mercato del lavoro, ho già detto che maggiore flessibilità non aiuterà a risolvere i problemi attuali, anzi li aggraverà aumentando le disuguaglianze e deprimendo ulteriormente la domanda. La situazione italiana, ad esempio, vede già presente un elevato grado di flessibilità; aumentarla ancora indebolirebbe l’economia senza portare vantaggi. Bisogna essere molto cauti.
Un’altra cosa che l’Europa non deve fare è sottoscrivere il Trattato transatlantico sul commercio e gli investimenti (Ttip). Un accordo di questo tipo potrebbe rivelarsi molto negativo per l’Europa. Gli Stati Uniti, in realtà, non vogliono un accordo di libero scambio, vogliono un accordo di gestione del commercio che favorisca alcuni specifici interessi economici. Il Dipartimento del Commercio sta negoziando in assoluta segretezza senza informare nemmeno i membri del Congresso americano. La posta in gioco non sono le tariffe sulle importazioni tra Europa e Stati uniti, che sono già molto basse. La vera posta in gioco sono le norme per la sicurezza alimentare, per la tutela dell’ambiente e dei consumatori in genere. Ciò che si vuole ottenere con questo accordo non è un miglioramento del sistema di regole e di scambi positivo per i cittadini americani ed europei, ma si vuole garantire campo libero a imprese protagoniste di attività economiche nocive per l’ambiente e per la salute umana. La Philip Morris ha fatto causa contro l’Uruguay perché l’Uruguay vuol difendere i propri cittadini dalle sigarette tossiche. La Philip Morris nel tentativo di contrastare le misure adottate in Uruguay per tutelare i minori o i malati dai rischi del fumo si è appellata proprio ai quei principi di libero scambio che si vorrebbero introdurre con il Ttip. Sottoscrivendo un accordo simile l’Europa perderebbe la possibilità di proteggere i propri cittadini. Questo tipo di accordi, inoltre aggravano le disuguaglianze e, in una situazione come quella europea, rischierebbero di approfondire la recessione.
L’Europa può ancora permettersi di aspettare? Se non si cambia la struttura dell’eurozona, se l’Europa continua sulla strada attuale, si candida a perdere un quarto di secolo, dovete esserne consapevoli. Quando eravamo nel mezzo della Grande Depressione degli anni trenta, non si sapeva quanto sarebbe durata, ed è finita solo con la seconda guerra mondiale e la massiccia spesa pubblica che l’ha accompagnata. Non dobbiamo augurarci che l’attuale crisi venga risolta allo stesso modo, ma oggi l’Europa ha le mani legate.
Infine, la questione della democrazia. C’è un deficit di democrazia creato dall’introduzione dell’euro. Gli elettori votano a favore di un cambiamento delle politiche, poi arriva un nuovo governo che dice «ho le mani legate, devo seguire le stesse politiche europee». Questo compromette la fiducia nella democrazia. Oltre alle argomentazioni economiche che rendono necessario un cambiamento c’è questa disaffezione nei confronti della politica, che porta al rafforzamento delle forze estremiste. Non è soltanto l’economia che è in gioco, la posta in gioco è la natura delle società europee.
(traduzione del Servizio interpreti della Camera dei Deputati, trascrizione e revisione di Dario Guarascio)
Leggi la biografia di Joseph Stiglitz
«Certo il terrorismo in Italia è stato sconfitto: ma l’assassinio di Moro ha prodotto una ferita che ha stravolto la politica italiana». Da lì è cominciato il dramma che viviamo ancora. Perciò è importante sapere perchè quel delitto venne compiuto.
Il manifesto, 23 settembre 2014
I terroristi italiani e in particolare le Br, furono eterodiretti dalle forze nazionali e internazionali che intendevano bloccare il processo politico innescato da Moro e Berlinguer alla fine degli anni ’70?
La domanda è tornata in occasione della presentazione a Roma di un libro che rievoca quegli anni attraverso una serie di testimonianze (Gli anni di piombo. Il terrorismo tra Genova, Milano e Torino 1970–1980, edito da De Ferrari e a cura di Roberto Speciale).
Il parlamentare del Pd Gero Grassi, impegnato nella costituzione di una terza commissione d’inchiesta sul caso Moro – che però stenta a formarsi per mancanza di candidati a comporla – si dice certo di questa eterodirezione. Ci sarebbe qui una verità storica da accertare, capace di riempire i buchi, spesso vistosi, lasciati dai procedimenti giudiziari sul rapimento e l’uccisione del leader democristiano nel ’78.
Emanuele Macaluso preferisce sottolineare la convergenza di obiettivi politici tra l’autonoma forza eversiva dei brigatisti e altri soggetti politici che, dalla Russia di Breznev al Dipartimento di Stato Usa, passando per altre centrali occidentali, avversavano l’avvicinamento del Pci al governo.
In quegli anni ero a Genova, dove il terrorismo rosso mosse alcuni primi passi determinanti, cronista all’Unità, dopo aver vissuto la parabola che dal momento magico del ’68 aveva prodotto rapidamente una deriva violenta. Condividevo quindi l’impegno del mio giornale e del Pci in una battaglia politica e culturale contro i terroristi e anche contro quella zona grigia dell’estremismo che non rompeva con i «compagni che sbagliavano». Ricordo polemiche molto dure con Il Lavoro diretto da Giuliano Zincone, dove scrivevano tra gli altri Gad Lerner, Daniele Protti, Luigi Manconi, che verso quell’area giovanile (e meno giovanile) movimentista manteneva interesse e apertura.
Avvertivo però il rischio di cancellare in quello scontro, e nel clima politico della «solidarietà nazionale», anche le buone ragioni di chi cercava di non disperdere la forza critica del ’68, senza la quale i propositi di modernizzazione del paese mi sembravano caricarsi di ambiguità.
In quel tanto – sempre troppo poco – di rielaborazione della memoria della sinistra e dell’Italia che si va compiendo per la coincidenza di anniversari importanti (Berlinguer, Togliatti, l’Unità…) e anche per la scossa prodotta dall’ascesa di Renzi nel Pd, non andrebbe rimossa quella stagione controversa e tragica.
Più che l’accertamento della eterodirezione delle Br a me sembra importante riandare alle culture costitutive di quei soggetti: l’estremismo e il terrorismo, il Pci e la Dc. Lo schematismo ideologico disperato di chi sparava e praticava il terrore. I limiti nella comprensione del mutamento profondo che l’Italia – e il mondo – stavano vivendo da parte del principale partito di governo e della più forte opposizione «comunista» dell’Occidente.
Leggo sul Corriere della sera Pierluigi Battista che riapre la polemica retrospettiva sulla «fermezza»: allora non si volle trattare con le Br per la vita di Moro mentre oggi si tratta con l’Isis per liberare gli ostaggi. Però americani e inglesi non lo fanno.
Forse per Moro quella via andava tentata. Il che per me non significa che la visione di Craxi fosse per il resto più adeguata di quella di Berlinguer e dello stesso Moro (che sul ’68 fece uno dei discorsi più aperti e intelligenti). Certo poi il terrorismo in Italia è stato sconfitto: ma l’assassinio di Moro ha prodotto una ferita che ha stravolto la politica italiana.
 A proposito dell’articolo 18: il dubbio che rimane è se siano servi sciocchi della peggiore fase del capitalismo ( nel senso che non capiscono ciò che fanno) oppure se siano anche complici.
A proposito dell’articolo 18: il dubbio che rimane è se siano servi sciocchi della peggiore fase del capitalismo ( nel senso che non capiscono ciò che fanno) oppure se siano anche complici.
Huffington post, 25 settembre 2014
Ha qualcosa di sconvolgente (nel senso letterale di "sconvolgere") il principio contenuto nell'emendamento del governo al Jobs Act sulle cosiddette "tutele crescenti", da applicare ai nuovi contratti di lavoro subordinato. Leggiamo: «(...) il Governo è delegato ad adottare, (...) in coerenza con la regolazione dell'Unione europea e le convenzioni internazionali, (...) la previsione, per le nuove assunzioni, del contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti in relazione all'anzianità di servizio».
Da questa disposizione si ricava che, nella nuova versione del welfare italico prospettata dal governo, sarà l'anzianità di servizio a determinare il livello di godimento dei diritti costituzionali da parte dei lavoratori, dunque, nella generalità dei casi, l'età dello stesso lavoratore.
Nel nostro ordinamento, solo la maggiore età costituisce uno spartiacque nella storia personale di un individuo, delineando una linea di confine tra un prima ed un dopo nella scala di godimento dei diritti sanciti dalla Costituzione. Beninteso, un minore non ha diritto di voto, non ha facoltà piena di porre in essere atti negoziali, ma non per questo è passibile di soprusi e di discriminazioni. Anzi, c'è una tutela rafforzata che lo riguarda, in quanto "soggetto debole".
Nello schema proposto dal governo in materia di rapporti di lavoro, c'è invece un rovesciamento del principio: più sei giovane (in Italia si può lavorare già a 13 anni) meno tutele e diritti avrai. Nel caso specifico dell'articolo 18 dello Statuto dei lavoratori, e segnatamente della reintegra in caso di licenziamento senza giusta causa, questo capovolgimento di scenario implicherebbe una vergognosa correlazione tra giovane età e possibilità di subire licenziamenti arbitrari o, addirittura, discriminatori, anche licenziamenti funzionali al non raggiungimento della soglia di "anzianità di servizio" prevista dalla legge per l'accesso al godimento di alcuni diritti.
Abile però il governo, ed il premier in particolare, a presentare la "riforma" come un rimedio al regime di apartheid che oggi vigerebbe nel mondo del lavoro, nel senso che la fattispecie denunciata sarebbe proprio quella che si andrebbe a concretizzare nel momento in cui venisse approvata la nuova disciplina in materia di rapporti di lavoro proposta dall'esecutivo.
Se davvero il governo avesse in mente di eliminare le discrepanze esistenti tra lavoratori "tradizionali" e lavoratori "atipici", certamente non inizierebbe ad occuparsi dei diritti dei primi. Piuttosto metterebbe mano alla giungla di contratti che negli anni ha generato il mare di precariato in cui sono immersi i secondi. Si porrebbe, in sostanza, il problema di estendere le tutele a chi oggi non ce l'ha, non a livellarle verso il basso, istituzionalizzando nuove forme di discriminazione su base generazionale.
Che c'entra il volersi occupare di "Marta", che "non ha la possibilità di avere il diritto alla maternità", col voler togliere diritti a "Francesca", che invece quel diritto ce l'ha insieme all'altro di poter ricorrere contro un licenziamento senza giusta causa? Ma soprattutto, qual è il modello di società che si prospetta alle "Marta" d'Italia? Quello in cui chi è giovane e precario oggi sarà un vecchio povero domani, che per giunta dovrà "guadagnarsi" con l'anzianità di servizio (di servigi?) l'accesso al godimento di diritti fondamentali?
C'è una Costituzione, tuttora vigente mi sembra, che all'art. 3 sancisce: "Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, (...)". Poi dice anche che la Repubblica ha il compito di "rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, (...)".
Ecco, "pari dignità" e "rimozione degli ostacoli". Esattamente il contrario di ciò che il governo sta prospettando.
 «Salvatore è lì, con le sue cassette, quando i vigili urbani minacciano di multarlo e di sequestrargli la merce. Lui li scongiura di evitargli almeno il sequestro. I vigili lo prendono in giro e, quando lui grida che è pronto a darsi fuoco, uno degli agenti replica che lo faccia pure, ma spostandosi un po’ più in là».
«Salvatore è lì, con le sue cassette, quando i vigili urbani minacciano di multarlo e di sequestrargli la merce. Lui li scongiura di evitargli almeno il sequestro. I vigili lo prendono in giro e, quando lui grida che è pronto a darsi fuoco, uno degli agenti replica che lo faccia pure, ma spostandosi un po’ più in là».
Il manifesto, 24 settembre 2014
Sebbene Salvatore La Fata, disoccupato catanese di 56 anni, non sia la prima torcia umana a bruciare in una piazza italiana, la sua vicenda è tragicamente esemplare. A tal punto che, questa volta, anche sul versante sindacale v’è qualche reazione adeguata. Dopo il tempestivo sit-in di solidarietà nei suoi confronti e di condanna del comportamento della polizia municipale, promosso dal circolo «Città Futura», pure la Cgil si è attivata. Ha, infatti, annunciato una conferenza-stampa per oggi,mercoledì 24 e una manifestazione unitaria, con le altre centrali sindacali, per il pomeriggio di venerdì 26, nella stessa piazza Risorgimento che è stata teatro dell’atroce protesta.
Operaio edile specializzato, spesso partecipe d’iniziative sindacali, La Fata era stato licenziato due anni fa. Il cantiere in cui lavorava era stato costretto a chiudere, come tanti: a Catania, riferisce la Fillea, ben diecimila edili hanno perso il lavoro negli anni recenti. Per un po’ Salvatore (sposato, due figli a carico) aveva sopportato umiliazione e vergogna. Poi, pur di non stare con le mani in mano, da alcuni mesi s’era messo a vendere qualcosa in piazza Risorgimento: nient’altro che due o tre cassette di olive e fichi d’india, appena venti euro di merce. Troppo per la squadra di vigili urbani, agguerrita e ultra-motorizzata, che al mattino del 19 settembre fa irruzione in piazza. In tempi di crisi e di disperazione sociale è quel che ci vuole: non sia mai che le classi pericolose si mettano a far di testa loro per sbarcare il lunario, invece che sopportare pazientemente la morte civile, contribuendo così al disegno deciso in alto loco. Fuor di sarcasmo, è da notare come, parallelo allo sfacelo sociale provocato dalle politiche di austerità, vada intensificandosi un crudele accanimento repressivo contro attività informali di nessun rilievo penale, volte alla pura sopravvivenza.
Ma torniamo a quel mattino catanese. Salvatore è lì, con le sue cassette, quando i vigili urbani minacciano di multarlo e di sequestrargli la merce. Secondo dei testimoni, lui li scongiura di evitargli almeno il sequestro. I vigili lo prendono in giro e, quando lui grida che è pronto a darsi fuoco, uno degli agenti replica che lo faccia pure, ma spostandosi un po’ più in là. Sta di fatto che nessuno di loro interviene per tutto il tempo in cui va a rifornirsi di carburante, torna in piazza, si cosparge di benzina e si dà fuoco. E neppure mentre è già avvolto dalle fiamme.
È quasi pleonastico osservare quanto questa storia somigli a quella di Mohammed Bouazizi, «la scintilla» della rivoluzione tunisina. Quanto sia simile, anche, alla vicenda del giovane marocchino Noureddine Adnane, morto il 19 febbraio 2011, dopo nove giorni d’agonia dacché s’era dato fuoco in una piazza di Palermo: anch’egli ambulante, ma regolare, eppure vittima di vessazioni da parte d’una «squadretta» di vigili urbani in odore di neonazismo. Peraltro, lo schema di queste due storie è del tutto sovrapponibile a quello delle centinaia di casi che ho raccolto nei paesi del Maghreb, nonché in Europa e in Israele.
Ad accomunarne molti v’è uno stesso «dettaglio», cioè il comportamento arrogante, persino di sfida, delle forze dell’ordine: un’autentica istigazione al suicidio. E in tutti i casi il suicidio per fuoco è un grido disperato di ribellione e protesta, un gesto sovversivo di sottrazione violenta del proprio corpo alla violenza del sistema, per citare Baudrillard. Destinato, delle volte, a cadere nel vuoto; altre volte, come in Maghreb, a perpetuare il ciclo rivolta-immolazione-rivolta; in un caso, quello tunisino, a scatenare un’insurrezione popolare.
Da noi, c’è uno iato profondo fra la drammaticità dell’autoimmolazione pubblica - atto non solo disperato, ma anche di speranza nel genere umano, in fondo - e la nostra impotenza. Da noi, non c’è alcun soggetto collettivo che rivendichi come proprio «martire» chi si è immolato o che sia capace di cogliere fino in fondo il nesso fra le proprie rivendicazioni e la disperazione sociale che spinge alcuni a suicidarsi in pubblico. Eppure le torce umane e più in generale i suicidi «economici» sono indizio di un conflitto sociale latente. Quello che la politica, i sindacati, perfino i movimenti non sempre sanno rendere esplicito, né sempre organizzare in forme razionali ed efficaci, tali da impedire che altri corpi umani ardano nelle piazze.
 «Sblocca Italia sostiene lo sviluppo dell’asfalto, molto meno destina alle ferrovie e poco alle reti del trasporto urbano, il vero deficit italiano. Il governo insiste con le distorsioni della Legge Obiettivo, senza una politica dei trasporti innovativa e sostenibile».
«Sblocca Italia sostiene lo sviluppo dell’asfalto, molto meno destina alle ferrovie e poco alle reti del trasporto urbano, il vero deficit italiano. Il governo insiste con le distorsioni della Legge Obiettivo, senza una politica dei trasporti innovativa e sostenibile».
Sbilanciamoci.info, 24 settembre 2014
Dopo roboanti annunci alla fine il Decreto “sblocca Italia” è arrivato1. Nessuna svolta riformista tanto declamata dal Presidente Renzi, ma “passodopopasso” si prosegue ed aiuta lo sblocco di cantieri inutili, il consumo di territorio e paesaggio, ad indebolire le Soprintendenze, a svendere il demanio pubblico, a scavare petrolio per mare e per terra, a insistere con la deregulation edilizia, ad imporre inceneritori in giro per l’Italia.
Era lecito sperare che un presidente del consiglio giovane e scattante, che parla un linguaggio nuovo, avesse anche idee e progetti nuovi per il futuro dell’Italia: green economy, riqualificazione delle città, efficienza ed energie rinnovabili, reti e servizi per il trasporto pubblico, ricerca ed innovazione tecnologica, beni comuni, patrimonio storico e bellezza del paesaggio. Idee e soluzioni che dove sono state attuate hanno assicurato anche crescita dell’occupazione in particolare di quella giovanile, che certamente resta un obiettivo primario per il nostro Paese.
Certo, qua e là, qualche idea giusta c’è - le opere contro il dissesto idrogeologico, quelle dei Comuni e per le scuole, la banda larga, reti tramviarie e metropolitane - ma annegano nella lunga lista di obiettivi e progetti che vengono direttamente dal passato a base di asfalto, cemento, petrolio, consumo di suolo. Anche semplificare la troppa carta e le burocrazie pesanti potrebbe avere un senso se quello che si vuole realizzare fosse utile ed innovativo, invece suona come togliere gli ultimi “lacci e lacciuoli” a chi fa rispettare le regole, o espropriare i poteri dei Comuni come per la bonifica e la riqualificazione di Bagnoli avocata alla Presidenza del Consiglio e sottratta al Comune di Napoli ed al suo piano regolatore.
Quando a luglio venne lanciata dal Governo la parola d’ordine “sblocca Italia” ( ormai abbiamo una lista di Salva Italia, Destinazione Italia, Fare Italia...) per le grandi opere strategiche si annunciava lo sblocco di 42 miliardi di opere da realizzare subito. Numeri “incredibili”, anche alla luce del fallimento di 13 anni di Legge Obiettivo, ridimensionati man mano che si avvicinava il Decreto Legge e la dura realtà dei numeri e delle coperture finanziarie.
Alla fine per le grandi opere sono destinati in totale 3,9 miliardi, spalmati dal 2014 al 2020 e prevalentemente negli anni 2017 e 2018. Il Decreto contiene la lista delle opere da rifinanziare subito (lista a), da sbloccare entro il 30 giugno (lista b) e quelle di cui aprire i cantieri entro il 31 agosto 2015 (lista c). Il testo non contiene quante risorse sono assegnate per ciascuna opera - che spetterà fissare dal Ministero delle Infrastrutture insieme a quello dell’Economia – ma nella relazione tecnica allegata vi sono le previsioni distinte opera per opera. La logica è quella di dare un poco di risorse a molte opere per evitare che si fermino i cantieri e realizzare altri “pezzi”.
Sommando le previsioni, si ottiene che ben il 47% dei 3,9 miliardi andrà a strade ed autostrade (1.832 milioni), il 25% a ferrovie (989 milioni) e solo l’8,8% a reti tramviarie e metropolitane (345 milioni). Il resto sarà destinato alle opere idriche (134 milioni), aeroporti (90 milioni) mentre 500 milioni sono destinati alle opere dei Comuni, il piano dei 6mila campanili del DL del Fare del 2013.
Quindi lo Sblocca Italia continua a sostenere lo sviluppo dell’asfalto, mentre molto meno destina alle ferrovie e davvero poco alle reti per il trasporto urbano, che sono il vero italiano, insistendo quindi con le distorsioni della Legge Obiettivo e senza una politica dei trasporti innovativa e sostenibile. Inoltre, anche dei 989 milioni destinati alle ferrovie, ben 520 milioni sono per tre nuove tratte ad alta velocità (Terzo Valico Milano-Genova, Tunnel del Brennero, AV Brescia Padova) e solo la restante parte per le ferrovie ordinarie.
Anche altre due tratte ferroviarie, la Napoli-Bari e la Palermo Catania Messina, sono inserite nello Sblocca Italia per accelerare le procedure autorizzative, mentre le risorse sono quelle fissate dal Contratto di Porgramma di RFI, che prevedono 2,9 miliardi per la prima e 2,4 miliardi per la seconda. L’amministratore Delegato di FS, Michele Elia, è nominato commissario straordinario, ha tempi stretti per l’approvazione e la revisione dei progetti (tratto Apice-Orsara) e per indire la Conferenza dei servizi. In deroga alle norme, in caso di “dissenso di una amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico territoriale, del patrimonio storico artistico, tutela della salute e pubblica incolumità” decide il commissario previa intesa con le regioni interessate. Non è di certo un buon modo per progettare una infrastruttura attenta al territorio ed al paesaggio, capace di adottare soluzioni innovative.
La lista delle strade ed autostrade contiene interventi per la terza corsia Venezia-Trieste, lavori per la Torino-Milano ed opere connesse, il quadrilatero Umbria Marche, messa in sicurezza della SS131 Carlo Felice, Salerno - Reggio Calabria, Benevento Caianello, Pedemontana Piemontese, asse viario Lecco Bergamo. Si può ben facilmente notare che alcune di queste opere di adeguamento di strade esistenti siano necessarie e che “sembrano mancare” le grandi autostrade che ogni giorno vengono invocate come la soluzione sia ai problemi di mobilità che di crescita e occupazione del paese.
In effetti alcune sono sparite dall’elenco, come le risorse per l’Autostrada della Maremma o la Cispadana, che il Governo rassicura saranno nel DDL Stabilità, o come la Valdastico nord, a cui la provincia Autonoma di Trento è fermamente contraria e prima il Governo deve ricomporre il quadro istituzionale.
Ma per altre come l’autostrada Orte -Mestre, opera in autofinanziamento del valore di almeno 10 miliardi, il cui promotore è una cordata di imprese capeggiata dall’On.Vito Bonsignore, è stata inserita una specifica norma (articolo 2, comma 4) per aiutare con la defiscalizzazione - almeno 2 miliardi di risorse pubbliche - il Piano Finanziario dell’opera. Era stata la Corte dei Conti con un parere del 7 luglio del 2014 che non aveva dato il via libera alla delibera Cipe di approvazione del progetto, a segnalare che le norme vigenti non consentivano di applicare la defiscalizzazione prevista dal 2013 alle opere già dichiarate di pubblico interesse e la Orte Mestre lo era stata nel lontano 2003 con il riconoscimento del progetto del promotore Bonsignore.
Questa retroattività - ottenuta con la norma inserita nello Sblocca Italia - per superare le obiezioni della Corte dei Conti, è assai grave ed anche indecente, perché se adesso lo stato mette 2 miliardi nel piatto, allora bisognerebbe azzerare anche il promotore e rifare questa selezione. Perché non dimentichiamo che il promotore ha diversi vantaggi tra cui quello che la gara avviene sul progetto preliminare da lui presentato, che ha il diritto di adeguarsi all’offerta migliore e vincere la gara per realizzare e gestire l’infrastruttura. In caso di perdita viene comunque ripagato di tutti i costi sostenuti.
Non è un cavillo, è una vera e propria distorsione dell’offerta a suo tempo presentata. Se all’epoca il promotore fu considerato il migliore da ANAS perché aveva bisogno di minori aiuti pubblici e sosteneva che si sarebbe autofinanziato l’opera, se adesso il Governo mette due miliardi di aiuti sotto forma di defiscalizzazione, allora tutto cambia. In realtà quelle risorse pubbliche si dovrebbero usare, come propongono gli ambientalisti riuniti della Rete Nazionale Stop Orte-Mestre2, per mettere in sicurezza la E45 e la Romea, senza realizzare nuovi inutili e devastanti 400 km di nuova autostrada.
Ma anche le altre autostrade hanno un articolo dedicato - art. 5, Norme in materia di concessioni autostradali - che con frasi criptiche e giri di parole consente la richiesta di proroga della scadenza delle concessioni . E’ la solita storia che si ripete, basti ricordare che dal 1993 la direttiva europea n. 37 intimava che per le concessioni fosse necessario procedere mediante gara, chiedendo a tutti i paesi membri di adeguarsi.
Ma tra la fine degli anni 90 ed i primi anni 2000 tutte le concessioni sono state prorogate invocando il contenzioso pregresso, le privatizzazioni e gli investimenti da fare: da Autostrade per l’Italia prorogata di 20 anni al 20383, alla Sitaf Torino-Bardonecchia che scade nel 2050, alla Satap di Gavio al 2016, Autostrada dei Fiori al 2021, poi quelle che devono realizzare nuove autostrade come la SAT per l’Autostrada della Maremma con scadenza al 2046, o l’Autocamionale della Cisa che deve realizzare il Ti-Bre Parma Verona con scadenza al 2031.
La discussione con Bruxelles è stata accesa ma alla fine anche dalla Commissione Europea è arrivato il via libera, perché si trattava di investimenti già inseriti nelle convenzioni e del fatto che era “l’ultima proroga”, per poi procedere a gara ed utilizzare il meccanismo del subentro. Cioè chi gareggia sa di doversi accollare gli investimenti in corso e da fare. Ma questo meccanismo “non funziona” dicono in coro le concessionarie, anche se praticamente non è stato mai sperimentato. Adesso con lo Sblocca Italia il Governo Italiano ci riprova ad ha avviato una dialogo con Bruxelles per ottenere ulteriori proroghe. Forse forte del fatto che anche la Francia avrebbe avanzato una analoga richiesta.
La norma all’art. 5 dice che le concessionarie possono “proporre modifiche del rapporto concessorio “ entro la fine del 2014, negoziazione e firma degli atti aggiuntivi entro il 31 agosto 2015, per realizzare potenziamenti della rete sia per quelli già in concessione e sia per nuove opere da inserire, per tenere tariffe favorevoli all’utenza, “anche mediante l’unificazione di tratte interconnesse contigue”, al fine di assicurare l’equilibrio del Piano Economico e finanziario senza ulteriori oneri a carico dello Stato.
Il terzo comma ha anche una prescrizione che sembra guardare a Bruxelles con occhio accorto: tutte le opere ulteriori inserite nelle convenzioni, saranno realizzate mediante gara di lavori per il 100% dell’importo (per quelle in convenzione va a gara il 60%). Un buon principio certo, ma che rischia di essere vano perché le convenzioni vigenti includono lunghe liste di opere e ben difficilmente se ne aggiungeranno.
L’articolo 5 al comma 4 prevede che per l’A21 Piacenza Brescia, la cui concessione è scaduta nel 2011 e per l’A3 Napoli Pompei sono approvati con legge gli schemi di convenzione ed i relativi Piani Finanziari per accelerare l’iter del “riaffidamento”. Vedremo se ad esito di gara o prorogando agli attuali concessionari.
Basti pensare che le proroghe di cui si parla (o si legge4) richieste dalle concessionarie, sono per lavori già assentiti ed opere note. Si parla di una proroga per l’AutoCisa che vuole realizzare il Tibre (1,8 miliardi) che ha però già avuto una concessione prorogata al 2031, di Autovie Venete che deve realizzare la terza corsia Venezia-Trieste (1,7 miliardi) che scade nel 2017 e che aveva già ottenuto una proroga, della SATAP A4, che chiede la proroga per ammodernare la Torino-Milano (500 milioni di investimento) e che ha una scadenza già prorogata al 2026.
Chiede la proroga anche l’Autostrada Asti Cuneo, nuova autostrada in parte realizzata e che per il completamento deve investire 1,5 miliardi e la cui scadenza è fissata al 2035. Infine c’è il caso dell’Autobrennero, scaduta il 30 aprile 2014, sui cui era stata avviata una gara poi annullata da un ricorso e che adesso chiede 20 anni di proroga sia per realizzare la terza corsia Modena-Verona e sia per destinare alla ferrovia i 500 milioni accantonati per il tunnel del Brennero (deciso con norma nel 1997).Ma anche l’autostrada Centropadane avrebbe richiesto una proroga, magari applicando quella norma sulle concessioni “contigue”.
A Genova il dibattito sulla Gronda Autostradale, prevista dalla Convenzione di Autostrade è molto acceso sia sul tracciato che sulla utilità dell’opera, ma la Società Autostrade per l’Italia ha già ventilato in diverse occasione che - dati gli alti costi dell’opera - si potrà realizzare solo se vi sarà una proroga della concessione che va ricordato scade nel 2038. Magari non sarà richiesta immediatamente, ma intanto già si lavora per andare quella direzione.
Staremo a vedere se anche questa volta Bruxelles darà il via libera alle proroghe.
Vanno segnalati anche due casi su cui c’è molta attenzione anche dalla Ue: la concessione SAT (Autostrada Tirrenica) che il governo si era impegnato a ridurre di tre anni e su cui è riaperta una procedura d’infrazione; la scadenza della Brescia-Padova prorogata al 31/12/2026 a condizione che il progetto definitivo della Valdastico Nord sia approvato entro il 30 giugno 2015. Progetto a cui si oppone in modo deciso la Provincia autonoma di Trento.
La richiesta delle proroghe si aggiunge alla richiesta diffusa da parte delle concessionarie di ottenere la “defiscalizzazione”, cioè la possibilità di non pagare Iva, Ires e Irap. Già deciso dal Cipe per la Pedemontana Lombarda, richiesto dalla autostrada Orte-Mestre e dalla Brebemi, di fatto è un contributo pubblico in quanto riduce le entrate dello Stato per gli anni a venire.
Anche su questi aiuti è acceso un faro da parte di Bruxelles, mentre nello Sblocca Italia, oltre alla norma specifica per la Orte Mestre, l’articolo 11 stabilisce che tutte le opere hanno diritto alla defiscalizzazione, abbassando da 200 a 50 milioni di euro il valore dell’opera.
Solo proroghe, niente gare ed aiuti dalla Stato. E’ il solito blocco di interessi, sono i signori delle autostrade che dopo aver promesso grandi investimenti, presentato ed ottenuto piani finanziari scritti sulla sabbia, con il calo di traffico e le banche sempre più prudenti, con il buco che si è creato nei piani finanziari, alza la voce in tempi di crisi per assicurarsi un futuro5.
Molte autostrade, qualche ferrovia, poche reti tramviarie e metropolitane: la politica del Presidente Renzi sulla mobilità e le infrastrutture non cambia verso.
1 Decreto Legge 12 settembre 2014 n.133. Misure urgenti per l’apertura dei cantieri, la realizzazione di opere pubbliche, la digitalizzazione del paese, la semplificazione burocratica, l’emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive. Pubblicato sulla G.U n. 212 del 12.09.2014.
2 vedi www.stoporme.org
3 Giorgio Ragazzi. I signori delle autostrade. Edizioni il Mulino. 2008
4 Autostrade, le opere da sbloccare. Di Alessandro Arona. Edilizia e Territorio, Il sole 24 ore. 15 settembre 2014
5 Roberto Cuda. Strade senza Uscita. Banche, costruttori e politici. Le nuove autostrade al centro di un colossale spreco di denaro pubblico. Edizioni Castelvecchi. 2013