

la Repubblica online, 1 febbraio 2017 (p.s)
«Abbiamo firmato con le associazioni del tavolo islamico italiano un importantissimo documento, cruciale, che riguarda il presente e il futuro dell'italia attraverso il dialogo interreligioso». Così il ministro dell'Interno Marco Minniti, al Viminale, presenta il 'Patto nazionale per un islam italiano, espressione di una comunità aperta, integrata e aderente e ai valori e principi dell'ordinamento statale', redatto con la collaborazione del consiglio per i rapporti con l'islam italiano e recepito dal ministero dell'Interno.
Minniti è soddisfatto, il documento è stato sottoscritto dalle principali associazioni e organizzazioni islamiche in italia, rappresentative di circa il 70 per cento dei musulmani che attualmente vivono in italia. «È un atto che considero straordinario - dice il ministro -, un importante passaggio utile per la vita del nostro Paese».
Tra i punti salienti del patto, come sottolinea Minniti in conferenza stampa, c'è la «formazione di imam e guide religiose» che prelude a un albo degli imam. Inoltre, le associazioni islamiche si impegnano a «rendere pubblici nomi e recapiti di imam, guide religiose e personalità in grado di svolgere efficacemente un ruolo di mediazione tra la loro comunità e la realtà sociale e civile circostante; ad "adoperarsi concretamente affinchè il sermone del venerdì sia svolto o tradotto in italiano»; ad «assicurare in massima trasparenza nella gestione e documentazione dei finanziamenti». Il documento di fatto consente di superare anche antiche contrapposizioni tra alcune associazioni islamiche.
Condividi «Il patto - sottolinea - si muove nell'alveo della nostra Costituzione, che sono i nostri valori. I valori che tutti quanti insieme ci impegniamo a difendere e a ripudiare qualsiasi forma di violenza e di terrorismo». «La prima parte del Patto - prosegue Minniti - richiama i valori della Costituzione italiana, che sono i valori dei firmatari, valori che tutti insieme ci impegniamo a difendere. Il cuore del documento - ha aggiunto - è il giusto equilibrio tra diritti e doveri».
Il segretario generale del centro Islamico culturale d'Italia (la grande moschea di Roma), Abdellah Redouane, tra i firmatari, esprime apprezzamento per lo "spirito" che ha portato alla firma: «Il centro continuerà a dare il suo contributo nel favorire una crescita e responsabile dell'islam in Italia».
Il Patto contiene dieci impegni da parte delle associazioni islamiche chiamate a far parte del Tavolo di confronto presso il ministro dell'Interno ed altrettanti da parte del ministero. Si sottolinea, rileva il ministro, «che la libertà di culto è una delle libertà inalienabili e che lo Stato non dà regole alle religioni, ma può fare intese. È l'incontro di libere volontà, non la supremazia di una volontà». Il titolare del Viminale definisce poi «un grave errore l'equazione tra immigrazione e terrorismo, ma è un errore anche dire che non c'è rapporto tra mancata integrazione e terrorismo. L'attentato di Charlie Hebdo ha dimostrato che livelli di integrazione non adeguati formano un brodo cultura per i terroristi».
Minniti quindi mette in guardia dagli imam fai da te, definiti "un grande pericolo" e illustra gli altri punti del documento: il contrasto al radicalismo religioso, l'impegno a garantire che i luoghi di preghiera siano accessibili a visitatori non musulmani e che il sermone del venerdì sia «svolto o tradotto in italiano", la massima trasparenza sui finanziamenti ricevuti per la costruzione e le gestione di moschee e luoghi di culto. "Non sono - conclude il ministro - standard che uno decide e gli altri devono accettare, sono condivisi e ho visto una straordinaria volontà dei firmatari di impegnarsi nella realizzazione di questo percorso. Sarà promossa una serie di incontri con le comunità musulmane, si organizzerà un tour per i giovani musulmani di seconda generazione e faremo una grande assemblea».
Infine il ministro ringrazia i docenti musulmani «per il lavoro straordinario svolto, per aver permesso con la loro professionalità e la loro apertura culturale di raggiungere un obiettivo non semplice. In altri momenti non tutte le associazioni avrebbero firmato un documento simile, oggi lo hanno fatto. Qualcuna magari convincendosi all'ultimo momento: quando ho fatto notare che nella nostra religione c'è piu festa in cielo per la pecorella smarrita, mi hanno fatto notare che lo stesso vale anche per la loro. Tanto che potremmo anche chiamarlo il patto della pecorella smarrita...».
huffingtonpost online, 1 febbraio 2017 (p.s.)
In un saggio del 1963, "Radicalism and the organization of radical movements", il sociologo cecoslovacco Egon Bittner definiva il radicalismo come reazione di rigetto rispetto al "normale e tradizionale" orizzonte assiologico vigente in un dato gruppo sociale e in un determinato momento storico. Essere radicali significa, per lo studioso, interiorizzare una serie di modi di agire, pensare e sentire che si pongono in antitesi con lo spirito del proprio tempo.
Questa prospettiva mette in luce l'essenziale: la radicalizzazione non è un processo socio-cognitivo che riguarda solamente terroristi irriducibili e sanguinari quanto, al contrario, costituisce una dinamica ricorrente nella vita quotidiana di ogni attore sociale. Percorrere contromano un senso unico, per intenderci, significa essere, a proprio modo, radicali.
Quando Bittner scriveva, erano anni nei quali il mondo degli intellettuali stava ancora cercando di razionalizzare il misterioso geroglifico che aveva condotto l'umanità occidentale nel baratro di due disastrosi conflitti che, erodendo le fondamenta della ragione, avevano provocato uno stato di barbarie e distruzione. È quantomeno sorprendente, tuttavia, che la lezione di Bittner sia stata quasi completamente ignorata nel dibattito attuale sulla radicalizzazione.
In particolar modo, nonostante tale dibattito abbia consentito di far luce su ogni singolo aspetto del percorso socio-psicologico che conduce un individuo "normale" verso la violenza politica e religiosa, ci si è completamente dimenticati che le stesse identiche dinamiche incidono sulla radicalizzazione, eguale e contraria, della quota parte di società che combatte la radicalizzazione. In parole più semplici, non è stato compreso che le dinamiche che regolano la radicalizzazione della violenza islamica sono in realtà le stesse che determinano quella che definisco "radicalizzazione dell'Occidente" nei confronti dell'Islam.
Per spiegare tale concetto occorre, tuttavia, fare un piccolo passo indietro, definendo cioè quali sono le macro-componenti della radicalizzazione, cioè di quel processo socio-cognitivo che porta un individuo "normale" ad acquisire una mentalità radicale che potrebbe condurlo verso la crescente volontà di sovvertire l'ordine esistente. Gli studiosi dividono la radicalizzazione in due sotto-processi che prendono il nome di radicalizzazione cognitiva (l'acquisizione mentale di una ideologia radicale) e comportamentale (la progressiva disponibilità all'azione violenta).
La violenza verbale, fisica, virtuale e terroristica, trova sempre la sua genesi nella selva psico-cognitiva del pensiero individuale. Spiegare la radicalizzazione significa, quindi, dipanare la matassa della mente dell'individuo che si radicalizza, tenendo a mente l'ironica provocazione di Joseph Margolin secondo cui "il terrorista" - e, dunque, ogni uomo - «è prima di tutto un uomo». Proprio da lì occorre partire.
La frustrazione come causa profonda della radicalizzazione
Per spiegare la dinamica della radicalizzazione del «noi contro di loro», cioè la reazione di rigetto del mondo Occidentale nei confronti dell'Islam, parto dal concetto di frustrazione e dai suoi effetti sulla vita delle persone. Nel 1954, lo psicologo statunitense Maslow Abraham propose una gerarchizzazione piramidale dei bisogni umani, suddividendoli in 5 macro-categorie: fisiologici, di sicurezza, di appartenenza, di stima e di autorealizzazione.
La relazione tra bisogni e soddisfazione, secondo Maslow, è di inversa proporzionalità. Più precisamente, considerati i bisogni fisiologici come la base della piramide e quelli legati all'autorealizzazione il vertice, la probabilità di soddisfare i secondi sarà di gran lunga inferiore rispetto ai primi. Questo comporta, inevitabilmente, una frustrazione crescente nell'uomo: al crescere dei bisogni, diminuiscono le possibilità di soddisfarli.
Questo è particolarmente evidente nelle moderne civiltà occidentali, dove il progresso ha generato crescente benessere materiale, consentendo a miliardi di persone di riempire la base della piramide di Maslow. Tuttavia, il progresso materiale non offre particolari risposte per quanto riguarda i bisogni di livello superiore, e cioè quelli legati, per così dire, alla dimensione spirituale della vita degli umani. Soddisfare lo spirito significa sentirsi appagati mentalmente, essere in pace con sé stessi, col mondo circostante, significa costruire un solido architrave attorno a cui erigere le "pareti" della propria esistenza terrena. L'ascensione della piramide è paragonabile all'arrampicata di uno scalatore: lenta, stancante e, talvolta, impossibile da terminare.
Date queste premesse e nonostante la realizzazione dei bisogni spirituali sia un percorso che ha come durata la vita stessa dell'uomo, in determinate circostanze e in date congiunture storiche segnate da crisi globali, sfiducia nel progresso umano e ultra-individualismo nelle relazioni, tale frustrazione assume delle caratteristiche ben precise, passando da essere la causa di un problema allo strumento per combatterlo. Gli individui soggetti alla frustrazione crescente della propria autorealizzazione cominciano improvvisamente a temere, non solo di essere giunti al termine del cammino di avvicinamento a essa, ma anche di dover difendere la propria posizione raggiunta dal rischio di perdere terreno, aggrediti da minacce esterne.
L'ideologizzazione della frustrazione
Qualora rimanga un fenomeno relegato alla mera vita privata di un individuo, la frustrazione non coincide con la radicalizzazione. Come sostiene il sociologo iraniano Farhad Khosrokhavar in un suo studio illuminante sulla radicalizzazione islamica nelle carceri francesi, la frustrazione è un parametro insufficiente per innescare la radicalizzazione. L'individuo frustrato, infatti, potrebbe reagire alle sue inquietudini chiudendosi in sé stesso, senza cercare in alcun modo la via del riscatto. La frustrazione - fattore determinante per la radicalizzazione dell'Occidente nei confronti dell'Islam - necessita di un solvente, di un catalizzatore che ne faciliti la trasformazione. La source del passaggio dalla frustrazione alla sua dimensione applicativa è costituita dall'ideologia, in un processo che Khosrokhavar definisce «ideologizzazione della frustrazione».
Nonostante la civiltà contemporanea si definisca post-ideologica, ritengo che le nuove organizzazioni politiche anti-sistemiche e populiste rappresentino il condensato più evidente di come l'ideologizzazione dei gruppi sociali sia un fattore preponderante e tutt'altro che scomparso.
Un'ideologia trasversale, che non ha più i connotati dei vecchi impianti del Novecento, ma che, comunque, ha il potenziale sufficiente per innescare una nuova forma di conflitto sociale che, come scrissi a margine dell'elezione di Donald Trump come Presidente degli Stati Uniti, «non ha più il suo fine nella conquista dei diritti, ma nella difesa di privilegi» e, addirittura, nell'introduzione di nuovi privilegi in opposizione frontale rispetto a chi, al contrario, vuole solamente garantire diritti.
Il successo dei movimenti anti-sistema, che trascendono i confini, deriva dal fatto che «sono tutte manifestazioni dello stesso fenomeno, che affonda le sue radici in una paura ormai radicata nell'inconscio di una maggioranza perlopiù silenziosa, ma che trova espressione politica in una narrativa rassicurante», estremamente "autoreferenziale" e capace di generare "una sorta di psicosi collettiva".
Qual è l'origine di tale paura? La frustrazione individuale per l'impossibilità di progredire nella marcia di soddisfazione dei propri bisogni, provoca la necessità di trovare appiglio nel mondo reale per lenire, almeno parzialmente, la propria angoscia esistenziale.
Questo processo virale, che si autoalimenta grazie anche ai mezzi di comunicazione, all'incessante creazione di "bufale" e, soprattutto, al fatto che ci siano persone che le prendono per vere, porta come logica conseguenza al settarismo e alla necessità di difendersi dal pericoloso assedio di agenti esogeni che minacciano direttamente i nervi scoperti della propria persona. Gli agenti patogeni, percepiti come origine della frustrazione, sono spesso identificati nell'"altro", nel "diverso", in chi si discosta dal proprio gruppo sociale di riferimento (per esempio, musulmani e migranti). Attraverso una narrativa riduttiva e semplicistica, viene a costituirsi un nuovo e potentissimo serbatoio ideologico.
L'operazionalizzazione della frustrazione
Chiunque ritenga ancora che l'ideologizzazione della frustrazione non sia, in realtà, un esempio di ideologia, non mette a fuoco l'essenziale. L'ideologia costituisce, da sempre, un complesso sistema di norme condivise da un dato gruppo sociale e che, in quanto tali, hanno un potente valore coattivo per i membri del gruppo. Per misurare la presenza di una narrativa condivisa, di un insieme di valori interiorizzati negli aderenti a tali movimenti, basti prendere come esempio il contenuto tematico ricorrente, verificabile nelle interazioni tra gli utenti delle varie piattaforme social, mentre esprimono la propria posizione su determinate tematiche.
Facendo questo esercizio, si potrà verificare con estrema facilità come funziona, da un punto di vista pratico, la frustrazione, nel momento in cui essa diventa ratio e guida per l'azione. Parole come "perbenismo", "buonismo", "ripulire", "povertà", "carestia", "miseria", "invasione", "questa gente/noi", ricorrono con un'insistenza maniacale, anche in frasi totalmente decontestualizzate. Detto in altri termini, fanno parte di un alfabeto parallelo costruito ad hoc dai membri di tali movimenti. In breve: la parola "ripulire", per esempio, ha raggiunto un tale livello di significatività da essere immediatamente visualizzabile e di grande efficacia.
Nel momento in cui si passa dalla fase della frustrazione alla fase della cyber-lotta per procura, avviene, definitivamente, quella che potrebbe essere denominata "operazionalizzazione della frustrazione", che sancisce il passaggio dalla radicalizzazione cognitiva alla radicalizzazione comportamentale. Si potrebbe obiettare che la radicalizzazione di un movimento anti-sistemico è differente da quella verso il terrorismo, in quanto mentre il primo produce morte e brutalità, il secondo genera, al massimo, odio virtuale.
Chi scrive, al contrario, ritiene che, i fattori che guidano la radicalizzazione cognitiva finalizzata al terrorismo e quelli che operazionalizzano la frustrazione siano gli stessi. Sottolineare una forte soluzione di continuità tra i due fenomeni significa ignorare completamente un concetto fondamentale: le manifestazioni di violenza verbale online, pur non producendo morte, sono atti gravissimi di violenza che potrebbero generare conseguenze irreversibili nelle vittime.
L'operazionalizzazione della frustrazione è un processo multifasico, i cui tratti ricorrenti sono i seguenti: frustrazione, individuazione della causa della stessa, ricetta per curarne gli effetti. Tutto comincia con la descrizione, ovvero la narrazione della frustrazione: "questa gente vuole rubarci il lavoro e imporci di aderire alla loro religione, svilendo i valori fondanti dei nostri antenati".
Poi si passa all'individuazione delle cause della frustrazione: «L'invasione islamica porterà allo stermino di noi cattolici ed ebrei, e se non fermiamo - noi italiani in primis - questa invasione, i nostri futuri figli non avranno neanche un lavoro, una casa, e una famiglia. Se è questo quello che volete buonisti, allora andate a vivere con loro: noi stiamo sia con Trump che con Israele. Israele fa bene a massacrare tutti i musulmani, e Trump fa bene a non fare entrare gli islamici nel suo paese, è ora che impariamo sia da Trump che da Israele».
Infine, si propone la ricetta per curarne gli effetti: «Siamo proprio ben messi, che schifo! Ripulire l'Italia da questa gente che porterà solo miseria e carestia per noi italiani senza contare tutte le malattie che non avevamo più ritorneranno e per causa loro sarà la fine della nostra specie».
I virgolettati appena riportati sono commenti di utenti di movimenti politici anti-sistema, su differenti piattaforme social. Si tratta di un esempio pertinente, utile per capire il funzionamento della radicalizzazione dell'Occidente. Si parte da una narrativa che, denunciando uno stato di pesante frustrazione legato alle condizioni materiali e spirituali del vivere presente, rintraccia nei gangli della società degli elementi patogeni di imperfezione e di impurità, che devono essere estirpati per evitare la «fine della nostra specie». Curioso notare, a questo proposito, che associare il linguaggio della parassitologia a gruppi sociali rivali è stato un tratto storicamente ricorrente in ogni gruppo radicale.
Le emozioni non costituiscono l'azione ma la predispongono
Nonostante i condizionamenti che si impongono agli attori sociali in virtù della coattività del contesto normativo in cui essi sono socializzati, si ritiene che la source delle azioni di un individuo sia da rintracciare nella dimensione psicologica ed emotiva insita nell'essere umano. In parole semplici, tanto in una storia d'amore, quanto nell'attività di un terrorista, di un criminale e di un assassino, agisce una interiorità emotiva capace di condizionarne i comportamenti.
È erroneo, dunque, sottovalutare il ruolo delle emozioni nel definire il cammino di ogni persona. Anche se è fuor di dubbio che le emozioni non costituiscono l'azione, esse hanno, tuttavia, la capacità di predisporla. Questo in virtù della cosiddetta "dimensione motivazionale" delle emozioni, e cioè del loro essere la cinghia di trasmissione in grado di trasferire i contenuti dello spirito alle azioni del corpo.
La radicalizzazione dell'Occidente nei confronti dell'Islam nasce, dunque, nelle innervazioni profonde della psiche collettiva di una certa parte di civiltà occidentale che, non trovando risposte alla necessità di soddisfare bisogni spirituali personali, trova nel "diverso" - musulmani e immigrati in primis - una facile e congeniale valvola di sfogo. Le prime mosse anti-immigrazione della Presidenza Trump costituiscono una estrinsecazione sinistra di tale radicalizzazione.
Tutto ciò produrrà, inevitabilmente, effetti negativi per ciò che concerne la lotta alla radicalizzazione jihadista vera e propria. Come sottolineano gli approcci più recenti nel campo del contrasto al terrorismo, una delle procedure-chiave per combattere la radicalizzazione violenta dell'Islam, consiste nel prevenire la dimensione cognitiva che guida l'intero processo. È imperativo categorico, dunque, che l'Occidente non risponda alla radicalizzazione con la radicalizzazione. Questo, oltre a essere oltraggioso nei confronti di una tradizione di difesa dei diritti tipicamente occidentale, ha pure effetti velleitari - se non addirittura peggiorativi - nella prevenzione della violenza. Nell'informare questo percorso, infine, gli intellettuali hanno una responsabilità imprescindibile.
Postilla
Noi per "radicale" intendiamo qualcosa di diverso: andare alla radice delle cose. Vedi su eddyburg Moderati e radicali secondo Bevilacqua
la Repubblica online, 1 febbraio 2017 (p.s)
Telegramma urgente a tutte le questure: «Rintracciare cittadini nigeriani in posizione irregolare sul territorio nazionale». L'obiettivo è riempire entro febbraio un volo charter per la Nigeria. Per questo, vengono riservati 95 posti nei Cie di Roma, Torino, Brindisi, Caltanissetta. Scatta la stretta sugli irregolari. Il Viminale prova a far ripartire la macchina delle espulsioni: precedenza assoluta ai nigeriani.
Un passo indietro: il complesso meccanismo di contrasto all'immigrazione irregolare, fatto di Cie, accordi bilaterali ed espulsioni è in stallo da tempo. Un sistema imponente che dà miseri frutti: nel 2016 i rimpatri effettivi sono stati meno di 6mila. L'obiettivo è ora raddoppiarli. Per questo, il Viminale annuncia più Cie e nuovi accordi di riammissione con i Paesi d'origine. Su questa linea, si muove l'ultimo telegramma del ministero.
Il telegramma spedito alle questure italiane dalla Direzione centrale dell'immigrazione e della polizia delle frontiere
Condividi Il 26 gennaio 2017 la Direzione centrale dell'immigrazione e della polizia delle frontiere spedisce a tutte le questure italiane un telegramma. Oggetto: «Audizioni e charter Nigeria. Attività di contrasto all'immigrazione clandestina». L'obiettivo è rintracciare nigeriani irregolari per provvedere al loro rapido rimpatrio forzato.
«Al fine di procedere, d'intesa con l'ambasciata della Repubblica federale della Nigeria, alle audizioni a fini identificativi di sedicenti cittadini nigeriani rintracciati in posizione irregolare sul territorio nazionale per il loro successivo rimpatrio, questa direzione ha riservato a decorrere dal 26 gennaio al 18 febbraio 2017 50 posti per donne nel Cie di Roma, 25 per uomini a Torino, 10 a Brindisi, 10 a Caltanissetta». Posti che andranno resi disponibili urgentemente anche tramite dimissioni di altri trattenuti. Le questure «sono invitate a effettuare mirati servizi finalizzati al rintraccio di cittadini nigeriani in posizione illegale sul territorio nazionale».
Per Filippo Miraglia, vicepresidente dell'Arci, «si tratta di un'azione di espulsione collettiva, vietata dalla legge, fatta sulla base della nazionalità, quindi discriminatoria, a prescindere dalle condizioni delle singole persone».
. Souk online, 14 novembre 2016. (m.c.g.)
Troppi morti innocenti nel mare Mediterraneo, troppe vite innocenti respinte, aggredite, umiliate e, infine, "vendute" a una dittatura (tuttavia "alleata") perché non invadano l'Europa delle democrazie. Troppi morti innocenti trucidati in nome di dio. Troppi morti innocenti trucidati in nome della democrazia che vende armi al supermercato. Troppe donne uccise per il solo fatto di essere donne.
L'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati stima che nel 2015, 65.3 milioni di persone erano dislocate dai loro paesi di origine, quasi 6 milioni di piú che l'anno precedente. Di questi 65.3 milioni, 3.2 milioni (ossia meno del 5%) attendono di essere accolti in paesi ad alto reddito. L'Alto Commissario Filippo Grandi scrive: "Un impressionante numero di rifugiati muore ogni anno in mare e quando si trovano in terraferma queste persone che sfuggono la guerra vengono bloccate da confini chiusi. Chiudere le frontiere non risolve il problema". (UNHCR, 2016).
Sembra davvero che il "Male" si radicalizzi a misura in cui la "Speranza" cristiana e la "Utopia" laica si affievoliscono e si perdono schiacciate dalla evidenza e dalla razionalità (presunte evidenza e razionalità) del pragmatismo senza visione della politica e dalla chiusura individualistica in nome della nuova "religione" miope del "well being", della "mindfulness" e di tutte le forme serie e meno serie, solide e meno solide di perseguimento del benessere individuale.
Vi è certamente una emergenza grave e pressante ma non è quella mediatizzata ogni giorno della "invasione" dei rifugiati, dei profughi e dei migranti (evitiamo aggettivi che classifichino i migranti ora come "politici" e dunque da compatire ora come "economici" e dunque da temere). Ció che deve fare riflettere è che una entità politica (l'Unione Europea) di 500 milioni di abitanti definisca emergenza l'arrivo di una popolazione che rappresenta meno dell' 1% della propria popolazione: si è deciso di chiamare emergenza la propria intolleranza, il proprio egoismo e soprattutto la propria cecità di fronte alla drammatica crisi demografica europea che beneficierebbe di una iniezione di immigrazione massiccia. Malgrado dunque la pressione mediatica, non è il caso di parlare di "emergenza migranti" per i paesi europei. Semmai i migranti stessi sono esposti a una emergenza che è quella di dovere fuggire e trovare paesi che li accolgano.
La vera emergenza occidentale, grave e pressante e da contrastare è quella della rinuncia alla Utopia quando, invece, contro la radicalità del male dovremmo dare vita e forza alla radicalità del bene, della utopia del bene, della speranza del bene, dell'operare per il bene. Con la troppo entusiasticamente celebrata "morte delle ideologie" (che hanno giustificato pensieri unici e totalitari ma che hanno anche prodotto sogni e speranze e visioni di società) siamo rimasti senza sogni e speranze ma non ci siano disfatti dei pensieri unici e totalitari che non sono piú sorretti da weltanshaung del bene (anche se subito tradite, è vero) ma piuttosto da deliri mortiferi (Palingenesi Islamiche che si scontrano con Identità Nazionali Xenofobe)
A partire dagli anni di piombo ci hanno inculcato (e troppo volentieri abbiamo accettato) che fra utopia e realtà c'è da fare un grande compromesso, che dobbiamo mediare fra i sogni del buono, del vero e del bello e la pratica quotidiana della realtà, pena l'infantilismo politico e individuale. Questo sembra ragionevole e certamente lo è. Tuttavia, dobiamo discutere e decidere quale sia la "misura" accettabile della mediazione; quale sia la quota di verità a cui rinunciare, quale sia la quota di bene da ritenere procrastinabile e quale quella di male da ritenere accettabile: questa è la questione politica e privata che ci si pone sempre piú pressante.
Negoziazione e Mediazione hanno fornito prove brillanti in un passato recente e basti pensare alla Commissione del perdono istituita in Sud Africa alla fine dell'apartheid. Ma anche prove disastrose e basti pensare ai fallimenti ripetuti e irreversibili del dialogo Palestinese-Israeliano. Gli operatori di pace, riconciliazione e perdono ritengono che la mediazione sia la unica strada possibile e umana affinché realtà e speranza si incontrino a mezza strada ma, e ancora una volta va ripetuto, c'è da decidere chi stabilisce quale sia la mezza strada e questo vale sia quando sono gruppi, popoli e nazioni a parlarsi sia quando la questione si presenta in forme individuali e talvolta intime: quale è la "mia misura" accettabile di mediazione?
Dunque, è necessario creare Laboratori di Mediazione per potere definire nuove forme piú efficaci di Mediazione? Oppure, a fronte della radicalità del male dobbiamo forse rinunciare all'ottimismo della mediazione e ri-pensare il Conflitto come unica risposta? Non vi è dubbio tuttavia che il Conflitto nelle sue forme tradizionali è fallito: gli anni di piombo hanno mostrato che il conflitto armato poteva solamente generare morte e banalizzare la morte. Ma anche nelle sue forme tradizionali non violente (lo sciopero, la manifestazione di piazza) il Conflitto non si declina piú con sufficiente efficacia e, non a caso, viene rapidamente reso inefficace dalla violenza degli ambigui "black bloc" che servono interessi spesso estranei alle buone ragioni del conflitto. Dunque laboratori di ricerca di nuove forme di Mediazione o di nuove forme di Conflitto?
C'è da chiedersi se il ripensamento non debba essere radicale e la ricerca debba volgersi al medesimo tempo verso nuove forme di conflitto e verso nuove forme di mediazione. Infatti, non c'è conflitto efficace che non abbia
in sè i germi della mediazione e non c'è mediazione autentica che non abbia in sè l'ipotesi della ripresa del conflitto: se non fosse cosí il conflitto sarebbe cieco e distruttivo e la mediazione troppo pragmatica e arrendevole. Il Conflitto efficace si nutre di speranza, di utopie, di weltanshaung, di ipotesi di società e solo se cosí nutrito avrà la capacità di confliggere, di resistere e anche di mediare.
Se riflettere e cercare queste nuove forme di conflitto-mediazione è la vera urgenza che ci attraversa in questi tempi di violenza e di perdità di umanità, questa ricerca ci deve attrezzare fino da ora a leggere e agire la pseudo-urgenza dei migranti. La pseudo urgenza dei migranti va decostruita, destrutturata, negata, deistituzionalizzata
Innanzitutto si deve chiarire una volta per tutte che la emergenza cui sono esposti i migranti esiste ed è reale e drammatica mentre la emergenza rappresentata dall'arrivo dei migranti e che colpirebbe i paesi di accoglienza non esiste.
Infatti, secondo la definizione dell'Alto Commissariato ONU per i Rifugiati (UNHCR) una emergenza per rifugiati è quella situazione in cui la vita e il benessere dei rifugiati è minacciata se non si prendono misure immediate e eccezionali (UNHCR 2007). Dunque non vi è alcun dubbio che i rifugiati e i migranti in generale sono esposti a una emergenza.
Ma che dire della emergenza cui si dicono esposti i paesi di accoglienza (o presunta accoglienza)? Una emergenza è un evento totalmente inaspettato, relativamente raro, di durata relativamente definita: il massicccio arrivo di migranti da paesi in guerra ove i piú basilari diritti sono assenti e le condizioni di vita materiale sono al di sotto di ogni soglia di tollerabilità non era inaspettato ma anzi era prevedibile; il fenomento della migrazione verso l'Europa è da tempo frequente, inarrestabile e destinato a durare.
Dunque, di tutto si puó parlare fuorchè una emergenza per i paesi che dovrebbero accogliere i migranti. Se una emergenza si definisce come un incidente che pone una minaccia immediata alla vita, la salute, la proprietà o l'ambiente , i paesi europei non possono dirsi esposti a queste minacce e dunque non possono definire emergenza quella rappresentata dai migranti (loro sí esposti a una emergenza che minaccia le loro vite e il loro benessere).
Ma allora cui prodest definire emergenza ció che emergenza non è?
I "benefici" di un regime di emergenza sono numerosi anche se ambigui, cinici, ingiusti.
Inanzitutto una emergenza in quanto eccezionale e inaspettata esime i governi nazionali e locali dall'assumere la questione dei migranti cone "sistemica" e come tale da gestire come fenomeno "normale" che richiede politiche, interventi sistemici, di largo respiro, di durata indeterminata e assimilabili agli interventi per tutti i cittadini vunerabili. Si tratta di una differenza non da poco: si tratta infatti di abbandonare la cultura del "materasso e della tazza di brodo" e assumere la cultura dell'intervento strutturale che garantisca diritti, salute, abitazione e educazione.
Il regime di emergenza facilita la creazione di stati di allarme, panico, disinformazione, isteria collettiva ("invasioni di migranti", "minaccia per i posti di lavoro nazionali", "pericoli di epidemie", "rischio di violenze sulle donne", "rischio terrorismo", "attentati alla identità etnica, religiosa e culturale nazionale"). Queste paranoie sociali sono alimentate dalle crescenti formazioni xenofobe che fondano la propria propaganda efficace sulla disinformazione sistematica e sulla intolleranza (in Italia la Lega, in Francia il Front National, nel Regno Unito il movimento di Farage, in Austria, Ungheria, Polonia i movimenti neofascisti xenofobi). Questi movimenti di "chiamata all'odio" fondano il loro successo sul regime di emergenza.
La disinformazione sistematica sulle conseguenze della emergenza migranti occulta "altre" verità e "altre" informazioni vere e scomode: la disoccupazione nazionale non è causata dai migranti ma dal crollo degli investimenti nazionali, dalle delocalizzazioni industriali e dal restringimento del mercato del lavoro; le grande maggioranza delle violenze sulle donne è perpetrata in famiglie nazionali da coniugi "nazionali"; il terrorismo non si serve dei migranti ma di cittadini di non recente immigrazione; gli unici veri rischi epidemici non dipendono dai migranti ma sono legati alla propaganda criminale contro le vaccinazioni ecc...
Infine, il regime di emergenza favorisce il business della emergenza; convenzioni e rette per capita rappresentano un giro di affari importante che alimenta molte organizzazioni non governamentali con e senza fini di lucro. Inoltre vi è un effetto economico indiretto legato alla formazione che rappresenta un altro business significativo anche se non viene mai sottoposto a verifiche e valutazioni di efficacia: formare per formare senza mai sapere quali effetti virtuosi abbia potuto avere la formazione.
Dunque, è urgente decostruire il paradigma della emergenza, smascherarne le ambiguità e reticenze. E' urgente "dire la verità". Ancora, l'Alto Commisario scrive: "La battaglia dell' Europa per gestire i poco piú di un milione di migranti e rifugiati arrivati attraverso il Mediterraneo ha dominato l'attenzione di tutti i media nel 2015 ma in realtà la maggiorparte dei rifugiati di tutto il mondo stanno altrove. In totale l'86% dei rifugiati sotto il mandato del UNHCR nel 2015 si trovavano in paesi a medio e basso reddito....la Turchia è stato il paese di maggiore accoglienza con 2,5 milioni di rifugiati; il Libano ha accolto il maggiore numero di rifugiati in proprozione alla propria popolazione nazionale: 183 rifugiati ogni 1000 abitanti..." (UNHCR, 2016).
E' necessario attrezzarsi con i saperi e le pratiche del conflitto e della mediazione. Essere capaci di andare allo scontro diretto, duro e aggressivo per denunciare la sistematica disinformazione, per mostrare i dati statistici reali e non quelli mediatico-emozionali, per denunciare gli abusi e le violazioni delle leggi nazionali e internazionali, per pretendere giustizia, salute, educazione, integrazione. Andare allo scontro duro ma anche essere pronti alla mediazione tecnica insieme a tutti quei giuristi, medici, economisti di buona volontà disponibili a costituire un esercito tanto determinato nel conflitto quanto astuto nella mediazione.
Scrive Virginio Colmegna nell'articolo intitolato "Indignarsi" e pubblicato su questo stesso numero di Souq: "Per questo mi chiedo: come contribuire a liberare l'umanità, la terra da questa morsa? Non si può realizzare questo solo raccontando un altro mondo, un'altra ideologia spesso retorica, ma è ancor più urgente e possibile stare dentro alle esperienze concrete di lotte,di condivisione per l'uguaglianza e inclusione. Va vissuta sul campo questa speranza straordinaria di cambiamento di novità, di utopia. Certamente è un cammino lungo e faticoso che forse riuscirà solo a passare da condizione di minore giustizia a condizione di maggiore giustizia, a uno sforzo di inclusione maggiore.E' questa l’unica ma esigente possibilità e responsabilità: stare nel mezzo di iniziative locali,di comunità territoriali,di laboratori operosi che testimoniano che si può e si deve non rassegnarsi."
Qui è detto tutto di questa sfida a coniugare conflitto e mediazione, scontro e ricerca di soluzioni.
In questa prospettiva dello "stare nel mezzo", per ancora citare Colmegna, Souq sta nel mezzo e il 6 marzo 2017 organizza una giornata a Milano in Università Statale per riflettere su questi temi invitando i protagonisti delle esperienze coraggiose e radicali della accoglienza ma anche le voci autorevoli delle istituzioni locali, nazionali e internazionali: l'alto Commissario delle Nazioni Unite per i Rifugiati (UNHCR) Filippo Grandi ha accettato di tenere in quella occasione una Conferenza Magistrale.
Bibliografia
- UNHCR Handbook for Emergencies. United Nations High Commissioner for Refugees, Geneva, Third Edition February, 2007.
- UNHCR Press Release 20 June 2016. United Nations High Commissioner for Refugees, Geneva Decostruire il paradigma della "emergenza migranti"
Riferimenti
L’autore, Benedetto Saraceno - psichiatra che si è formato a Trieste con Franco Basaglia e Franco Rotelli e che è stato per 12 anni il Direttore del Programma di Salute Mentale della Organizzazione Mondiale della Sanità a Ginevra – è Direttore scientifico della rivista online Souk Quaderni pubblicata dal ‘Centro Studi sulla sofferenza urbana’ che è parte integrante delle attività della Casa della Carità presieduta da Don Virginio Colmegna. Il centro studi promuove e presenta reti e connessioni con le grandi città del mondo che vivono situazioni simili, contesti analoghi di urbanizzazione e quindi di marginalizzazione e di nuove povertà. (m.c.g.)
Una delle tante inadempienze del governo italiano in materia di accoglienza. Il testo integrale dell'intervento di Barbara Spinelli, eletta nella lista "L'Altra Europa con Tsipras". barbara-spinelli.it, 30 gennaio 2017
Accolgo positivamente – ha dichiarato l’eurodeputata del gruppo GUE/NGL – il rapporto del gruppo di esperti anti-tratta incaricato dal Consiglio d’Europa di monitorare l’attuazione della Convenzione sulla lotta contro la tratta degli esseri umani nel nostro Paese. Benché l’Italia abbia ratificato la Convenzione, permangono gravi lacune e violazioni verificate dal GRETA durante una visita effettuata a settembre dello scorso anno negli hotspot e nei centri di accoglienza.
Il procedimento d’urgenza avviato nel 2016 sull’Italia ha messo in luce preoccupanti falle nell’accoglienza, nella detenzione e nel rimpatrio delle vittime di tratta e una grave situazione di incuria nei riguardi dei minori non accompagnati. Oltre che alle denunce delle Ong che con competenza e determinazione si occupano di vittime di tratta e minori non accompagnati, la visita ha fatto seguito a una mia lettera inviata a Frontex, al Ministero dell’Interno italiano e per conoscenza all’Ombudsman il 14 ottobre 2015, e a un’interrogazione scritta alla Commissione europea del 10 novembre 2015, in cui criticavo il rimpatrio forzato di venti donne nigeriane dal CIE romano di Ponte Galeria, e a un’interrogazione
scritta alla Commissione europea del 13 maggio 2015 in cui denunciavo l’uso del manganello elettrico nel CPA di Pozzallo per il rilascio forzato delle impronte, anche di minori.
Entrambe le denunce sono state possibili grazie a una stretta collaborazione con attivisti e associazioni della società civile, tra cui BeFree, Terre des Hommes, Campagna Lasciatecientrare e Clinica legale dell’Università Roma3.
Unendomi alla richiesta del Consiglio d’Europa affinché il governo italiano metta al più presto in atto le misure necessarie per proteggere adeguatamente i migranti e i rifugiati in balia dei trafficanti di esseri umani e agisca con determinazione per combattere il fenomeno della tratta in Italia, auspico che la collaborazione tra rappresentanti della società civile e istituzioni – che ha prodotto questo importante risultato – venga sostenuta e incoraggiata nelle democrazie dell’Unione come un elemento chiave per la tutela dei diritti, anziché subire crescenti e preoccupanti limitazioni.
L'Espresso online, 31 gennaio 2017 (p.s.)
Non c’è solo l’Italia delle barricate. C’è anche un’Italia di persone che si autotassano per ospitare una famiglia di profughi. Succede a Coriano, un comune di poco più di 10mila anime in provincia di Rimini, dove cento famiglie hanno deciso di versare quindici euro al mese, per un anno, per ospitare una coppia di siriani con tre bambini. Sono atterrati ieri a Fiumicino, facevano parte dei quaranta profughi arrivati con il corridoio umanitario, e ieri sera sono arrivati a Coriano. La loro nuova casa è in fase di preparazione, questione di qualche giorno. L’accoglienza che hanno ricevuto è quella riservata agli ospiti più desiderati.
Hanno potuto trascorrere forse la prima notte serena dopo tre anni di incubi. L’uomo ha passato un anno in un carcere del regime siriano, dove è stato torturato e seviziato, dopo che gli sono state uccise la moglie e la sorella. E’ riuscito a liberarsi pagando una cauzione da tremila euro e a raggiungere quindi il campo profughi al confine con il Libano, dove ha conosciuto la nuova compagna. Qui sono stati avviati i primi contatti con la Comunità Papa Giovanni XXIII che si è impegnata per portarli fuori da quell’inferno. In particolare a farsi avanti è stata una coppia, Massimiliano Zannoni e Gilda Pratelli, dopo il ritorno dal campo profughi libanese. Hanno raccontato quanto visto ai concittadini convincendoli quindi in questa insolita gara di solidarietà. Partendo da sindaco e parroco. Servivano almeno 18mila euro per garantire il viaggio e il nuovo alloggio: quindici euro a famiglia.
«All’inizio non è stato per nulla facile, non ci seguiva praticamente nessuno», racconta Massimiliano Zannoni. «Più le persone si rendevano conto dell’importanza dell’obiettivo e della concretezza di questo sostegno più si facevano avanti. Siamo quindi riusciti a mettere insieme un centinaio di famiglie praticamente contattandole una a una. E’ stata un’operazione fatta da cittadini con i cittadini».
A chi li critica perché “con quei soldi si poteva aiutare una famiglia italiana”, Zannoni risponde deciso: «Io aiuto chi mi trovo davanti, a prescindere da chi sia, che religione segua o a quale nazione appartenga. Inoltre chiedo a queste persone che si lamentano che cosa fanno loro per i bisognosi, italiani o stranieri che siano?». Accogliere ieri quella famiglia è stata già una enorme ricompensa a tutti gli sforzi fatti. «Non trovo le parole per descrivere quel momento. Per loro è cominciata una nuova vita che non speravano più di poter vivere. Ed è anche per noi è stata una forte emozione».
«E’ nato tutto dai racconti di alcuni ragazzi che, nell’ambito dell’operazione Colomba, avevano visitato negli anni scorsi alcuni campi profughi in Libano», spiegano dalla Comunità Papa Giovanni. «Massimiliano e Gilda hanno voluto fare la propria parte in modo diretto per aiutare queste persone che sono tra l’altro quelle più povere perché non possono permettersi nemmeno quei viaggi della speranza che spesso conducono alla morte in mare. Ovviamente questa famiglia non sarà solo ospitata ma lavoreremo per una sua piena integrazione nella città».
La città invisibile online, n. 56 26 gennaio 2017 (c.m.c.)
Il quotidiano trattamento da “dannati della terra” riservato a bambini, donne e uomini in fuga da disastri sociali e ambientali, rende manifesta la strategia securitaria cui in Italia è stata ridotta la politica dell’accoglienza.
Una civile e lungimirante politica dell’accoglienza non può relegare i profughi dello sviluppo nelle inqualificabili macrostrutture: CIE (Centri di Identificazione e di Espulsione) o CPA (Centri di Prima Accoglienza). Il “popolo nuovo” ha invece bisogno di case e diritti, lavoro, uguaglianza e cittadinanza. Di ospitalità diffusa e capillare, come già messa in pratica in alcune, isolate, realtà peninsulari.
A fuggiaschi, clandestini per legge e rifugiati politici devono essere destinati alloggi dignitosi nel cuore delle città e dei centri minori. Non ricoveri provvisori nelle estreme periferie, non ghetti, non soluzioni securitarie.
Nelle città italiane abbondano edifici vuoti, privati ma più spesso pubblici, non raramente di valore monumentale, in attesa di essere venduti a faccendieri e multinazionali. Edifici che in tal modo, da bene comune, diventano oggetto di speculazione immobiliare e la cui trasformazione, il più delle volte in residenze e alberghi di lusso, contribuisce a desertificare le città e i centri storici. Città che mancano invece di luoghi di socialità, di aggregazione e di cura e che necessitano di essere ripopolati.
Per attrarre nuovi abitanti, in una nazione dal tasso di natalità assai basso, la città può rispolverare le virtù civiche dell’accoglienza attingendo a una plurisecolare tradizione ospitale. Una hospitalitas rivolta ai bisognosi di ogni provenienza e fede.
Molti edifici pubblici (alcuni nati proprio in funzione dell’accoglienza) si trovano ora in stato di abbandono e potrebbero essere riabilitati allo scopo. Caserme, ospedali, ex conventi, scuole etc., costituiscono un imponente «vuoto pubblico nazionale». Cui si aggiunge il patrimonio edilizio privato, per il quale non va sottovalutata la possibilità, specie da parte dei Comuni, di formulare protocolli speciali con i proprietari disponibili; laddove invece la proprietà è rappresentata da persone non fisiche – spesso immobiliari a scopo di lucro – che tengono fuori dal mercato sociale milioni di appartamenti, vanno ricercati gli idonei strumenti coercitivi: dalla tassazione progressiva sul vuoto inutilizzato fino alla requisizione per pubblica utilità.
Su questo monumento allo spreco sociale, economico e ambientale, gli enti potrebbero far leva per trasformare l’accoglienza in una delle componenti fondamentali delle azioni, non solo abitative, ma anche di rinascita di qualità civile e ambientale delle città.
La presenza di nuova popolazione può infatti favorire la ricostituzione del tessuto socio-culturale urbano e rurale, oggi slabbrato. Di più, i migranti possono essere gli attori principali di nuove occasioni lavorative, nella cura e nel recupero degli ambienti di vita, soprattutto nei centri abbandonati che, come già avviene in alcuni contesti meridionali, vivono una nuova stagione di sostenibilità sociale legata all’agrorurale e al turismo socioculturale.
A tale riguardo, sarebbe auspicabile affidare ai migranti interessati ruoli più “strutturali” per rivitalizzare attività utili all’economia locale, specie nelle aree interne e abbandonate dell’arco alpino e dell’«osso appenninico», che costituiscono la parte preponderante del territorio italiano. Queste aree, che il dramma dei terremoti nell’Appennino dell’Italia centrale ha evidenziato nella loro struttura di un fittissimo reticolo insediativo di piccole città, borghi, frazioni, e che costituisce un patrimonio estesissimo e unico in Europa, possono diventare, con l’aiuto dei migranti, i luoghi di una nuova civilizzazione collinare e montana, di un ripopolamento urbano e rurale agro-ecologico in grado di curare le urbanizzazioni malate delle aree metropolitane di pianura.
Iniziative di livello e responsabilità pubblica municipale, di lungo termine, conformi ai tempi della pianificazione e non a quelli dell’emergenza, potrebbero esaltare la vocazione delle città, dei piccoli centri, dei borghi e delle loro campagne come luoghi in cui si intrecciano storie e nascono nuove identità perché esse sono plurimondi di vita. Luoghi dello stare insieme, della convivenza, della solidarietà. Luoghi da cui ripartire per costruire un tessuto sociale in cui si riconoscano e crescano le generazioni future.
Riferimenti
Sull'argomento vedi su eddyburg le cartelle EsodoXXI e Accoglienza Italia
 Un terrificane episodio, che nell'atto più disperato di una vita e nell'indifferenza che lo circonda riassume tutta la corale ignominia che caratterizza la "accoglienza" in questa parte del pianeta.
Un terrificane episodio, che nell'atto più disperato di una vita e nell'indifferenza che lo circonda riassume tutta la corale ignominia che caratterizza la "accoglienza" in questa parte del pianeta.
Il Fatto quotidiano, blog di Daniela Padoan, 26 gennaio 2017
Lui, che era giunto per mare attraverso il Canale di Sicilia – la rotta più pericolosa del mondo, dove solo nei primi quindici giorni del 2017 sono morte annegate 240 persone – ha terminato la sua breve vita annegando nello scenario della nostra più sublime bellezza, nella stratificazione perfetta della nostra storia e cultura, domenica, in mezzo ai turisti che lo filmavano dal Ponte degli Scalzi.
La scena, ripresa da un cellulare, è stata condivisa sui social e pubblicata dal Gazzettino.it. Nel video si vede il ragazzo annegare mentre il vaporetto gli passa a pochi metri. Si sentono voci agitate, ma non disperate. Gente che grida, gente che ride, una voce dice: “Questo è scemo!”. Un’altra: “Africa!”. Nessuno si lancia a salvarlo. I soccorsi arrivano quando ormai la corrente ha trascinato il corpo dall’altra parte del canale.
Quando due anni fa era sbarcato in Sicilia, a Pozzallo, Pateh non sapeva nemmeno il giorno della sua nascita. In questi casi, nei cosiddetti hotspot imposti dall’Agenda sulla migrazione dell’Unione europea, la polizia attribuisce un’età convenzionale: il primo gennaio. Così Pateh, sul permesso umanitario ritrovato nel suo zaino, risultava essere nato il primo gennaio 1995.
Non sappiamo cosa facesse a Milano, solo che era stato trasferito lì in via temporanea, perso in un limbo che non accoglie ma imprigiona nelle reti del regolamento di Dublino e dell’attesa dei permessi di soggiorno. Era arrivato a Venezia il pomeriggio del giorno prima, chissà come aveva passato quelle 24 ore, probabilmente girovagando fino al pomeriggio di domenica. Pare gli fosse stato revocato il permesso di soggiorno per motivi umanitari.
La sua morte pubblica e muta torna in mente come una scena fantasmatica, oggi che la Commissione europea ha finalmente scoperto le carte, mostrando quel che intendeva ottenere già da tempo con l’addestramento della cosiddetta Guardia costiera libica: accordarsi con la Libia (ma quale Libia: quella di Tripoli, dove l’apertura dell’ambasciata italiana ha quasi causato un colpo di Stato? Quella dell’ultimo rapporto dell’Onu che parla di schiavitù, torture, abusi sessuali nei campi? Quella delle denunce di traffico degli organi?) per “salvare le vite dei migranti”. Con eufemismo grottesco, non fosse che tutti sembrano prenderlo sul serio, si pretende di voler salvare i migranti dai “trafficanti di uomini”, ributtandoli nella situazione dalla quale erano scampati, talvolta dopo una prigionia durata anche uno o due anni e fatta di violenza, come dimostrato dalla recente inchiesta milanese sul torturatore somalo Osman Matammud.
Pateh è un’immagine, uno specchio che ci viene messo davanti nel giorno in cui Trump ordina l’innalzamento del muro con il Messico e l’Europa si prepara, nel prossimo vertice dei capi di governo che si terrà a Malta il 3 febbraio, a distruggere la Convenzione di Ginevra e il diritto d’asilo, affidando a terzi il respingimento collettivo, senza che nessuno protesti, seguendo la direzione già tracciata dal governo Renzi durante il semestre di presidenza europea, e ora dal governo Gentiloni e dal suo ministro Minniti.
L’Europa ha dichiarato guerra ai migranti. Noi guardiamo dicendo “Africa!”. La Procura di Venezia ha aperto un’inchiesta. Ma contro chi, davvero, dovrebbe essere aperta?
 Ancora, e di nuovo, via i poveri dal centro cittadino, in nome del "decoro", e della sfrenata tendenza a illudersi che il mondo sia come lo descrive la propaganda commerciale.
Ancora, e di nuovo, via i poveri dal centro cittadino, in nome del "decoro", e della sfrenata tendenza a illudersi che il mondo sia come lo descrive la propaganda commerciale.
la Nuova Venezia, 20 gennaio 2017, con postilla
«Ci dispiace molto per coloro e sono tanti che non c’entrano nulla con questi episodi e si comportano bene e che vengono pure loro disturbati da queste situazioni. Tanto che quando ho annunciato la chiusura, sono stati alquanto comprensivi», ci spiega Bozzi. «Per questo da lunedì con la riapertura saremo impegnati in una riformulazione delle procedure di accesso e di rilascio delle tessere. Certi comportamenti, dovuti all’alcool che non si consuma all’interno della mensa e che non può neanche essere portato dall’esterno», continua a spiegare il responsabile di Ca’ Letizia che si augura che da lunedì arrivi un ulteriore aiuto del Comune, magari attraverso una maggiore presenza in strada e di fronte alla struttura delle pattuglie della polizia locale, per tenere fuori le persone moleste.
È utile ricordare che le mense dei poveri sono un servizio reso a persone “difficili” perché la loro situazione è difficile. La mensa dei poveri non è un self service per dipendenti comunali, e per definizione è un servizio sociale che deve dar da mangiare a persone con le difficoltà più svariate, dall’ubriaco al tossico, allo schizzato. Ahimè spesso i poveri, proprio perché sono poveri, non sono persone sempre gentile con sorriso sulle labbra, che accettano mestamente tutto quello che gli viene ordinato.

«controradio online,
La proposta dei sindaci della Città metropolitana ai 90 somali che occupavano il capannone-rifugio a Sesto Fiorentino dove dieci giorni fa in un incendio è morto il loro connazionale Alì Muse Mohamud, 44 anni, resta la stessa prospettata subito dopo il rogo: sì all’ospitalità, «suddivisi in gruppi nei vari comuni, per tre mesi. L’idea che devono stare tutti insieme in una struttura è una proposta irricevibile».
Lo ha detto il sindaco della Città metropolitana Dario Nardella al termine di un tavolo tecnico convocato dal prefetto Alessio Giuffrida, dopo l’occupazione da parte dei somali stessi di un edificio di proprietà dei Gesuiti in via Spaventa a Firenze.
«La differenza della proposta, rispetto a quella presentata pochi giorni fa, sta nel fatto che questa arriva da un tavolo al quale tutti i comuni erano presenti, con il supporto del prefetto che ringrazio – ha proseguito Nardella -. Tutti sono disponibili ad ospitare alcuni di loro, ma occorre rispettare le regole e tutto deve avvenire in piena legalità: nessuno può pensare di occupare perchè noi non facciamo disparità e sarebbe ingiusto, per tutti gli italiani e gli altri migranti che aspettano una casa ma non per questo occupano, un trattamento diverso. Ci aspettiamo da loro il rispetto delle regole».
Un riferimento esplicito al fatto che dopo il rogo il gruppo rifiutò la proposta di una suddivisione chiedendo una soluzione definitiva comune per tutti. Al rifiuto degli enti locali i somali, in gran parte richiedenti asilo o già da tempo in Italia con lo status di profughi, insieme al Movimento di lotta per la casa ha occupato tre giorni fa l’edificio dei Gesuiti.
Il sindaco Nardella ha quindi spiegato che entro martedì tutti i Comuni presenteranno la loro proposta. «E’ importante – ha detto – anche il fatto che questa volta ci sia un impegno concreto della Regione Toscana che si è dichiarata disponibile a dare un contributo economico ai Comuni e ha messo a disposizione tre moduli, tre casette, per un totale di 20 posti».
A proposito dell’eventuale sgombero dell’edificio di via Spaventa, sia Nardella sia il prefetto hanno ricordato che deve esserci una denuncia da parte della proprietà, cioè della Compagnia di Gesù: lo stabile è in vendita ormai da tempo. Per il momento i gesuiti sembrano voler tentare la via del dialogo con gli occupanti anche se per il sindaco della Città metropolitana la proposta di una suddivisione dei 90 ospiti in tutti i comuni dell’area dovrebbe essere una risposta che favorisce pure i gesuiti.
«Nessun comune potrebbe ospitarli tutti insieme e, tanto meno, farlo all’infinito. Qual è la situazione dell’emergenza casa – ha concluso il primo cittadino – credo sia abbastanza evidente a tutti».
postilla
Forse quei sindaci pensano di essere accoglienti e "umanitari", ma sembra – da quanto si comprende – che sfugga loro la comprensione di un aspetto decisivo per affrontare con decenza e civiltà problemi di questo genere. In quel capannone si è formata una comunità di molte decine di persone, fuggite dagli inferni che non da loro sono stati creati; persone che hanno trovato approdo precario in una regione sconosciuta. La loro unica forza è negli elementi della loro identtà di somali costretti alla fuga, nello stare insieme, in nome e in ragione delle loro comuni origini e destini. Con questa comunità occorre trattare, magari suddividendoli in nuclei ma concordando con loro le soluzioni possibili. Insomma, bisogna trattarli come persone, non biglie. E persone dotate di legami, più o meno profonde, con altre dello stesso insieme.
Il razzismo dei "non siamo razzisti". «La rivolta dei genitori forza la decisione dell’Asd Pegolotte. La motivazione è per ragioni di igiene e sanità pubblica».
la Nuova Venezia, 20 gennaio 2017
CONETTA. «Per ovvie ragioni di igiene e sanità pubblica, è stato sospeso l’accesso a questo impianto sportivo a tutte le persone accolte nel campo base di Cona che sono in attesa di essere sottoposte ai previsti controlli sanitari e vaccinazioni».
L’avviso è stato affisso lunedì per decisione della società Asd Pegolotte, ai muri degli spogliatoi dello stadio “don Mario Zanin” su richiesta dei genitori dei bambini, i quali hanno minacciato la società di ritirare i loro figli se i profughi avessero usato gli impianti, per paura di contagi.
L’Asd sostiene di non aver avuto scelta. Due notti prima un ragazzo bengalese di 19 anni, ospitato a Conetta, era finito in ospedale per sospetta meningite. Una diagnosi che, nelle ore successive, era stata precisata come encefalite virale non contagiosa. La disposizione è ineccepibile ma l’effetto è andato oltre il contenuto letterale.
Adesso due giovani profughi, tesserati con il Pegolotte, non possono più giocare nella squadra e un’altra squadra, il Campo Cona (interamente formata da profughi), una ventina, che milita in un campionato amatoriale, non può più giocare in quello stadio che, prima, era quello “di casa”. Nessuno di questi giocatori è malato. Sono tutti in regola con le vaccinazioni.
Si interrompe così un’esperienza di integrazione che dura quasi da un anno e mezzo, da poco dopo, cioè, l’arrivo dei primi profughi al campo di Conetta. In quei giorni, chi visitava, incuriosito, la ex base militare, poteva vedere spesso i giovani profughi giocare a pallone negli spazi verdi attorno alla caserma.
Ma qualcuno di loro faceva di più: andava a vedere gli allenamenti delle squadre locali, fino a Codevigo, in bicicletta, andata e ritorno, con qualsiasi condizione atmosferica. A notarli è stato un padovano, Gino Mez, con la passione del calcio che, una serata di pioggia, li ha caricati in macchina e riaccompagnati al campo.
Da lì è nato un rapporto e un lavorio di contatti, che ha permesso a sei giovani profughi di tesserarsi con il Pegolotte e ad altri 25 di dare vita alla squadra amatoriale. Percorsi diversi giunti alla stessa meta: praticare uno sport e farlo, da pari a pari, con i giovani italiani, compagni o avversari.
I trasferimenti in altri campi hanno ridotto gli organici: da 25 a 21 per il Campo Cona e da 6 a 3 per gli altri, uno dei quali è in infortunio, per un piede rotto, e non finirà il campionato. Gli altri due, invece, hanno giocato fino a domenica, in campo con i ragazzi italiani del Pegolotte. Ma da lunedì è tutto finito.

Nell'accoglienza degli sfrattati dello sviluppo gli egoismi e le paure fomentate dai neonazisti sembrano dominare in Italia. Ma non mancano le luci. Vogliamo dar evidenza a entrambi, nella cartella di Accoglienza Italia
 Naturalmente il Veneto è all'avanguardia nell'applicazione delle decisioni dell'onnipotente Minniti, quella procedura neonazista che vede il passaggio dai campi di concentramento (CIE) al lavoro coatto.
Naturalmente il Veneto è all'avanguardia nell'applicazione delle decisioni dell'onnipotente Minniti, quella procedura neonazista che vede il passaggio dai campi di concentramento (CIE) al lavoro coatto.
La Nuova Venezia, 18 gennaio 2017
Venezia. Sono dieci i comuni del Veneziano che da quando sono arrivati i profughi nella nostro provincia, hanno firmato un protocollo con la Prefettura per impegnare queste persone in lavori socialmente utili. Si tratta di impegno su base volontaria e che sta dando dei buoni frutti sia rispetto all’impatto con le comunità che li ospitano, sia nel rendere meno oziosa la permanenza dei richiedenti asilo. I comuni che hanno un programma di inserimento con la disponibilità dei migranti sono: Annone Veneto, Salzano, Mira, Mirano, Fiesso, Dolo, San Donà di Piave, Cona, Cavallino e Stra.
Riferimenti
Vedi su eddyburg gli articoli raccolti sotto il titolo "Campi di concentramento e lavoro obbligatorio. Per il governo il futuro ha un odore antico" e la relativa postilla
il blog di GuidoViale, 15 gennaio 2017 (c.m.c.)
Fermare il flusso dei profughi che vogliono raggiungere l’Europa dall’Africa e dal Medioriente è impossibile. E’ un fenomeno che durerà decenni. Forse è possibile contenerlo e renderlo in parte reversibile. Ma questo significa aggredirne le cause: guerre, deterioramento ambientale provocato dai cambiamenti climatici e dalla rapina delle risorse locali, miseria e sfruttamento delle popolazioni.
Ci vogliono molte più risorse di quelle che l’Unione europea è disposta a sborsare per indurre gli Stati di origine o di transito dei profughi a trattenerli o a riprenderseli. Ma i soldi sono il meno. Ci vogliono programmi di pacificazione e riqualificazione di quei territori: porre fine alla vendita di armi e bloccare interventi e progetti che devastano territori e comunità. L’opposto di quanto proposto da Renzi con il migration compact: un documento che le armi non le nomina nemmeno, mentre ne prosegue a pieno ritmo la vendita. Ma che vorrebbe affidare la rinascita di quei paesi alle multinazionali che li devastano: le due che nomina sono Eni ed Edf, la società petrolifera italiana responsabile dello scempio nel delta del Niger e la società elettrica francese che alimenta le sue 56 centrali nucleari con l’uranio estratto schiavizzando il Niger.
Ma c’è un problema ancora più a monte: chi può promuovere la pacificazione del proprio paese e la riqualificazione del suo territorio? Non certo le popolazioni rimaste là: se ne avessero la capacità e la forza lo avrebbero già fatto. Meno che mai le potenze che guerre e devastazioni le stanno alimentando.
Le forze che possono promuovere iniziative del genere sono le comunità migranti già insediate da noi e i tanti profughi che sono riusciti a varcare i confini della “fortezza Europa”. Molti di loro, soprattutto coloro che sono fuggiti da una guerra, vorrebbero fare ritorno nei loro paesi di origine se solo ce ne fossero le condizioni. Molti altri sono pronti a farlo in un contesto di collaborazione tra paesi di origine e paesi di arrivo.
Tutti comunque conoscono i loro territori e le loro comunità di origine molto meglio di qualsiasi cooperante europeo. Adeguatamente supportate, non manca certo loro la capacità di individuare le soluzioni per ristabilire la pace, riqualificare il territorio, ricostituire le comunità dei loro paesi. La rinascita dell’Africa e del Medioriente avrà un riferimento irrinunciabile nelle comunità già presenti in Europa, una volta messe in grado di organizzarsi e di far sentire la loro voce, o non sarà.
Per questo il modo in cui profughi e migranti vengono accolti, inseriti nel tessuto sociale e valorizzati per il contributo che possono dare alla soluzione dei problemi che li hanno spinti a emigrare o a fuggire è l’unico modo serio per gestire un processo che l’Europa non sa affrontare; ma che la frantuma e la contrappone al mondo in fiamme da cui è circondata.
Ma non è tutto. L’Europa dovrà confrontarsi in forme sempre più acute con un terrorismo che viene dall’esterno, ma che recluta i suoi adepti soprattutto tra le comunità migranti già insediate al suo interno. Respingere i profughi nei paesi di origine o di transito significa rispedirli tra le braccia delle forze da cui hanno cercato di fuggire, rafforzarne le file, offrire carne da macello al loro reclutamento.
Bistrattare profughi al loro arrivo o trattare chi è già insediato tra noi come un corpo estraneo o un nemico significa promuovere il reclutamento di nuovi terroristi. Anche in questo caso la strada da seguire passa per le comunità di profughi e migranti già presenti o in arrivo in Europa. Parlano le stesse lingue, ne conoscono abitudini e atteggiamenti, frequentano o incrociano facilmente i connazionali che stanno imboccando la strada dello stragismo. Possono individuarli o bloccarli meglio di qualsiasi apparato di “intelligence”, che certo non ha da restare con le mani in mano. O, viceversa, possono essere, con una tacita connivenza, il loro brodo di coltura. La lotta contro il terrorismo passa inevitabilmente attraverso l’instaurazione di rapporti solidali con le comunità migranti.
Altre strade non ci sono. Chi prospetta i respingimenti come soluzione di entrambi i “problemi”, profughi e terrorismo – presentandoli per di più come legati, mentre non c’è maggior nemico del terrore di chi è fuggito da una guerra o da una banda di predoni – inganna sé e il prossimo. Un blocco navale per riportarli in Libia? Bisognerebbe conquistare anche tutta la costa libica, come ai tempi di quell’Impero che chi prospetta questa soluzione forse rimpiange. E poi gestire in loco i campi di concentramento; o di sterminio. O affidarsi a un accordo con le autorità locali, che per ora non hanno alcun potere né alcun interesse ad assumere un ruolo del genere se non lautamente retribuiti (come la Turchia). Per poi minacciare in ogni momento di aprire le dighe (come aveva fatto a suo tempo Gheddafi e come minaccia di fare Erdogan) se non vengono soddisfatte le loro pretese, ogni volta più pesanti e umilianti per tutta l’Europa.
Considerazioni che valgono per tutti i paesi con cui il Governo italiano ha siglato o vuole siglare accordi del genere. Nel migliore dei casi le persone trattenute o “rimpatriate” riprenderanno la strada del deserto e del mare appena possibile. Nel peggiore…
Autorità, politici e media non spiegano che cosa significa riportare i profughi nei paesi di origine o di transito, posto che sia possibile. Intanto costa carissimo: tra viaggio, Cie resuscitati col plauso dell’Europa, costo degli accordi, apparati polizieschi e giudiziari, più di quanto basterebbe per dare casa, istruzione e lavoro a ognuno dei profughi da rimpatriare. Infatti lo si fa con pochissimi. Agli altri a cui non si riconosce il diritto di restare, si consegna un foglio di via intimandogli di abbandonare il paese entro sette giorni: senza soldi, senza documenti, senza conoscere la lingua, senza alcuna relazione con la popolazione. Vuol dire metterli per strada, consegnarli al lavoro nero; o alla criminalità, allo spaccio e alla prostituzione; o, cosa da non trascurare, al reclutamento jihadista. L’appello a impossibili respingimenti crea solo illegalità, criminalità, terrorismo.
Ma che succede nei paesi dove si vorrebbe rispedire gli esseri umani da fermare sul bagnasciuga dell’Africa o del Medioriente? Saperlo non è difficile e chi finge di ignorarlo se ne rende corresponsabile. Succede che i morti nell’attraversamento del deserto sono più di quelli (5.000 solo nel 2016) naufragati nel Mediterraneo. Ma gli uomini, le donne e i bambini che sopravvivono a quella traversata sono fatti oggetto di stupri, rapine, schiavitù e sfruttamento di ogni genere; o vengono imprigionati in locali al cui confronto Cona e Mineo sono Grand Hotel: affamati, maltrattati e umiliati in ogni modo.
E’ questa la soluzione? Quella finale? Condannarli a una fine del genere è cosa di cui domani i nostri figli e nipoti ci chiederanno conto. E i popoli respinti anche: e in modo tutt’altro che delicato.
il manifesto, 18 gennaio 2017
L’orrore che ha caratterizzato le cronache internazionali a ridosso del passaggio d’anno, l’abisso di barbarie che sembra aprirsi intorno a noi, il degrado di secoli di conquiste nel solco della civilizzazione, sembrano far vacillare il principio di azione e reazione, caposaldo della fisica newtoniana ma anche eccellente descrittore delle dinamiche sociali e politiche.
Cos’altro deve accadere nel mondo perché si levi una mobilitazione di massa che sappia affermare – con la massima chiarezza possibile – che gli atti di terrore, le stragi, la paura, non avranno la meglio su una società libera, democratica e secolarizzata? E che con la stessa fermezza dica – nel contempo e una volta per tutte – che non è con la negazione dei diritti umani, con la proliferazione degli armamenti, con la costruzione di muri, che si possono costruire le condizioni di convivenza, dignità, rispetto reciproco tra popoli e Stati?
In questo senso la sponda sud del Mediterraneo, il Medio e Vicino Oriente hanno dimostrato una notevole reattività della società civile, ben superiore al Vecchio Continente, nonostante le oggettive difficoltà, come in Turchia – dove le libertà personali e i diritti civili sono oltremodo compromessi – o in Siria – dove la principale preoccupazione delle persone sarebbe quella di sopravvivere; di contro in Germania – neanche dopo il sanguinoso attacco terroristico a Berlino – si è levata una qualsivoglia forma di protagonismo dei cittadini.
Non sono mancate diverse e contraddittorie congetture sull’assopimento della società civile in questo inizio di secolo, disponiamo di strumenti di conoscenza e di analisi sopraffini, abbiamo sviluppato una straordinaria ricchezza di iniziative sulle policy e nell’interlocuzione con le istituzioni, ma quello che sembra mancare è la capacità di coinvolgimento popolare, ampio e di massa, senza cui la stessa autorevolezza di rappresentanza della società civile organizzata è destinata a barcollare.
Le forme di conflitto, la guerra asimmetrica, l’irruzione del terrorismo a tutto campo, rendono la realtà che ci circonda – e la sua descrizione – molto più complessa che nel passato: la semplificazione schematica – che non pochi risultati ha portato all’ampliamento del fronte di mobilitazione negli scorsi decenni – in buoni e cattivi, o aggressori e aggrediti, oggi è mutevole e cambia di volta in volta, a seconda dei luoghi o delle circostanze. Possiamo però subire passivamente l’irreversibile aumento di entropia – quella che Ignacio Ramonet definì come «la geopolitica del caos» – e rassegnarci quindi all’inazione ?
C’è un lavoro immane da fare sulle fondamenta culturali di una nuova cittadinanza europea e globale: la strada percorsa durante il «secolo breve» per la definizione e codifica del diritto internazionale e dei diritti dell’uomo è un patrimonio che ha formato le coscienze di intere generazioni, che hanno poi tradotto nella passione civile e nell’impegno politico quel dibattito e quella tensione a loro contemporanei. Alcune cose sono andate per il verso giusto, altre si sono arenate producendo sogni infranti e disillusioni, che rischiano oggi di essere l’elemento prevalente nella cultura condivisa delle giovani generazioni, che quella esperienza non hanno vissuto.
E’ necessario ripartire proprio da qui, da una paziente e meticolosa opera di pedagogia dei diritti, di narrazione delle conquiste raggiunte, che sappia convincere e appassionare anche coloro che – per motivi anagrafici – a questo processo non hanno avuto modo di prendere parte, che àncori e ispiri l’azione concreta a principi universali. Possiamo e dobbiamo tenere insieme vocazioni e aspirazioni differenti del nostro vasto mondo, proseguendo sulla via dell’expertise e dei think tank, luoghi più ristretti dove condividere e confrontarsi su analisi, progetti e buone pratiche, ma non perdere di vista l’obbiettivo di essere soggetti includenti, popolari e di massa, missione alla quale siamo geneticamente vocati e che costituisce l’anima più propriamente politica del nostro agire come soggetti costituiti per rappresentare sogni e bisogni della società.
 Per un approccio dignitoso al tema dell'accoglienza - per una società che voglia essere coerente con le sue migliori tradizioni - servono certamente volontà politica e disposizione popolare,
Per un approccio dignitoso al tema dell'accoglienza - per una società che voglia essere coerente con le sue migliori tradizioni - servono certamente volontà politica e disposizione popolare,
ma anche proposte concrete. Per Firenze ci sono già. La Città invisibile newsletter, 15 gennaio 2017
L’assessore al welfare, Sara Funaro, invita la città ad offrire sacchi a pelo per far fronte all’ “emergenza profughi” tornata alla cronaca con la morte di Alì Moussa. Rifugiato politico, somalo, Moussa è vittima dell’incendio del capannone industriale nel quale da due anni vivevano cento “migranti”, di vecchia e nuova data. Reietti e clandestini per legge, cui il Comune di Firenze, inabile, non aveva fornito alloggio dopo l’ultimo sgombero.
La politica dell’accoglienza da parte delle istituzioni non può, non deve limitarsi alla risibile invocazione di opere di misericordia presso i singoli. Deve e può, invece, offrire casa e diritti, uguaglianza e cittadinanza, ai superstiti dell’incendio e ai molti altri – stranieri ed italiani – presenti sul territorio in analoghe, precarie condizioni abitative.
Nell’età del neolicapitalismo agguerrito, non si pretende certo che gli amministratori requisiscano gli appartamenti sfitti, come fece nel post-alluvione il (da loro) tanto invocato – perlopiù a sproposito – sindaco La Pira. Si pretende invece, che offrano ai migranti un rifugio che renda agli «umili» (P. Toschi, Il Ponte, 1945) dignità e pieni diritti di cittadinanza.
Si pretende il colpo d’ala. Che il Comune di Firenze, o la Città metropolitana, offra una casa al “popolo nuovo”, nel cuore delle città. Non ci accontenteremo delle periferie e delle «casette mobili prefabbricate» proposte dalla Regione Toscana (cfr. la Repubblica-Firenze, 14 gennaio 2017).
E case nel cuore della città non ne mancano. È sufficiente aprire il catalogo di Nardella – sindaco del capoluogo e della sua area metropolitana – e pescare, tra quelli presentati alle fiere della speculazione immobiliare, uno dei tanti edifici vuoti in attesa dell’agognata valorizzazione (economica). Centinaia di migliaia di metri cubi.
Alle istituzioni locali si richiede lungimiranza. Che comprendano cioè che il centro città ha bisogno di essere ripopolato e non messo in vendita in nome del lusso e della speculazione fondiaria. Per far ciò la città deve rispolverare le virtù civiche dell’accoglienza di indigenti e viandanti, non affidarsi solo a quella mercificata di lusso.
Firenze e le altre città toscane possono attingere a un’ammirevole tradizione ospitale, di hospitalitas rivolta ai bisognosi di ogni provenienza e fede. Molti edifici nati in funzione dell’accoglienza si trovano ora in stato di abbandono. Così le caserme, vuote o in vendita, naturalmente attrezzate (e già pronte) per l’accoglienza provvisoria, pur di altra ascendenza: caserma Baldissera; ex Ospedale militare in via San Gallo (16.200 mq); Accademia di Sanità militare in via Tripoli; Scuola di Sanità militare nell’ex convento del Maglio; Caserma Cavalli in piazza del Cestello; Dogana in via Valfonda.
Tra gli edifici centrali cui potrebbe esser fatto ricorso, spicca l’ex convento di San Paolino (poi Monte di Pietà, in via Palazzuolo), inutilizzato da anni, pronto ora per essere trasformato in hotel di lusso da parte di un colosso alberghiero. In un quartiere che avrebbe invece bisogno di luoghi di socialità, di aggregazione e di cura.
All’interno di un progetto urbano di lungo termine, che sia conforme ai tempi della pianificazione e non a quelli dell’emergenza, il complesso di Sant’Orsola (di proprietà della Città metropolitana) potrebbe risultare invece – per posizione, per volumi, per lo stato dei lavori di consolidamento già effettuati, per natura proprietaria – un’ubicazione preferenziale per l’ospitalità di rifugiati, richiedenti asilo, senza tetto e profughi, che si lasciano alle spalle guerre e paura.
In quei settori del centro cittadino nei quali risulta evidente una situazione di disagio sociale e abitativo – ciò che torbidi o inani amministratori chiamano “degrado” –, la trasformazione di un edificio monumentale e la sua restituzione alla cittadinanza rappresenterebbe un’operazione esemplare di emersione del dolore che affligge, nella città vecchia, il popolo nuovo.
 I voltafaccia dei governanti e (molto peggio) la disumana realtà delle loro decisioni. Articoli di Silvia d'Onghia e Fiorenza Sarzanini.
I voltafaccia dei governanti e (molto peggio) la disumana realtà delle loro decisioni. Articoli di Silvia d'Onghia e Fiorenza Sarzanini.
Corriere della Sera il Fatto Quotidiano, 16 dicembre 2017, con postilla
Il Fatto Quotidiano
QUELLI CHE…
I CIE ERANO CAMPI DI CONCENTRAMENTO
di Silvia d'Onghia
I centri di identificazione degli immigrati assomigliano «a dei campi di concentramento, tanto è vero che il Parlamento ha negato che la permanenza possa essere aumentata a sei mesi». Peccato che il governo, ponendo la fiducia, abbia prolungato la permanenza nei Cie fino a sei mesi”. Parola di Marco Minniti, quando ancora non era ministro dell’Interno. Era il Marco Minniti responsabile sicurezza del Pd, il 19 maggio 2009: al governo c’era Silvio Berlusconi. Forse è la stessa persona? Chissà. Certo di acqua ne è passata sotto i ponti in quasi otto anni: si è andati a votare nell’ormai lontano 2013, i governi sono cambiati, l’immigrazione è tornata a essere un’emergenza dopo la fine dell’operazione Mare Nostrum e, soprattutto, dopo le stragi terroristiche che hanno colpito l’Europa.
E allora si vede che il remoto ricordo dei Cie come “campi di concentramento”, in cui i migranti si cucivano le bocche o davano fuoco alle strutture per protesta, è svanito nel nulla (il nostro è un Paese dalla memoria corta) o è stato ammorbidito dalle rassicuranti parole del nuovo Minniti: “Non avranno nulla a che fare con quelli del passato. Punto. Non c’entrano nulla perché hanno un’altra finalità, non c’entrano con l’accoglienza ma con coloro che devono essere espulsi”, ha detto il neo ministro dell’Interno lo scorso 5 gennaio, poco dopo aver tirato fuori il coniglio dal cilindro.
Memoria corta, dicevamo. Del resto non tutti ricordano che i Centri di identificazione ed espulsione furono istituiti dalla legge 40 del 6 marzo 1998, passata alla storia come Turco-Napolitano. L’allora ministra per la Solidarietà sociale e l’allora collega agli Interni previdero per la prima volta di trattenere i destinatari di provvedimenti di espulsione in appositi Centri definiti “di permanenza temporanea e assistenza”, poi trasformati nel 2011 in Centri di identificazione ed espulsione. Il Testo Unico sull’immigrazione ha subìto negli anni alcune modifiche: prima con la Bossi-Fini (2002) e poi con il cosiddetto “pacchetto sicurezza” del governo Berlusconi, che nel 2008 ha introdotto il reato di immigrazione clandestina. Nel 2014 il Parlamento ha delegato al governo la riforma del sistema sanzionatorio dei reati (l’irregolarità del soggiorno non dovrebbe avere più rilievo penale), ma ad oggi, nonostante vi siano almeno sei proposte di legge ferme, nonostante la Corte Europea abbia stabilito che gli ingressi irregolari di migranti non possano essere sanzionati con il carcere e nonostante il richiamo – lo scorso anno – del presidente della Corte di Cassazione, Giovanni Canzio (“un reato inutile e dannoso”), nessuno ha fatto nulla.
L’articolo 14 del Testo Unico del ’98 prevede che “quando non sia possibile eseguire con immediatezza l’espulsione mediante accompagnamento alla frontiera” (e su questo giornale abbiamo visto le difficoltà della polizia a farlo), il questore “disponga che lo straniero sia trattenuto per il tempo strettamente necessario” presso un Cie. Il “tempo necessario”, inizialmente di 30 giorni (Turco-Napolitano), è diventato di 60 con la Bossi-Fini, di 180 con il “pacchetto sicurezza” del 2008 e addirittura di 18 mesi nel 2011; è tornato di 90 giorni nel 2014, ma un decreto legislativo del 2015, in attuazione di una direttiva europea, ha previsto in alcune circostanze il trattenimento fino a un anno per il richiedente asilo che “costituisce un pericolo per l’ordine e la sicurezza” e per il quale sussiste “rischio di fuga”. Attualmente sono sei i Cie funzionanti (Bari, Brindisi, Caltanissetta, Crotone, Roma e Torino), anche se il sito del Viminale, fermo a luglio 2015, ne elenca soltanto cinque. Diventeranno molti di più, piccoli e in ogni Regione, se il nuovo Minniti andrà avanti per la sua strada. Giovedì prossimo il ministro incontrerà i governatori per illustrare le proprie intenzioni: “Proporrò strutture piccole, che non c’entrano nulla con quelle del passato, con governance trasparente e un potere esterno rispetto alle condizioni di vita all’interno”.
E dire che, all’epoca, Minniti non era il solo del suo schieramento a pensare che i Centri dovessero essere chiusi. Nel giugno 2011, mentre Roberto Maroni faceva approvare – tre giorni dopo Pontida – il decreto legge che innalzava a 18 mesi la permanenza nei Cie, l’attuale sottosegretario piddino Sandro Gozi solennemente commentava: “Il ministro Maroni ha voluto solo mostrare il pugno duro, ma è propaganda con le gambe corte, buona solo per Pontida e conferma che il governo affronta il fenomeno dell’immigrazione solo con politiche repressive”. Si vede che adesso che è al governo anche lui, le politiche repressive hanno le gambe più lunghe. Nel 2012, il Forum Immigrazione del Partito Democratico affrontava le “linee programmatiche a breve e media scadenza: dalla abrogazione del reato di clandestinità al superamento dei Cie. Occorre superare il diritto speciale dello straniero e tornare a un sistema di espulsione che sia coerente con la nostra Costituzione”.
E solo tre anni e pochi giorni fa, il 18 dicembre 2013, il vice ministro dell’Interno, Filippo Bubbico (incarico del premier Letta, poi confermato da Renzi e Gentiloni), a proposito del Centro di Lampedusa tuonava: “Bisogna riformare il prima possibile quelle norme, bisogna chiudere il Cie”. La notte dei governi, evidentemente, porta consiglio.
«CHI CHIEDE ASILO DOVRÀ LAVORARE»
di Fiorenza Sarzanini
«Nuove regole per gli immigrati: chi arriva in Italia e chiede asilo dovrà svolgere lavori socialmente utili in attesa di ottenere risposta all’istanza. È una delle norme che sarà illustrata mercoledì al Parlamento dal ministro dell’Interno, Marco Minniti. Per quanto riguarda i Cie (Centri di identificazione ed espulsione) saranno strutture da massimo cento posti. Record di sbarchi dall’inizio dell’anno»
ROMA Chi arriva in Italia e chiede asilo dovrà svolgere lavori socialmente utili in attesa di ottenere risposta all’istanza. È una delle novità più importanti del pacchetto di nuove misure in materia di immigrazione che sarà illustrato mercoledì al Parlamento dal ministro dell’Interno Marco Minniti, al ritorno dalla sua missione in Germania proprio per discutere di una linea comune in sede europea.
Si tratta di un insieme di regole che hanno l’obiettivo di marcare il «doppio binario» tra profughi e irregolari e si affiancheranno a due proposte legislative sulle quali spetterà alle Camere pronunciarsi. In attesa di chiudere nuovi accordi bilaterali con gli Stati africani che in cambio di aiuti sono disposti ad accettare i rimpatri, ritenuti una delle priorità dal governo.
60 sbarchi al giorno
L’appuntamento è fissato davanti alla commissione Affari costituzionali nell’ambito di un progetto che coinvolge anche le Regioni e i Comuni. Un percorso condiviso che — come ha sottolineato il titolare del Viminale — «servirà a garantire accoglienza a chi ha titolo, essendo inflessibili con chi non ha i requisiti per rimanere nel nostro Paese».
Anche tenendo conto dei numeri: nei primi dodici giorni del 2017 sono sbarcate 729 persone, il triplo rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, con una media di 60 al giorno. A ciò si aggiunge l’emergenza per i minori non accompagnati. Secondo Telefono azzurro lo scorso anno sono scomparsi in Italia oltre 5.000 ragazzi e bambini.
I venti Cie
I nuovi Cie saranno strutture da massimo cento posti, stabili demaniali lontani dai centri delle città, preferibilmente vicini agli aeroporti.
All’interno lavoreranno i poliziotti per effettuare la procedura di identificazione ed espulsione in modo da poter poi pianificare i rimpatri. La vigilanza esterna potrebbe essere affidata ai soldati che finora hanno svolto compiti di sorveglianza per il dispositivo antiterrorismo.
All’interno sarà sempre presente un «garante» che possa verificare il rispetto dei diritti degli stranieri. A Roma, Torino, Crotone e Caltanissetta si è deciso di utilizzare i centri già operativi, altrove si stanno individuando gli edifici adeguati. Dovrebbero rimanere escluse la Valle d’Aosta e il Molise, anche tenendo conto delle difficoltà per effettuare i trasferimenti.
Il lavoro
Due mesi dopo la presentazione della richiesta di asilo, ai migranti viene rilasciato un documento in cui vengono indicati come «sedicenti» rispetto alle generalità che hanno fornito al momento dell’arrivo.
Basterà quel foglio per inserirli nel circuito dei lavori socialmente utili che diventerà uno dei requisiti di privilegio per ottenere lo status di rifugiato. Proprio come già accade per il corso di italiano obbligatorio per chi vuole ottenere la cittadinanza.
Si faranno convenzioni anche con le aziende per stage che potranno essere frequentati da chi ha diplomi o specializzazioni, proprio come avviene in Germania, nell’ottica di inserire gli stranieri nel sistema di accoglienza avendo la loro disponibilità a volersi davvero integrare.
Le nuove norme
Sono due le norme per le quali si chiederà al Parlamento di valutare modifiche sostanziali. La prima riguarda la possibilità di presentare appello contro il provvedimento che nega l’asilo, sia pur prevedendo alcune eccezioni. Si tratta di una misura che mira a snellire le procedure, evitando inutili lungaggini che impediscono di far tornare nel proprio Paese chi non ha titolo per rimanere.
Una linea che riguarda anche il reato di immigrazione clandestina, di cui da tempo i magistrati chiedono l’abolizione proprio perché impedisce di rendere effettive la maggior parte delle espulsioni. Chi viene denunciato e poi processato per questo illecito può infatti chiedere e ottenere di rimanere in Italia fino alla sentenza definitiva. Con il risultato di non poter effettuare il rimpatrio, anche se lo Stato di nascita concede il nulla osta.
 Anche oggi, una testimonianza dell'epidemia velenosa che serpeggia nel popolo italiano. Dicono che ospitare bambini cacciati dalle loro terre può minacciare il business turistico e la sicurezza pubblica,«visti i recenti fatti di cronaca che leggiamo tutti i giorni» (?!).
Anche oggi, una testimonianza dell'epidemia velenosa che serpeggia nel popolo italiano. Dicono che ospitare bambini cacciati dalle loro terre può minacciare il business turistico e la sicurezza pubblica,«visti i recenti fatti di cronaca che leggiamo tutti i giorni» (?!).
L'Avvenire, 15 dicembre 2017
Eppure gli abitanti di Ponte Sasso non ci stanno a passare per razzisti ed hanno appeso davanti alla colonia un maxi striscione con la scritta «Salviamo la nostra infanzia». Quella struttura infatti – a detta dei manifestanti – fa parte della storia della piccola comunità locale che teme che ai 32 minori si possano aggiungere altri migranti. In merito alla vicenda è intervenuto anche l’arcivescovo di Urbino-Urbania-S. Angelo in Vado che, sulla stampa locale, ha invitato a riflettere sul dovere di accoglienza verso ragazzini che non hanno più accanto i genitori. E sulla stessa linea è anche il settimanale Il Nuovo Amico delle diocesi di Pesaro, Fano e Urbino. «Domenica 15 gennaio – scrive la testata cattolica – cade la 103esima Giornata mondiale del migrante e del rifugiato che quest’anno è dedicata proprio ai migranti minori. Il Papa nel suo messaggio sollecita tutti a prendersi cura dei fanciulli che sono tre volte indifesi perché minori, perché stranieri e perché inermi, quando, per varie ragioni, sono forzati a vivere lontani dalla loro terra d’origine e separati dagli affetti familiari. Davvero – conclude l’editoriale – sono un pericolo 32 bambini e adolescenti rimasti soli al mondo?».
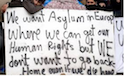 Un articolo di Alessandra Ziniti e due interviste di Massimo Vanni e Paolo Rodari al presidente della Toscana e al Patriarca di Venezia.
Un articolo di Alessandra Ziniti e due interviste di Massimo Vanni e Paolo Rodari al presidente della Toscana e al Patriarca di Venezia.
La Repubblica, 4 gennaio 2017, con qualche domanda in postilla
RABBIA E POLEMICHE
di Alessandra Ziniti
QUEI pochi che sono rimasti aprono e chiudono a singhiozzo tra un incendio e una rivolta. Le bocche cucite con ago e filo degli ospiti di Ponte Galeria, i padiglioni in fiamme di Lampedusa e Brindisi, le pietrate dei siriani rinchiusi a Bari nel centro poi devastato dal fuoco. Filo spinato e luridi stanzoni, giacigli per terra e servizi igienici indecorosi, pericolose promiscuità e soprattutto lunghissimi periodi di “detenzione” in attesa di quell’espulsione che, nel 60 per cento dei casi, continua ad essere impossibile. E attorno “pezzi” d’Italia chiamati ad una difficilissima convivenza.
È una raffica di no quella che, all’indomani dei disordini di Cona seguiti ieri da altre proteste di migranti a Verona e Vicenza, respinge il piano di riapertura dei Cie annunciato dal ministro dell’Interno Marco Minniti. Governatori e sindaci, associazioni umanitarie e sindacati di polizia, esponenti di vertice della stessa maggioranza di governo dicono no al progetto, accolto invece positivamente da Salvini che chiede espulsioni di massa e forze di centrodestra, con il quale il Viminale intende dare una stretta all’emergenza clandestini. «Appena possibile ascolteremo il ministro Minniti. Vogliamo capire se predisporre i Cie in ogni regione sia realmente la risposta giusta all’emergenza immigrazione — dice perplesso il presidente della commissione di inchiesta sui migranti Federico Gelli, del Pd — L’esempio del Cpa di Cona ribadisce l’inadeguatezza di queste strutture che troppo spesso diventano ghetti difficili da gestire ». Con Minniti chiede di parlare anche la presidente del Friuli Venezia Giulia Debora Serracchiani, d’accordo sull’esigenza di maggiori espulsioni ma «assolutamente contraria ai Cie così come li abbiamo conosciuti a Gradisca».
Un Cie in ogni regione per arrivare al raddoppio dei rimpatri di chi non ha diritto a rimanere nel nostro paese. I posti effettivamente attivi in questo momento, a causa del continuo apri e chiudi delle strutture teatro di rivolte da parte degli ospiti, sono 359, meno della metà di quelli originariamente previsti dagli spazi degli unici cinque Cie rimasti in Italia: Roma, Torino, Caltanissetta, Brindisi e Bari (da diversi mesi chiusi dopo gli ultimi danneggiamenti). Per arrivare in tempi brevi all’obiettivo 2000, la strada più breve è la riattivazione di almeno una parte degli altri otto Cie che negli ultimi anni sono stati riconvertiti in hotspot (come Lampedusa e Trapani), in centri di prima accoglienza o per richiedenti asilo o di chiudere perché riconosciuti, come dice monsignor Giancarlo Perego della Cei «centri ingestibili ed esplosivi».
C’è un numero che parla più di altri: dei 175.000 migranti nel circuito dell’accoglienza in Italia più di 150.000 sono ospiti di centri di accoglienza, solo 25.000 nel sistema Sprar che prevede una vera integrazione.
Cpa o Cie poco importa: è di strutture pronte ad esplodere che hanno paura sindaci e governatori. Lo aveva detto subito il sindaco di Lampedusa Giusi Nicolini memore dell’isola trasformata in una prigione a cielo aperto, ma lo dice anche il governatore del Veneto Zaia: «Centri come Cona devono chiudere. Tenere in ostaggio gli operatori, dare fuoco a cose, sono proteste che non si possono giustificare. Bisogna attuare la politica dei rimpatri iniziando da questi signori che fanno casino». Dal centro di via Corelli a Milano a quello di Gradisca d’Isonzo, da Crotone a Catanzaro, da Modena alla ex caserma Chiarini di Bologna. Il governo riprende in mano la lista delle strutture che si potrebbero riaprire velocemente. E già si alzano le barricate. Non ha remore Sandra Zampa, vicepresidente del Pd: «A Bologna non faremo riaprire il Cie. Mi spiace che l’idea sia di un ministro del mio partito. Sono posti disumani. Inseguire i leghisti è un errore».
«Il presidente della Toscana Rossi: servono accordi bilaterali che rendano effettive le espulsioni»
Presidente Rossi, la Toscana non ha Cie. Il ministro Minniti però ne vuole uno per ogni regione.
CITTÀ DEL VATICANO. «Una volta di più risalta l’inadeguatezza e la pericolosità della concentrazione di uomini e donne in un’unica struttura, non è il primo momento di difficoltà che si manifesta in un anno a Cona e basta un niente in un clima già surriscaldato per far scoppiare l’incendio. Ciò che preoccupa è che questo produrrà una reazione di rigetto dell’immigrazione in quanto tale».Così dice Francesco Moraglia, patriarca di Venezia, che rivolge anzitutto un pensiero a Sandrine, la giovane ivoriana deceduta nel Centro, la donna «che è passata attraverso terribili vicissitudini e ha finito per incontrare la morte».
 Perché i diritti umani non sono più al centro dell’attenzione, ed è venuta a determinare un’innegabile caduta di sensibilità e solidarietà umana? L'autore risponde: la regione è nella paura. Potrebbero esserci anche altre risposte.
Perché i diritti umani non sono più al centro dell’attenzione, ed è venuta a determinare un’innegabile caduta di sensibilità e solidarietà umana? L'autore risponde: la regione è nella paura. Potrebbero esserci anche altre risposte.
La Repubblica, 31 gennaio 2016, con postilla
È un fatto. I diritti umani non sono più al centro dell’attenzione internazionale, e soprattutto la loro tutela non è più sentita come una priorità. Né da parte dei responsabili politici né da parte dei cittadini. Non è sempre stato così. Pensiamo agli anni Settanta del secolo scorso, quando le sorti dei dissidenti sovietici o dei cileni vittime della repressione di Pinochet ispiravano forti prese di posizione morali capaci di determinare anche risposte politiche.
postilla
Forse la ragione della violenza che si abbatte sulle muraglie della Fortezza Europa, e che genera la paura, è una conseguenza della violenza e della paura che alcuni secoli di colonialismo hanno suscitato fuori da quelle muraglie. Forse è ormai perduta, per l'Europa, la possibilità di uscire da un destino catastrofico cominciando col comprendere che nessuna pretesa di "universalismo" ha senso ma che la civiltà della razza umana è caratterizzata dalla pluralità delle culture, e quindi le azioni dovrebbero essere ispirate dalla comprensione e dal rispetto reciproci. Ma la potenza degli interessi economici è più forte della ragione, ed e cosi miope da essere quasi cieca.