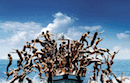i
l manifesto, 22 maggio 2018. Prosegue la trasformazione dell'Europa in una fortezza. Rinunciando sempre di più al suo ruolo storico l'U-E rafforza la barriera che esclude gli altri popoli e le altre culture. Con commento (e.s.)
Sempre più stretto il cappio all collo di quel subcontinente, geograficamente racchiuso tra gli Urali e gli oceani del nord-ovest, ma legato al mondo mediorientale, arabo e africano dal Mediterraneo, culla e cerniera di molte civiltà. Sempre più la migrazioni non sono vissute come occasioni per l'incontro e lo scmbio fruttuoso di culture, come strumenti benefici per produrre meticciato e multiculturalità, ma come rischio da evitare impiegando ogni strumento e a ogni ideologia, da quelle del razzismo a quelle dell'affarismo dei commercianti e costruttori di barriere antiuomo. Ne parla un articolo redazionale ripreso da il manifesto, che a nostra volta riprendiamo (e.s.)
il manifesto, 22 maggio 2018
Migranti, una nuova barriera al confine
tra Montenegro e Albania
La paura dei migranti rischia di far sorgere l’ennesimo muro in Europa. Dopo le barriere fatte costruire nel 2015 dal premier ungherese Viktor Orban al confine con la Serbia, ieri è stato il Montenegro ad annunciare l’intenzione di innalzare una recinzione lungo la frontiera con l’Albania per impedire nuovi arrivi di uomini, donne e bambini nel suo territorio.
Per ora si tratta solo di un’ipotesi alla quale starebbero pensando le autorità d Podgorica, come ha spiegato il capo del Dipartimento per la sorveglianza dei confini, Vojislav Draganovic, resa necessaria dal fatto che «la polizia frontaliera ha difficoltà nel riportare i migranti indietro sul territorio albanese».
E’ dall’inizio dell’anno che sono ripresi i flussi di migranti che cercano di raggiungere il nord Europa. Migliaia di persone che viaggiano sul nuovo percorso che si è aperto di recente dopo la chiusura delle vecchia rotta balcanica, avvenuta due anni fa in seguito all’accordo siglato dall’Unione europea con la Turchia. Il nuovo percorso attraversa prima l’Albania e poi il Montenegro prima di arrivare in Bosnia e da lì proseguire in Croazia.
Nei giorni scorsi Sarajevo ha reso nota l’intenzione di voler presentare due note di protesta contro Montenegro e Serbia, Paesi accusati entrambi di non impegnarsi a sufficienza nel fermare i migranti provenienti dalla Grecia.
Se verrà realizzata, la nuova barriera riguarderà solo determinate aree del Paese e consisterà in un recinto in filo spinato steso lungo il confine. Tra Montenegro e Albania esiste un accordo sui rimpatri.
Dal 2015 a oggi, da quando è cominciata la crisi dei migranti, sempre più Paesi hanno deciso di innalzare barriere. Subito dopo l’Ungheria è stata la Macedonia ad avviare nel novembre del 2015 la costruzione di una barriera lunga 1,5 chilometri al confine con la Grecia e precisamente vicino al campo di Idomeni, dove si trovavano accampati migliaia di migranti. Una barriera di 30 chilometri esiste anche lungo il confine tra Bulgaria e Turchia, mentre in soli tre mesi, nel 2016, la Gran Bretagna ha finanziato e realizzato la costruzione del «muro di Calais» per impedire ai migranti che si trovano nella località francese di attraversare la Manica.
Da ricordare, infine, le continue minacce dell’Austria di innalzare una barriera al confine con il Brennero.

Potere al popolo-Firenze,
«In una città colonizzata dallemultinazionali dell’industria turistica, dove le case del centro sono sottrattealla residenza e i grandi edifici pubblici trasformati in alberghi di lusso, ilsindaco di Firenze imputa alle famiglie straniere l’emergenza casa.» Così Potere al popolo-Firenze che prosegue:«Sulle pagine del Corriere fiorentino, Nardella si abbandona adichiarazioni degne del peggior repertorio programmatico destrorso. Il registroè quello classico: “prima la casa agli italiani”, “troppi gli stranieri”. Lapriorità degli italiani nell’accesso ai servizi è un caposaldo delle politichediscriminatorie della destra. Da guerra tra poveri».
Il bonus di residenzialità proposto daNardella, che darebbe la priorità agli italiani nell’accesso alle case popolari(già ribattezzato la “scala mobile della toscanità”) è infatti un punto deiprogrammi della destra. Salvini twitta, e la Meloni rivendica orgogliosamentela paternità del provvedimento. La misura favorirebbe la risalita dellefamiglie “toscane” nell’assegnazione della casa, mentre a quelle migrantiresterebbe l’inferno della residenzialità precaria e delle occupazioniclandestine.
Grave, nelle dichiarazioni di Nardella,l’assenza di una progettualità in merito al diritto alla casa. Non è con unamisura poliziesca e discriminatoria che si risolve il problema annoso deldisagio abitativo e della penuria di appartamenti sociali. Per di più aFirenze, città da centrotrenta sfratti esecutivi al mese (nel 2016), dove sonopiù di duemila le famiglie in graduatoria. E dove si contano a centinaia glialloggi pubblici vuoti in attesa di ristrutturazione.
La soluzione al disagio abitativo non stanella svendita del patrimonio residenziale pubblico che trasforma i residentiin proprietari. Sta semmai nell’acquisizione di nuovi appartamenti da destinarealla residenza popolare, e nella riconversione degli edifici di proprietàpubblica in residenze provvisorie e in alloggi ERP: ex caserme, ex conventi, exmanifatture, ex carceri. Non sta nella trasformazione dei volumi edilizi infunzioni di lusso, ma nella loro restituzione all’uso collettivo.
È urgente, da parte dello stato,l’applicazione di una giusta tassazione all’edificato tuttora invenduto edesentasse: si tratta di milioni di metri cubi che costituiscono il capitalefisso su cui le imprese accedono ai prestiti bancari per poter continuare acostruire e a produrre invenduto."
Conclude Potere al popolo: «È necessarioun investimento consistente nell’edilizia residenziale pubblica e farla finitacon la farsa del social housing che ha affidato ai grandi gruppi bancari laquestione irrisolta dell’edilizia popolare, gettandola sul mercato.
Nardella chieda questo al governosopravvivente. Non poteri straordinari che tramutano le questioni di civileconvivenza in questioni di ordine pubblico.»
Contatti Lorenzo Alba 305938661

Avvenire, 5 aprile 2018.
«Acquisito il rapporto choc di Guterres. Nel mirino la Guardia costiera di Tripoli. Monitorati salvataggi e condizioni nei centri. Nei mesi scorsi gli accordi con l’Italia per contenere i flussi »
E' un’indagine a vasto raggio quella che la Procura internazionale dell’Aja sta conducendo sui crimini contro l’umanità commessi in Libia.Un’inchiesta monstre che l’Ufficio del Procuratore svolge da mesi «in collaborazione con una serie di Stati, organizzazioni internazionali e regionali e altri partner nella raccolta e analisi di informazioni e prove relative a presunti crimini contro i migranti in Libia».
Fonti dell’Aja lo hanno confermato ad Avvenire. Un team di investigatori sta «analizzando» una serie di segnalazioni circostanziate. L’ultima delle quali è arrivata da Antonio Guterres, il segretario generale delle Nazioni Unite che nel report consegnato al Consiglio di sicurezza dell’Onu e divulgato da Avvenire nei giorni scorsi, accusa di violazioni dei diritti umani anche la Guardia costiera libica. Un Paese, la Libia, con cui l’Italia ha stretto accordi, vale la pena ricordarlo, proprio con l’obiettivo di contenere i flussi migratori. Nel dossier Guterres scrive che la missione internazionale su mandato Onu (Unsimil) ha continuato a documentare «la condotta spregiudicata e violenta da parte della Guardia costiera libica nel corso di salvataggi e/o intercettazioni in mare».
Alla domanda se le denunce del segretario generale siano state acquisite nell'indagine aperta sulla Libia, dall’Aja rispondono senza mezzi termini: «Sì». Aggiungendo che «i presunti crimini contro i migranti sono una questione seria che continua a riguardare il procuratore ». Crimini commessi da una varietà di soggetti sul campo: trafficanti, milizie, autorità locali.
La Libia non ha aderito alle convenzioni per la giurisdizione internazionale dell’Aja, ma la Corte penale può intervenire anche a carico di Paesi non membri se a richiederlo, come in questo caso, è il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite che nel febbraio 2011 incaricò la magistratura dell’Aja a investigare. A novembre arrivarono i primi mandati di cattura per l’allora colonnello Gheddafi e gran parte dei suoi fedelissimi. L’indagine è guidata dal procuratore Fatou Bensouda il cui «Ufficio riceve informazioni da una varietà di fonti sulla situazione in Libia – ribadiscono dalla procura dell’Aja– comprese le relazioni del Segretario Generale sulla Missione di sostegno delle Nazioni Unite in Libia (Unsmil)».
L’inchiesta, ancora nella fase preliminare e dunque senza alcun mandato di cattura né indagati, procede anche nell’analisi delle effettive modalità operative delle motovedette e come i militari di Tripoli si rapportino con le forze navali dell’Unione Europea. I funzionari del Palazzo di Vetro nel loro rapporto ricevuto da Bensouda «hanno anche documentato l’uso di forza eccessiva e illegale da parte dei funzionari del Dipartimento per la lotta alla migrazione illegale». Già nel maggio 2017 la procuratrice intervenendo al Palazzo di Vetro per aggiornare sull’andamento del dossier Libia disse che «secondo fonti credibili, gli stupri, gli omicidi e gli atti di tortura sarebbero all’ordine del giorno e sono rimasta scioccata da queste informazioni che assicurano che la Libia è diventato un mercato per la tratta di esseri umani».
All’Aja procederanno per gradi. «Come facciamo con tutte queste informazioni – spiegano dalla procura internazionale – analizzeremo i materiali, a seconda dei casi, in conformità con lo Statuto di Roma con piena indipendenza e imparzialità». Tra gli episodi documentati e citati da Guterres vi è quello avvenuto il 6 novembre 2017 in acque internazionali, quando «i membri della Guardia Costiera hanno picchiato i migranti con una corda e hanno puntato le armi da fuoco nella loro direzione durante un’operazione in mare».
Anche a terra gli uffici che afferiscono al governo riconosciuto dall’Onu non si distinguono per le buone maniere. «L’Unsmil ha visitato quattro centri di detenzione supervisionati dal Dipartimento per la lotta alla migrazione illegale – ricorda Guterres – e ha osservato un grave sovraffollamento e condizioni igieniche spaventose ». I prigionieri «erano malnutriti e avevano limitato o nessun accesso alle cure mediche».
Articolo tratto dalla pagina qui raggiungibile. Vi potrete trovare altre interessanti informazioni sull’inumanità del trattamento dei profughi da parte dei complici libici del Belpaese

il manifesto, 4 aprile 2018.
Come sarà l’Italia in mano a partiti razzisti? Cominciamo a chiedercelo. Combattere la solidarietà verso profughi e «stranieri» non la rafforza tra i «nativi», ma distrugge anche quella: promuove sospetto, invidia, insensibilità per le sofferenze altrui, crudeltà. E affida «pieni poteri» a chi governa: non solo per reprimere e tener lontane le persone sgradite, ma anche per giudicare sgradite tutte quelle che non obbediscono. La società che respinge e perseguita gli stranieri non può che essere autoritaria, intollerante, violenta.
La storia del secolo scorso ci ha insegnato che questo è un piano inclinato da cui è sempre più difficile risalire. Ma che risultati possono raggiungere i governi impegnati a fare «piazza pulita» di profughi e migranti? Nessuno. La pressione dei profughi sull’Europa continuerà, perché continueranno a peggiorare le condizioni ambientali dei paesi da cui centinaia di migliaia di esseri umani sono costretti a fuggire a causa del saccheggio delle loro risorse e dei cambiamenti climatici che colpiscono soprattutto i loro territori. Quel degrado ambientale è anche la causa principale delle guerre che creano ulteriori «flussi» di profughi: quando le risorse disponibili si riducono, la lotta per accaparrarsele si fa più feroce.
«Aiutiamoli a casa loro» non vuol dire niente: chi mai li dovrebbe aiutare? Le multinazionali che saccheggiano le loro risorse? I tiranni e i governi corrotti che si appropriano di quel che resta? Le popolazioni locali che non hanno la forza per scrollarsi di dosso quei gioghi? Nessuno di loro, ovviamente; solo la volontà di far ritorno nel proprio paese può rendere coloro che ne sono dovuti fuggire i «catalizzatori» di una rigenerazione sociale e ambientale delle terre dove sono rimaste le loro comunità d’origine.
A condizione che profughi e migranti siano accolti bene; messi in condizione di collegarsi tra loro, di organizzarsi, di consolidare legami con cittadini e cittadine europee, di mettere a punto e far valere insieme a loro programmi di pacificazione dei rispettivi paesi e di contenimento e di inversione del loro degrado.
Niente di tutto ciò è prospettato o perseguito da chi ha ripetuto fino alla nausea «aiutiamoli a casa loro»; e meno che mai verrà fatto da chi ha fatto campagna elettorale promettendo di cacciare i «clandestini» dall’Italia. Quella politica, che abbiamo già vista all’opera con il ministro Minniti, non ha fermato gli sbarchi né li fermerà. Perché, anche se tutte le navi delle Ong solidali e delle marine europee venissero messe nell’impossibilità di operare, l’obbligo di salvare chi è in pericolo in mare resterà in capo ai mercantili in transito, come accadeva prima del programma Mare Nostrum; e il porto di sbarco non potrà che essere in Italia. In compenso ci sono stati e ci saranno sempre più morti, sia in mare che nel deserto; che resteranno per sempre sulla coscienza di chi non fa niente per cercare di garantire ai vivi una via di transito sicura verso l’Europa.
Ma soprattutto ci saranno sempre più violenze, torture, ricatti, estorsioni, schiavismo, sia in Libia che in tutti i paesi in cui si sta cercando o si cercherà di bloccare il transito dei profughi. Respingere i profughi significa renderli schiavi e schiave di bande locali o spingerli a farsi reclutare nelle loro armate; il che moltiplicherà i conflitti e renderà tutti i territori dell’Africa e del Medio Oriente infrequentabili per gli europei, sia turisti che tecnici o uomini d’affari. Il modo più sicuro per strangolare sia l’economia europea che le loro.
Ma che sarà, poi, di coloro che sono già in Italia, o in Europa, come «clandestini»? Espellerli tutti è impossibile: costerebbe troppo e chi continua a prometterlo lo sa benissimo.
D’altronde, nessun governo dei paesi di provenienza è disposto ad accoglierli e anche quelli che firmano accordi in tal senso (in cambio molto denaro) non li rispetteranno: quei rimpatriati a forza creerebbero solo problemi. Quei respingimenti li si può fare, o far fare, solo verso la Libia o verso paesi ridotti nello stesso stato: campi di prigionia e tortura a disposizione di un’Europa trasformata in fortezza.
Per questo i migranti «irregolari» resteranno qui, condannati a una clandestinità permanente, che significa costringere centinaia di migliaia di uomini e donne a delinquere, prostituirsi, farsi reclutare dalla criminalità organizzata di casa in molti ambienti politici (soprattutto quelli che più strillano contro il loro arrivo) e anche tra non pochi addetti all’ordine pubblico. È questo, e non l’arrivo di nuovi profughi, a creare quello stato di insicurezza che i nemici dell’accoglienza e della solidarietà dicono di combattere. Essere sempre più feroci con i profughi non fa che peggiorare la situazione; il che fa molto comodo a quei governi europei che già contano di usare l’Italia come discarica dei migranti che non vogliono accogliere, come noi stiamo usando la Libia.
Ma in Europa ci sono già decine di milioni di immigrati, recenti e no, molti anche già «naturalizzati», cioè cittadini e cittadine europee, che da ogni nuova manifestazione di razzismo, o anche di semplice «rifiuto» dello straniero, sono indotti a viversi sempre più come un «corpo estraneo» nella società; e a covare quello spirito di rivalsa che porta alcuni a voler vendicare in qualsiasi modo le sofferenze inflitte ai loro connazionali o correligionari.
Non è un caso che foreign fighters e terroristi vengano quasi tutti da comunità già insediate in Europa. Per fermarli non basta la polizia; non si possono controllare tutti. Bisogna prevenire; e lo si può fare solo con più rispetto sia per loro che per i loro connazionali in cerca di una vita nuova in Europa.
I partiti che hanno governato e quelli che governeranno nei prossimi anni sono chiusi a questo ascolto. Né bastano i sermoni per aprirgliele. È dalla pratica attiva della solidarietà che nasce un nuovo modo di vivere. Ed è da una rete di tutti coloro che si impegnano in questo campo che può nascere un’alternativa reale - sociale, politica e culturale - al disastro in cui ci ha trascinato la politica attuale.
Tratto da Il Manifesto, qui raggiungibile.

Avvenire,
«
I ragazzini arrivano a frotte al campo sul fiume Roja e spesso tentano di passare il confine. Sono i più vulnerabili, come le donne che spesso finiscono nei gironi della tratta»
Guardie e ladri a Ventimiglia. Con i gendarmi francesi che respingono minorenni stranieri soli che dovrebbero proteggere. In barba alle convenzioni internazionali e a due sentenze della magistratura transalpina che hanno condannato a gennaio e a febbraio i ' Refus d’entrée', i documenti di espulsione illegali che sbattono le porte in faccia ai ragazzini che provano a passare il confine. Questi non vogliono neppure rimanere in Francia, ma raggiungere i parenti nell’Eldorado Germania, in Scandinavia o in Gran Bretagna. E intanto in questa terra di transito parte l’allarme tratta. Sotto il ponte sulle rive del Roja, di fronte alla chiesa delle Gianchette – dove per due anni sono state accolte dalla Caritas diocesana centinaia di persone, soprattutto vulnerabili – da tre mesi arrivano in misura maggiore donne eritree predate dai passeur, i passatori, per indurle a prostituirsi in Francia.
A tre anni dall’inizio dell’emergenza migranti, la situazione resta complicata anche se i numeri sono calati. Nel campo gestito dalla Croce Rossa si oscilla da 200 a 280 ospiti, molti stabili perché dopo diversi respingimenti hanno chiesto asilo rassegnati. E nell’accampamento abusivo sul Roja dormono almeno 200 persone. Nel centro della Caritas Intemelia, diocesi di Sanremo, si contano le persone di passaggio ogni mattina quando gli 80 volontari a turno distribuiscono pasti ed effettuano visite mediche. «Il tasso di ricambio è alto – spiega il direttore della Caritas diocesana, Maurizio Marmo – segno che molta gente in transito da Ventimiglia riesce a passare. Al centro abbiamo visto in due mesi 1.054 persone. Le donne, che fino a dicembre erano pochissime, a fine febbraio erano salite a 150, il 12% circa. E un quarto dei migranti è un minore non accompagnato. Il 65% degli adulti e under 18 sono eritrei, contro il 20 % dei sudanesi ». Tre ragazzine 16enni in viaggio da sole caricano i cellulari. Due sono eritree, una libica berbera. I libici con la pelle scura sono i nuovi arrivi. Erano fedelissimi di Gheddafi non hanno futuro. Sono appena sbarcate in Sicilia, fuggite dalla comunità per arrivare a Ventimiglia. Ignorano i rischi che corrono.
«Ogni giorno incontriamo ragazzi come loro, girano in gruppo, provano a passare in Francia e vengono respinti – raccontano Chiara Romagno, responsabile dell’intervento di Oxfam Italia con Simone Alterisio,operatore della Diaconia Valdese –. Stanno soprattutto in tende sotto il ponte del Roja perché diffidano della polizia che presidia il campo di transito. Ci sono madri con figli molto piccoli. Ogni giorno distribuiamo coperte, scarpe, cappelli per affrontare il freddo della notte».
Come le altre Ong, l’unità identifica i casi di abuso verso i più vulnerabili fornendo assistenza legale. Tutte le organizzazioni a Ventimiglia denunciano l’illegalità dei respingimenti francesi. Un minore secondo le convenzioni internazionali e la normativa di Schengen va preso in carico dallo Stato dove si trova. Ma spesso l’aiuto è discrezionale, anche per gli adulti. «Ventimiglia è un tappo – spiega Romagno – vi arrivano persone che sono state mesi in centri di accoglienza a far nulla. O i “dublinanti”, passati da qui due anni fa e rispediti qui da tedeschi o francesi perché devono stare nel Paese di approdo. Capita che questi richiedenti asilo vengano a loro volta espulsi dall’Italia perché sono stati interrogati senza interprete e alla domanda se volevano restare qui hanno risposto di no». Quanto ai minori, una rete di legali italiani e francesi supportata dalle Ong e dalle Caritas delle due parti del confine ha monitorato in alcuni fine settimana l’operato delle polizie. Ha presentato due ricorsi in Francia e ha vinto. Cosa è cambiato?
«Nulla. I gendarmi – spiega Alessio Fasulo, coordinatore dell’unità mobile di Save the Children – aggirano la sentenza falsificando l’età e scrivendo sul provvedimento d’espulsione che sono maggiorenni. Così li consegnano alla polizia italiana che deve fare accertamenti. Nel frattempo il ragazzo ritenta per non perdere tempo e sparisce. Altri minori mal consigliati dichiarano di essere maggiorenni anche se sono visibilmente 15-16enni». E i francesi li prendono in parola. Tommy, 16 enne eritreo, maglietta nera, cappello da baseball e una faccia da bambino era riuscito a passare e ad entrare in una comunità protetta come prevede la legge in attesa di ricongiungimento con due fratelli in Germania. I gendarmi lo hanno trovato alla stazione di Nizza senza documenti, lui non parla francese né inglese e lo hanno riconsegnato agli italiani dicendo che era maggiorenne. È partito da casa quasi un anno fa, è stato in Libia dove è stato picchiato dai carcerieri, ha attraversato il mare. E ora deve beffare i francesi a guardie e ladri nonostante la legge sia dalla sua e potrebbe chiedere anche all’Italia di portarlo in Germania in 9 mesi. Ma lui ha fretta per ascoltare.
Ce ne sono tanti come lui nell’accampamento sul Roja. Le Ong vi entrano abitualmente, poi ci sono i “solidali”, gli ex no border che portano cibo da Francia e Germania. Fuori presidia la polizia che mercoledì ha sedato una rissa. Nelle tende dormono diverse famiglie con bambini piccoli. Non vogliono andare nel campo organizzato perché gli eritrei diffidano delle divise, temono di essere arrestati e ricondotti nel Mezzogiorno. Quasi tutti provengono dagli sbarchi di febbraio e marzo, quasi tutti hanno pagato un trafficante eritreo che vive il Libia di nome Absalam. «I 'passatori' qui vendono passaggi da 50 fino a 150 euro – spiega Daniela Zitarosa di Intersos, organizzazione che ha da poco pubblicato il rapporto “I minori stranieri non accompagnati lungo il confine Nord italiano” – e un trasporto in taxi o camion. Capita che incassino i soldi e li lascino a Genova o a Milano. Spesso non sanno neppure dove si trova Ventimiglia, per loro è una tappa». È il problema anche delle donne. Di là dal fiume, nascoste dagli alberi in alcune baracche di legno, dormono ragazze eritree. «Con il blocco delle coste libiche – prosegue – hanno patito di tutto nei centri di detenzione. Devono raggiungere la Francia a ogni costo e non hanno soldi. Qui restano pochissimo, a volte accettano di prostituirsi oltre confine per pagarsi il viaggio». Ma non c’è un posto, dicono le Ong, per parlare con loro e i minori e aiutarle. Forse hanno tutti troppa fretta. Loro di andarsene, Francia e Italia di disfarsi del problema.
la Nuova Venezia,
Leaty, posso farti una domanda?». Leaticia: «Certo, dimmi tutto». M.: «Ma cosa vuol dire negher?». Leaticia: «Perché me lo chiedi?». M.: «Perché oggi all'intervallo A. e G. mi hanno detto negher». Leaticia: «E tu cos'hai risposto?». M.: «Ehhh niente perché non so cosa vuol dire». Leaticia: «Ok... Allora, negher vuol dire negro». M.: «Ohhh!!!». Leaticia: «Eh sì, ti hanno detto che sei negro. Doveva essere un insulto. Magari credono di essere migliori di te perché loro sono bianchi. Ma tu non ci devi credere, perché non è vero. La prossima volta che te lo dicono, tu rispondi che sei fiero di essere negro. Capito?». M: «Sì».
Questa è una conversazione che ho avuto con il mio fratellino di otto anni al ritorno da scuola. Risiediamo a Bergamo con i nostri genitori, ma studio come fuori sede a Venezia e ci sentiamo spesso al telefono. In otto anni della sua vita, non ho mai pensato che avrei dovuto un giorno spiegargli il razzismo. Sono stata molto ingenua perché, dall'alto dei miei vent'anni, di episodi di razzismo ne ho vissuti. I primi si sono verificati quando avevo all'incirca dodici anni. Ma ero già grande e sapevo difendermi con le sole parole. Ma a otto anni, come si rielabora il razzismo? E io, da sorella maggiore, come lo semplifico il razzismo per un bambino ingenuo? Ancora non lo so. Ma devo trovare un modo di rendere mio fratello immune al razzismo. Proprio come sua sorella.
Sì, perché io mi ritengo immune al razzismo: non sono razzista e i razzisti non mi fanno paura, non mi fanno arrabbiare, non li detesto. E oltretutto, ho sviluppato una sottile arma per combattere il razzismo a modo mio. Io rispondo con l'ironia, anzi, il sarcasmo. Faccio fiumi di battute auto-razziste alle quali in generale la gente rimane di stucco. Non sa se ridere o meno. Perché verrebbe da ridere, ma ridere sarebbe politicamente scorretto. Quando la gente comincia a conoscermi, si abitua alle mie battute e comincia a ridere. Quando la gente ride e soprattutto quando la gente riesce a fare battute razziste, ritengo che il mio lavoro abbia avuto successo, semplicemente perché portando in superficie l'ignoranza e ridendone, la si demistifica.
Io sono immune al razzismo: questo mi sono sempre detta. E sono sempre stata fiera di aver sconfitto il razzismo. Imperdonabile ingenuità! Nei giorni scorsi nei bagni della biblioteca in cui lavoro come collaboratrice sono state trovate delle scritte fasciste e razziste. "W il duce, onore a Luca Traini. Uccidiamoli tutti sti negri".Wow. Un momento di profondo respiro. Rileggo la frase di nuovo. Per un bianco, o comunque un non negro, credo che questa affermazione possa suscitare ribrezzo, tristezza, rabbia. In verità non so cosa possa provare un bianco, e non so perché debba essere diverso da quello che può provare una negra quale sono io. Da negra, non mi sento offesa. Sono profondamente confusa che queste scritte si ritrovino in un luogo così culturale, e confusa soprattutto perché probabilmente l'autore è un mio coetaneo.
La biblioteca delle Zattere è anche chiamata Cultural Flow Zone: un ambiente giovane e vivace, dove, tra una pausa e l'altra dallo studio, si può spostarsi di sala e vedere una mostra, assistere alla presentazione di un libro o partecipare ad un cineforum. Devo dire che è un ambiente lavorativo umanamente parlando molto stimolante e si può proprio sentire la cultura fluire. Incontro persone diverse tra loro: dagli universitari ai liceali, dal personale tecnico ai docenti, dagli attori e cantanti ai corrieri. Questo ambiente non mi sembra un ambiente razzista, anzitutto perché altrimenti non avrei superato un colloquio in cui concorrevo con molti altri ragazzi bianchi. Tuttavia, è stato un colpo per me vedere queste scritte. Ho tentato a più riprese di immaginare la scena di un ragazzo che come molti altri mi chiede di fare una tessera giornaliera, e lo immagino come il probabile autore delle scritte. E voglio parlargli, capire perché mi voglia uccidere, visto che sono negra.
Sono impaurita, non perché io abbia paura di essere uccisa, ma mi spaventano le ragioni per cui verrei uccisa. Come puoi pensare di uccidere qualcuno solo per il colore della sua pelle? Cosa ti può distorcere così tanto da volere uccidere qualcuno perché non è bianco? Ho le vertigini solo a pensarci. Cosa otterresti dalla mia morte? Io vorrei solo capire. Vienimi a parlare. Voglio essere guardata dritto negli occhi e voglio sentire cosa ti affligge. Perché mi odi? Come mi uccideresti? Come ti sentiresti dopo la mia morte? Saresti felice? Voglio capire i tuoi sentimenti. Vienimi a parlare prima di uccidermi, cosicché io ti possa abbracciare e mostrare un po' di umanità.
Io non ti odio, non perché io sia gentile. È perché sono profondamente triste per te, provo pietà perché non so come tu sia giunto a questo punto. Mi dispiace per i fallimenti che ci sono stati nella tua educazione. Mi dispiace che qualcuno sia riuscito a manipolarti a tal punto e a convincerti di queste cose. Ti hanno avvelenato la mente e il cuore con questo odio insensato e questo suprematismo bianco. Ti hanno rubato la tua libertà intellettuale e questo non è giusto. Mi sono sempre ritenuta immune al razzismo, convinta che fosse una bassa manifestazione di odio dovuto alla mediocrità intellettuale. Ho sempre attribuito il razzismo ai bigotti. Dovrei sentirmi rassicurata e felice che tutti i miei amici e conoscenti non siano bigotti. Ma a me non basta. A me interessi tu, caro fascista, caro razzista.
Credo che tu viva in una grande farsa, un equivoco impensabile. Il valore più grande della tua umanità è l'universalità, perché di umanità ve n'è una sola. Non mi puoi uccidere solo perché sono negra. È una argomentazione inconsistente. Tu non sei fatto per l'ignoranza o l'oscurantismo, semplicemente perché sei umano e sarebbe un tradimento alla tua umanità. Un alto tradimento, imperdonabile a te stesso. Non devi uccidere me, devi uccidere quel mostro oscuro che si nutre delle tue paure e della tua ignoranza, ma anche della tua ingenuità. Ti auguro di sconfiggere questi mostri.

il manifesto,
“Ba-sta razzismò, ba-sta razzismò”. I tantissimi senegalesi in corteo lo ritmano lungo tutto il percorso, restituendo senso, una volta tanto, alle parole. Si manifesta per Idy Diéne, e come hanno chiesto le associazioni dei senegalesi di Toscana “questo vuol essere un ricordo doloroso di una persona cara, ma anche una affermazione collettiva del rifiuto dell’incitamento all’odio nei confronti dei migranti e rifugiati, che ha caratterizzato in modo marcato il dibattito pubblico nell’ultimo anno”. Per certo è un fiume intergenerazionale e arcobaleno quello che invade piazza Santa Maria Novella, via dei Fossi, i lungarni Vespucci e Soderini, il ponte alla Carraia e il ponte Vespucci. Lì dove il 54enne ambulante è stato usato come un bersaglio, prima di essere ammazzato, con il colpo di grazia alla testa, da un tipografo in pensione con l’hobby delle armi.
Sfilano in (molti) più di 10mila – numero della questura – e tutti sanno bene che nessuno potrà riportare in vita Idy Diéne. Ma essere qui può aiutare a combattere il razzismo, che sia dichiarato o strisciante poco conta, ormai sdoganato da forze che con la parola d’ordine del “prima gli italiani” portano migliaia di loro ad essere “eletti dal popolo” in Parlamento e negli enti locali. “Quell’uomo l’ha studiato, l’ha studiato (l’omicidio, ndr) – quasi urla un senegalese ai microfoni di Radio Popolare – lui quel giorno ha incontrato un milione di persone e poi ha sparato a un nero. Salvini, io ti vedo tutte le volte al telegiornale, tu parli solo male degli africani, questi sono i risultati”.
Agli angoli del ponte Vespucci, attaccato sul muro, un volantino racconta l’Italia di oggi vista con gli occhi di un migrante: “Cari fratelli e sorelle italiani, se avete fame oggi; se siete senza lavoro; se siete diventati poveri, noi neri, noi africani, non siamo colpevoli; non siamo responsabili delle vostre rogne. Cercate i responsabili da Sarkozy a Berlusconi, alleati hanno bombardato la Libia e il resto dell’Africa. Se le vostre bombe cadessero in Italia cosa fareste? Dov’era la colpa del povero Diéne Idy, il fatto di essere nero. Essere nero è un reato in Italia, basta!”.
La manifestazione è stata in forse fino a venerdì, anche questo è toccato vedere dopo che la parola razzismo è stata tabù per giorni, sindaco Nardella in testa. Invece dal direttore degli Uffizi, Eike Schmidt, erano arrivate parole sensate: “Se qualcuno spara pallottole contro qualcun altro che ha la pelle di colore diverso, avendo incontrato prima anche altre persone, è chiaro che si tratta almeno di razzismo subliminale: questo è ovviamente inaccettabile e va debellato, così come il razzismo manifesto e proclamato”.
E’ stato un corteo talmente civile che a Nardella, anche lui in marcia, è stato dedicato solo un graffiante striscione: “Je suis fioriera”. In eterno ritardo, anche il sindaco ha finalmente capito: “Ho parlato con la famiglia di Idy, ha acconsentito a far svolgere una giornata funebre con una cerimonia funebre, e questo ci consente di programmare il lutto cittadino. In questo modo noi diamo un ulteriore segnale di sensibilità e vicinanza della nostra città”.
Nel lunghissimo corteo altri rappresentanti istituzionali (Enrico Rossi), la portavoce di Potere al popolo Viola Carofalo (“non si poteva non essere qui”), intellettuali (Adriano Sofri, Wlodek Goldkorn, Tomaso Montanari), i responsabili dell’Anpi dell’intera provincia, Gigi Remaschi in testa. Con loro la Cgil, l’Usb, i Cobas, l’Arci, la rete antirazzista fiorentina con le variegate anime della sinistra che resiste. E ancora Tommaso Fattori e Giacomo Trombi con lo striscione “Stay human”: restiamo umani. Senza dimenticare la realtà, fotografata dallo striscione di uno spezzone di corteo tutto al femminile: “Chi spara alla moglie, chi spara all’immigrato, è un maschio bianco, e va fermato”.
“Forza, dobbiamo parlare, dobbiamo farci sentire – spiega una ragazza senegalese alle sue compagne di corteo – perché queste tragedie non devono più succedere, non vogliamo piangere altri morti come Samb, come Diop, come Idy”. Perché Firenze è recidiva. Anche se la sua parte migliore, oggi in corteo, la pensa come il cartello portato dal manifestante ignoto: “Mio fratello non è figlio unico”.

il manifest
Accogliere è una parola che viene dal latino: ad-cum-ligare, legare insieme. Ma più che cercare il suo significato nel passato, dobbiamo costruirne uno nuovo, adatto ai tempi in cui viviamo, ai problemi con cui ci confrontiamo, alle persone che oggi sono al centro dello scontro politico e sociale: i profughi.
Innanzitutto accogliere non ha niente a che fare con le “rilocalizzazioni” pretese e non realizzate dalla Commissione europea che trattano i profughi come “pezzi” (una parola che richiama ricordi atroci) da smistare. E con ciò, a prescindere dalla “selezione” (altro termine dai rimandi atroci) con cui l’Unione europea pretende di accettarne alcuni e di scartare gli altri, attacca loro l’etichetta di “ingombri, problemi. Questo produce insofferenza, rancore e razzismo e spinge i Governi a inseguire le parole d’ordine delle destre. Al di là delle false professioni di spirito umanitario, con i migranti Commissione europea è più feroce di Trump.
Inserita in questa cornice, anche la migliore “accoglienza” riservata a persone trattate come ingombri umilia sia loro che noi: sono esseri (umani?) di cui occorre sbarazzarsi al più presto.
L’ospitalità, che un tempo era sacra, ci può indicare un’altra strada: l’ospite, lo “straniero”, veniva trattato come un membro della famiglia (come il naufrago Ulisse nell’isola dei Feaci); poi veniva preparato e attrezzato per continuare il suo viaggio.
E qual è la meta del viaggio dei profughi del nostro tempo? Le mete possibili sono due: o la piena cittadinanza nel paese che li ospita; ed è certamente un percorso complesso. Oppure il ritorno nel paese da cui sono fuggiti, o sono stati cacciati, e in cui per ora non possono ritornare: un percorso ancora più arduo.
Ma che cosa può invertire l’effetto di una rilocalizzazione così disumanizzante? Il fatto che l’ospite porti con sé un dono, una “dote” più grande dei tanti problemi che pure può generare.
Perché questo succeda, l’ospite deve essere messo in grado di valorizzare, e di fare in modo che vengano apprezzate, la cultura, l’energia, l’esperienza, ma anche il dolore di cui è portatore: perché la comprensione del dolore, sia nostro che altrui, aiuta tutti ad affrontare meglio le circostanze della vita.
Ma deve anche portare con sé lavoro, reddito, diritti, salute. E non certo perché crea un po’ di lavoro per quei pochi che oggi vengono impiegati nella gestione dell’”accoglienza”; questo è un falso “beneficio” che costringe all’inattività e confina nell’inutilità l’ospite e che spesso induce nell’ospitante speculazione e sfruttamento delle altrui disgrazie.
La dote che l’ospite, lo straniero, il profugo, deve essere messo in grado di portare con sé è un grande piano europeo di conversione ecologica, di lavori pubblici, di potenziamento dei servizi, di promozione dell’agricoltura biologica: un piano capace di garantire lavoro e sicurezza sia a lui che a tutti i cittadini dei paesi dell’Unione che sono disoccupati, o in povertà, o costretti a lavori precari e umilianti, o senza casa.
Gli Stati membri dell’UE che accoglieranno i profughi avranno accesso ai fondi e ai progetti del piano; e quanti più profughi accoglieranno, tanto più potranno salvaguardare il proprio territorio, riconvertire la propria economia, creare posti di lavoro sicuri e un’abitazione decente anche per i propri disoccupati, per i propri lavoratori precari, per i propri cittadini emarginati. Così i profughi saranno i benvenuti, perché quanti più saranno, maggiori saranno le occasioni di risolvere i problemi sociali della popolazione. E i progetti dovranno avere un raggio di azione locale, in modo che la popolazione possa percepire il rapporto diretto tra arrivo dei migranti e aumento delle opportunità. Mentre i paesi che non vorranno accoglierli non avranno accesso a quei fondi.
Ma chi paga? Certo, c’è da ridurre, e poi azzerare, la spesa militare; da combattere l’evasione e l’elusione fiscali; da mettere la parola fine alle Grandi opere devastanti; da arginare la corruzione. Ma non basta. A finanziare questo piano di riconversione ecologica deve essere la BCE.
La BCE ha “tirato fuori dal cappello” più di 1000 miliardi di euro all’anno per salvare le banche e promuovere (forse; ma forse no) una ripresa stentata, precaria e in molti casi dannosa; comunque insignificante per l’occupazione. Per alcuni economisti quei soldi avrebbe potuto distribuirli a lavoratori e cittadini svantaggiati con quello schema paradossale di sostegno alla domanda detto helicopter money: gettare soldi a piene mani da un elicottero. Si sarebbero ottenuti sicuramente, dicono, risultati migliori.
Ma c’è una via di mezzo e più sensata tra questi due modi cretini di sostenere l’economia; ed è quello di finanziare, con altrettanto denaro (almeno 1000 miliardi all’anno) un piano europeo di riconversione ecologica vincolato all’accoglienza dei profughi, legandola indissolubilmente alla salvaguardia dell’ambiente.
Poi c’è da prendere seriamente in considerazione la seconda possibile meta del viaggio dei profughi: il ritorno. Non con i rimpatri forzati che equivalgono a riconsegnarli, incatenati, ai dittatori, o alle bande armate, o alle guerre, o ai suoli abbandonati, perché ormai sterili, da cui erano fuggiti. Bensì aiutandoli a farsi portatori di pace, di riconciliazione, di democrazia, di risanamento sociale e ambientale delle loro terre. Per farlo devono potersi organizzare durante la loro permanenza in Europa, aver voce in capitolo nelle trattative di pace del loro paese, nella politica estera del paese ospitante, nella destinazione dei fondi (immensi) che oggi vengono spesi per “esternalizzare” le frontiere e fare la guerra ai migranti lungo le loro rotte. E niente come la partecipazione a pieno titolo alla vita associata nei paesi “ospitanti” e la partecipazione, come lavoratori, ai progetti di conversione ecologica di questi paesi può preparare quelli di loro che lo vorranno, e saranno sicuramente molti, a un ritorno, da pionieri, nei paesi da cui sono fuggiti. Così si gettano le basi di una grande comunità euro-afro-mediterranea, dove la libera circolazione delle persone sia non solo un diritto, ma anche una reale possibilità.
Vaste programme, avrebbe detto De Gaulle. Impraticabile per chi non vede alternative ai diktat dell’Unione europea e della BCE. Ma irrinunciabile per chi si candida a un ruolo di vera opposizione. Non dobbiamo scrivere l’elenco delle cose che faremmo “se fossimo al Governo”. Perché al Governo non ci andremo. Per ora. Il nostro compito è avvalorare e diffondere la prospettiva di una inversione radicale delle priorità, sostenerla, renderla concreta con gli esempi, individuare e affrontare gli ostacoli che si parano di fronte. Un programma di opposizione deve indicare la strada per arrivare: non al Governo, ma a governarci.
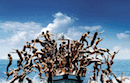
The SubmarineTerraferma e Nuovomondo
Negli ultimi anni il cinema italiano ha provato a raccontare, nel bene o nel male, i processi migratori in atto all’interno del nostro continente - opere come Fuocoammare, L’ordine delle coseIo sto con la sposa hanno indagato la ciclicità di tali processi e il loro effetto sulla società.
Mentre l’Italia osserva meccanicamente in televisione le stesse immagini di sbarchi e soccorsi, il cinema infatti si sforza si squarciare il velo del racconto mediatico, cercando storie universali che trasmettano i valori necessari per superare un rifiuto sociale e umano che attanaglia la nostra società.
Uno dei registi italiani che ha approfondito con maggior lucidità il tema del movimento è stato Emanuele Crialese, regista romano di origini siciliane. Oggi più che mai i temi affrontati dai suoi film risultano essenziali per una riflessione sociale e culturale sul nostro passato, ma soprattutto sul nostro futuro. Partendo dalle sue pellicole abbiamo discusso con il regista di quanto le sue esperienze abbiano influenzato il suo linguaggio e di quanto il documentare si stia sostituendo al raccontare.
L’intervista è stata condotta durante il mese di luglio di quest’anno.
Comincerei da due elementi molto presenti nei tuoi film: la terra e il mare. Entrambi vengono rappresentati come simboli di speranza e allo stesso tempo immobilità, penso alla Sicilia di Nuovo Mondo e al mare che la circonda in Terraferma. Sono due simboli forti che tu racconti con altrettanta forza. Come può il cinema far risuonare questi concetti nello spettatore?
È una domanda per la quale non ho una sola risposta perché forse non c’è una sola risposta. Partiamo dal presupposto che non a tutti arrivano i messaggi che possono arrivare a te, è una questione di sensibilità. Il cinema è un linguaggio, che viene compreso da alcuni ma non da tutti, si tratta di immagini, di personaggi, di storie, e in quest’ottica deve risuonare qualcosa in te per poterlo interpretare. Ma non è che chi non vede non capisce, semplicemente la sua sensibilità sarà interessata a farsi trasportare da altre storie.
Com’è maturato dunque il tuo linguaggio e la tua sensibilità, da dove deriva l’importanza di guardare al passato per riuscire a comprendere il presente espressa nei tuoi film? Le tue origini siciliane hanno contribuito alla costruzione delle tue storie?
Quello che ha aiutato di più è stata la condizione di clandestino dopo gli studi fatti in America, senza permesso di soggiorno e visto mi sono sentito in una condizione di alieno, come lì vengono chiamati quelli nella mia situazione. Probabilmente il fatto di essere stato per tanto tempo fuori dal mio paese, mi ha fatto guardare l’Italia e la Sicilia da una prospettiva completamente diversa. Anche per questo mi sento a disagio a parlare di migrazione, perché non abbiamo mai smesso di migrare dall’inizio della nostra storia come civiltà. lo facciamo fisicamente e mentalmente, è un movimento che porta con sé conoscenza e sviluppo, è inutile negarlo, senza movimento non c’è vita. Questo è il paradosso più grande che sono andato a scardinare: l’uomo ha bisogno di muoversi, chi non parte mai non capisce fino in fondo cosa vuol dire essere quelli che si è. Quando non ci si mette mai in discussione e si danno per scontate le proprie origini e il proprio stato sociale non si riesce veramente a riflettere sulla propria condizione.
Dall’altra però i tuoi film descrivono anche un senso di appartenenza molto radicato.
È come pensare al passato: è nel momento in cui ci ricordiamo di quello che abbiamo vissuto che ne capiamo il valore. In qualche modo quindi capiamo il valore del posto a cui siamo legati, coi suoi pregi e difetti, solo quando ne scopriamo un altro.
A proposito di presente e passato, pensi che i tuoi film abbiano assunto nuovi valori in questi ultimi anni oppure sono opere che valgono sempre così come la continua ricerca dell’uomo per il movimento?
Io spero che valgano sempre, ma non sono io a poterlo dire, sarà il tempo a decidere. Non mi sono soffermato troppo sulla durata nel futuro di queste storie, proprio perché si legano a riflessioni momentanee e personali.
Mettendo da parte per un attimo il piano personale, dall’esterno hai notato un cambio di prospettive sui tuoi film, o meglio le tue storie incidono di più nel contesto di oggi?
Sicuramente incide più adesso perché c’è stato un risveglio, quindi nei ricorsi storici ci si accorge di qualcosa che diventa la voce dell’attualità ma che in realtà non sono altro che aspetti sempre esistiti. Giravo Nuovo Mondo quindici anni fa, Terraferma cinque, adesso è due anni che si parla davvero molto di immigrazione, ma è un interesse a scoppio ritardato, non un’emergenza. L’emergenza non è di due anni fa e nemmeno di dieci, la vogliamo chiamare emergenza, chiamiamola così, ma è una cosa che abbiamo sempre fatto e con cui abbiamo sempre dovuto avere a che fare: il senso di appartenenza, dove posso far valere i miei diritti, in quale terra, dove sono cittadino, di quale paese. Queste sono domande che ci poniamo ciclicamente, in maniera più prepotente in alcuni momenti storici, ma non abbiamo mai smesso di muoverci.
È chiaro che ci sono uomini per natura stanziali, la dimensione del viaggio non gli appartiene, sono uomini che crescono una verticalità piantata nella terra e difendono la loro territorialità. Poi ci sono coloro che per indole sono spinti a cercare nuovi territori. Io mi sento appartenere a questa seconda categoria, non per scelta, ma perché questo è quello che la vita mi ha insegnato. Io sono un nomade e per questo sono molto sensibile rispetto al destino di coloro che vogliono andare altrove.
In questi giorni a Milano c’è proprio una mostra a cura di Massimiliano Gioniche racconta questo aspetto dell’umanità in movimento e della sua, spesso drammatica, ciclicità.
C’è appunto una differenza che va marcata: noi oggi trattiamo queste persone molto peggio di come facevano i nostri nonni e le generazioni prima di loro. Oggi chiudiamo i confini, ma siamo stati i primi ad aver avuto bisogno della loro apertura in passato.
Tornando alla prima domanda, oggi il mare sembra essere uno spazio con cui nessuno vuole avere a che fare, mentre la terra ha sempre più barriere.
Il mare, insieme alla sabbia e alle camere a gas, ha il potere di far sparire la memoria dei corpi. Quando riportiamo a galla, per usare un termine della psicoanalisi, le cose che abbiamo rimosso nel nostro inconscio allora arrivano i dolori, che non vanno però ostacolati, anzi elaborati e integrati, cosa che noi non siamo in grado di fare come società. Individualmente ognuno di noi può invece avere un atteggiamento diverso, ma come società dobbiamo risolvere questo nostro conflitto interno.
Ho notato che negli ultimi tempi la tendenza è quella di utilizzare una forma documentaristica per descrivere queste storie, quando invece secondo me la finzione narrativa aiuterebbe di più il processo di avvicinamento dello spettatore a questo tipo di temi. Tu come vedi il documentare rispetto al raccontare?
Qua siamo in un terreno molto farraginoso, in cui mantengo una posizione un po’ fondamentalista. Adesso c’è molta confusione intorno alla parola documentario, il documentario è un documento prezioso perché rappresentativo di una realtà che non si può mettere in scena, ma che va raccontata per quella che è, cercando di rimanere più fedeli possibili al tempo e all’individuo. In questo contesto non ci si può assolutamente esimere dal raccontare la verità, non si possono manipolare i fatti che si raccontano, oggi invece c’è una tendenza dei documentaristi a mettere in scena, quindi a drammatizzare, ciò che è già altamente drammatico. Questo atteggiamento finisce per mettere in una posizione scomoda lo spettatore, che alla fine non sa a cosa credere.
La rappresentazione è un modo per evocare una realtà molto personale usando il racconto metaforico e il gioco delle maschere, il documentario invece con la scusa del vero maschera ancora di più la realtà. Una cosa è mettere in scena quello che vedo, un’altra è inserirmi in quello che vedo e raccontare una verità parziale accompagnata da una storia che aggiungo io. Allora si usava un altro termine per definire questo tipo di produzioni, il mockumentary, in cui si dichiara da subito l’unione tra verità e messa in scena.
Sempre di più siamo messi di fronte a storie che raccontano la partenza perché sembra quasi impossibile percepire il ritorno, secondo te arriverà il momento per il cinema di raccontare il ritorno?
Bisogna capire di che ritorno stiamo parlando. È attraverso le immagini che uno ritorna a se stesso, si rielabora ciò che si vede e lo fa proprio, questo è già un ritorno alle proprie origini. Non tanto come individui ma come genere umano. Si ritorna quando si smette di negare i corsi e ricorsi storici, quando le latenze diventano presenze.
In questo contesto di eterno ritorno però i tuoi ultimi film partono comunque dall’elemento del viaggio, cosa racconteresti dopo?
Esattamente quello che hai citato tu, in questo momento sto ragionando sul tema del ritorno. Mi domando se sia qualcosa che possiamo rappresentare sapendo che lo stiamo rappresentando. Vorrebbe dire la fine di un percorso che non ha mai fine, in realtà una fine molto precisa ce l’ha, non sapremo quando né dove, ma ci sarà. Io sento che nel momento in cui c’è comunicazione tra una massa di persone che vedono e assistono a qualcosa che parla di loro, anche indirettamente, lì si compie la magia del ritorno, che non sarà mai consapevole, ma sempre metafisico e indefinito.

Avvenire
«Immediato il trasferimento dei richiedenti asilo che da mesi dormono per terra nella galleria Bombi di Gorizia». L’annuncio questa volta non arriva dal sindaco del capoluogo isontino, il forzitaliota Rodolfo Ziberna, nelle ultime settimane protagonista di un braccio di ferro con i volontari che tutte le sere portano in galleria cene calde e coperte, ma dall’assessore regionale alla Solidarietà del Friuli Venezia Giulia, Gianni Torrenti, di ritorno dal Viminale: «Nell’incontro di Roma è stato programmato un percorso di immediato trasferimento di queste persone che occupano la Galleria e vivono quindi in stato di degrado – ha dichiarato –. Ma si vuole anche capire quali siano le ragioni di tanti nuovi arrivi a Gorizia in queste settimane da parte di persone straniere che non provengono dal confine orientale, ma che erano soggiornanti in Europa da anni» (un’inedita 'rotta goriziana', insomma).
Ragioni che il neosindaco Ziberna, che aveva basato la sua campagna elettorale proprio sullo 'Stop all’immigrazione incontrollata', spiegava da una parte con la presenza a Gorizia dell’unica Commissione prefettizia per l’esame delle richieste di asilo di tutta la regione, ma anche con «il business di vere 'agenzie' che dall’Europa portano qui i richiedenti cui gli altri Paesi hanno negato lo status di rifugiati perché non ne hanno diritto ». E puntava il dito anche contro i volontari, gli unici che intanto, nei ritardi della politica e nei rigori delle notti all’addiaccio, hanno evitato il peggio: «Finché si sa che a Gorizia ogni giorno c’è chi dà da mangiare a tutti fuori dalle regole dell’accoglienza strutturata, è chiaro che verranno sempre di più qui». In realtà il Comune non dà ricovero a nessuno, il cento per cento delle strutture che a Gorizia danno un tetto ai 350 profughi e richiedenti asilo (con convenzione prefettizia) sono della Chiesa o ad essa collegate, ed è la Caritas diocesana da anni ad assicurare ogni giorno i pasti ai poveri della città, italiani o stranieri che siano. Un impegno che, sottolinea l’arcivescovo Carlo Redaelli, «ha sopperito alle mancanze delle pubbliche istituzioni, Comune e Prefettura. Bisogna saper distinguere tra accoglienza, tema complesso e annoso, ed emergenza: mentre la politica nazionale e internazionale cerca le soluzioni, non possiamo lasciare che le persone muoiano. Qui la notte siamo già a meno due...». Se dunque, come annunciato da Torrenti, la galleria Bombi sta per essere definitivamente sgomberata «siamo i primi ad esserne soddisfatti – conclude l’arcivescovo –, perché quel dormitorio a prova di bora non era certo una soluzione dignitosa: in questo caso le istituzioni pare abbiano preso le decisioni giuste anche se tardive, vedremo nel futuro se continueranno ad occuparsi di queste persone, dato che dopo i primi sgomberi già questa notte c’erano trenta persone».
La Chiesa non abbassa l’attenzione: se tornerà l’emergenza «noi ci saremo, con le nostre strutture e con misure aggiuntive», come la grande tenda riscaldata di Medici senza Frontiere, pronta da installare su suolo della diocesi. Emergenza che però il sindaco Ziberna esclude: «La scorsa settimana i cento richiedenti asilo in galleria sono già stati trasferiti con i pullman in strutture attrezzate. Le poche decine che restano lo saranno a breve, pare già venerdì mattina (domani, ndr): prima verranno accompagnati in questura a fare i documenti, poi alle adempienze sanitarie, infine nei centri di accoglienza qui in zona, dove occuperanno altrettanti posti appena lasciati liberi da altri migranti trasferiti in altre regioni d’Italia secondo il piano nazionale dell’accoglienza ». La mattina stessa la galleria, dove in questi mesi solo i volontari (tra loro anche medici del Cuamm) hanno provato a garantire il minimo accettabile di pulizia e decoro, «verrà igienizzata e chiusa da entrambi i lati, per essere riaperta al traffico automobilistico tra 3 o 4 mesi, dopo i lavori di ripristino».
Annapaola Porzio, Commissario del governo del Friuli Venezia Giulia nonché prefetto di Trieste, conferma: «Alla ben nota situazione della galleria Bombi si è data una concreta risposta disponendo il trasferimento dei richiedenti asilo. L’ultimo, avvenuto venerdì scorso, ha interessato cento migranti – ha scritto ieri in una lettera a Ziberna e al neo prefetto di Gorizia –. Malgrado ciò questa mattina nella galleria si sono registrate nuovamente numerose presenze: sull’arrivo continuo e consistente di richiedenti asilo a Gorizia sono in corso approfondimenti, anche in collaborazione con le forze di polizia». Inoltre, come da tempo chiedeva Ziberna, la Commissione per il riconoscimento della protezione internazionale verrà trasferita da Gorizia a Trieste, quando non si sa, ma nel frattempo aprirà una sezione a Udine per snellire le attese dei migranti. Questo, assicura il prefetto, è il «percorso tracciato per ricondurre la situazione alla normalità». «Gorizia sta rispondendo da tempo all’accoglienza di un numero eccessivo di migranti», sottolinea infatti Torrenti, «è necessario ripristinare numeri accettabili». Per l’assessore regionale «è indispensabile la presenza di un centro di prima accoglienza, e a tal proposito c’è quello di San Giuseppe, che non deve essere una struttura permanente ma piuttosto un decoroso primo ricovero nei casi di necessità come quella creatasi nella galleria Bombi». Manco a dirlo, anche il San Giuseppe è una struttura della diocesi.

Internazionalel'ex base militare di Conetta, trasformata in un centro di accoglienza, pessimo anche per il suo genere, dove cattiva gestione e speculazione imperano.
“È da stamattina che parlo con questi ragazzi, ognuno di loro è una tragedia: chi ha perso un fratello, chi è stato venduto all’asta degli schiavi in Libia, chi è stato torturato”. Lino, 62 anni, ex operaio del petrolchimico di Marghera, scoppia a piangere quando racconta le storie dei ragazzi della Costa d’Avorio, della Nigeria, del Mali con cui ha passato qualche ora nella parrocchia di Mira, una cittadina a venti chilometri da Venezia.
Sono circa quaranta e hanno dormito per terra in canonica, avvolti in coperte e sacchi a pelo, dopo aver marciato per tre giorni dall’ex base militare di Conetta, in Veneto, per raggiungere a piedi la prefettura di Venezia, a cinquanta chilometri di distanza. Fanno parte dei 250 profughi che protestano contro le condizioni di un centro di accoglienza in cui vivono 1.400 persone e dove il 3 gennaio del 2017 una richiedente asilo della Costa d’Avorio di 25 anni, Sandrine Bakayoko, è morta per una tromboembolia polmonare acuta che l’ha colpita all’improvviso mentre era nella doccia, scatenando una rivolta tra gli ospiti.
Da Campolongo Maggiore i ragazzi sono arrivati stremati nelle sei parrocchie di Mira e di Chioggia, ma hanno trovato decine di persone – parrocchiani, attivisti, semplici cittadini – ad accoglierli con pasti caldi, vestiti e coperte. La sera del 16 novembre il patriarca di Venezia Francesco Moraglia aveva chiesto alle parrocchie della zona di aprire le porte per la notte ai profughi.”La popolazione si è mobilitata e i ragazzi per fortuna hanno potuto passare una notte al caldo, perché sono stati due giorni e due notti molto fredde e la situazione stava diventando davvero pesante per loro”, afferma Barbara Barbieri, un’attivista del sito d’informazione Progetto Melting Pot Europa.
Dopo tre giorni di cammino lungo l’argine del fiume Brenta e una lunga trattativa con la questura e la prefettura, ce l’hanno fatta. La prefettura ha deciso di trasferirli in altri centri della regione: 180 rimarranno nella provincia di Venezia, gli altri saranno spostati in strutture di accoglienza nelle diverse province del Veneto. Per ognuno di loro è un’altra scommessa, una specie di lotteria, non sanno cosa li aspetta, ma sembrano soddisfatti di non essere tornati indietro, nella base militare da dove erano andati via tre giorni prima, caricandosi le valigie sulle spalle.
“Si tratta d’integrare questi ragazzi, sono persone forti che vogliono lavorare, non si può chiuderli in un ghetto come quello di Cona”, commenta Lino mentre si asciuga le lacrime che spuntano sotto gli occhiali. Ha lavorato per 42 anni al petrolchimico, ha cominciato quando ne aveva 14, ora ne ha più di sessanta e da quando è in pensione fa volontariato in una delle parrocchie di Mira. Per Lino la questione è molto semplice: i richiedenti asilo che ha incontrato in canonica hanno l’età dei suoi figli e non possono essere confinati in strutture fatiscenti, lontane da tutti i servizi.
“Lui, Benjamin, ha l’età del mio figliolo più piccolo che studia all’università. In lui vedo mio figlio”, dice, mentre indica un ragazzo alto e sorridente che indossa una felpa rossa col cappuccio. Con semplicità spiega che l’integrazione dovrebbe essere un’opportunità di lavoro anche per la popolazione locale: “Ci sarebbe bisogno di insegnanti d’italiano, di operatori sociali, di mediatori” e invece “stiamo con i forconi”.
Usa parole forti l’ex operaio per definire il centro di accoglienza che ospita metà dei richiedenti asilo presenti in tutta la regione, costretti a dormire in tensostrutture senza riscaldamento in mezzo alla campagna della bassa padovana. “Non si possono tenere ragazzi giovani, che hanno vent’anni, in un lager”, dice. “A Mira ci sono dei centri d’accoglienza, ma non ci sono stati problemi, perché sono piccole strutture dentro la città e i migranti si sono integrati bene”, continua Lino, che critica duramente il modello d’accoglienza più diffuso in Veneto, quello dei grandi centri in cui sono concentrati migliaia di richiedenti asilo.
“Se ogni comune del Veneto desse ospitalità a un piccolo gruppo di migranti, non ci sarebbe problema e invece ognuno vuole curare il suo orticello. Ma che futuro stiamo dando ai nostri figli se gli insegniamo a non accettare l’altro?”, chiede l’uomo, mentre si sistema la coppola di tweed sulla testa per ripararsi dall’umidità pungente di metà novembre. Intanto un gruppo di ragazzi è seduto sulla panchina davanti alla canonica, altri giocano a ping pong. Stanno aspettando che arrivino i pullman della prefettura per trasferirli nei nuovi centri a Verona e a Treviso.

Meglio dormire per strada
“Vivevamo in tende di plastica a Cona, freddissime d’inverno e caldissime d’estate”, spiega Ahmad, un richiedente asilo di 23 anni che viveva nel campo da quasi un anno. L’ultima protesta è scoppiata con l’arrivo dell’inverno, quando alcune stufe si sono rotte e non sono state sostituite. “Per me è meglio dormire per strada che stare in quelle condizioni, avevo raggiunto il limite”, continua Ahmad, che tiene le braccia conserte e saltella per riscaldarsi.
“Siamo stati fermati dalla polizia appena usciti dal campo, poi abbiamo ripreso a camminare il giorno successivo. Abbiamo dormito nella parrocchia di Codevigo. Poi abbiamo marciato fino a quando la polizia ci ha fermato di nuovo a Campolongo e ha portato i rappresentanti del gruppo in questura. Ma noi non avevamo intenzione di tornare indietro”, dice. Per il ragazzo, oltre alle condizioni precarie del campo, uno dei problemi dell’ex base militare è la lontananza dalla città e dalle attività produttive.
“Ci volevano quaranta minuti per arrivare alla prima fermata dell’autobus da Conetta e poi almeno un’ora di autobus per andare a Padova, che è l’unica città in cui avremmo potuto trovare lavoro”, spiega Ahmad in un inglese fluente che ha imparato a scuola in Costa d’Avorio, dove si è diplomato in ragioneria. È d’accordo con lui anche Daniel Eruenga, nigeriano originario di Benin City, che dice schietto: “Non siamo venuti in Europa per dormire tutto il giorno in un campo, vogliamo lavorare, contribuire all’economia, vogliamo pagare le tasse in questo paese”.
Eruenga stava spesso male a Conetta: “Siamo sani, ma a forza di stare al freddo, ci ammaliamo, e quando ci sentivamo male non ci davano medicine e non ci portavano all’ospedale. Ci davano una pasticca di paracetamolo per qualsiasi tipo di problema”. Gbenge, un altro richiedente asilo della Costa d’Avorio, ricorda Sandrine Bakayoko, la ragazza morta all’inizio dell’anno: “Era una splendida persona, era così giovane e bella, la sua morte non me la posso spiegare”. Dieci mesi dopo quella morte nell’ex base militare di Cona non è cambiato niente.
Bakayoko era arrivata in un porto siciliano nel settembre del 2016, poi con il marito Mohamed era stata trasferita in uno dei centri per migranti più grandi del Veneto. Era in attesa che la sua richiesta d’asilo fosse esaminata. È morta da sola mentre era nel bagno.
A dare l’allarme è stato il marito, che l’ha trovata in fin di vita. Secondo il referto dell’autopsia si è trattato di una tromboembolia polmonare bilaterale fulminante. La morte della ragazza ha scatenato una protesta dei richiedenti asilo ospitati nel centro, che hanno accusato i gestori di aver chiamato i soccorsi in ritardo. Secondo i testimoni, infatti, la ragazza si è sentita male intorno alle 7, ma i soccorsi sono arrivati diverse ore dopo.
In una nota, però, l’ospedale di Piove di Sacco ha detto che i mezzi di soccorso sono partiti subito dopo aver ricevuto la chiamata. Gli operatori del centro, spaventati dalle proteste, si sono barricati in un container e negli uffici amministrativi della struttura. La protesta è durata ore, venticinque operatori sono rimasti chiusi in un container fino alle due di notte, quando la situazione è tornata tranquilla.
A Conetta c’erano già state delle proteste in passato da parte dei migranti che si lamentavano del freddo, delle camerate sovraffollate, della mancanza di docce, dei servizi igienici inadeguati, della scarsità dei pasti, e del fatto che era impossibile frequentare corsi di italiano e raggiungere i posti di lavoro. Una delegazione della campagna LasciateCIEentrare aveva visitato il centro nel giugno del 2016 e lo aveva descritto come una “tendopoli nel nulla”. Al coro delle proteste si è aggiunta anche quella del sindaco di Cona, Alberto Panfilo, eletto nel 2014 con una lista civica di centrodestra: “La realtà è che questa gente è costretta a vivere dentro una tenda. Quando la tenda si riempie, la comunità che ha in gestione l’accoglienza ne pianta un’altra. E tutto questo avviene nell’oblio più completo”.
L’integrazione impossibile
Le condizioni preoccupanti del centro erano state oggetto di un’interrogazione del parlamentare di Sinistra italiana Giovanni Paglia nel novembre del 2016, rivolta all’allora ministro dell’interno Angelino Alfano. Nell’interrogazione Paglia descriveva “condizioni di soggiorno difficilmente compatibili con la parola accoglienza” e avvertiva che la situazione sarebbe potuta “degenerare in qualsiasi momento”. L’Associazione studi giuridici sull’immigrazione nel gennaio del 2017 aveva denunciato, inoltre, la presenza di almeno trenta minorenni nella struttura e ha portato il caso di tre di loro davanti alla Corte europea dei diritti umani (Cedu).
Le denunce, tuttavia, sono state ignorate e il centro di Conetta ha continuato a funzionare a pieno regime. Quando è morta Sandrine Bakayoko il centro ospitava circa 1.300 persone, quasi 800 in più delle 542 che avrebbe potuto accogliere. Nell’estate del 2017 sono stati censiti nel centro 1.400 profughi. Una delle ragioni del sovraffollamento di centri come questo è che i comuni del Veneto non danno disponibilità all’apertura di centri di accoglienza per richiedenti asilo: meno del 50 per cento dei comuni della provincia di Venezia ha aderito al Sistema nazionale per richiedenti asilo e rifugiati (Sprar), quindi spesso i migranti sono mandati dai prefetti in centri d’accoglienza straordinari (Cas): hotel ed ex caserme riconvertite.
Il prefetto di Venezia Carlo Boffi, responsabile del centro di Cona, visitando i richiedenti asilo dopo la protesta il 15 novembre ha fatto appello ai sindaci della zona: “Rinnovo ancora l’appello a tutti i sindaci della città metropolitana di collaborare a individuare nuove piccole strutture per l’accoglienza di queste persone. Più si spalmano sul territorio e meno problemi ci sono”.
I grandi centri, infatti, non sono adatti a ospitare centinaia di persone per lunghi periodi di tempo e sono molto lontani dai centri abitati. La cooperativa che gestiva l’ex base di Conetta, la Ecofficina-Edeco di Padova, è una realtà importante dell’assistenza ai profughi in Veneto, è entrata nel settore nel 2011 e da allora gestisce tre strutture di accoglienza: Bagnoli a Padova, Cona a Venezia, Oderzo a Treviso. La cooperativa, però, è al centro di tre indagini delle procure di Rovigo e di Padova. Le accuse sono truffa, falso e maltrattamenti.
La procura di Padova sta indagando su un buco in bilancio da 30 milioni di euro nelle casse di Ecofficina-Edeco per un presunto scambio di denaro tra la cooperativa e la società Padova Tre, che si occupa della raccolta dei rifiuti. Le altre due indagini riguardano: una denuncia per maltrattamenti e soprusi e la falsificazione di alcuni documenti per aggiudicarsi una gara di appalto.
Come ha mostrato l’inchiesta Mafia capitale, il sistema d’accoglienza italiano che prevede un doppio binario (uno ordinario e uno straordinario), rischia di alimentare fenomeni di cattiva gestione, perché non ci sono protocolli efficaci di monitoraggio dei centri quando si agisce con la procedura di emergenza. Molti specialisti, come Gianfranco Schiavone dell’Asgi, hanno sottolineato che l’unica possibile alternativa ai grandi centri è il ricollocamento diffuso dei profughi sul territorio nazionale con il coinvolgimento dei comuni nell’assistenza e l’applicazione degli standard e dei controlli previsti dal sistema centrale di accoglienza. Nel 2016 appena il 19 per cento dei richiedenti asilo accolti in Italia era ospitato da un centro Sprar. Se tutti gli ottomila comuni italiani partecipassero all’assistenza dei profughi, ogni centro dovrebbe ospitare al massimo una ventina di persone e il sistema sarebbe più sostenibile.
Di nuovo in marcia
“Moraglia giuda, l’euro il tuo dio”, c’è scritto sullo striscione di Forza Nuova affisso sulle pareti del patriarcato di Venezia per contestare la richiesta di accoglienza fatta dai vertici della curia veneziana, che il 17 novembre ha aperto la strada al ricollocamento dei profughi su tutto il territorio regionale. Secondo Federico Fornasari del Coordinamento nazionale dell’Unione sindacale di base (Usb), il modello di accoglienza del Veneto alimenta il razzismo e soffia sul fuoco della guerra tra poveri. “Le forze di estrema destra e la Lega nord giocano molto su questo clima di diffidenza e paura che si crea quando ci sono situazioni come quelle di Cona”, afferma Fornasari.
Intanto il 20 novembre altri cinquanta richiedenti asilo sono usciti dall’ex base militare di Conetta, pronti a mettersi in marcia verso Venezia come hanno fatto gli altri duecento qualche giorno prima. “Sono stati bloccati di nuovo dalla polizia, ma ormai è chiaro che anche chi è rimasto nel centro non vuole tornare indietro e fare finta di niente”, spiega il rappresentante sindacale, che ha seguito la marcia fin dall’inizio e ha condotto la mediazione tra i profughi e le autorità locali.
“Ormai sono due anni che seguiamo la situazione a Cona chiedendo dei miglioramenti sostanziali nel campo. Nulla di tutto questo è mai avvenuto, quindi alla fine abbiamo preso atto che quel campo non si può cambiare e oltre alle condizioni materiali c’è una questione che riguarda la qualità della vita e dell’integrazione di queste persone. Un campo come quello di Cona è in contrasto con la normativa europea sull’accoglienza. L’integrazione può avvenire solo in una condizione in cui i diritti sono riconosciuti sia ai migranti sia agli abitanti del posto”, conclude Fornasari.
“Il centro di Cona non lo possiamo considerare un centro d’accoglienza”, aggiunge Barbara Barbieri di Melting Pot Europa. “Le condizioni di vita sono terrificanti e sono anni che lo denunciamo. Lo sforzo della prefettura di spostare piccoli gruppi non è stato sufficiente”. Il centro deve essere chiuso.
Il 23 novembre i parlamentari Giulio Marcon, Davide Zoggia e Michele Mognato visiteranno la base, chiedendo al prefetto di superare questo modello d’accoglienza il prima possibile. Intanto a Cona i richiedenti asilo hanno ripreso la marcia: poche cose caricate sulle biciclette, valigie sulla testa, coperte avvolte intorno alle spalle per ripararsi dal freddo umido della bassa. Prima tappa Piove di Sacco. “Nel campo di Cona si muore”, hanno scritto i migranti su un pezzo di cartone.

Corriere della Sera e la Nuova Venezia,
«COSÌ ABBIAMO AIUTATO
I MIGRANTI IN MARCIA»
di Gian Guido Vecchi
«Venezia, il patriarca Moraglia: evitata l’emergenza umanitaria. Già ricollocate 150 persone»
Che effetto le ha fatto vedere questi esseri umani in marcia?
«Era un’immagine quasi biblica. Procedevano lungo l’argine, i volti provati. Non esprimevano rabbia. Piuttosto, avevano l’aspetto di persone che domandano essenzialmente dignità, il riconoscimento della loro condizione umana. Un popolo in marcia che chiede di essere considerato per ciò che ci accomuna e unisce come esseri umani».
 Francesco Moraglia, patriarca di Venezia, l’altra notte ha salvato una situazione che stava diventando disperata. Più di duecento migranti in cammino da giorni, via dal cosiddetto «centro di accoglienza» ricavato nell’ex base missilistica di Conetta, nella campagna veneziana, una frazione di 190 anime dove sopravvivono ammassati milletrecento «richiedenti asilo» o forse di più, nessuno sa il numero reale. Una marcia verso Venezia per i diritti e la dignità che rischiava di finire male. Il freddo, la fame, nessun posto dove stare. Ieri pomeriggio la prefettura ha infine annunciato una soluzione, 151 sono partiti in pullman per altri alloggi «sparsi nel territorio regionale», per altri 90 «si sta lavorando». Ma la sera prima, lungo il Brenta, c’è stato un momento in cui non si sapeva che fare. Finché in prefettura è arrivata la telefonata del patriarca.
Francesco Moraglia, patriarca di Venezia, l’altra notte ha salvato una situazione che stava diventando disperata. Più di duecento migranti in cammino da giorni, via dal cosiddetto «centro di accoglienza» ricavato nell’ex base missilistica di Conetta, nella campagna veneziana, una frazione di 190 anime dove sopravvivono ammassati milletrecento «richiedenti asilo» o forse di più, nessuno sa il numero reale. Una marcia verso Venezia per i diritti e la dignità che rischiava di finire male. Il freddo, la fame, nessun posto dove stare. Ieri pomeriggio la prefettura ha infine annunciato una soluzione, 151 sono partiti in pullman per altri alloggi «sparsi nel territorio regionale», per altri 90 «si sta lavorando». Ma la sera prima, lungo il Brenta, c’è stato un momento in cui non si sapeva che fare. Finché in prefettura è arrivata la telefonata del patriarca.
Che cosa è successo, eccellenza?
«Nel pomeriggio ho sentito che la situazione cominciava a diventare preoccupante. Si annunciavano ore di tensione e qui, di notte, inizia a fare molto freddo. Ho sentito i parroci della zona di Mira uno ad uno, ho chiesto loro se potevano individuare degli spazi dove accogliere queste persone, almeno in questa fase di emergenza. Tutti mi hanno dato la piena disponibilità. Così ho mandato il mio vicario sul posto, si è mossa la Caritas e la “macchina” diocesana. E ho chiamato il prefetto: cosa possiamo fare per evitare che la situazione esploda e diventi un’emergenza umanitaria e sociale?».
Come si è riusciti a risolvere la faccenda in poche ore?
«Grazie alle nostre strutture diocesane e ai volontari, non soltanto ma soprattutto giovani: scout, associazioni. Alla fine abbiamo ospitato 212 persone: 55 a San Nicolò di Mira, 45 a Gambarare, 45 a Borbiago, 47 a San Pietro di Oriago e altri 20 a Mira Porte. Si sono recuperate le coperte, serviti i pasti. Dalla Protezione civile sono arrivati i bagni chimici. Abbiamo chiamato anche un medico. La notte è stata serena, hanno potuto mangiare e riposare».
Li avete accolti in vari luoghi. Com’è possibile che a Cona siamo ammassate più di mille persone?
«L’impegno delle istituzioni è indiscutibile, ma è chiaro che situazioni simili esasperano gli animi. Proprio pochi giorni fa, in vista della giornata mondiale dei poveri voluta da papa Francesco, avevo scritto una lettera alla Chiesa di Venezia che parlava di questi problemi: c’è bisogno che ognuno faccia la sua parte, non eliminando o accantonando difficoltà e problemi ormai “strutturali” per il nostro vivere, ma aiutando concretamente a risolverli».
E quindi?
«Nessuno - istituzioni, enti locali, politica, società civile, realtà ecclesiali - deve sottrarsi al senso profondo del proprio impegno e delle proprie responsabilità».
Bisogna trovare soluzioni diverse?
«Sì. In queste ore si è affrontata l’emergenza. Ma bisogna stare attenti a gestire i rapporti con il territorio. La nostra è una terra generosa che conosce i disagi e le speranze di chi migra. Possiamo vincere la sfida dell’accoglienza: creare una società inclusiva, capace d’incontrare gli altri anche davanti a diritti che configgono».
Che cosa intende?
«Intendo mettere in chiaro che i nostri diritti esistono come esistono quelli degli altri. C’è qualcuno che guarda ai migranti con aria di chiedere: perché venite da noi?».
Cosa direbbe a chi dice «tornate a casa vostra»?
«Che se queste persone hanno lasciato casa loro, lo hanno fatto con dolore e sofferenza, perché non c’erano le condizioni per vivere. Chi dice così dà una risposta che non corrisponde ad una realtà percorribile. Sono passati 50 anni dalla Populorum progressio di Paolo VI, dobbiamo anche domandarci come abbiamo trattato questi popoli».
E qual è la via percorribile?
«L’unica possibile, da un punto di vista umano e cristiano, è superare il conflitto: potremo salvaguardare sia i nostri diritti sia quelli degli altri, se sapremo metterci insieme».
la Nuova Venezia
«UNA GESTIONE FALLIMENTARE
BISOGNA PRESIDIARE I CONFINI»

«La non gestione delle frontiere ha portato a questo». Il sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro, è intervenuto sul "bubbone Conetta" e sulla situazione dei profughi dell'ex base militare. «Ho sempre detto che la questione sta nella non gestione delle frontiere, avevo già annunciato che sarebbe finita male, questo è l'ennesimo esempio». Ha proseguito il sindaco: «Quando accalchi la gente continuamente, la fai entrare in Italia quando tutti ti dicono che non ci stiamo davvero più, è evidente che dovremo fare qualche cosa. Con il ministro Minniti le cose stanno andando meglio, con il Prefetto lavoro benissimo, sono state brave le parrocchie, la gente che ha ospitato i profughi, ma è una questione di pura emergenza che non può assolutamente essere sedimentata così».
Il problema maggiore, per Brugnaro, è dunque la gestione delle frontiere, come ribadisce, e dei confini italiani che affacciano sull'acqua, e che sono aperti. «Il tema dell'integrazione lavorativa e del rilancio delle fabbriche serve a questo. «La situazione è molto complicata, ma non può essere che continuiamo a non affrontare i problemi veri, qualcuno deve assumersi la responsabilità di presidiare i confini, siamo l'unica nazione che ha i confini in acqua aperti». Poi aggiunge intervistato ai microfoni: «Bisogna dire agli africani che non si può più venire qui da noi, in Italia, è inutile illudere le persone, così come questa idea che si può fare tutto, anche questo non è più possibile». Il sindaco, insomma, ha ribadito la sua posizione, già espressa in più di un'occasione, sottolineando che il problema non è Venezia, che anzi parrocchie, Patriarcato, Diocesi e persone di buona volontà hanno fatto tutto quello che era nelle loro capacità e anche di più. Così come fa la Prefettura, ma che il problema è serio e urgente, sta a monte e va risolto alla radice gestendo in maniera diversa i confini e le frontiere.
la Repubblica,
«Dopo la morte di un giovane ivoriano, investito e ucciso da un’auto, gli ospiti dell’ex base Nato hanno ripreso il cammino verso la prefettura di Venezia: “Anche i cani vivono meglio di noi” Hanno passato la notte al riparo nelle chiese messe a disposizione dal Patriarca»
CODEVIGO ( PADOVA). Solo la disperazione, la mancanza di ogni speranza, può spingere duecento uomini carichi di masserizie a dirigersi a piedi, nel freddo e nella nebbia del Veneto a novembre, lungo l’argine del Brenta sperando di arrivare a Venezia. Cinquanta chilometri a piedi per parlare con il prefetto per convincerlo a chiudere il centro di accoglienza dell’ex base Nato di Cona e trovare un’altra sistemazione per le 1.300 persone che vi sono ospitate.
Sono partiti martedì, dopo l’ennesima discussione con la cooperativa che gestisce il centro: i responsabili hanno tolto ai migranti le stufette malfunzionanti che - o meglio che dovrebbero - riscaldare le tende nelle quali sono ospitati. Questioni di sicurezza che, però, hanno scatenato una nuova protesta.
Dopo aver appreso la notizia della morte di uno di loro, investito da un’auto mentre attraversava al buio una strada provinciale a bordo della sua bici, i profughi hanno trascorso la notte nella chiesa di Codevigo, poco oltre il confine con la provincia di Padova, dove il parroco - grazie alle mediazione della Caritas - ha deciso di aprire le porte e li ha lasciati dormire tra i banchi dei fedeli.
Ieri mattina, poco dopo le 10, erano già di nuovo in marcia. Silenziosi, le coperte come scialli, gli asciugamani come copricapo. Un corteo aperto dai più politicizzati, assistiti dal sindacato Usb (Unione sindacati di base) e dai militanti di GlobalProject, seguiti dagli altri con gli zaini e i trolley sulla testa. In fondo una ventina di biciclette, cariche di pacchi, coperte, valige, come solo in Africa si usa. Un gruppo eterogeneo: vengono da Nigeria, Costa D’Avorio, Mali, Bangladesh, Pakistan, Libia, Marocco, Mauritania.
Tra i capi della rivolta c’è Camarà Alsane, 32 anni, ivoriano, da 18 mesi in Italia, parla bene l’italiano: «L’ho imparato con la gente di Cona. Non sono un migrante per la fame, al mio Paese mio padre è un uomo politico che lavorava con l’ex presidente, rischio la vita. Per questo sono scappato». La sua richiesta d’asilo è stata respinta e ora è in attesa del ricorso. Racconta le condizioni dell’ex base Nato di Cona, 540 posti regolamentari, 1.300 ospiti: nelle case stanno quelli della cooperativa, i migranti sono in 10 tende, 5 bagni, e 5 docce ognuna, acqua solo fredda, anche con questa temperatura. Come cibo, sempre pasta al pomodoro. «È l’ottava, nona volta che protestiamo. Niente cambia. Per questo abbiamo deciso di andare a farci sentire direttamente dal capo del centro di Cona, il prefetto di Venezia».
Promise Okospadt, 27 anni, nigeriano, è stato nei centri di detenzione in Libia e dice che Cona è come quelli: «In Italia, anche i cani vivono meglio di noi», sospira. Abu, 28 anni in Sierra Leone ha lasciato moglie e tre figli: «Sono venuto qui solo perché lì non potevo più vivere. Mi rivolgo alle Nazioni Unite, al Papa che è cristiano come noi: non torniamo indietro al centro di Cona, siamo trattati peggio degli schiavi-. Considerate che siamo esseri umani e trovate una soluzione». «Cona - spiega Keita Mamadi, 39 anni della Guinea - non è un centro, è una prigione. Ci prendono in giro: qualsiasi dolore abbiamo la cura è la stessa, sempre e solo paracetamolo».
Camminano con la pancia vuota, nel pomeriggio alcun abitanti di Piove di Sacco portano pacchi di biscotti e latte. La polizia in assetto antisommossa blocca la loro marcia con sei blindati dall’ora di pranzo fino al tramonto lungo l’argine del Brenta-Cunetta tra Bojon e Campolongo Maggiore.
Alle 15 arriva il prefetto di Venezia Carlo Boffi ma la mediazione non va a buon fine. «No Cona. No Cona», intonano nel corteo. Con il buio arrivano due pullman a prendere i manifestanti per portarli a Mira, a dormire nelle chiese di Gambarare e di Oriago e Mira, messe a disposizione del Patriarca di Venezia. Di lì lungo la riviera del Brenta tenteranno di arrivare fino a piazzale Roma attraverso il Ponte della Libertà.
I VOLTI

Il fatto quotidiano
Sono in marcia da tre giorni per protestare contro le condizioni di vita nel centro d’accoglienza di Cona (Venezia) e per non abbandonare la manifestazione hanno passato la notte nella chiesa parrocchiale di Codevigo (Padova). Il corteo in questo momento è fermo sull’argine del Brenta, nel Comune di Campolongo Maggiore, bloccato dalle forze dell’ordine: “Dicono le istituzioni che stanno lavorando per trovare una soluzione e non vogliono farci passare, ma nessuno vuole tornare a Cona”, spiegano i manifestanti. Una protesta silenziosa, colpita anche da una tragedia. Nella tarda serata del 15 novembre, un ivoriano di 35 anni che stava raggiungendo i compagni in bicicletta è morto dopo essere stato travolto da un’auto: un connazionale è rimasto invece ferito.
Il gruppo è diretto a Venezia dove intende incontrare il prefetto. Ieri pomeriggio è stato fermato nella zona di Codevigo. Il sindaco Annunzio Belan, d’accordo con la prefettura di Venezia, aveva cercato nella notte di convincere gli aderenti alla protesta, per la quasi totalità uomini, a salire all’interno di due autobus per evitare di dormire all’aperto, ma i migranti si sono rifiutati perché, hanno spiegato, la loro protesta avrebbe perso visibilità. Il vescovo ha quindi autorizzato l’apertura della chiesa e il gruppo è entrato all’interno dell’edificio religioso.
Mercoledì sera a Codevigo c’erano il parroco, don Michele Fanton, il direttore di Caritas Padova don Luca Facco e padre Lorenzo Snider, delegato dal vescovo per l’assistenza spirituale nelle basi di Cona e Bagnoli. “Abbiamo valutato la situazione in diretto collegamento con il vescovo, mons. Claudio Cipolla e con il parroco – spiega don Facco – per comprendere il perché di questa marcia. Ci siamo anche relazionati con le autorità del territorio, le forze dell’ordine e con il prefetto vicario. Sapendo che i ragazzi erano di passaggio e interagendo direttamente ed esclusivamente con loro, abbiamo aperto la chiesa per dare un ricovero caldo e sicuro per la notte”. Ma c’è stata una breve trattativa. “Prima di aprire le porte è stato concordato il comportamento e lo stile da tenere, di ordine e rispetto del luogo. La chiesa è rimasta riscaldata tutta la notte e sono stati aperti i servizi igienici del centro parrocchiale. Abbiamo anche pregato insieme per il ragazzo che era morto durante il tragitto ed è stato un momento molto intenso. I ragazzi si sono comportati con ordine e decoro e al risveglio hannosistemato e ripulito con estrema cura la chiesa”. Prima che ripartissero, la Caritas parrocchiale ha rifocillato i giovani con tè caldo. Ma quale è il giudizio della chiesa padovana di fronte allo scempio della base di Cona? “Da parte nostra – risponde don Facco – abbiamo sempre promosso l’accoglienza diffusa nel territorio, che è meno impattante e favorisce percorsi di integrazione. Comprendiamo la fatica e le ragioni del disagio di vivere in una hub, che dovrebbe essere di sosta temporanea e invece vede, purtroppo, tempi troppo lunghi. Le loro ragioni vanno comprese ma non strumentalizzate. Si devono trovare soluzioni di accoglienza sempre più qualificata, favorendo la microaccoglienza”.
I richiedenti asilo hanno lasciato l’ex base militare di Cona per protestare contro le cattive condizioni all’interno del centro di accoglienza. Il centro era già stato teatro di una rivolta scoppiata nel gennaio scorso in seguito alla morte della giovane Sandrine Bakayoko. In quell’occasione aveva fatto discutere anche per la vicinanza politica dei suoi gestori con il Nuovo Centrodestra di Angelino Alfano: un fenomeno molto diffuso tra centri d’accoglienza di tutta Italia. A gestire quello di Cona è la coop Ecofficina Edeco, presieduta da Gaetano Battocchio mentre l’amministratore delegato è Sara Felpati, moglie di Simone Borile, ex consigliere provinciale del Pdl – oggi vicino ovviamente a Ncd – ed ex vicepresidente di Padova Tre, la società che si occupa di rifiuti dal quale era nata la stessa coop nel 2011.
La stampa locale ha da tempo ribattezzato Ecofficina come la coop nasce la coop “pigliatutto dell’accoglienza“, come l’ha ribattezzata la stampa locale. La società, infatti, gestisce tre centri d’accoglienza e in soli quattro anni ha visto esplodere il proprio fatturato: dai 114 mila euro del 2011 ai 10 milioni del 2015. Nel frattempo sono arrivate le inchieste giudiziarie – ben tre – per truffa, falso e maltrattamenti, e la fatwa di Confcooperative, che nel settembre del 2015 ha sospeso Ecofficina. Il motivo? “Fanno troppo business” ha spiegato Ugo Campagnaro, il presidente delle coop bianche.
Qui il link alla pagina, dove potete leggere tutti i commenti. Qui qualche esempio:
"Caricateli su un barcone e riportasteli in Libia, li staranno sicuramente meglio, e non avranno modo di lamentarsi" (gerry d)
"Rispediamoli seduta stante il Libia. Li si che ci sono dei resort a loro misura. Mangiare e dormire, wifi e qualche soldino in saccoccia, il tutto a spese di pantalone, evidentemente non sono sufficienti per questi choosy aspiranti afro-qualcosa con cellulare e cuffiette!" (Temolo56)
"Sediziosi e ribelli. Che devono ricevere il trattamento consono a sediziosi e ribelli e pure mantenuti. Mi vergognp per il prefetto e il questore che si genuflettono e si umiliano a sedersi attorno ad un tavolo a trattare con questi malviventi" (Lapasoa3 )
Corriere della Sera,
Bruxelles. L’organizzazione delle Nazioni Unite mette sotto accusa l’Unione Europea e l’Italia, che hanno frenato gli arrivi di immigrati in Europa finanziando le autorità della Libia per bloccarli o riaccettarli sul suo territorio. La dura denuncia dell’Alto commissario Onu per i diritti umani, il giordano Zeid Raad Al Hussein, sui «terrificanti» campi di detenzione per migranti in Libia è stata ulteriormente drammatizzata da un video-choc diffuso dalla tv Usa Cnn su migranti venduti all’asta come schiavi in Libia. Al punto che la Commissione europea ha chiesto la chiusura di queste prigioni e il presidente dell’Europarlamento Antonio Tajani ha annunciato per oggi la costituzione di una delegazione di eurodeputati da inviare in Libia per verificare le violazioni dei diritti umani.
«Orrori inimmaginabili» hanno sconvolto gli osservatori Onu quando hanno visitato a Tripoli quattro centri di detenzione per migranti gestiti dal Dipartimento per la lotta all’immigrazione illegale del ministero dell’Interno libico. «La sofferenza dei migranti detenuti in Libia è un oltraggio alla coscienza dell’umanità», ha protestato Al Hussein in un comunicato, dove ha definito «disumana» la politica della Ue e dell’Italia di finanziare le autorità libiche, perché «rischia di condannare molti migranti a una prigionia arbitraria e senza limiti di tempo, esporli alla tortura, allo stupro, costringerli al lavoro, allo sfruttamento e al ricatto». L’invito è a «non essere testimoni silenti della schiavitù moderna, di stupri e altre violenze sessuali, di uccisioni fuorilegge per evitare che persone disperate e traumatizzate raggiungano le coste dell’Europa».
La Commissione europea ha replicato ammettendo che «i centri di detenzione in Libia debbono essere chiusi» perché «la situazione è inaccettabile». Ha aggiunto che «l’Ue sta proseguendo gli sforzi per sostenere la creazione di un processo standard da parte delle autorità libiche attraverso il quale i migranti, soccorsi dalla guardia costiera libica, siano sbarcati e portati in centri di accoglienza che corrispondano agli standard umanitari internazionali». Il commissario Ue per l’Immigrazione, il greco Dimitris Avramopoulos, ha condiviso «la necessità di migliorare urgentemente» le condizioni dei migranti in Libia e ha detto che «proteggere vite ed assicurare un trattamento umano e dignitoso a tutti lungo le rotte migratorie resta la nostra priorità condivisa, dell’Ue e dei suoi Stati membri, in particolare dell’Italia». Il governo italiano si è difeso tramite la Farnesina sostenendo che «sono mesi che chiediamo a tutti i player coinvolti di moltiplicare l’impegno e gli sforzi in Libia per assicurare condizioni accettabili e dignitose alle persone presenti nei centri di accoglienza».
Tajani ha definito «assolutamente inaccettabile» quanto accade in Libia. «L’azione forte contro l’immigrazione illegale non può essere confusa con la violazione dei diritti umani - ha spiegato -. Tutto ciò che si deve compiere deve essere fatto nel rispetto dei diritti delle persone». I missionari comboniani, in base alla loro lunga esperienza assistenziale in Africa, hanno denunciato che la comunità internazionale «dimentica troppo facilmente che spesso le oligarchie locali africane sono al soldo di potentati stranieri (cinesi, americani, europei)» e che «gli sbarchi sono il drammatico risultato di politiche di sfruttamento umano e ambientale del continente».

Avvenire
C'è un filmato di oltre 30 minuti che lascia pochi dubbi sull'operarto della Guardia Costiera libica nell'incidente in mare costato la vita a una cinquantina di migranti. Il video esclusivo di Sea Watch, l'ong tedesca che con la sua nave era stata inviata sul posto dal Centro di coordinamento dei soccorsi di Roma, ha ripreso momento per momento l'intervento compiuto a circa 30 migla e dalle coste libiche.
 |
| Migranti venduti come schiavi a Sahba. Le drammatiche storie raccolte dall'Oim |
Come già raccontato da Avvenire nei giorni scorsi
si vedono i militari libici picchiare i sopravvissuti sul ponte della motovedetta. Sono immagini forti. Maltrattamenti da cui alcuni migranti cercano di sfuggire gettandosi nuovamente in mare. Le urla di donne e bambini lasciano senza fiato. Se la strage non è stata ancora peggiore lo si deve non solo alla presenza di Sea Watch ma a un elicottero della Marina Militare italiana inviato nella zona e che ha sorvegliato l'intera operazione. Una presenza che ha parzialmente fatto da deterrente. Fino a quando i libici, con i motori avanti tutta, riprendono la rotta verso Tripoli con un uomo di colore rimasto aggrappato alla scaletta esterna. La coraggiosa manovra compiuta dall'elicotterista italiano sembrava più simile ad un'azione in dase di combattimento che non a una normaale pattugliamento a ridosso di mezzi alleati, come dovrebbero essere quelli libici. Il velivolo della Marina dopo avere osservato la scena, insegue la motovedetta libica ordinando al comandante di fermare i motori, ma questi al contrario compie una brusca virata. A quel punto l'elicottero si mette di traverso puntando il muso verso la motovedetta, che dopo qualche istante riprende la rotta. L'uomo rimasto impgigliato nella scaletta, però, è sparito. Le telecamere di Sea Watch non riescono a riprenderne il salvataggio e, assai probabilmente, il migrante è morto annegato.
La polizia di Ragusa ha raccolto numerose testimonianze ma non è stato ascoltato l'unico volontario italiano, Gennaro Giudetti, membro del team di soccorso della Sea Watch. Nel corso di una intervista a Radio Radicale Giudetti ha raccontato di avere assistito a una vera strage. E nel parapiglia in acqua, a pochi metri dalla motovedetta libica, «ho dovuto scegliere chi salvare e chi lasciare affogare. Non è giusto», ha detto il 26enne.
Domani Sea Watch terrà una conferenza stampa per spiegare in dettaglio l'accaduto. Elementi che potrebbero venire acquisiti dai magistrati ragusani nel caso in cui decidessero di aprire un'inchiesta sul naufragio che ha portato alla morte di almeno 50 persone.

a Repubblica, 14 novembre 2017.«Il gip nega l’archiviazione per la strage di migranti dell’11 ottobre 2013 Smentita la versione della Marina: “Non ordinò alla Libra d’intervenire”. 268 i morti nel naufragio dell’11 ottobre 2013: 60 erano bambini in fuga dalla Siria»
SUL naufragio dei bambini c’erano due verità. Quella riferita dalla Marina militare al Parlamento. E quella dei papà sopravvissuti al massacro, raccontata nel film-inchiesta “Un unico destino”, prodotto da Espresso e Repubblica con 42° Parallelo e Sky. Ieri mattina il giudice per le indagini preliminari di Roma, Giovanni Giorgianni, ha dimostrato che la versione consegnata dai militari alla massima istituzione della Repubblica non è vera.
È l’effetto più evidente della decisione del Tribunale, che ha respinto la richiesta di archiviazione della Procura e accolto gran parte del ricorso degli avvocati delle vittime, Alessandra Ballerini, Emiliano Benzi e Arturo Salerni: le 268 persone annegate nel naufragio dell’11 ottobre 2013, tra cui sessanta bimbi in fuga dalla Siria, potevano e dovevano essere salvate. Per questo il giudice ha stabilito l’imputazione coatta, cioè la necessità di un processo, per due alti ufficiali in servizio quel giorno e un supplemento di indagini per la comandante di nave Libra, l’allora tenente di vascello Catia Pellegrino, 41 anni, famoso volto immagine della Marina.
Omicidio colposo e omissione d’atti d’ufficio, i reati contestati. Una decisione inevitabile, che riaccende le preoccupazioni su quanto sta ora accadendo in mare tra la Libia, Malta e l’Italia: le regole d’ingaggio sono praticamente le stesse.
Sono passati quattro anni dal naufragio dell’11 ottobre. Ma i muri di gomma costruiti intorno a quel pomeriggio hanno rinviato a oggi la resa dei conti giudiziaria. La ministra della Difesa, Roberta Pinotti, ha assicurato massima collaborazione e trasparenza alle indagini. E così si è espresso l’attuale capo di Stato maggiore della Marina, Valter Girardelli. Ma nella lunga catena di comando fino al mare, non tutti i sottoposti condividono la linea. Questa era infatti la versione ufficiale comunicata al Parlamento il 17 maggio scorso: «La Marina riferisce che, appena informata dalla centrale operativa del comando generale del Corpo delle capitanerie di porto delle attività di ricerca e soccorso in atto, a cura del centro di coordinamento del soccorso marittimo maltese, ha disposto di propria iniziativa che nave Libra, distante circa quindici miglia nautiche dal natante in difficoltà, si dirigesse verso il punto segnalato».
Il provvedimento del giudice Giorgianni depositato ieri, dopo l’udienza tra le parti del 27 ottobre, dimostra una realtà molto diversa: dalle 16.22 di quel giorno la Marina militare e la Guardia costiera non solo non hanno disposto ma hanno respinto le richieste telefoniche e via fax di Malta che sollecitava l’impiego immediato del pattugliatore comandato da Catia Pellegrino. La Libra era la nave più vicina: 15 miglia corrispondono a meno di un’ora di navigazione. «È evidente », scrive il gip, «come un ordine immediato di procedere alla massima velocità in direzione del barcone dei migranti... emesso subito dopo la ricezione del fax delle 16.22 avrebbe permesso a nave Libra di giungere sul punto in cui si trovava il barcone con ogni probabilità anche prima del suo ribaltamento o, in ogni caso, in un momento che avrebbe consentito di contenere quanto più possibile le devastanti conseguenze». La Libra, pur essendo a meno di venti miglia, è arrivata alle 18, ormai al tramonto: cinquantatré minuti dopo il rovesciamento e 5 ore e 34 minuti dopo la prima richiesta di soccorso. Nel frattempo, dei 480 passeggeri finiti in acqua, 268 sono annegati.
L’ordine alla Procura perché formuli la richiesta di rinvio a giudizio è stato disposto nei confronti dell’allora comandante della centrale operativa della Squadra navale della Marina, il capitano di fregata Luca Licciardi, 47 anni: è l’ufficiale che si sente ordinare alla Libra di allontanarsi perché, letterale, «non deve stare tra i coglioni quando arrivano le motovedette» maltesi. Il secondo ufficiale per cui si chiede il processo è il responsabile della sala operativa della Guardia costiera, il capitano di vascello Leopoldo Manna, 56 anni: «Dopo la espressa richiesta di utilizzo di nave Libra da parte di Malta, non emette l’ordine di far intervenire la nave da guerra italiana». Supplemento d’indagini per la comandante Pellegrino: il gip ordina alla Procura di valutare le testimonianze dei piloti dell’aereo militare maltese che avrebbero supplicato la Libra sul canale radio delle emergenze, senza ottenere risposta. Accolta l’archiviazione per gli ufficiali della Guardia costiera, Clarissa Torturo e Antonio Miniero, per il capitano di fregata Nicola Giannotta, diretto sottoposto di Licciardi, e per l’allora comandante in capo della Squadra navale, ammiraglio Filippo Maria Foffi. Da adesso l’inchiesta ha un nuovo inizio.
Tra le accuse l’omicidio colposo. Chieste ulteriori indagini per la comandante Pellegrino
268
I morti nel naufragio dell’11 ottobre 2013: 60 erano bambini in fuga dalla Siria
Qui sopra, Besher Dahhan, un anno, con i suoi fratelli Mohamed, 8 anni, e Tarek, 4 anni, dispersi in mare nel naufragio dell’11 ottobre 2013 e mai più ritrovati. A sinistra, nave Libra, il pattugliatore della Marina militare che a
 Noi italiani, obbedienti a Minniti, abbiamo ucciso ieri cinquanta fuggitivi dai paesi che noi abbiamo ridotto a inferni per pagare il nostro benessere. Li abbiamo ammazzati con le armi che abbiamo regalato ai nostri alleati libici per liberarci dal fastidio dei migranti
Noi italiani, obbedienti a Minniti, abbiamo ucciso ieri cinquanta fuggitivi dai paesi che noi abbiamo ridotto a inferni per pagare il nostro benessere. Li abbiamo ammazzati con le armi che abbiamo regalato ai nostri alleati libici per liberarci dal fastidio dei migranti
«
THIS IS ITALIAN Navy helicopter, channel 16, we want you to stop now, now, now».
L’elicottero della Marina italiana volava basso in tondo e provava a fermare la motovedetta libica mentre John moriva, trascinato via a folle velocità, sospeso in aria sul mare, una mano disperatamente attaccata alla cima e l’altra protesa verso la moglie, ormai in salvo sul gommone della Sea Watch.
«Lui era lì, sul ponte della barca e gridava verso di me. I libici lo picchiavano con delle corde, lo prendevano a calci, poi l’ho visto scavalcare e buttarsi in acqua. È andato giù, l’ho visto riemergere, era riuscito a riaggrapparsi alla fune sul fianco della motovedetta. Gridava: “aspettatemi, aspettatami, aiuto, non lasciatemi qui…”. Ma a un certo punto i libici hanno riacceso il motore e la barca ha fatto un balzo in avanti trascinando via lui e tutti gli altri che stavano ancora in acqua. E non l’ho più visto. John non sapeva nuotare, era salvo ma è morto perché voleva raggiungere me che ero già in Italia».
Darfish piange senza sosta, in ospedale a Modica, mentre riavvolge il tragico film che lunedì mattina ha cambiato per sempre la sua vita. Lei, sul gommone della nave umanitaria tedesca, dunque «già in Italia », suo marito, a bordo della motovedetta della Guardia costiera, dunque destinato a tornare in Libia. Viaggio di andata e ritorno all’inferno. Di nuovo in prigione, di nuovo torture, violenza, un nuovo riscatto da pagare per riprovarci ancora. Una prospettiva agghiacciante anche per chi, come questa giovane coppia camerunense, è sopravvissuto alla traversata nel deserto, alla prigionia nella connection house e persino al naufragio di quel gommone davanti al quale il destino ha aperto loro le “sliding doors” del Mediterraneo. Un drammatico soccorso conteso tra i libici e le Ong che, per la prima volta da quando sono entrati in vigore gli accordi tra il governo italiano e quello di Al Serraj, ha aperto gli occhi dell’Europa sulla roulette russa a cui è affidato il destino delle migliaia di persone che ancora tentano la traversata nel Mediterraneo.
Un incidente che avrebbe fatto una cinquantina di dispersi e sul quale adesso indaga la Procura di Ragusa. Nei prossimi giorni i pm vaglieranno le testimonianze dei 59 superstiti portati a Pozzallo dalla Sea Watch insieme al corpicino del bimbo di due anni, annegato sotto gli occhi della madre, e a quelli delle altre quattro vittime recuperate e trasferite a bordo di un’altra nave umanitaria, la Aquarius di Sos Mediterranèe. Dovranno stabilire se su queste morti vi siano delle responsabilità di qualcuno degli attori intervenuti nelle operazioni di soccorso che, coordinate dalla sala operativa della Guardia costiera di Roma, hanno dovuto fare i conti con il contemporaneo arrivo sul luogo del naufragio della motovedetta libica e della nave umanitaria.
L’Italia da una parte e la Libia dall’altra, il gommone semiaffondato in mezzo, tanti corpi galleggianti in acqua ma soprattutto decine di persone, che ormai in salvo sull’imbarcazione libica, si sono buttate in mare nel vano tentativo di raggiungere quei due gommoni che avrebbero aperto loro le porte dell’Europa. Terribili disperati minuti di caos spezzati dalla fuga in avanti della motovedetta libica che, dopo aver tentato di trattenere a bordo con minacce e violenze i migranti, ha riacceso i motori ripartendo a tutto gas verso Tripoli con 42 superstiti a bordo che imploranti tendevano le mani urlando verso mogli, figli, fratelli, sorelle da cui proba- bilmente sono stati divisi per sempre.
La scena, da girone dantesco, è rimasta impressa non solo nei racconti di chi ce l’ha fatta, ma anche nella scatola nera della Sea Watch che ora l’equipaggio della ong tedesca mette a disposizione degli inquirenti per andare a fondo nelle indagini. Il disperato grido partito dall’elicottero della Marina italiana presente sulla scena è tutto registrato nelle conversazioni sul canale 16 riservato ai soccorsi: «Guardiacostiera libica, questo è un elicottero della Marina italiana, le persone stanno saltando in mare. Fermate i motori e collaborate con la Sea Watch. Per favore, collaborate con la Sea Watch », l’invito inascoltato.
Nel racconto di Gennaro Giudetti, attivista italiano imbarcato sulla Sea Watch, tutto l’orrore di quei momenti: «Quando siamo arrivati sul posto c’erano già diversi cadaveri che galleggiavano e decine di persone in acqua che gridavano aiuto. Abbiamo dovuto lasciare stare i corpi per cercare di salvare più gente possibile. I libici ci ostacolavano in tutti i modi, per quanto incredibile possa sembrare, ci tiravano anche patate addosso. Loro non facevano assolutamente nulla, abbiamo dovuto allontanarci un po’ per non alzare troppo il livello di tensione e in quel momento abbiamo visto che sulla nave libica i militari picchiavano i migranti con delle grosse corde e delle mazze. In tanti si sono buttati a mare per raggiungerci e sono stati spazzati via dalla partenza improvvisa della motovedetta. È stata una cosa straziante. E la colpa è di tutti noi, degli italiani, degli europei che supportiamo questo sistema. Quelle navi libiche le paghiamo noi. Quando ho raccolto dall’acqua il corpo di quel bambino, ho toccato davvero il fondo dell’umanità ».

MIGLIAIA DI MIGRANTI IN ARRIVO,
DECINE DI MORTI
di Adriana Pollice
«Mediterraneo. Il numero crescente di sbarchi e tragedie smentisce il ministero degli interni. E la guerra alle Ong impedisce soccorsi rapidi ed efficaci. Partono da Tunisia e Algeria ma anche dalla Libia, Stato fallito con cui Roma ha stretto accordi»
Con il saluto d’onore degli ufficiali di bordo, ieri mattina sono sbarcate sul molo del porto di Reggio Calabria le salme di 5 donne e 3 uomini, tutti annegati. Erano sulla nave Diciotti della Guardia costiera e facevano parte del gruppo di migranti recuperati venerdì, in diverse operazioni, al largo delle coste libiche.
Ce l’hanno fatta a salvarsi in 765, tra i quali 112 minori (63 non accompagnati). Dal gruppo erano già stati prelevati con l’elicottero 14 ustionati gravi per contatto con il carburante dello scafo su cui erano stipati, tre talassemici e una bambina con dolori al petto.
Dopo le operazioni di rito, partiranno per i centri di accoglienza di undici regioni. Arrivano da 27 stati differenti, sparsi tra Asia e Africa, dal Pakistan al Nepal, dalla Somalia al Libano. Venerdì la nave militare spagnola Cantabria aveva incrociato al largo della Libia un gommone affondato con 64 sopravvissuti e 23 annegati.
Ieri il papa, in un discorso alle università cattoliche, si è augurato per il futuro una classe dirigente aperta ad accogliere: «Vorrei invitare gli atenei a educare i propri studenti, alcuni dei quali saranno leader politici, imprenditori e artefici di cultura, a una lettura attenta del fenomeno migratorio in una prospettiva di giustizia, di corresponsabilità globale e di comunione nella diversità culturale».
Sono stati 2mila i migranti soccorsi nel Mediterraneo tra lunedì e venerdì. Il ministro degli interni Marco Minniti, lo scorso week end alla conferenza programmatica del Pd, aveva vantato i risultati della sua politica in tema di blocco degli sbarchi: «Gli arrivi in Italia sono diminuiti del 30% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso e ci sono stati 8.500 rimpatri volontari assistiti».
Gli accordi con la Libia (incluse le milizie attive sul territorio) prevedono il blocco delle partenze e il contenimento dei flussi nei centri di detenzione locali (in condizioni terribili), in cambio di mezzi navali, addestramento, sostegno economico. Evidentemente il meccanismo si è rotto.
Questa settimana, infatti, la marina libica ha recuperato in diverse operazioni 900 migranti, tra questi anche sette cadaveri, al largo delle proprie coste ma le motovedette, invece di riportarli a terra, li hanno imbarcati su mezzi militari europei verso l’Italia.
La politica messa in campo da Minniti con le Ong non ha certo migliorato le cose. Il numero di soccorritori è drasticamente diminuito rendendo le operazioni più insicure.
Mercoledì la nave Aquarius di Sos Méditerranée ha dovuto sostenere quattro interventi in 18 ore, 588 naufraghi salvati: «Abbiamo soccorso un gommone con 108 persone a bordo e ci siamo preparati a soccorrere un secondo gommone. Prima che la nostra lancia arrivasse sulla scena, l’imbarcazione si è rotta e le persone hanno cominciato a saltare in acqua. Erano in molti in acqua. Abbiamo lanciato i mezzi di galleggiamento e stabilizzato la situazione. Anche se abbiamo fatto tutto quello che potevamo, non potremo mai essere sicuri che tutti siano stati salvati», ha spiegato Madeleine Habib, coordinatrice delle operazioni Search and Rescue dell’Aquarius. Impossibile sigillare le frontiere italiane anche sui fianchi est e ovest. Venerdì nel crotonese è riuscito ad approdare un barcone con 48 migranti.
A condurli sulle coste calabre, dietro il pagamento di 6mila dollari a testa, uno scafista russo, Timur Shirchenko, arrestato dalla polizia italiana. Ieri una motovedetta della guardia costiera siciliana ha intercettato una piccola barca con 23 persone a bordo: erano tutti algerini ed erano diretti in Sardegna. Tratti in salvo, sono stati trasportati nel porto di Calasetta, nel Sulcis. Ancora nel Sulcis, il giorno precedente, erano arrivati 38 algerini.
Si tratta delle cosiddette barche fantasma, natanti di ridotte dimensioni che da Algeria e Tunisia arrivano indisturbati sulle spiagge di Sicilia e Sardegna portando piccoli gruppi. La marina tunisina ieri ha bloccato 12 connazionali su uno scafo in avaria al largo di Sfax.
Ieri sono sbarcati nel porto di Taranto 324 migranti dalla fregata tedesca Mecklenburg. Stamattina a Salerno ne sono attesi 400, accanto ai superstiti ci saranno anche i cadaveri: 26 salme, tutte donne. Domani arriverà a Crotone la nave dell’Ong Proactiva Open Arms con 378 scampati al mare.
Il tema migrazioni entra nella campagna elettorale per le regionali siciliane con Forza Italia, in vantaggio nei sondaggi, che attacca il Pd: «Il tappo libico è saltato – dice il parlamentare Gregorio Fontana –, ci sono di nuovo i morti, gli sbarchi sono ripresi. Solo che vengono dirottati verso le coste pugliesi e calabresi per evitare che l’ennesimo fallimento dell’esecutivo vada a interferire con le elezioni siciliane. Il bluff governativo è venuto alla luce».
IN MILLE PEZZI
IL «CODICE MINNITI»
di Alessandro Del Lago
«Morti a mare. Minniti aveva dichiarato che con il codice di comportamento imposto alle navi di soccorso e gli accordi con i libici, «si cominciava a vedere la luce in fondo al tunnel». Quale luce e quale tunnel? La soluzione escogitata da Minniti l’Africano era semplice: scopare la questione dei migranti sotto il tappeto libico»
n naufragio in ottobre, quando le condizioni dl mare sono già pessime, 23 i morti recuperati. Probabilmente, molti di più i cadaveri scomparsi nelle vastità marine. 600 salvataggi in un solo giorno. Altri morti e centinaia di salvataggi sempre nel Canale di Sicilia negli ultimi tre giorni.
Le cronache riportano questi dati con una certa impassibilità, come se si trattasse di normali conteggi amministrativi o di statistiche demografiche. Ma c’è qualcosa che non torna. Anzi, molto.
Basta riandare allo scorso ferragosto alle parole del ministro degli interni Minniti, al culmine di una campagna condotta contro le Ong e alimentata da media e procure.
Minniti aveva dichiarato che con il codice di comportamento imposto alle navi di soccorso e gli accordi con i libici, «si cominciava a vedere la luce in fondo al tunnel». Quale luce e quale tunnel? La soluzione escogitata da Minniti l’Africano era semplice: scopare la questione dei migranti sotto il tappeto libico affinché le impaurite popolazioni italiche, soprattutto al nord, non avessero più preoccupazioni e anche – honni soit qui mal y pense («guai a chi pensa male» ) – per sottrarre voti a leghisti, berlusconiani e grillini, che sulla paura dei migranti stanno costruendo la loro fortuna elettorale.
E come sistemare la faccenda? Finanziando il governicchio di al Serraj a Tripoli, che controlla poco più di un fazzoletto di terra in riva al mare, e i signori della guerra anti-Isis. Noi vi diamo soldi e armi e vendiamo sottocosto un po’ di vedette. Voi in cambio, ci fermate i migranti, cioè li internate nei vostri campi.
E i migranti che, inevitabilmente, continueranno ad arrivare? Qui Minniti, coerentemente con la discrezione appresa occupandosi di servizi segreti, tace, gira la testa, glissa. Esattamente come hanno fatto tutti i suoi predecessori, primi ministri e dell’interno, da Amato in poi.
Anche i sassi sanno che rispedendo i migranti in Libia se ne condanna una buona percentuale a morte, e gli altri alle torture, agli stupri e all’inedia. La Libia non è un paese «safe», come esigono le ipocrite normative internazionali, ma un guazzabuglio di bande in cui tutti combattono contro tutti e l’Isis, sconfitto in Iraq e Siria, fa affluire i suoi uomini.
E gli scontri armati tra le centinaia di milizie libiche, dati per «finiti» in realtà sono ripresi proprio in questi giorni. Gli interlocutori del «patto» di Minniti si combattono fra loro.
Le denunce di Msf, Amnesty International ecc. sono incessanti. Persino l’Onu, solitamente cauta in materia, ha ammonito che con le limitazioni imposte alle navi delle Ong e gli accordi con la Libia i morti sarebbero aumentati, nel deserto e in mare. Silenzio delle istituzioni.
L’evidente motto di Minniti, occhio non vede e cuore non sente, ha funzionato per un paio di mesi, con qualche protesta delle Ong e sparse sparatorie in mare dei libici, che hanno invaso le acque internazionali per proteggere i propri interessi nell’affare. Finché, in questi giorni, gommoni e barconi hanno ricominciato a fare la spola e i migranti annegano.
Bisogna essere ciechi per non vedere che dai paesi sub-sahariani, con redditi annuali inferiori a quanto una media famiglia italiana spende in un mese in beni di prima necessità, centinaia di migliaia di migranti si metteranno in marcia verso il Marocco, la Libia, la Tunisia, l’Algeria, l’Egitto.
Se vengono fermati a una frontiera, cercano di passare da un’altra parte, come farebbe ognuno di noi nei loro panni. Bisogna essere ipocriti fino all’oscenità per continuare a blaterare di un piano Marshall per l’Africa che nessuno metterà mai in cantiere.
E bisogna essere trasparenti come funzionari dei servizi segreti per tacere che in Ciad, sud della Libia e Niger, per non parlare dell’Africa centro-occidentale, si combattono guerre con partecipazione occidentale (contro l’Isis, certo, ma soprattutto per il controllo delle materie prime e dell’influenza geopolitica).
Così, chi si mette in marcia per non morire di fame o in qualche bombardamento, finirà, se sopravvive, in qualche campo libico o tenterà, come sempre, la sorte in un gommone.
La luce infondo al tunnel vero, ministro Minniti?

Internazionale
Faccio e rifaccio il conto, ma non riesco a credere al risultato. Eppure è sempre lo stesso: nella mia vita, tra anni di pendolarismo e stagioni di viaggi frequenti, ho attraversato la stazione centrale di Bologna almeno diecimila volte. E non una di queste mi sono sentito in pericolo. Un forte disagio, invece, l’ho provato davanti alla campagna di stampa dell’estate 2017 che la dipingeva come un luogo da cui scappare a gambe levate, dove i viaggiatori sono vessati dalle pretese dei mendicanti e circondati da “una folla di disperati”. Cosa che, semplicemente, non è vera.
I poveri che gravitano attorno alla stazione lo fanno per cercare risposta a semplici necessità, come quella di trovare un bagno per lavarsi o un riparo tranquillo per la notte. E, ancora, la stazione è un luogo dove chiedere l’elemosina o proporsi come facchini. Al culmine di questa campagna, il sindaco Virginio Merola ha incontrato i rappresentanti del governo e delle Ferrovie dello stato italiane spa (Fs). Invece di respingere l’odiosa equiparazione della povertà con il crimine, dalla riunione è uscita la promessa di realizzare “in tempi rapidi [il] maxi progetto di adeguamento strutturale della stazione per filtrare gli accessi”. La stazione sarà dotata di gate, cioè di varchi presidiati che consentono l’accesso ai binari solo a chi ha un titolo di viaggio. Una soluzione già da tempo studiata dalla Rete ferroviaria italiana (Rfi, gruppo Fs) e auspicata dalla destra bolognese.
Il progetto è in perfetta continuità ideologica con il decreto Minniti, e ne condivide l’obiettivo di espellere le persone marginali dai luoghi della vita cittadina. Per capire come si manifesta concretamente decido di andare a vedere e attraversare i gate a Milano centrale, dove sono stati già da tempo istituiti. La loro inaugurazione risale al maggio del 2015, lo stesso giorno in cui apriva Expo.
Controllo dei biglietti e prevenzione del terrorismo
In vista della grande fiera del cibo era stata approvata una nuova legge antiterrorismo e Giuseppe Sala, allora commissario governativo della manifestazione, dichiarava che l’esposizione poteva diventare “un bersaglio ideale”. Rfi non faceva alcun riferimento esplicito al terrorismo, ma annunciava “stazioni più sicure” grazie ai varchi presidiati. Il sospetto che sia stata sfruttata la data significativa e il clima emergenziale per introdurre una novità potenzialmente sgradita resta un sospetto, ma legittimo.
Nel settembre successivo anche Roma Termini alzava muri di plexiglas prima dei binari, e i gate entravano esplicitamente nella narrazione delle misure antiterrorismo. Si arrivava a scrivere che, con i varchi, “Trenitalia vuole sia contrastare il terrorismo, sia garantire protezione per i viaggiatori e per i dipendenti”. Nel novembre 2015, dopo il sanguinoso attacco al teatro Bataclan, Striscia la notizia ha mandato in onda un servizio in cui metteva alla berlina l’azienda ferroviaria per i controlli non abbastanza severi ai gate di Milano e Roma. La sovrimpressione avvertiva che le riprese erano state fatte sia “prima” sia “dopo gli attentati di Parigi”. Così, tra musica da comiche e risate registrate, il filmato celebrava il matrimonio tra il controllo del biglietto e la prevenzione del terrorismo.
Eppure è evidente che questo nesso non ha alcun senso. Con poco più di due euro un terrorista può procurarsi un biglietto per Zagarolo o Monza, usarlo per attraversare indisturbato i varchi a Termini o a Milano centrale e, immediatamente dopo, aprire il fuoco o farsi esplodere. Ma perché poi dovrebbe agire proprio vicino ai binari, quando ha tutto il resto della stazione a disposizione? Perché non scegliere come obiettivo, per fare un esempio non casuale, le dense code che si formano nelle ore di punta proprio a causa del controllo dei biglietti presso i gate?
Ancora nell’agosto 2017, la parlamentare del Partito democratico Francesca Puglisi insisteva per l’istituzione dei varchi a Bologna, facendo esplicito riferimento alla strage del 2 agosto 1980. Un atto terroristico che ha visto in azione le più nere trame dell’Italia repubblicana e che nessuno, fin qui, si era azzardato ad associare al controllo dei biglietti. Ogni argine è travolto, anche il più banale buonsenso e la minima consapevolezza storica. A Bologna perfino un falso allarme bomba ha alimentato la campagna per i gate. Due taniche dimenticate su un treno, attribuite arbitrariamente da una passeggera a uno “straniero di colore” che aveva già lasciato il vagone, hanno fatto scattare un’allerta del tutto infondata.
Nero, probabilmente, anche l’uomo con il borsone ritratto in silhouette sul rendering delle Fs che annunciava i varchi a Firenze Santa Maria Novella. Dopo la denuncia del contenuto razzista l’immagine è stata ritirata, ma la vicenda ha tutto il sapore del lapsus. Al di là delle generiche “ragioni di security”, sono infatti proprio ambulanti, mendicanti e poveri che le Fs vogliono intercettare ed espellere dall’area dei binari. “Il progetto [di istituzione dei gate], elaborato dal Gruppo Fs italiane in collaborazione con le Forze dell’Ordine e le Istituzioni, mira ad aumentare la sicurezza dei passeggeri e a prevenire i fenomeni di evasione, accattonaggio, attività illecite e vendite abusive in prossimità e a bordo dei treni”, si legge su Fsnews.
I segni dell’esclusione
A Firenze una stazione mai realizzata è costata, secondo Il Post, quasi 800 milioni di euro; a Bologna lo scalo per l’alta velocità inaugurato nel 2013 ne è costati 530. Ed è considerato dalla stessa Rfi “un esempio critico, non appetibile dal punto di vista commerciale”, con conti a rischio e difficoltà logistiche. Davvero, in queste due città, quel che urge sono i gate? No, decisamente le motivazioni fornite da Fs non dicono tutto: i varchi ai binari, prima di essere una soluzione tecnica, sono un dispositivo sociale. Come vedo, e tocco con mano, appena arrivato a Milano centrale. Qui capisco che l’uomo con il borsone evocato dal rendering non è gradito in nessun angolo della stazione, non solo nella parte sigillata dai gate. Le panchine sono scarse e ostili a chi ha bisogno di riposo, con braccioli “anti-bivacco” che impediscono di sdraiarsi. Non c’è più la sala d’attesa, sostituita da negozi già nella ristrutturazione del decennio scorso. I bagni sono a pagamento e delle fontanelle non resta neppure il ricordo.
Torno ai binari per aspettare Michele Lapini. Michele viene per fotografare i segni dell’esclusione, le emergenze visibili della separazione sociale che parte dai varchi e corre fino all’esterno della stazione. Supero i gate con un biglietto qualsiasi. Dallo sguardo distratto dell’addetto ricavo l’impressione che essere bianco e decentemente vestito sia un titolo di viaggio che aiuta ad attraversarli senza rallentamenti. Negli orari di punta la fila però si ingrossa, e per passare veloci diventa necessario dimostrare, seppure indirettamente, la consistenza del proprio conto corrente. È per questo che nasce il varco “fast track”, accesso “prioritario ed esclusivo” per viaggiatori dotati di Cartafreccia “platino” e “oro”, o delle corrispondenti “privilege” e “gold” di Italo.
Bar al posto di profughi
Michele ha fame, così puntiamo verso il kebabbaro che si trova su un lato di piazza Duca d’Aosta, la piazza della stazione. Mentre scendiamo dal piano binari lo costringo a una sosta nel mezzanino. Questo ballatoio nel 2015 era luogo di sosta di migranti e profughi che arrivavano con i treni dall’Italia del sud, ed era un punto d’incontro tra loro e i volontari milanesi. Sgomberato a giugno di quell’anno, già in agosto era occupato da bar. La sequenza fotografica che ritrae il prima e il dopo del mezzanino mostra il volto feroce della valorizzazione commerciale: dove c’era vita, e solidarietà umana, ci sono anonimi tavolini e arredi da street food. Prima di riprendere la discesa ci sporgiamo sui menù, e vi troviamo un “arancino del giorno” al prezzo di sei euro. Con in bocca un sapore amaro, scendiamo gli ultimi gradini.
Superiamo la cancellata “anti-clochard” installata nel 2015 per sigillare la stazione nelle ore notturne e, appena gli occhi si abituano al sole, Michele indica qualcosa alla nostra sinistra, sotto gli sparuti alberi di piazza Duca d’Aosta. Visto da dove ci troviamo pare un tableau vivant: una cinquantina di uomini dai vestiti colorati e la pelle nera sono seduti lungo due lati di un’aiuola. Altri uomini in piedi, bianchi, in divisa e armati, li circondano.
Blitz in piazza Duca d’Aosta
Quando ci avviciniamo emergono i dettagli: i poliziotti controllano documenti, un ragazzo tra i fermati grida la sua amarezza, i cani antisommossa abbaiano senza che gli agenti facciano nulla per farli tacere. Attorno al gruppo si agitano giornalisti e fotografi, ma il giorno dopo, sulla stampa milanese c’è poco o nulla. L’operazione a cui assistiamo non fa più notizia, non è che la reiterazione in tono minore della grande retata del 2 maggio scorso, quando 300 agenti hanno trattenuto cinquantadue migranti. Dopo quel giorno, i rastrellamenti sono diventati routine: 26 luglio, 1 e 9 agosto, 12 settembre, 10 ottobre.
Le persone che non risultano in regola con il permesso di soggiorno vengono portate in questura, si fanno multe come quella di tremila euro a una venditrice “abusiva” di birra, e soprattutto si mette in scena la guerra in corso, la guerra contro i poveri. Nonostante lo spiegamento di forze, i suoi massimi sostenitori sono ben lontani dall’essere soddisfatti: se durante la prima retata Matteo Salvini esultava in diretta Facebook, ora Riccardo De Corato di Fratelli d’Italia si rammarica che si tratti soltanto di “mini-blitz”. Chiedono di più, appellandosi al decreto più amato dall’estrema destra, quello sulla “sicurezza urbana” del ministro del Partito democratico, Marco Minniti.
In realtà, a spingere le persone a trattenersi in piazza Duca d’Aosta c’è soprattutto l’irrigidimento del sistema dell’accoglienza milanese, non più aperto ai migranti in transito ma solo a regolari e richiedenti asilo. Una conseguenza dell’“approccio hotspot” preteso dalle istituzioni europee e adottato dal governo Renzi nel 2015. Naturalmente la situazione della piazza è anche pretestuosamente drammatizzata, come dimostra la presenza dei tanti viaggiatori e turisti che ogni giorno siedono, tranquilli e indisturbati, a pochi metri dagli “stranieri e sbandati” oggetto delle retate.
Ci sediamo lì anche noi, quando il pomeriggio è ormai inoltrato e il blitz concluso. L’abbiamo visto: i poveri non sono semplicemente fermati dai gate, come avviene all’uomo con il borsone nel rendering delle Fs. Sono espulsi dalla stazione, dalla piazza, spesso dal sistema dell’accoglienza, e perfino quando si accampano in miseri cunicoli lungo i binari sono perseguitati da bravi cittadini che li segnalano a consiglieri di Forza Italia. D’altra parte, se la risposta delle istituzioni all’esclusione sociale è quella di far sparire gli esclusi, è inevitabile che nel ventre della società, sui social e nei bar, fermenti l’odio.
Adeguarsi ai cambiamenti delle stazioni
Alessandro Radicchi è direttore dell’Osservatorio nazionale sul disagio e la solidarietà nelle stazioni italiane (Onds), istituito dalle Fs per affrontare, anche tramite 17 help center, “il fenomeno dell’emarginazione sociale e delle povertà estreme nelle aree ferroviarie”. Prima di partire per Milano ho chiesto a Radicchi cosa pensasse dell’istituzione dei gate, e mi ha risposto che dopo l’iniziale rammarico – a Roma Termini il centro d’aiuto si trovava al primo binario – avevano avuto spazi più grandi e il servizio era addirittura migliorato. Non ho potuto fare a meno di pensare che la generosità delle Fs fosse proporzionale alle centinaia di metri di distanza messe tra la galleria commerciale di Termini e gli utenti della nuova sede dell’help center. E che invece, per quelle persone, la stazione continua a rappresentare la possibilità di raggranellare qualche spicciolo e forse anche quella di mantenere un contatto con la vita “normale” che vi scorre.
A Milano l’help center è più vicino, ma si viene accolti da una guardia in divisa e gli operatori parlano da dietro vetri da sportello bancario: non esattamente la situazione capace di intercettare le tante, e spesso necessariamente illegali, varietà dell’esclusione. Radicchi mi ha detto anche qualcosa di rivelatore a proposito delle trasformazioni delle stazioni: “L’help center deve essere come l’acqua, adeguarsi ai cambiamenti del territorio”. Un’immagine forte: i liquidi non hanno forma, assumono quella del contenitore. La interpreto in questo modo: il contenitore sono le Fs, che decidono in modo privatistico che forma dare alla stazione, mentre l’umanità che l’attraversa deve scorrere secondo le regole aziendali.
Per l’agio dei consumatori
Uno dei mezzi che le Fs utilizzano per dare forma all’acqua è la Grandi stazioni spa (Gs). Costituita dal gruppo nel 1998, ha lo scopo di “conseguire una diversificazione dell’offerta dei servizi di stazione: non solo treni, dunque, ma anche negozi, boutique, librerie, ristoranti e bar, centri riunione, servizi di ogni genere per trasformare in luoghi sicuri, confortevoli, adatti agli incontri e allo shopping ambienti oggi poco utilizzati dal punto di vista commerciale e della vivibilità”. Attualmente le aziende che partecipano alla gestione delle 14 maggiori stazioni italiane sono tre. La prima è Gs rail, interamente di proprietà delle Fs, che cura la logistica funzionale al traffico ferroviario. La seconda è Gs immobiliare, che si occupa della valorizzazione degli edifici e ha ovviamente tutto da guadagnare dall’allontanamento dei poveri.
I suoi azionisti sono le Fs al 60 per cento e la Eurostazioni spa (gruppi Benetton, Caltagirone e Pirelli) al 40. Infine c’è Gs retail, che amministrerà fino al 2040 la parte commerciale delle stazioni. Questa società è di proprietà di una cordata italofrancese in cui ha un ruolo chiave Maurizio Borletti, che dal 2005 al 2011 è stato presidente della Rinascente. Il gruppo Borletti costruisce centri commerciali che ambiscono o almeno ammiccano al lusso. Così, anche per le stazioni, “la chiave sarà soprattutto un’offerta di maggiore qualità, soprattutto nella ristorazione e nel food in generale […]. Stiamo cercando di andare incontro alla gente che ha bisogno di sentirsi a suo agio nelle aree delle stazioni e perciò abbiamo lanciato un piano di collaborazione con i comuni per la riqualificazione anche delle zone limitrofe”. (Maurizio Borletti, intervista)
La motivazione materiale dei gate, e perfino delle retate, è quindi da cercarsi nella trasformazione di un luogo pubblico, aperto a tutti, in un privatissimo e luccicante centro commerciale. Da cui poveri, migranti e rom devono essere espulsi in nome dell’agio dei consumatori, cioè del maggior profitto. Sono stati evocati ordigni e trolley esplosivi, poi impastati con l’ideologia del decoro, ma la sicurezza dei viaggiatori non c’entra nulla. E mentre la paura alimentata irresponsabilmente continua ad avvelenare la società, il privato già guarda avanti, alla prossima valorizzazione. Lo fa Borletti, che in un’intervista dice di voler “raddoppiare il fatturato [di Gs retail] nel giro di 5-6 anni”. Ma lo fa anche quello strano privato, interamente di proprietà del ministero dell’economia e delle finanze, che è il gruppo Fs italiane.
Più tornelli, meno ferrovieri
Tra i pretesti per imporre gli accessi controllati ai binari di Bologna c’è stato un comunicato delle maggiori sigle sindacali dei ferrovieri che chiedeva “iniziative atte a garantire la massima tutela e incolumità” dei lavoratori. Ma, come mi ha detto un ferroviere di un sindacato di base, “la nostra insicurezza è causata principalmente dalla riduzione del personale nelle stazioni, a bordo dei treni, nelle biglietterie, ai binari”. Se questo è il punto, l’idea delle Fs di dotare di gate o tornelli 620 stazioni aggraverà la situazione rendendo praticabili ulteriori tagli. Saranno infatti “gate intelligenti da cui si entrerà semplicemente con il biglietto senza esibirlo a una persona fisica”, ha spiegato l’amministratore delegato della Rfi in un’audizione al senato. E la loro estensione è ancora da finanziare, come è scritto nel contratto di programma 2016-2021 tra il ministero competente e la Rfi. Sarà lo stato quindi a pagare i varchi per stazioni trasformate in gallerie per lo shopping? La partita, dal punto di vista economico, è significativa: a Firenze le barriere sono costate più di un milione di euro.
Bologna centrale, ore 22
Torniamo a Bologna in tempo per la chiusura della sala d’attesa, che dallo scorso giugno è alle dieci di sera. Con scarsa fantasia, e sicura efficacia, l’azienda ha giustificato la chiusura anticipata con i soliti “motivi di sicurezza”. Tre guardie armate fanno sloggiare una trentina di viaggiatori, che escono brontolando. Fino alle sei di mattina, quando la sala riaprirà, devono partire ancora una quarantina di treni, ma la stazione riorganizza i propri orari attorno a quelli di bar e negozi, che chiudono alle 22. Perché la sala d’attesa dovrebbe restare ancora aperta, visto che non si può più fare shopping? La stazione, fortezza e centro commerciale, ha porte aperte solo per chi consuma.

officinadeisaperi.it,
Come molti sanno, nell’ultimo decennio Riace, questo piccolo paese della costa jonica calabrese che conta solo milleduecento abitanti, è diventato famoso nel mondo e ha rivalutato l’immagine della Calabria: non più e solo terra di ‘ndrangheta, ma il luogo principe dell’accoglienza dello straniero. Finalmente una immagine positiva di questa regione di cui potersi vantare andando fuori per le strade del mondo. Quando nell’autunno del 2009 si celebravano a Berlino i vent’anni dalla caduta del muro, il grande regista Winnie Wenders di fronte a dieci nobel per la pace disse: «La vera civiltà, la nostra speranza come Europa io l’ho incontrata a Riace, un piccolo paese della Calabria». E quest’anno quando abbiamo letto la notizia che la famosa rivista Fortune aveva inserito il sindaco di Riace, Domenico Lucano, tra le cinquanta personalità più autorevoli della terra, in tanti abbiamo provato un sentimento di gioia ed orgoglio legittimo.
È in questo scenario che, come un fulmine in una limpida giornata autunnale, va letto il titolo a caratteri cubitali apparso sulla stampa locale e nazionale: il sindaco dell’accoglienza modello dei migranti accusato di truffa aggravata, concussione e abuso d’ufficio. Naturalmente la stampa di destra che odia gli immigrati ha scritto anche di peggio, ed era scontato. Quello che invece non è più accettabile è il modo con cui viene usato un avviso di garanzia, che significa solo che una persona è indagata, non condannata, non processata, e quindi ha diritto che la sua privacy venga rispettata.
Negli ultimi decenni l’avviso di garanzia si è trasformato in una pre-condanna, soprattutto se si tratta di persona famosa, che però quando viene prosciolta gli si concede qualche rigo illeggibile in una pagina interna al giornale. Perché la notizia, vendibile, è la presunta colpevolezza non l’innocenza della persona indagata. Ora, non si tratta di scommettere sull’onestà di Domenico Lucano, su cui molti ci metteremmo la faccia, ma si tratta di mettere a nudo un modo di fare informazione: non è possibile che un avviso di garanzia diventi pubblico, finché il PM non finisce l’istruttoria e la manda al Gip (Giudice per le indagini preliminari) questa informazione non deve diventare di dominio pubblico, e chi lo fa deve essere sanzionato. La macchina del fango, lo sappiamo, funziona così: lo butti sulla persona che vuoi colpire e qualcosa resta, anche dopo la “doccia” (il proscioglimento).
Ho conosciuto Domenico Lucano nel novembre del 1998 mentre a Badolato ero impegnato con il Cric (una ong calabrese molto attiva in quegli anni) nel primo progetto di accoglienza dei migranti che si è realizzato in Italia, che puntava all’integrazione economica, sociale e culturale. Domenico ed i suoi amici dell’associazione “Riace città futura” volevano replicare nel loro paese quanto fatto a Badolato e chiedevano un sostegno per partire. Il loro entusiasmo, la loro onestà e grande idealità ha fatto sì che mentre Badolato si spegneva Riace raccoglieva la solidarietà di tanti gruppi/associazioni del mondo pacifista, del commercio equo e solidale, della finanza etica e di una straordinaria comunità anarchica, l’ultima rimasta in Europa: Longo maï. Una comunità, nata in Provenza e diffusasi in altre zone della Francia e in diversi paesi europei, che si mobilitò per sostenere l’esperienza di Riace attraverso una forma di turismo solidale con cui svizzeri, francesi e tedeschi vennero a fare le vacanze in questo piccolo Comune calabrese allora sconosciuto al mondo. Un sostegno, anche economico, venne da Cornelius Koch, una straordinaria figura di prete cattolico che in Svizzera chiamavano l’Abate dei profughi che venne più volte a Riace insieme ad Hannes, uno dei fondatori della comunità di Longo maï (Vedi: Un chrétien subversif. Cornelius Koch, l’abbé des réfugiés, Editions d’en bas, Losanna, 2013).
Tutto questo per dire che la solidarietà, che la popolazione di Riace ha dimostrato di saper dare agli immigrati, innesca meccanismi di ulteriore solidarietà, legami sociali e reti conviviali, che si allargano a macchia d’olio ed in modo spesso imprevedibile. Ne è una ulteriore prova quello che è successo venerdì scorso: nell’anfiteatro costruito dove c’era una discarica (grazie anche all’impegno dell’ex assessore Tripodi, come ha voluto ricordare il sindaco), più di mille persone provenienti da tutta la Calabria e da varie parti d’Italia, dal Piemonte fino alla Sicilia, erano lì fino a notte fonda per essere vicini a Domenico Lucano, senza che alcun partito, sindacato o altro soggetto avesse organizzato questa manifestazione. Perché anche questo insegna questa storia: quello che le persone trovano a Riace è una grande dose di umanità, a partire da Domenico Lucano che riesce a parlare al cuore della gente senza cadere nel populismo e nella demagogia. Quello che molti di noi cerchiamo e di cui abbiamo bisogno è di Restare Umani, come scrisse prima di venire barbaramente ucciso Vittorio Arrigoni, un martire della pace, che cercava di unire le fazioni palestinesi in lotta.
Infine, la terza cosa che merita una riflessione seria sull’esperienza di Riace riguarda l’uso di quello che Lucano chiama “bonus” e che vengono usati per pagare i negozianti di Riace da parte dei migranti ospiti. Di che si tratta? Di una sorta di moneta locale che ha esattamente la stessa funzione dei “buoni pasto” che dipendenti pubblici e privati (grande aziende) usano per fare la spesa. Il vantaggio per l’economia di Riace è evidente: i migranti possono spendere questi “bonus” solo all’interno del paese e nei negozi convenzionati con l’amministrazione comunale. Questo fa sì che aumenti il legame tra i rifugiati e la popolazione locale e, inoltre, offre a loro la possibilità di fare acquisti di beni alimentari (e non solo) in base ai loro bisogni, cultura e tradizioni. Ed ancora: grazie a questo sistema l’amministrazione Lucano è riuscita a far risparmiare al progetto Sprar decine di migliaia di euro che sarebbero serviti per pagare gli interessi alle banche per avere gli anticipi di cassa con cui acquistare i beni per i migranti ospitati a Riace, mediamente duecento persone. Un sistema virtuoso che è stato accettato dalla Prefettura per sette anni e che improvvisamente quest’anno è stato messo in discussione. Un sistema che è stato ripreso e replicato anche in altri Comuni e che forse anche per questo diventava pericoloso perché dava un’autonomia agli enti locali che da diversi anni viene sempre più ridotta, grazie anche ai tagli nei trasferimenti dallo Stato ai Comuni che dal 2011 ha fatto registrare un taglio di ben 11 miliardi di euro.
Questa straordinaria storia di Riace non può finire nel macero per ragioni burocratiche o di bassa cucina. Bisogna che tutte le autorità e i rappresentanti delle Istituzioni (a partire dalla Giunta regionale) comprendano che in questo momento stare a guardare significa solo essere complici dello smantellamento di un modello di accoglienza apprezzato da tutte le persone che non hanno perso la loro umanità, che ancora credono che è possibile costruire un mondo migliore, senza muri e fili spinati, un mondo in cui la diversità – di culture, etnie, religioni – sia un valore e non un terrore.

Avvenire, 7. La Polizia è salita a bordo della Vos Hestia, impegnata nelle operazioni di soccorso nel Mediterraneo centrale. L'ong: «Noi estranei». E sospende le operazioni di soccorso in mare». Chissà perché e impediscono la partenza sempre e solo le navi sospettate del "reato" di soccorso i n mare w su accoglienza, Ogni barriere è buona per respingere chi chiede aiuto
La Polizia ha eseguito una serie di perquisizioni a bordo di nave Vos Hestia, l'imbarcazione di Save the Children impegnata nelle operazioni di soccorso ai migranti nel Mediterraneo centrale, che attualmente si trova nel porto di Catania. A bordo della nave, nei mesi scorsi, ha operato anche un agente sotto copertura. La perquisizione, eseguita dagli uomini del Servizio centrale operativo, è stata disposta dalla procura di Trapani che ha da tempo aperto un fascicolo sull'operato delle Ong.
La perquisizione sulla nave Vos Hestia «è relativa alla ricerca di materiali per reati che, allo stato attuale, non riguardano Save the Children», si legge in una nota dell'ong. La documentazione oggetto della ricerca «come si evince dallo stesso decreto di perquisizione» è «relativa a presunte condotte illecite commesse da terze persone».
«Non siamo indagati: fare subito chiarezza»
L'ong rende anche noto di aver sospeso le operazioni di soccorso in mare «come già pianificato data la riduzione dei flussi», e ribadisce di aver «sempre agito nel rispetto della legge durante la propria missione di ricerca e salvataggio nel Mediterraneo» e
conferma «ancora una volta che l'Organizzazione non è indagata».
«Tutte le operazioni sono state condotte in strettissimo coordinamento con la guardia costiera italiana e nella massima collaborazione con le autorità. La nostra missione è sempre stata guidata unicamente dall'imperativo umanitario di salvare vite», prosegue l'ong, che conclude: «Confidiamo che la magistratura, nella quale l'Organizzazione ha piena fiducia, faccia immediata chiarezza sull'intera vicenda».
Sospese le operazioni in mare
«Oltre a ribadire la nostra totale estraneità alle indagini, Save the Children annuncia la sospensione della propria attività di ricerca e salvataggio in mare, come già pianificato, e del resto attuato anche lo scorso anno. La decisione arriva dopo aver valutato attentamente la riduzione del flusso di migranti che tentano di attraversare il Mediterraneo centrale per raggiungere l'Europa e le mutate condizioni di sicurezza ed efficacia delle operazioni di ricerca e soccorso in mare nell'area», dichiara Valerio Neri, direttore generale di Save the Children Italia. «Per troppo tempo abbiamo supplito all'inesistenza o inadeguatezza di politiche europee di ricerca e soccorso, nonché di accoglienza dei migranti, cercando di portare un contributo concreto e volto al salvataggio delle vite
di bambini e adulti», conclude Neri.
C’è il ragazzo che indossa una maschera con la faccia del ministro degli Interni Marco Minniti versione vampiro, con i canini ben appuntiti che spuntano dalla bocca. E poi, poco più avanti, ci sono decine di ragazzi e ragazze che portano stretto alla vita o sulle spalle il telo termico color oro con cui i soccorritori coprono i migranti salvati dal mare. «Questo telo è un segno di solidarietà nei confronti di tutti gli uomini e le donne che rischiano la morte per fuggire», spiega una ragazza.
Non sono i quasi centomila che solo cinque mesi fa, a maggio, hanno riempito le strade di Milano in una grande manifestazione per l’accoglienza dei migranti, ma di questi tempi i circa ventimila (secondo gli organizzatori) che ieri hanno attraversato Roma per manifestare contro il razzismo rappresentano pur sempre un risultato di tutto rispetto. Come sa bene Filippo Miraglia, vicepresidente nazionale dell’Arci, che infatti non nasconde la sua soddisfazione. «Considerato il momento che stiamo attraversando il risultato è molto buono», dice quando il corteo è già arrivato a piazza Vittorio, tappa finale della giornata. «L’iniziativa di oggi fa ben sperare per l’avvio di una stagione di mobilitazioni di cui abbiamo bisogno per dare maggiore spazio a chi non ha voce perché considerato ininfluente dal punto di vista elettorale», commenta Miraglia.

Contro il razzismo, per la giustizia e l’uguaglianza», c’è scritto sullo striscione che dà il via al corteo. Alla manifestazione indetta dall’Arci hanno aderito un centinaio di associazioni e organizzazioni, insieme al vescovo emerito di Caserta, monsignor Raffaele Nogaro, ad Andrea Camilleri, Moni Ovadia e don Luigi Ciotti: «L’immigrazione non è un reato perché non è reato la speranza», ha spiegato ancora ieri il fondatore di Libera e del Gruppo Abele. «Oggi ci troviamo invece a fare i conti con un sistema che garantisce il privilegio di pochi e toglie la speranza a tutti gli altri».
Il razzismo non è l’unico tema del corteo. Negli slogan, sugli striscioni e dagli altoparlanti montati sui camion si lanciano parole d’ordine anche sul diritto alla casa e a favore dello ius soli, la legge che permetterebbe a oltre ottocento mila ragazzi, figli di immigrati, di diventare cittadini italiani. Ma soprattutto contro gli accordi stretti dall’Italia con la Libia e che se finora hanno ridotto drasticamente gli arrivi lungo le coste del paese – come vantava ancora ieri il ministro Minniti – non sono certo serviti a rendere più umane le condizioni di vita dei migranti che si trovano ancora nel paese nordafricano, prigionieri delle milizie e rinchiusi in centri dove subiscono violenze di ogni genere. «Si parla sempre di immigrati, ma mai delle cause che la genera, che sono le politiche dell’occidente che hanno prodotto fame», dice Essane Niagne, nata in Italia ma originaria della Costa d’Avorio.
Dalla Campania sono arrivati sette pullman. Su uno di questi hanno viaggiato i giocatori della Rlc Lions Ska di Caserta, squadra che gioca in terza divisione «Rfc» sta per «Ritieniti fortemente coinvolto», e il messaggio è chiaro. Il 70% dei giocatori è composto da ragazzi immigrati, il 60% dei quali sono richiedenti asilo. Il calcio per loro è un ottimo modo per integrarsi, ma spesso può significare anche sbattere la faccia contro l’ignoranza della gente. «A una partita ci hanno gridato negri di merda», ricorda Makan, che viene dal Mali e nonostante tutto riesce ancora a sorridere. «Purtroppo sono episodi che capitano sempre più spesso. Quest’anno non c’è stata una partita senza insulti», conferma Marco Prato, cofondatore, nel 2011, della squadra.
Un razzismo che non appartiene solo alle curve degli stadi. A piazza Vittorio, da sopra il cassone di un camion trasformato in palco per l’occasione, una ragazza spiega cosa significa sentirsi italiani senza esserlo per colpa dell’ostruzionismo che blocca la riforma della cittadinanza. «Non siamo immigrati eppure non siamo nemmeno cittadini italiani. Vogliamo solo essere riconosciuti per la nostra identità».