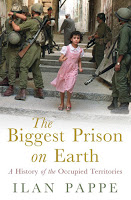NENA news
Secondo La più grande prigione al mondo, il nuovo libro dello storico israeliano Ilan Pappe, fin dal 1963 – quattro anni prima della guerra del 1967 – il governo israeliano stava progettando l’occupazione militare ed amministrativa della Cisgiordania.
La pianificazione dell’operazione – nome in codice “Granit” (granito) – ebbe luogo durante un mese nel campus dell’università Ebraica nel quartiere di Givat Ram a Gerusalemme ovest. Gli amministratori militari israeliani responsabili del controllo dei palestinesi si riunirono con funzionari legali dell’esercito, figure del ministero dell’Interno e avvocati privati israeliani per stilare le norme giuridiche ed amministrative necessarie per governare sul milione di palestinesi che all’epoca vivevano in Cisgiordania.
Questi piani facevano parte di una strategia più complessiva per mettere la Cisgiordania sotto occupazione militare. Questa strategia era denominata in codice “Piano Shacham”, dal nome del colonnello israeliano Mishael Shacham che ne era l’autore, e venne ufficialmente presentata dal capo di stato maggiore dell’esercito israeliano il 1 maggio 1963.
Pappe ha sostenuto a lungo che la guerra del 1967 e l’occupazione che ne seguì non furono “l’impero casuale” descritto dai sionisti progressisti. Pappe ritiene che un “Grande Israele” fosse stato prospettato fin dal 1948, e la sua pianificazione sia avvenuta fin dalla guerra di Suez del 1956.
La novità contenuta in La più grande prigione al mondo è il resoconto dettagliato da parte di Pappe esattamente di quello che i pianificatori israeliani avevano stabilito nel 1963: ossia “la più grande mega-prigione per un milione e mezzo di persone – un numero che sarebbe cresciuto fino a quattro milioni – che sono ancor oggi, in un modo o nell’altro, incarcerati all’interno dei muri reali o virtuali di questa prigione.”
Sistema di controllo
La descrizione da parte di Pappe degli incontri di Givat Ram ricorda il modo in cui aprì il suo libro più venduto, La pulizia etnica della Palestina, con la sua descrizione della “Casa Rossa” a Tel Aviv in cui il “Piano Dalet” (il Piano D) – per espellere quasi un milione di palestinesi – fu ordito 15 anni prima.
E in un certo senso La più grande prigione al mondo completa una trilogia, che comprende anche I palestinesi dimenticati: una storia dei palestinesi in Israele, che include la storia del popolo palestinese sotto il sionismo dal 1948 ad oggi.
Pappe afferma che il governo israeliano comprese nel 1963 che non sarebbe stato in grado di condurre un’espulsione di massa delle dimensioni della Nakba, espulsione forzata dei palestinesi nel 1948, a causa del controllo internazionale. Ciò spiega perché cominciò a disegnare un sistema di controllo e di divisione che avrebbe garantito una colonizzazione di successo in Cisgiordania, avrebbe privato i palestinesi dei diritti umani fondamentali, non concedendo loro la cittadinanza, e avrebbe garantito che la loro condizione di non cittadini nel loro stesso Paese non sarebbe mai stata negoziabile.
Benché la guerra del 1967 abbia determinato l’espulsione di altri 180.000 palestinesi (secondo le Nazioni Unite) e forse addirittura 300.000 (secondo il libro di Robert Bowker Palestinian refugees:Mythology, Identity, and the Search for Peace [Rifugiati palestinesi: mitologia, identità e la ricerca della pace]), secondo Pappe gli incontri di Givat Ram e quelli che seguirono prospettarono una specie di amministrazione carceraria per i palestinesi rimasti.
Già il 15 giugno, tre giorni dopo la fine della guerra, una commissione di direttori generali, compresi tutti i ministri del governo responsabili dei territori appena occupati, iniziò ad edificare quella che Pappe chiama una “infrastruttura per l’incarcerazione” dei palestinesi. Tutta questa pianificazione, egli scrive, ora si può trovare in due volumi di resoconti resi pubblici, per un totale di migliaia di pagine, derivanti dai verbali degli incontri del comitato.
Quasi subito dopo la conclusione della guerra, Israele iniziò a mettere in atto un piano ideato da Yigal Alon – membro del parlamento israeliano, la Knesset. Il piano era di creare dei “cunei” de-arabizzati, serie di colonie solo di ebrei in Cisgiordania “che avrebbero separato palestinesi da palestinesi ed essenzialmente annesso parti della Cisgiordania ad Israele.”
Questi cunei, inizialmente nella valle del Giordano e sulle montagne orientali, sarebbero stati più tardi perfezionati da Ariel Sharon, ministro dell’Edilizia di Israele e più tardi primo ministro. Alla fine avrebbero assunto le caratteristiche concrete di una prigione, nella forma di posti di blocco, di un muro dell’apartheid e di altre barriere fisiche.
Pappe contesta la tesi secondo cui le colonie israeliane, illegali secondo il diritto internazionale, siano state il risultato di un movimento messianico nazional –religioso, un argomento sostenuto in modo più articolato da Idith Zertal e Akiva Eldar nel loro libro Lords of the Land: The War Over Israel’s Settlements in the Occupied Territories, 1967-2007. [“Signori della terra: la guerra sulle colonie israeliane nei territori occupati, 1967-2007]. Al contrario fornisce prove che dimostrano il fatto che i governi sionisti laici, compreso quello di Golda Meir, del partito Laburista, corteggiarono questo movimento e lo utilizzarono per promuovere l’espansione coloniale da parte di Israele.
Percepibile
Non ci volle molto, comunque, prima che lo schema del governo provocasse una resistenza di massa, iniziata con la Prima Intifada del 1987-1993. Gli accordi di Oslo cercarono di affrontare questa resistenza. Pappe mostra che gli accordi di Oslo non ebbero mai l’obbiettivo di arrivare ad uno Stato palestinese e che definirono semplicemente la creazione di piccoli cantoni simili ai bantustan dell’apartheid sudafricano, con benefici aggiuntivi per il fatto che i costi e le responsabilità dell’occupazione vennero in larga misura trasferiti a importanti donatori ed organizzazioni internazionali – soprattutto l’Unione Europea – ed all’Autorità Nazionale Palestinese appena creata.
E’ qui che la metafora della prigione di Pappe diventa più percepibile. Finché l’ANP darà seguito alle proprie responsabilità riguardo alla sicurezza, la resistenza palestinese verrà messa a tacere, i palestinesi potranno vivere in una prigione di minima sicurezza “senza diritti civili ed umani fondamentali”, ma con l’illusione di una limitata autonomia. Appena la resistenza si manifesta, tuttavia, Israele impone i controlli di una prigione di massima sicurezza.
Quindi negli anni seguenti la Cisgiordania è diventata la prigione di minima sicurezza e Gaza - con Hamas alla guida della resistenza – è diventata quella di massima sicurezza. I palestinesi, scrive Pappe, “potrebbero essere sia i detenuti della prigione aperta della Cisgiordania o incarcerati in quella di massima sicurezza della Striscia di Gaza.” Tutto quello che è avvenuto dopo la guerra del 1967, nota Pappe, segue la “logica del colonialismo di insediamento” e quella logica prevede la possibile eliminazione dei palestinesi autoctoni. Tuttavia questo risultato non è inevitabile. Un’alternativa è possibile, afferma Pappe, se Israele smantella le colonie e apre la strada “alla logica dei diritti umani e civili.”
Rod Such è un ex curatore delle enciclopedie “World Boook” ed “Encarta” [una cartacea e l’altra digitale, entrambe pubblicate negli USA, ndt.]. Vive a Portland, Oregon, ed è attivo nella campagna di Portland “liberi dall’occupazione”.
(traduzione di Amedeo Rossi – Zeitun.info)

L’espansione coloniale israeliana nella Valle del Giordano prosegue. Tel Aviv non ha mai nascosto l’enorme interesse su quel 30% di Cisgiordania, la zona più fertile dell’intera Palestina storica e unica via di comunicazione con il mondo esterno per il governo dell’Anp. Da anni il governo Netanyahu pone come precondizione intoccabile all’eventuale negoziato il mantenimento del controllo militare e di sicurezza sulla Valle del Giordano, annullando di fatto ogni possibilità di uno Stato palestinese sovrano.
Secondo fonti locali, ora le autorità israeliane stanno lavorando al trasferimento forzato di 200 palestinesi (di cui 45 donne e 60 bambini) dai propri villaggi e dalle proprie terre nelle comunità di Ein al-Hilweh e Umm al Jamal, nella parte settentrionale della Valle del Giordano. Mahdi Daraghmeh, membro del consiglio municipale della Valle del Giordano, ha denunciato ieri la consegna di ordini di demolizione e di evacuazione a 30 famiglie palestinesi da 60 abitazioni e strutture agricole.
Datati primo novembre, ma consegnati ieri, gli ordini danno solo 8 giorni di tempo. Dunque, sono “scaduti” nello stesso giorno della notifica. Le famiglie aspettano l’arrivo dei bulldozer israeliani in qualsiasi momento. Secondo Daraghmeh, la motivazione reale è l’espansione delle colonie agricole.
Una paura che si lega a quanto annunciato dal ministro israeliano dell’Abitazione, Yoav Galant, che mercoledì ha reso noto un piano “per rafforzare le comunità ebraiche nella Valle del Giordano”, un progetto che – attraverso fondi statali a cooperative e insediamenti agricoli a chi deciderà di trasferirsi e l’eliminazione dei limiti alla costruzione – raddoppierà il numero di coloni israeliani nell’area. Da 6mila a 12mila: le colonie presenti nella Valle del Giordano, 37, sono esclusivamente colonie agricole e i residenti non sono numerosi come nel resto degli insediamenti della Cisgiordania.
Numeri ridotti ma effetti devastanti per la popolazione palestinese: dal 1967 la Valle del Giordano è per oltre il 90% sotto il controllo israeliano, tra Area C, zone militari chiuse e aree di addestramento. Area A, sotto il controllo palestinese, sono solo la città di Gerico e piccolissime porzioni di alcuni villaggi. È a Gerico che buona parte della popolazione è stata costretta a trasferirsi in questi 50 anni, spinti da demolizioni di case, espansione coloniale e perdita dei mezzi di sussistenza: dei 320mila abitanti pre-1967 ne restano 56mila, meno del 20% delle riserve d’acqua sono utilizzabili da palestinesi e il tasso di povertà è pari al 33,5%, il più alto della Cisgiordania.
Senza acqua e con sempre meno terra a disposizione, le comunità palestinesi hanno difficoltà estreme nel coltivare la terra e sono per lo più costretti a lavorare per pochi shekel al giorno nelle colonie israeliane, che da parte loro producono a basso costo e si rendono molto più competitivi sul mercato interno, prigioniero, palestinese.
L’obiettivo di un simile piano è chiarissimo. Israele va avanti nell’espansione territoriale in una zona strategica per rendere più difficile in futuro un’eventuale evacuazione dei coloni. Tel Aviv sa che il tempo è prezioso e che ogni metro guadagnato sarà un punto in più al tavolo del negoziato. E la Valle del Giordano è centrale nei piani del governo.

internazionale,
Non è mai successo niente di simile: un impero promette una terra che non è stata ancora conquistata a un popolo che non ci vive, senza chiedere il permesso agli abitanti del posto. Non c’è altro modo di descrivere l’incredibile incoscienza colonialista che viene fuori da ogni sillaba della dichiarazione Balfour, con cui cent’anni fa, il 2 novembre 1917, il Regno Unito s’impegnò a facilitare la nascita di uno stato per il popolo ebraico in Palestina.
Questa settimana i primi ministri di Israele e Regno Unito festeggiano un’enorme conquista sionista. Ma è arrivato il momento di fare un esame di coscienza. Il tempo di festeggiare è finito. Sono passati cento anni di colonialismo, prima britannico poi israeliano, e a farne le spese è stato un altro popolo. È stato un disastro senza fine. La dichiarazione Balfour avrebbe potuto essere un documento giusto, se avesse garantito un trattamento equo sia al popolo che sognava quella terra sia al popolo che la abitava. Il Regno Unito però preferì i sognatori, pochissimi dei quali vivevano in quel paese, a discapito degli abitanti, che stavano lì da centinaia di anni e che erano la maggioranza assoluta. A loro preferì non dare alcun diritto nazionale. Immaginate se uno stato promettesse di trasformare Israele nella patria nazionale degli arabi israeliani e chiedesse alla maggioranza ebraica di accontentarsi dei “diritti civili e religiosi”. È quello che successe all’epoca, ma in modo ancora più discriminatorio: gli ebrei erano una minoranza ancora più esigua (meno di un decimo) di quanto non lo siano oggi gli arabi israeliani.
Così il Regno Unito gettò i semi di una catastrofe che oggi continua ad avvelenare entrambi i popoli con i suoi frutti. Non c’è da festeggiare. Anzi, il centesimo anniversario della dichiarazione dev’essere un monito a rimediare all’ingiustizia mai riconosciuta, né dal Regno Unito né, ovviamente, da Israele. Dalla dichiarazione Balfour nacquero non solo lo stato di Israele, ma anche le politiche nei confronti delle “comunità non ebree”, come si legge nella lettera inviata dal ministro degli esteri britannico lord Arthur James Balfour al barone Rothschild, rappresentante della comunità ebraica e sionista convinto. La discriminazione degli arabi israeliani e l’occupazione delle terre dei palestinesi sono la continuazione diretta di quella lettera. Il colonialismo britannico spianò la strada a quello israeliano, anche se non era nelle sue intenzioni farlo continuare per altri cento anni.
Anche nel 2017 Israele s’impegna a garantire “diritti civili e religiosi” ai palestinesi, che però non hanno una patria. Balfour fu il primo a prometterne una. In quel periodo, negli anni della prima guerra mondiale, il Regno Unito fece varie promesse contraddittorie. Ne fece anche agli arabi, ma ha mantenuto solo quelle fatte agli ebrei. Come ha scritto Shlomo Avineri su Haaretz, l’unico scopo della dichiarazione Balfour era quello di minimizzare l’opposizione degli ebrei statunitensi alla partecipazione degli Stati Uniti alla guerra.
Dopo la dichiarazione Balfour, molti ebrei emigrarono in Palestina. Da subito si comportarono come padroni e il loro atteggiamento nei confronti degli abitanti non ebrei non è cambiato. Non fu un caso che un piccolo gruppo di ebrei sefarditi che abitavano in Palestina si oppose a Balfour e difese l’uguaglianza con gli arabi. E non fu un caso che furono messi a tacere.
La dichiarazione Balfour permise alla minoranza ebrea di controllare il paese, ignorando i diritti nazionali di un altro popolo. Cinquant’anni dopo la pubblicazione del documento, Israele conquistò la Cisgiordania e Gaza. Le invase con lo stesso piglio colonialista. E ancora oggi prosegue la sua occupazione, trascurando i diritti degli altri abitanti.
Balfour pensava che nello stato d’Israele gli ebrei avevano dei diritti e i palestinesi non li avevano e non li avrebbero mai avuti. Come i suoi successori nella destra israeliana, Balfour non lo ha mai nascosto. Nel suo discorso tenuto al parlamento britannico del 1922, lo dichiarò apertamente.
Nel centesimo anniversario della dichiarazione Balfour, la destra nazionalista dovrebbe chinare il capo e ringraziare la persona che ha dato origine alla superiorità ebraica in Israele, cioè Arthur James Balfour. I palestinesi e gli ebrei che vogliono giustizia invece dovrebbero essere in lutto. Se non ci fosse stata quella dichiarazione, forse oggi questo paese sarebbe diverso e più giusto.

il manifesto,
Israele/Palestina. Oggi è l'anniversario del documento con cui cento anni fa la Gran Bretagna promise un "focolare ebraico" in Palestina. Israele celebra, i palestinesi chiedono le scuse di Londra. La partenza ieri del premier israeliano Netanyahu per Londra, dove prenderà parte con i massimi rappresentanti politici britannici, ad eccezione del leader laburista Jeremy Corbyn, alle celebrazioni per il 100esimo anniversario della Dichiarazione Balfour - che promise un “focolare ebraico” in Palestina aprendo la strada alla nascita di Israele -, è stata accompagnata ieri dall’ironico saluto organizzato a Betlemme da Banksy.
Davanti al suo hotel, “The Walled Off”, con vista sul Muro, lo
street artist britannico ha organizzato un party per i bambini dei campi profughi vicini, per ricordare gli 800mila palestinesi (oggi cinque milioni) costretti all’esilio dopo la proclamazione dello Stato di Israele nel 1948. Durante il party in strada è stata pronunciata una dura critica dei risultati della Dichiarazione Balfour.
L’evento si è aperto con l’invito da parte di un uomo vestito secondo la moda del secolo scorso ai bambini ad avvicinarsi al tavolo, dove spicca una torta coi colori della bandiera britannica. L’uomo poi ha pronunciato un discorso in cui critica la Dichiarazione Balfour “che diede inizio ad un secolo di confusione e conflitto”. Infine su sua richiesta una signora simile alla regina di Inghilterra apre una tenda e sul Muro appaiono così i simboli della casa reale britannica e la scritta a grandi lettere: Sorry.
La leadership palestinese intanto continua a chiedere le scuse di Londra, che la premier Theresa May ha escluso, e il riconoscimento britannico dello Stato di Palestina. Oggi migliaia di scolari di Cisgiordania e Gaza invieranno lettere di protesta alle autorità diplomatiche della Gb mentre una delegazione di decine di attivisti inglesi, partiti nei mesi scorsi da Londra, concluderà a Gerusalemme la sua simbolica “marcia di scuse” al popolo palestinese. In Israele al contrario l’anniversario della Dichiarazione Balfour viene celebrato con conference, incontri e numerose iniziative di ringraziamento alle autorità britanniche.

Internazionale articoli per comprendere adici storiche e politiche delle divisioni etniche, nonché una forte povertà da entrambe le parti rendono la crisi birmana molto complessa
EREDITA' COLONIALE
di Lee Jones
Negli ultimi due mesi quasi 600mila musulmani rohingya sono scappati da una persecuzione cruenta nello stato birmano del Rakhine, rifugiandosi in Bangladesh. Gli osservatori occidentali, inorriditi, hanno avuto reazioni in gran parte moralistiche, ma alcuni hanno sottolineato i fattori economici alla base delle violenze. Hanno ragione, ma sarebbe semplicistico ridurre la crisi agli interessi legati alla terra o all’intolleranza religiosa.
Lo scontro tra buddisti e musulmani per la terra e le risorse nello stato del Rakhine non è una novità. Dal quattrocento al settecento in questa regione ci furono ripetuti conlitti tra gli imperi musulmani che si espandevano da ovest e il regno buddista di Mrauk U, nell’Arakan (Rakhine). Questi conflitti terminarono solo nel 1785, quando la regione fu conquistata dal regno di Birmania. Fu però soprattutto il colonialismo britannico (1824-1948) a gettare i semi della crisi attuale. La Birmania faceva parte dell’impero britannico e fu meta di grandi migrazioni dal subcontinente indiano.
I britannici incoraggiarono in particolare i bengalesi a migrare in Birmania per far fronte alla carenza di manodopera o per il lavoro nelle piantagioni. Nel distretto di Akyab (oggi Sittwe), per esempio, dal 1871 al 1911 la popolazione musulmana triplicò, mentre quella rakhine, buddista, aumentò di appena un quinto. Comprensibilmente, quindi, nella memoria culturale dei rakhine c’è la percezione di essere stati “travolti” dagli “immigrati musulmani”.
Più in generale, l’immigrazione verso la Birmania raggiunse il livello massimo nel 1927, con 480mila nuovi arrivi su una popolazione di 13 milioni di persone. a quel tempo gli abitanti di etnia indiana avevano ormai assunto posizioni di rilievo nell’economia del paese, non solo come braccianti nell’agricoltura ma anche come professionisti qualificati, commercianti e finanzieri. Durante la crisi economica degli anni trenta, molti contadini indebitati con gli usurai indiani fallirono e gli indiani diventarono grandi proprietari terrieri.
La risposta a questo rapido afflusso demografico fu una forma di nazionalismo economico con connotazioni razziali che resiste ancora oggi. È un fenomeno non tanto diverso dal nazionalismo xenofobo che ha accompagnato talvolta l’immigrazione di massa per motivi economici neipaesi occidentali. Scoppiarono rivolte contro gli indiani nel 1930 e 1931 e in particolare contro i musulmani nel 1926 e nel 1938. Queste ultime furono guidate dalla maggioranza etnica bamar e non interessarono il Rakhine. Solo nel 1942, dopo che il Regno Unito fu sconitto dalle forze d’invasione giapponesi, nella regione scoppiarono scontri tra le diverse comunità. Le milizie rakhine sfruttarono il conflitto per vendicarsi dei loro nemici musulmani, costringendo decine di migliaia di persone a riparare in India. Come se non bastasse, i britannici armarono le forze volontarie rohingya, ufficialmente per attaccare le forze d’occupazione giapponesi; in realtà, però, spesso i gruppi armati volontari attaccarono gli insediamenti rakhine, le pagode e i monasteri buddisti. I rohingya, inoltre, accompagnarono la riconquista britannica del Rakhine, in seguito alla quale i gruppi rakhine furono repressi con la forza.
Con la decolonizzazione, i musulmani di ritorno temettero giustamente di essere accorpati allo stato birmano postcoloniale e organizzarono una rivolta (mujahid) a favore dell’annessione del Rakhine settentrionale al Pakistan orientale, scatenando una serie di operazioni di controinsurrezione dell’esercito birmano per tutti gli anni cinquanta. Un’eredità fondamentale di questi spostamenti di popolazioni causati dal secondo conflitto mondiale e dai successivi disordini è che i musulmani che via via tornarono nel Rakhine furono bollati come “immigrati clandestini bengalesi”.
Questa storia complessa e drammatica è il motivo per cui i rohingya (termine diventato comune solo dopo l’indipendenza della Birmania) non sono tra le 135 minoranze etniche ufficialmente riconosciute e sono classificati come “bengalesi”.
Nazionalismo economico
Data l’esperienza del colonialismo britannico, non sorprende che il nazionalismo popolare birmano abbia avuto in dall’inizio un tono fortemente razzista, in particolare nei confronti dei cosiddetti kalar, gli “intrusi” dalla pelle scura provenienti dal subcontinente indiano. L’obiettivo fondamentale del governo dopo l’indipendenza fu la birmanizzazione dell’economia, dominata dagli stranieri. Memore del trauma degli anni trenta, nel 1953 il governo nazionalizzò la terra e vietò l’affitto privato agli agricoltori (divieto che in larga misura rimane ancora oggi), sradicando quel che restava della classe dei proprietari terrieri indiani.
La birmanizzazione culminò nella nazionalizzazione di 15mila imprese dopo il colpo di stato militare del 1962, che spinse tra i 125mila e i 300mila birmani di etnia indiana ad abbandonare il paese. Questi si aggiunsero ai 400mila indiani, britannici e anglobirmani già evacuati durante la decolonizzazione. Il movimento 969, nato dopo il 2011, che incoraggia i buddisti a boicottare le imprese musulmane, è solo l’ultimo rigurgito di questo nazionalismo economico xenofobo.
La colonizzazione lasciò anche profondi traumi religiosi. Dopo aver causato la perdita della sovranità indigena e l’afflusso dei musulmani, i britannici si rifiutarono di assolvere ai tradizionali doveri del potere sovrano buddista – per esempio quello di nominare gli abati – favorendo la crescita delle attività dei missionari cristiani e provocando una profonda crisi culturale tra i buddisti. La restaurazione del buddismo diventò così un elemento centrale del nazionalismo bamar, e sia la religione sia la cultura bamar diventarono elementi dominanti degli sforzi di ricostruzione postcoloniale, mentre le minoranze etniche e religiose furono sempre più marginalizzate.
Oggi molti buddisti in Birmania sono sinceramente convinti che, come nel periodo coloniale, la loro religione e la loro cultura siano minacciate da un’“onda anomala” di immigrazione musulmana. L’Indonesia, che ha avuto imperi buddisti e indù, è spesso spesso citata come esempio di quello che potrebbe succedere in Birmania se non saranno prese contromisure drastiche. In realtà questi timori non hanno alcuna base oggettiva: solo il 3 per cento della popolazione birmana è musulmana, contro circa l’89 per cento di buddisti. ma la cosa è irrilevante, perché la maggior parte della gente è condizionata da anni di propaganda del governo, cattiva istruzione e deferenza generalizzata verso i monaci buddisti, alcuni dei quali hanno fomentato l’islamofobia. Del resto, la paura di essere culturalmente travolti non è nuova, e non è legata solo alla transizione “democratica” cominciata dopo il 2010. Ci sono state rivolte antimusulmane anche durante il regime militare, nel 1997 e nel 2001, e il famigerato monaco nazionalista Ashin Wirathu, esponente del maBatha, l’associazione per la tutela della razza e della religione, è stato arrestato per istigazione alla violenza nel 2003.
Questa vicenda spiega perché oggi ci sia un difuso consenso per il maBatha, per le leggi sulla tutela della razza e della religione (che discriminano i musulmani) e per la pulizia etnica condotta dall’esercito birmano nel Rakhine. e spiega perché, politicamente, Aung San Suu Kyi ha uno spazio di manovra così limitato, anche se bisogna dire che non ha fatto quasi nulla per smontare queste pericolose leggende o per favorire l’armonia tra le diverse comunità. Anzi, L’uso del termine “bengalesi” da parte dei suoi collaboratori, i suoi commenti passati sul “potere globale musulmano” e l’epurazione dei candidati musulmani dalle liste elettorali dell’Nld nel 2015 fanno pensare aun certo pregiudizio antimusulmano.
L’espulsione originaria alla base delle continue persecuzioni dei rohingya (e più in generale degli attacchi antimusulmani) c’è un intreccio di fattori materiali e ideologici che vanno oltre la questione superficiale e a breve termine dell’appropriazione della terra. molti musulmani sono guardati con sospetto per il solo fatto di essere associati al colonialismo e alla rivolta mujahit. Dopo la ine del colonialismo, anche se il termine “rohingya” veniva usato nei circoli ufficiali, i rohingya non furono mai riconosciuti come uno dei gruppi etnici ufficiali della Birmania. All’inizio avevano il diritto di voto e alcuni di loro furono eletti in parlamento (uno diventò anche viceministro). Poi però, con l’ascesa del nazionalismo buddista bamar e le crescenti resistenze delle minoranze etniche contro l’omologazione (che portarono allo scoppio di una delle guerre civili più lunghe del nostro tempo), lo stato diventò sempre più ostile verso i musulmani.
Nel 1962 l’esercito espulse i soldati musulmani. Nel 1977 si diffuse la voce che molti “bengalesi” avevano approfittato dei blandi controlli alla frontiera per attraversare il confine dal Pakistan orientale (Bangladesh dal 1971) ed entrare nel Rakhine: il regime appoggiato dai militari reagì ordinando una serie di operazioni di “pulizia” alla vigilia del censimento nazionale e rimpatriando in Bangladesh 200mila musulmani.
Poi, sulla base della nuova legge sulla cittadinanza del 1982, i rohingya furono gradualmente privati dei loro diritti. Spesso non potevano nemmeno dimostrare di essere residenti in Birmania, anche perché i documenti ufficiali erano stati distrutti e loro erano stati costretti a rimpatriare con la forza. Dopo il 1988, quando i rohingya assunsero un ruolo di primo piano nel movimento per la democrazia sperando di recuperare i loro diritti, furono ancora una volta vittime di una violenta repressione, che nel 1992 provocò un nuovo esodo di 250mila persone verso il Bangladesh.
In tutto questo bisogna distinguere la posizione dei rakhine buddisti, che si considerano “vittime” sia del numero crescente di “immigrati clandestini bengalesi” (anche se il rapporto è ancora di due a uno a loro favore) sia del governo centrale a maggioranza bamar. Il Rakhine è il secondo stato più povero della Birmania, e il poco sviluppo che c’è stato si deve a una manciata di megaprogetti – che non creano occupazione a livello locale e i cui benefici sono monopolizzati dal regime e dagli investitori stranieri – o alla crescita di un’industria ittica con alti tassi di sfruttamento. In alcuni villaggi del Rakhine le condizioni non sono molto diverse da quelle dei campi profughi dove vivono molti rohingya. In una situazione di scarsità di risorse e di forte competizione economica, i rakhine guardano con risentimento all’attenzione che l’occidente riserva ai rohingya e percepiscono come “di parte” le donazioni e i finanziamenti stranieri. Questo spiega gli attacchi ai camion degli aiuti e le proteste contro le sedi dei donatori, considerati colpevoli di aver offeso il buddismo.
Con la transizione democratica cominciata nel 2011 i rakhine hanno colto l’occasione per organizzarsi politicamente, conquistando la maggioranza all’assemblea dello stato. Molti hanno appoggiato le brutali azioni dell’esercito e della polizia come forma di rivalsa contro i loro avversari, e hanno approfittato dei disordini per occupare i terreni coltivati dai rohingya. Alcuni, invece, sono scappati con i rohingya, a riprova della disperazione e della povertà condivise. Non è un caso che condizioni così straordinariamente difficili abbiano scatenato la violenza di entrambe le comunità. Le prime milizie rakhine antimusulmane si formarono negli anni quaranta; oggi ne sono attive tre, ognuna delle quali promuove l’“autodeterminazione” del Rakhine e rifiuta i rohingya in quanto “bengalesi”. anche i rohingya hanno più volte preso le armi, e il vero mistero è come mai l’Arakan Rohingya Salvation Srmy (Arsa) abbia impiegato tanto a formarsi di fronte a simili persecuzioni e violenze. Gli attacchi dell’Arsa ai posti di polizia e contro l’esercito birmani – l’ultimo dei quali, alla fine di agosto, ha provocato l’offensiva armata che ha provocato l’attuale esodo dei rohingya – sono atti disperati di uomini armati di catapulte e “pistole” di legno.
Insomma, anche se le semplici motivazioni economiche non vanno sottovalutate, il quadro politico ed economico dietro l’attuale crisi è molto più complesso. Come per altri conflitti etnici nel paese, le tensioni sono il riflesso della crisi da cui è nato lo stato birmano. La Birmania è stata fondata senza un vero consenso dei vari gruppi etnici sulla natura dello stato o sull’organizzazione del potere e la divisione delle risorse. Gli sciovinisti bamar buddisti, impreparati a fare le concessioni necessarie per assicurarsi la partecipazione degli altri gruppi alla costruzione dello stato, hanno cercato di imporre la loro visione con la forza, aprendo la strada a una serie di scontri nelle zone di confine. I rohingya sono quelli che hanno sofferto di più, perché si sono visti negare anche lo status di minoranza. Mentre lo stato bamar cerca di accorpare con la forza i gruppi etnici riconosciuti all’interno dell’Unione birmana, fa di tutto per espellere con la forza i rohingya.
 |
|
Il campo profughi di Balukali, Cox’s Bazar, 2 ottobre 2017
Fonte: Internazionale 1128
|
LA FINE DELLA FAVOLA BIRMANA
di Thant Myint-U
Finalcial Time
Oggi la situazione in Birmania è preoccupante, come non accadeva dai giorni più bui della dittatura militare. L’attenzione di tutto il mondo si è giustamente concentrata sulla crisi dei rohingya e sulle centinaia di migliaia di uomini, donne e bambini in fuga, uno dei più grandi esodi di profughi dalla seconda guerra mondiale.
Il peggio potrebbe non essere finito. I bisogni essenziali sono tutt’altro che soddisfatti e non si è ancora cominciato a parlare seriamente di un possibile ritorno dei profughi né di un’inchiesta sulle violazioni dei diritti umani. C’è la possibilità che i paesi occidentali rispondano con sanzioni mirate. anche se non sono state imposte sanzioni formali, l’interesse degli investitori stranieri e il numero di turisti subiranno di sicuro un crollo. Questo in un momento in cui la fiducia degli investitori locali è debole e il settore bancario instabile.
Presto milioni di persone tra le più povere dell’Asia potrebbero dover affrontare un futuro drammatico. Il minimo peggioramento economico minaccerà direttamente il processo di pace in Birmania, già molto fragile. Nel paese sono attivi una ventina di “gruppi etnici armati”, il più grande dei quali conta più di 20mila uomini, e centinaia di milizie locali. Negli ultimi anni in più occasioni ci sono stati scontri violenti e lungo i confini con la Thailandia e la Cina vivono quasi 500mila sfollati.
La crescita economica da sola non sarà sufficiente a portare la pace, ma senza la spinta di un’economia inclusiva e in rapida crescita il processo di pace esaurirà il suo slancio. L’Arakan Rohingya Salvation Army (Arsa), responsabile degli attacchi che lo scorso agosto hanno scatenato l’ultima ondata di violenze, potrebbe potrebbe colpire ancora. In uno scenario ancora peggiore, i gruppi jihadisti internazionali potrebbero prendere di mira le città della Birmania centrale, dove altri due milioni di musulmani non rohingya vivono in pace, almeno per il momento, con i loro vicini buddisti, indù e cristiani. Il terrorismo importato dall’estero potrebbe innescare nuove violenze tra le diverse comunità, con conseguenze devastanti.
Molti in occidente hanno visto per decenni la Birmania quasi esclusivamente attraverso le lenti di una lotta tra il movimento per la democrazia, guidato da Aung San Suu Kyi, e una giunta militare senza volto. Pochi si sono sforzati di comprendere la profondità e le complessità delle sfide del paese o hanno cercato di trovare una soluzione pragmatica. I fallimenti nella gestione del potere hanno avuto un costo politico minimo. Nel paese circola il mito della Birmania come una nazione ricca che ha sbagliato, di un’epoca d’oro non troppo lontana rovinata da dittatori militari. Il corollario di tutto questo è che un unico cambiamento, per esempio la nascita di un governo democratico, basti a sprigionare il potenziale del paese e a restituirgli il posto che gli spetta tra i più ricchi della regione. Non c’è traccia di un vero programma di modernizzazione. Si tende a sorvolare sugli effetti di vent’anni di sanzioni, trent’anni di isolamento volontario, cinquant’anni di governo autoritario, settant’anni di guerre interne e più di un secolo di colonialismo. Ovunque si vedono le conseguenze di decenni in cui la spesa pubblica per la sanità e l’istruzione è stata cancellata. Le tendenze xenofobe sono radicate in tutti gli schieramenti politici. Le istituzioni statali sono fragilissime e in molte parti del paese quasi assenti. Di sicuro alcune cose sono migliorate negli ultimi anni: la vita politica oggi è più libera rispetto a qualsiasi momento negli ultimi cinquant’anni e si sta almeno tentando di compiere una transizione dalla dittatura militare a un governo quasi democratico. Nessuno vuole tornare all’isolamento. ma l’insieme delle side che oggi il paese ha di fronte è così imponente che è difficile capire come questa tendenza positiva possa sopravvivere.
Senza lungimiranza
Non si tratta solo del processo di pace, dell’economia e della crisi dei rohingya. Migrazioni, urbanizzazione, cambiamento climatico e la rivoluzione delle telecomunicazioni stanno ridefinendo la società birmana. I rapporti con la Cina sono in una fase critica, con la possibilità che enormi progetti infrastrutturali ridisegnino la geografia del paese. al contempo quasi nessuno si sofferma sul quadro a lungo termine.
Pensiamo allo stato del Rakhine settentrionale, che oggi è teatro di violenze e domani potrebbe essere il luogo dove torneranno i profughi: cosa sarà tra dieci o quindici anni? Una fermata lungo la nuova autostrada tra Cina e India? O sarà sommerso a causa del cambiamento climatico?
Perfino un governo esperto e aiutato da tecnocrati preparati avrebbe difficoltà a gestire ciò che la Birmania sta affrontando, per non parlare dei possibili progetti per il futuro. Il mondo fa bene a dare
priorità alla crisi in corso. ma è altrettanto importante liberare il campo una volta per tutte dalla favola birmana e capire che lavorare in questo paese significa avere a che fare con uno stato quasi fallito. Bisogna raddoppiare gli sforzi per valorizzare le risorse del paese, soprattutto attraverso investimenti nella sanità e nell’istruzione; e, cosa forse più importante, contribuire a trasmettere un’idea di futuro nuova e positiva. Altrimenti la crisi di oggi sarà solo la prima di una lunga serie.
IL GRANDE ESODO
di Francis Wade
Due anni fa, in un villaggio pochi chilometri a nord di Sittwe, nello stato birmano del Rakhine, ho conosciuto un ragazzo di 25 anni che mi ha parlato della sua amicizia, ormai finita, con un coetaneo rohingya. Nel giugno del 2012 il suo villaggio e altri vicini nel Rakhine erano stati usati come base da bande di estremisti buddisti che, armati di bastoni, machete e taniche di benzina, avevano devastato un quartiere a maggioranza musulmana nel centro di Sittwe.
Il ragazzo non era nel villaggio durante l’attacco. sapeva però che molti suoi vicini erano saliti sugli autobus diretti a Sittwe, dove i buddisti avevano preso d’assalto le case dei musulmani, costringendo migliaia di rohingya a rifugiarsi nei campi profughi. Il ragazzo simpatizzava con gli aggressori. Il suo amico rohingya aveva smesso da tempo di venire al villaggio, e lui non aveva alcuna voglia di riallacciare i rapporti. Gli ho chiesto perché. “Il suo sangue è diverso”, mi ha detto. L’amico vendeva riso al mercato locale e qualche volta restava a dormire a casa sua. “Non credo sia una cattiva persona, ma la sua etnia è cattiva. È il suo gruppo che è cattivo”.
Quelli del 2012 sono stati i primi focolai di violenza tra buddisti e musulmani in Birmania mentre il paese attraversava la fase di transizione dal regime militare, e si sono conclusi con la quasi totale segregazione delle due comunità in gran parte della zona occidentale del paese. Diversi mesi dopo, sempre nel 2012, sono andato a intervistare i rohingya nei campi profughi. Ma né io né la maggior parte dei giornalisti arrivati sul posto ci siamo preoccupati di parlare con l’“altra parte”, i buddisti rakhine che si erano resi responsabili di molte violenze ma che a loro volta, anche se in misura minore, avevano subìto aggressioni dai rohingya. all’epoca nessuno sapeva esattamente quali forze, interne ed esterne, avessero spinto i buddisti a commettere quelle atrocità.
Mentalità collettiva
Ho pensato al ragazzo del villaggio quando, alla fine di agosto, in Birmania è cominciata un’ondata di violenze molto più sanguinosa. a nord di Sittwe, in un piccolo lembo di terra, sono stati incendiati più di duecento villaggi. In meno di due mesi quasi 600mila rohingya sono scappati in Bangladesh per sfuggire alla campagna di terrore dell’esercito birmano in risposta agli attacchi di un gruppo di ribelli rohin magya contro alcune postazioni della polizia.
Le testimonianze dei profughi, che parlano di esecuzioni sommarie dei civili e di donne stuprate dai soldati birmani, sono sconvolgenti, ma altrettanto sconvolgente è l’atteggiamento cinico e sarcastico di una fetta ampia e trasversale della società birmana di fronte alle violenze. Questo clima si avverte non solo nel Rakhine, dove i contrasti tra la maggioranza rakhine e i rohingya hanno radici profonde, ma in tutto il paese; e non solo tra la gente comune, ma anche nei palazzi del potere. “Guardate quelle donne”, ha detto recentemente un funzionario del Rakhine quando gli hanno chiesto dei presunti stupri di massa. “Chi mai le violenterebbe?”.
Il sostegno popolare alla campagna dell’esercito ha portato alla luce un violento pregiudizio contro i rohingya. La forza e la quasi universalità di questo sentimento stride con la lettura semplicistica degli osservatori occidentali, secondo i quali le tensioni etniche e religiose in Birmania esistono da molto tempo ma sono state oscurate tanto dalla dittatura militare quanto da una visione binaria della situazione politica del paese: da una parte la società, virtuosamente unita contro i militari, dall’altra il regime.
Mentre cercano di capire da dove nasce questa ostilità collettiva nei confronti dei rohingya, in grado di unire una maggioranza composta da comunità con interessi contrastanti ma che a quanto pare concordano sulla necessità di una campagna di pulizia etnica, ho ripensato alla conversazione con quel ragazzo. sapeva benissimo che il suo amico rohingya non era mai stato coinvolto personalmente in attacchi contro i rakhine. Il problema era che i rohingya sono visti come un tutt’uno, con l’individuo sempre al servizio del gruppo. Quest’incapacità di separare il singolo dalla massa è stata la causa di innumerevoli violenze in tutto il mondo, ed è stata la colonna portante della propaganda contro i rohingya fin dagli attentati dello scorso agosto. sui social network circolano vignette
di bambini rohingya armati di machete segno che ai rohingya viene attribuita una malvagità innata che non lascia spazio a distinzioni tra giovani e anziani, violenti e non violenti. al ragazzo non importava che il suo amico, individualmente, non avesse fatto niente di male. “È il suo gruppo che è cattivo”.
Queste convinzioni sono state in parte alimentate da altri fatti accaduti nel frattempo in Birmania. Ridurre il tutto ad antichi contrasti che oggi trovano una nuova valvola di sfogo vuol dire sottovalutare i processi messi in moto dalla polarizzazione
delle varie comunità dopo le violenze del 2012 e dalla transizione politica. Oltre che alle tensioni locali nel Rakhine e alla difesa della supremazia etnica e religiosa da parte dell’esercito, il sostegno dell’opinione pubblica all’ultima ondata di violenze contro i rohingya è legato ai timori, reali e immaginari, di ciò che la democratizzazione potrebbe portare con sé.
La ritirata delle due comunità in enclavi separate dopo il 2012 ha creato da entrambe le parti un senso condiviso di chi fosse l’“altro” e delle sue presunte intenzioni. L’effetto più profondo è stato quello di ricontestualizzare il significato delle precedenti esplosioni di violenza. In questo clima ogni disputa tra vicini, anche la più banale (per esempio sulla terra, storicamente motivo di forti tensioni in questa parte del paese), è percepita come l’avvisaglia di un disegno di invasione e conquista da parte della comunità musulmana. I rohingya sono bollati come immigrati clandestini bangladesi, mentre i buddisti rakhine si considerano gli eredi legittimi della pianura costiera. Qualsiasi rivendicazione di
diritti, politici o economici da parte dei rohingya – per non parlare delle manifestazioni di violenza – è vista come il tentativo di annacquare l’identità etnica del Rakhine e, più in generale, il buddismo.
Questo forse spiega il curioso paradosso della Birmania: più la democrazia avanza, più aumenta la violenza. a quasi sette anni dalla cessione definitiva del potere da parte dei militari e dopo diciotto mesi di governo pseudo-civile, una campagna di pulizia etnica è stata appoggiata dall’opinione pubblica. Il fenomeno non è circoscritto al Rakhine, ma coinvolge anche comunità che hanno avuto scarsissimi contatti – o addirittura nessuno – con la popolazione rohingya.
L’antropologo Arjun Appadurai ha spiegato il ruolo che “copioni più ampi”, una volta diventati parte dell’interpretazione locale di un conflitto, possono giocare sulla percezione di quel conflitto. magari in passato il risentimento che ha provocato le violenze era limitato al Rakhine, ma agli occhi di molte persone i recenti attentati dei ribelli rohingya hanno svelato un complotto islamista che parte da fuori dei confini birmani e minaccia di penetrare nel paese. La principale linea di frattura nella società della Birmania occidentale è storicamente di natura comunitaria, ma il modo in cui lo stato e i social network hanno insistito sulla dimensione religiosa del conflitto ha avuto un’influenza fondamentale sulla piega che i fatti hanno preso, ben al di là del Rakhine.
Oggi, in Birmania, per molte persone la democratizzazione è evidentemente un pericolo. Del resto è quello che hanno sempre sostenuto i militari, che in cinquant’anni al potere hanno schiacciato a tal punto le libertà dei cittadini da far sembrare i diritti una risorsa limitata. In una nazione etnicamente spaccata, dove alcuni gruppi erano più privilegiati di altri ma a tutti era negata una voce politica, la strategia dei militari ha inevitabilmente fatto nascere il timore che dare potere a una comunità significasse toglierlo alle altre.
È molto probabile che dietro agli ultimi avvenimenti in Birmania ci sia una forte spinta ideologica e sciovinista, con i nazionalisti che usano il loro ritrovato potere per provare a forgiare una società più omogenea e libera dalla “contaminazione” etnica. e tra i fattori in gioco c’è sicuramente il tentativo di comunità diseredate come i rakhine di ritagliarsi un ruolo nel nuovo panorama politico prima che qualcun altro glielo porti via.
Una nuova sintonia
Queste paure sono state abilmente sfruttate dai militari e, più recentemente, dai leader nazionalisti in lotta per il potere nella nuova Birmania. e spiegano in parte perchéla campagna militare contro i rohingya non ha perso legittimità neanche tra chi condivide gli ideali democratici: le operazioni nel Rakhine sono viste da molti come un mezzo per difendere una democrazia giovane. ma il fatto che la persecuzione di un’intera popolazione possa essere considerata moralmente giustificabile non si spiega solo con l’ansia delle tensioni politiche.
C’è evidentemente la convinzione che i rohingya siano portatori di una corruzione innata che va sradicata a tutti i costi. Durante la transizione democratica del paese la percezione della portata di questa minaccia è cambiata, e oggi l’ostilità nei confronti dei rohingya non è più circoscritta alle città e ai villaggi della parte occidentale del paese. È dai tempi del regime militare che le varie componenti della società birmana non sembravano così in sintonia, a prescindere dalle differenze geografiche. Oggi, però, sono unite da un obiettivo profondamente diverso.

Il manifesto, 19 ottobre 2017 nell’intervista di Chiara Cruciati la fortedenuncia di Jeff Halper, l’attivista israeliano che da una vita combatte per idiritti della Palestina; nella cronaca di Michele Giorgio i recenti atti direpressione dei soldati di Israele contro i palestinesi.
HALPER: «GUERRE CONTRO I POPOLI: IL MODELLO È ISRAELE»Chiara Cruciati intervista Jeff Halper
«Il capitalismo globale reprime i popoli usando il concetto di pacificazione. Ma l’Occidente non ha molta esperienza in questo tipo di conflitti. E Israele gli fornisce armi e high tech», spiega lo storico attivista israeliano Jeff Halper
Guerre contro-insurrezionali, anti-terrorismo,guerre non convenzionali, limitate, guerre a bassa intensità. Nell’ultimodecennio il mondo ha assistito alla trasformazione del concetto di conflittomilitare: da guerre tra Stati e eserciti a guerre contro i popoli. Repressione,stato di polizia, frontiere chiuse al passaggio di esseri umani ne sono laplastica rappresentazione.
In cima alla piramide del mercato globale dellasicurezza c’è Israele, paese che conduce da 70 anni una guerra contro un interopopolo, quello palestinese. Ne abbiamo discusso con ©, fondatore di “The People Yes! Network" e di “Icahd,Comitato israeliano contro la demolizione di case”. In questi giorni è in Italia per la presentazionedel libro La guerra contro il popolo. Israele, i palestinesi e lapacificazione globale (Ed. Epokè).
I sistemi usati oggi in Europa per impedirel’ingresso dei rifugiati lungo le rotte terrestri sono spesso made in Israel.
«Muri, sistemi di sorveglianza, barriere high techche individuano i movimenti umani: è tutto israeliano. Israele vende in Europale tecnologie di confine sviluppate sui palestinesi a Gaza e in Cisgiordania.Questa è la Palestina globalizzata. Israele sa che i palestinesi nonrappresentano alcuna minaccia ma forniscono un conflitto di basso livello chegli permette di sviluppare armi e sistemi di sicurezza e sorveglianza daesportare sul mercato globale. Israele è all’avanguardia perché ha un popolointero da usare come cavia da laboratorio».
Il libro introduce i concetti di «conflittosecuritario» e «industria globale della pacificazione». Perché il modelloisraeliano è diventato globale?
«L’occupazione israeliana va posta oggi all’internodel sistema capitalista globale che, entrato in crisi, è divenuto maggiormentecoercitivo. Cambia anche la guerra: dalle guerre tra Stati, convenzionali, si èpassati oggi a guerre contro i popoli, repressive di istanze popolari e a bassaintensità. Il capitalismo globale reprime i popoli utilizzando il concetto dipacificazione, ovvero una forma di repressione popolare che rende la baseincapace di reagire e riorganizzarsi.
«E, a parte il caso del Vietnam per gli Stati uniti,il nord globale – il centro del sistema capitalista mondiale – non ha moltaesperienza in questo tipo di conflitti. Ed è qui che Israele si inserisce: hale armi, le tattiche, il sistema di sicurezza e sorveglianza, il sistema dicontrollo della popolazione a cui oggi anelano le classi dirigenti di tutto ilmondo. E questo dà a Israele un potere nuovo, sul mercato militare ma anche sulpiano politico».
Un know how militare che si traduce in cartamonetapolitica e diplomatica?
La sua incredibile influenza è proporzionale albisogno che di Israele ha il capitalismo globale. La chiamo la «politica dellasicurezza» che intreccia l’economia israeliana (fondata sulla commistione traindustria bellica e high tech) a influenza politica internazionale.
Alcuni esempi. L’avvicinamento alla Cina: Israele èil secondo o il terzo esportatore di armi a Pechino, tradizionalmente vicinaalle istanze palestinesi. O la normalizzazione con l’Arabia saudita che sulpiano ideologico dovrebbe essere una nemica ma con cui condivide obiettivi(l’Iran) e bisogni (la repressione interna)».
Durante le proteste di Black Lives Matter negliUsa, gli attivisti palestinesi inviavano consigli su come resistere allecariche della polizia. Se il sistema securitario si globalizza, se ilcapitalismo si globalizza, è possibile che si globalizzi anche la resistenza?
«Il problema è l’assenza della sinistra. Ilcapitalismo è globalizzato, la cooperazione è globalizzata, gli Stati sonoglobalizzati e lo sono anche terrorismo e reti criminali. Solo la sinistra nonriesce a globalizzarsi. Il movimento delle donne non parla agli attivistipro-palestinesi, il movimento per il clima non parla a quello per i dirittidegli afroamericani e così via. I movimenti di base tendono a restare isolati,limitati, a concentrarsi su temi specifici senza fare i dovuti collegamenti conaltre questioni.
«La ragione sta nell’incapacità della sinistra divedere il quadro completo. Le nuove generazioni sono nate e cresciute sotto ilmodello globale del neoliberalismo, un sistema che ha annullato i movimentiglobali e distrutto la collettività, imponendo l’individualismo e la riduzionedei cittadini a consumatori. La sinistra dovrebbe dotarsi di un’agenda globaleche leghi le diverse questioni».
Il neoliberismo vive anche istigando la guerra tragli ultimi.
«Leopinioni pubbliche si sono assuefatte alla violenza di questo modellosecuritario. Il cittadino medio pensa a come proteggersi da soggetti cheapparentemente mettono in pericolo il suo lavoro, la sua casa, i suoi interessi,affibbiando le responsabilità del neoliberismo ai soggetti da questo esclusi.Anche qui Israele è modello ad una visione distorta, al non-impatto del modellorepressivo sulla società».
RAID NELLE SEDI DEIMEDIA PALESTINESI,
ALTRE 2600 CASE PER I COLONI
di Michele Giorgio
«Cisgiordania. Pugno di ferro di Israele nei Territori occupati dopo l'annuncio del governo Netanyahu che non negozierà con un governo palestinese con all'interno il movimento islamista Hamas».
Arresti notturni in Cisgiordania, migliaia di nuove case per coloni, demolizioni di abitazioni a Gerusalemme Est e raid dell’esercito nelle sedi di organi d’informazione palestinesi. Tutto nel giro di poche ore. Notizie che certo non rappresentano una novità nei Territori palestinesi che Israele occupa del 1967. Tuttavia questa escalation potrebbe essere collegata alla decisione del governo Netanyahu di far uso del pugno di ferro contro la riconciliazione tra il movimento islamista Hamas e il partito Fatah.
L’altro giorno è passata nell’esecutivo israeliano la linea del ministro ultranazionalista Naftali Bennett che aveva chiesto di dare una risposta forte all’accordo al Cairo tra le due principali forze politiche palestinesi divise per dieci anni da uno scontro devastante. Il premier Netanyahu che, secondo gli analisti aveva inizialmente scelto una posizione più prudente, ha deciso che il suo governo non negozierà con quello palestinese se al suo interno ci sarà anche Hamas del quale è tornato a chiedere il disarmo.
«Le decisioni del gabinetto israeliano sono una scusa per arrivare a un punto morto» denunciano i palestinesi. Il «no» di Netanyahu al negoziato con il futuro governo di unità nazionale avrebbe lo scopo, aggiungono, di aprire la strada al “piano di pace” dell’Amministrazione Trump che, secondo le indiscrezioni, propone la soluzione della questione palestinese nel quadro di una trattativa tra Paesi arabi e Israele.
Sono 1.323 i nuovi alloggi che saranno costruiti per i coloni israeliani nella Cisgiordania occupata, dove ieri un palestinese avrebbe tentato di accoltellare un soldato israeliano ma è stato bloccato e ferito. Un numero che porta, in appena tre giorni, a 2.646 il totale delle nuove unità abitative negli insediamenti coloniali, rivela l’organizzazione pacifista Peace Now. A questi appartamenti si aggiungono i 31 approvati lunedi, per la prima volta dal 2002, per i coloni nella città di Hebron. Una colata di cemento che non turba il leader dell’opposizione laburista Avi Gabbai che a inizio settimana aveva escluso l’evacuazione anche di una sola colonia nel quadro di un accordo di pace. Poi ha fatto una parziale retromarcia.
Invece vengono demolite subito le case palestinesi “illegali” nei territori sotto occupazione. Tra martedì e ieri le ruspe del comune israeliano di Gerusalemme hanno trasformato in un cumulo di macerie un edificio nel quartiere di Beit Hanina e due abitazioni a Silwan. «Ai palestinesi vengono rilasciati pochi permessi edilizi mentre dal 1967 i governi di Israele sono stati coinvolti nella costruzione a Gerusalemme Est di 55mila case per israeliani contro le 600 per i palestinesi», ricorda Daniel Seidemann di “Terrestrial Jerusalem”. L’Onu riferisce che dall’inizio dell’anno sono stati demoliti a Gerusalemme 116 edifici palestinesi.
Sarebbero parte, secondo il portavoce militare israeliano, di una operazione dell’Esercito contro «l’istigazione alla violenza e al terrorismo» i raid compiuti martedì notte negli uffici di otto redazioni giornalistiche palestinesi a Betlemme, Nablus, Ramallah e Hebron, città che ufficialmente sono sotto la piena autorità, anche di sicurezza, dell’Anp di Abu Mazen. I soldati hanno sequestrato computer, documenti, filmati, registrazioni audio negli studi di Pal Media, Ram Sat, Trans Media, Al Quds, Al Aqsa, Palestine Alyoum e di altre due emittenti.
«È stata una brutale aggressione. L’occupazione israeliana vuole prevenire la copertura mediatica delle atrocità che compie», ha protestato il portavoce dell’Anp, Yousif Mahmoud. Immediata la replica dell’Esercito: «Le forze di sicurezza continueranno a lavorare contro l’incitamento al terrorismo». Da Londra la Commissione di sostegno ai giornalisti (Journalist Support Committee) ha condannato i raid, sottolineando che sono 33 i reporter palestinesi nelle prigioni israeliane, gli ultimi due, arrestati ieri, sono i fratelli Amer e Ibrahim al Jaabari di Trans Media. Nelle stesse ore sono stati arrestati altri 16 palestinesi.

il Fatto Quotidiano
Piove a gocce grosse come biglie. In pochi minuti il sole si oscura e con la stessa velocità la strada si trasforma in una palude. Le capanne flettono sotto il peso dell’acqua, i viottoli che scendono per le collinette diventano ruscelli. Un mese fa questo era un bosco, oggi è il campo profughi di Balukhali, dove vivono oltre 100 mila rifugiati. Ma i numeri dell’esodo rohingya sono ancora più imponenti. Da fine agosto una violenta azione dell’esercito birmano ha messo in fuga verso il Bangladesh oltre mezzo milione di persone, tutte bloccate in una manciata di chilometri quadrati all’estremo sud del Paese. In un quarto d’ora torna il sole e illumina il fango lasciato dall’acquazzone. Il termometro schizza sopra i 35 gradi, che con l’umidità sembrano 45.
“Sono rimasto solo – Rohaman, sedici anni, non perde il sorriso nemmeno mentre racconta il massacro della sua famiglia – l’esercito è arrivato e ha iniziato a sparare, era notte. I miei genitori e mia sorella dormivano, sono bruciati con la casa”. Rohaman quella sera era da suo zio. Quando ha visto il fuoco è scappato nella foresta. “Mi sono nascosto lì per 12 giorni – continua il ragazzo – senza mangiare, senza dormire”. Ha altri otto fratelli, anche loro sono scappati: “Saranno in un altro campo o forse ancora in Myanmar”. Racconta che di Buthi Dung, il suo piccolo villaggio, non è rimasto più nulla: “Tutto è stato bruciato, le trecento persone che ci vivevano o sono fuggite o sono morte”.
La storia di Rohaman è piena di dettagli, di colpi di macete, di arti amputati, di stupri, ma soprattutto di paura. Tutto questo però non è verificabile. Il Myanmar non permette ai giornalisti e agli osservatori internazionali di visitare il Rakine, la regione interessata dagli scontri. Le immagini satellitari, analizzate da Human Right Watch, hanno registrato il rogo di oltre 65 villaggi nelle ultime sei settimane. Per chi scappa si tratta della mano incendiaria dell’esercito birmano. Per i generali, invece, sono gli stessi rohingya a dar fuoco alle proprie case per poi fuggire in Bangladesh. Ma la versione della giunta militare, che guida il Myanmar da quasi 30 anni, non convince gli osservatori internazionali: “Le operazioni della Birmania contro i rohingya, sembrano applicare i principi della pulizia etnica”, ha detto a metà settembre Zeid Ràad el Hussein, l’Alto Commissario dei diritti umani delle Nazioni Unite a Ginevra.
Le accuse della comunità internazionale fanno ancora più rumore, perché offuscano l’aura di Aung San Suu Kyi, icona mondiale della nonviolenza. Nel 1990, poco dopo che la giunta militare s’impadronì del potere, Suu Kyi si presentò alle elezioni e le vinse. L’esercito la fece incarcerare. L’anno successivo la signora di Rangoon fu insignita del Nobel per la Pace. Da lì in poi, fino al 2010, visse agli arresti domiciliari. Oggi, dopo aver vinto le elezioni del 2015, sarebbe dovuta essere il primo ministro, ma i militari le hanno assegnato un ruolo creato ad hoc: consigliere di Stato. Per tre settimane dall’inizio della crisi, Suu Kyi ha mantenuto il silenzio sulle violenze perpetrate contro la minoranza rohingya. Il 18 settembre ha, finalmente, detto la sua: difendendo le forze di sicurezza che starebbero prendendo tutte le misure necessarie per non colpire i “civili innocenti” e per evitare “danni collaterali”. Strano che dopo anni di arresti domiciliari l’eroina birmana si schieri con i suoi (ex) aguzzini.
All’ingresso del campo di Balukhali su un cartellone nero si legge “Basta omicidi. Aung San Suu Kyi riconsegna il Nobel”. Se violenze e ferite possono essere nascoste, bastano pochi passi tra i rohingya rifugiatisi in Bangladesh per vedere i segni della malnutrizione. Da ogni tenda spuntano bambini nudi da braccia, gambe scheletriche e con il ventre gonfio. In piedi davanti all’ingresso della capanna di bambù c’è una donna con un bimbo di poche settimane tra le braccia. “Siamo scappati quando lui aveva 20 giorni – spiega Nurtaz Bagan, 25anni e cinque figli – non avevo latte da dargli. Prima di arrivare qui non mangiavo da giorni”. L’esercito di Dhaka registra tutti i rohingya che entrano nel Paese e li invia verso i campi profughi, a pochi chilometri dal confine. Non è il governo a prendersi cura di loro, ma le ong. Lunghe file dall’alba al tramonto segnano il ritmo dei pasti. Dei recinti di bambù racchiudono centinaia di bambini che aspettano nel fango. Chi di loro ha un piatto lo usa per ripararsi dal sole. Dai pentoloni escono mestolate di riso e salsa piccante. Non ce n’è per tutti. Si corre, si litiga, qualcuno scoppia a piangere, molti resteranno a digiuno anche oggi.
Un mormorio ritmico e ripetitivo arriva dalla cima di una collinetta. Uomini in galabeya bianca e barba lunga appoggiano la fronte a terra. La moschea è il luogo più pulito di tutto il campo. Il trentenne Ayoub Khan sorregge il padre anziano mentre si infila le ciabatte dopo aver terminato il rito della preghiera. “Non meritava di lasciare la sua casa prima di morire – dice mentre prende sottobraccio il genitore e lo accompagna verso la tenda – ci danno la caccia perché siamo rohingya, perché siamo musulmani”. Ayoub divide la capanna con tutta la famiglia allargata, meno di 20 metri quadrati dove dormono e mangiano 13 persone. “Sono laureato, ma non mi hanno mai fatto lavorare. In Birmania noi rohingya non possiamo avere impieghi qualificati. Ci odiano e ci perseguitano”.
In Myanmar la maggioranza della popolazione è buddista. I rohingya sono confinati nel nord del Paese, alla frontiera con il Bangladesh. Nei secoli quell’area passa di mano diverse volte. Si crea così una minoranza musulmana con lingua e cultura diversa dal resto dello Stato. Durante la Seconda guerra mondiale i britannici armano i rohingya, i giapponesi fanno lo stesso con i buddisti. I massacri si susseguono per anni. Non basta la fine del conflitto mondiale: le armi continuano ad arrivare dal Regno Unito, questa volta per fermare l’avanzata dell’Unione Sovietica. Nel 1948 la Birmania diventa indipendente. Subito la maggioranza burma e buddista inizia una discriminazione sistematica contro la minoranza musulmana. Media e società civile etichettano i rohingya come migranti illegali bangladesi. La repressione genera una resistenza violenta che negli ultimi anni si riunisce nell’Arsa, un gruppo di matrice islamica che lotta per la liberazione dell’Arkan, antico regno dei rohingya. Per ogni attacco dell’Arsa l’esercito birmano colpisce i villaggi musulmani. I civili scappano. Il copione si ripete, fino a degenerare ad agosto nella più grande crisi umanitaria dei nostri giorni.
Nessuno è in grado di dare dati ufficiali né su quanti siano i rohingya entrati in Bangladesh né su quanti ce ne siano nei campi. Lungo le strade che attraversano gli insediamenti gli uomini camminano schiacciati dal peso dei lunghi bambù che trasportano. “Dieci pali lunghi quattro metri – dice un ragazzo con gli alberi in equilibrio sulla spalla – due teloni di plastica e qualche cordino. Basta questo per costruirmi casa”. Tra il fango e la pioggia i profughi stanno costruendo una città con canne di bambù. Le tagliano, legano e intrecciano, trasformandole in tetti, muri e recinti. Tutto destinato a durare meno della stagione monsonica.
Non c’è un piano di sviluppo, non ci sono bagni né acqua corrente. Mancano le scuole e le strutture sanitarie, ma si contano già decine di moschee. Le fogne non sono altro che dei canali di scolo che scaricano in mezzo alle colline, proprio accanto ai primi embrioni di negozi. L’odore acre di feci mischiate ad acqua lasciata al sole, è un campanello d’allarme importante. La organizzazione mondiale della Salute ha già annunciato un piano di vaccinazioni obbligatorie contro il colera.
I campi si snodano per una lingua d’asfalto lunga quasi dieci chilometri, alle due estremità i posti di controllo dell’esercito di Dhaka. I rohingya possono entrare, ma non uscire. Siamo nel distretto di Cox’s Bazar, la riviera romagnola del Bangladesh, 120 chilometri di spiaggia con sabbia bianca, la perla del turismo nazionale. Il mezzo milione di rifugiati ha visto quel mare solo una volta, quando lo ha attraversato scappando dalla Birmania.
Shamlapur è un villaggio di pescatori, il Myanmar dista meno di un’ora di navigazione. Sul bagnasciuga sono adagiate diverse barche lunghe una decina di metri, hanno poppa e prua affusolate verso l’alto. “Ci sono stati molti naufragi – racconta Saad Bin Hossain, regista di Dhaka che sta documentando la fuga dei rohingya – lunedì scorso l’ultimo. Sono arrivati a riva 12 cadaveri, dieci erano bambini”. L’acqua è scura, carica della terra che i monsoni gettano in mare. “Si può attraversare il confine anche a piedi – continua Saad – ma è più pericoloso. Ho visto il corpo di un ragazzo imputridire nella no man’s land, ha pestato una mina anti-uomo, con lo zoom della telecamera lo potevo vedere in faccia, i suoi resti sono ancora lì”.

Nigrizia.
A lanciare l’allarme è un nuovo rapporto dell’International Crisis Group, che rileva come le violenze tra pastori e contadini in Nigeria stiano diventando sempre più pericolose, tanto da poter essere equiparate all’insurrezione di Boko Haram nel nord-est del paese. Secondo lo studio, intitolato “Herders against Farmers: Nigeria’s Expanding Deadly Conflict“ (Contadini contro agricoltori: sanguinoso conflitto nigeriano in espansione), nel 2016, circa 2.500 persone sono rimaste uccise a causa degli scontri e finora il governo, sia a livello federale che statale, si è dimostrato incapace nel contrastarli.
All’origine dell’atavica conflittualità tra contadini e pastori c’è la ricerca di nuovi terreni e spazi vitali per l’allevamento delle mandrie, il possesso e il controllo dell’acqua, la chiusura delle tradizionali vie di migrazione, il furto di bestiame e i danni arrecati alle coltivazioni.
La relazione rileva però che le radici del conflitto sono più profonde e vanno ricercate nella siccità e nella desertificazione, che hanno degradato i pascoli e prosciugato molte fonti di approvvigionamento idrico nella cintura saheliana settentrionale della Nigeria. Tali cause hanno costretto molti pastori a spostarsi verso sud in cerca di pascoli e acqua per il loro bestiame.
Altre motivazioni che hanno spinto un numero crescente di pastori a migrare verso la parte meridionale della Nigeria, sono da ricercare nell’insicurezza negli stati settentrionali generata dall’insurrezione di Boko Haram e dal susseguirsi di atti di banditismo nelle zone centro-settentrionali e nord-orientali del paese.
Anche l’incremento di insediamenti umani, l’espansione delle infrastrutture pubbliche, l’acquisizione di terreni su larga scala da parte degli agricoltori e altri interessi commerciali privati, ??hanno sottratto i pascoli ai pastori. Pascoli che gli erano stati riservati dal governo dopo l’indipendenza dal Regno Unito, quando il paese era una federazione di tre regioni.
Tensioni etniche e religiose
Il report evidenzia pure che la diffusione del conflitto negli stati del sud sta ulteriormente aggravando i già fragili rapporti tra i principali gruppi regionali, etnici e religiosi del paese. Le comunità cristiane, di maggioranza del sud, risentono dell’influenza esercitata dai pastori, prevalentemente musulmani, descritti in alcune narrazioni come “milizie islamizzate”.
I pastori nomadi appartengono in prevalenza al gruppo dei fulani e tale appartenenza imprime una dimensione etnica alle violenze. Il fatto che i fulani siano presenti in molti paesi dell’Africa occidentale e centrale, implica inoltre che qualsiasi scontro di congrua rilevanza tra essi e altri gruppi nigeriani, potrebbe avere anche ripercussioni regionali.
Gli analisti dell’Istituto di Bruxelles sottolineano che negli ultimi cinque anni sono state uccise migliaia di persone e anche se i dati precisi non sono disponibili, una stima basata sull’analisi delle fonti aperte dal 2011 al 2016, indica una media annuale di oltre 2 mila vittime, superando in alcuni anni il numero di quelle provocate dagli attacchi del movimento jihadista Boko Haram.
Decine di migliaia di persone sono inoltre state forzatamente sfollate, con ingenti danni per raccolti e bestiame che hanno causato la perdita di miliardi di naira (la moneta nigeriana, un milione di naira equivale a circa 2.360 euro) e pesanti ripercussioni per le economie locali.
Indifferenza dei governi
A fronte di questa situazione, la reazione delle autorità federali e statali della Nigeria, finora è stata ben poco incisiva. Le agenzie di sicurezza federali e le forze dell’ordine non hanno istituito meccanismi di prevenzione o di risposta rapida per arginare le violenze. L’incapacità dimostrata dalle istituzioni nigeriane nel contrastare gli scontri, ha indotto sia i pastori che gli agricoltori a gestire la situazione da soli, aggravando di conseguenza il conflitto.
In conclusione, il rapporto ritiene che il fallimento del governo federale nel definire un approccio politico chiaro e coerente per risolvere la crisi e riconoscerne la portata, unito alla mancanza di una risposta decisiva ed efficace, comporti per la Nigeria il rischio di sprofondare in conflitti sempre più letali, mettendo in pericolo la sicurezza di tutti i nigeriani.

Nena News
“La libertà verrà, è inevitabile. L’occupazione avrà fine o con l’indipendenza dello Stato di Palestina o, se vogliono, con uguali diritti per tutti gli abitanti della Palestina storica, dal fiume [Giordano] al mar [Mediterraneo]”. A dirlo è stato ieri il presidente dell’Autorità palestinese Mahmoud Abbas (Abu Mazen) sul podio della 72esima Assemblea generale delle Nazioni Unite. Il discorso di Abbas è stato però complessivamente deludente: il leader di Fatah ha sì espresso parole dure nei confronti “dell’apartheid” israeliana e della complicità della comunità internazionale per il suo sostegno al “processo di colonialismo di insediamento” israeliano, ma ha anche espresso fiducia sull’abilità del presidente Usa Trump di porre fine al conflitto israelo-palestinese. Una fiducia, quest’ultima, che appare priva di alcun fondamento logico: proprio due giorni fa all’Onu The Donald ha ribadito la sua forte alleanza con Israele e, concentrandosi sull’Iran e Corea del Nord, ha ignorato del tutto la causa palestinese.
Abbas ha poi ricordato la questione di al-Aqsa a Gerusalemme dicendo che Israele sta “giocando con il fuoco” poiché sta cercando di cambiare lo status quo sulla Spianata delle Moschee, teatro questa estate di due settimane di proteste. Il presidente è ritornato su quei giorni lodando la risposta “pacifica” dei palestinesi alle decisioni delle autorità israeliane. Il passaggio ad al-Aqsa ha offerto all’anziano leader l’opportunità per mandare un messaggio a Israele: non trasformare il “conflitto politico” in uno religioso esacerbando le tensioni a Gerusalemme est.
Il popolo palestinese, ha aggiunto, ha fatto “tutti gli sforzi possibili per fare la pace con i vicini israeliani”, ma lo stato ebraico ha rifiutato tutte le iniziative. A partire dalla “soluzione a due stati” il cui rifiuto di Tel Aviv “pone a rischio l’intera regione”. Lo status quo – ha aggiunto – peggiora sempre di più per le continue violazioni della legge da parte d’Israele”. Una situazione che si fa sempre più difficile perché, ha sottolineato, la Palestina sta terminando lo spazio per formare uno stato indipendente a causa “dell’inarrestabile attività coloniale israeliana sul territorio palestinese”. Nonostante però si accorga di questa realtà sul terreno, Abbas continua a sposare la vecchia linea: la necessità di una soluzione a due stati con Israele nei confini del 1967.
Abbas ha poi criticato il sostegno ad Israele da parte della comunità internazionale apparendo più convincente: “L’apartheid – ha detto – è stata abolita in Sud Africa, ma è ancora presente in Palestina. Come può essere accettabile? Proprio per sconfiggere questa discriminazione, ha argomentato, la comunità internazionale deve fornire un esatto quadro temporale entra il quale l’occupazione israeliana dovrà terminare, deve implementare la Risoluzione 194 (il ritorno dei rifugiati palestinesi prodotti dalla fondazione d’Israele del 1948), garantire protezione internazionale ai palestinesi fin quando non sarà terminata l’occupazione israeliana e smetterla di essere complice del “processo di colonialismo d’insediamento” israeliano. La strada, ha osservato, è già stata tracciata durante la segregazione razziale in Sud Africa quando il paese africano fu oggetto di un boicottaggio internazionale.
Significativo il passaggio su Hamas e Striscia di Gaza. Qui il presidente ha dichiarato che “non ci sarà nessuno stato. E non ci sarà uno stato palestinese senza Gaza” esprimendo il suo “sollievo” per i recenti sforzi di riavvicinamento compiuti dai rivali islamisti. Proprio sulla riconciliazione nazionale, Abbas ha detto che alcuni ufficiali dell’Autorità palestinese si recheranno la prossima settimana a Gaza per “assumere le loro responsabilità” e ha aperto alla possibilità di indire in futuro le elezioni generali.
Qualche ora prima di parlare dal podio dell’Assemblea Generale dell’Onu, Abbas aveva incontrato Trump e il Segretario generale dell’Onu Guterres. Con il primo, il leader di Fatah ha parlato degli sviluppi regionali esprimendo la sua fiducia sull’abilità dell’inquilino della Casa Bianca di mediare un accordo tra Palestina e Israele. Secondo quanto riporta l’agenzia palestinese Wafa, il presidente palestinese ha affermato che il quarto incontro con Trump da quando è stato eletto alla presidenza statunitense “mostra la serietà” di quest’ultimo nel voler raggiungere “l’accordo del secolo in Medio Oriente quest’anno o nei mesi a seguire”.
Con il Segretario generale dell’Onu, invece, sono stati discussi i recenti sviluppi politici palestinesi. Abbas ha però anche esortato il capo delle Nazioni Unite a far rispettare le risoluzioni internazionali relative alla Palestina. Posizioni che, almeno a parole, il Segretario dell’Onu condivide: lo scorso mese, in visita alla Striscia di Gaza, ha chiesto la fine del decennale assedio israeliano descrivendo la situazione nella piccola enclave come “una delle crisi umanitarie più drammatiche” che ha mai visto.
 «Russia, Usa, Francia, Cina, Gran Bretagna, India, Pakistan, Israele e Corea del Nord hanno bombe, missili, sottomarini. Una corsa al riarmo in barba ai trattati».
«Russia, Usa, Francia, Cina, Gran Bretagna, India, Pakistan, Israele e Corea del Nord hanno bombe, missili, sottomarini. Una corsa al riarmo in barba ai trattati».
il Fatto Quotidiano, 11 settembre 2017 (p.d.)
Il mondo è in pieno riarmo nucleare. Non tanto per il numero di testate, in lento calo dopo il nuovo trattato Start del 2010, ma per i programmi di modernizzazione delle forze nucleari avviati da tutte le nazioni armate di atomica. Non solo la Corea del Nord, ma tutti i nove Stati nucleari sono impegnati in costosissimi progetti per la costruzione di bombe più potenti o di nuovi missili, bombardieri e sottomarini per il lancio di testate nucleari. Una competizione tra programmi a lungo termine che, come osserva l’Istituto Internazionale di Ricerche sulla Pace di Stoccolma, dimostra che “nessuno di questi Stati sarà pronto a privarsi del suo arsenale nucleare nel prevedibile futuro”.
Il 92% delle quasi 15.000 testate nucleari esistenti – di cui 4.150 schierate, cioè ponte all’uso – si trova negli arsenali americani e russi in quantità equivalenti: 7.000 in Russia (di cui 1.950 schierate) e 6.800 negli Stati Uniti (di cui 1.800 schierate). Le due potenze nucleari europee, Francia e Gran Bretagna, detengono rispettivamente 300 testate (quasi tutte schierate) e 215 testate (la metà schierate). La Cina ha 270 bombe, tutte schierate, così come gli eterni nemici India e Pakistan che ne hanno circa 130 ciascuna, tutte puntate contro il vicino avversario. Anche le 80 atomiche di Israele sono pronte all’uso. Infine la Corea del Nord, che sembra averne almeno una ventina, il triplo secondo Washington.
Troppo spesso nel tracciare la mappa globale del Risiko atomico (che fino agli Anni 90 comprendeva anche Sudafrica, Ucraina, Bielorussia e Kazakistan) ci si limita a questi nove Paesi dimenticando di citare anche gli Stati nucleari “in subappalto”, tra cui l’Italia, vale a dire le cinque nazioni che fin dagli Anni 60, in virtù della dottrina atlantica della “condivisione nucleare” (Nuclear Sharing) detengono bombe atomiche Usa che, in caso di conflitto nucleare, saranno impiegate dalle forze aeree nucleari nazionali (oggi i Tornado, domani gli F-35). In tutto almeno 150 bombe, di cui un terzo in Italia (nelle basi di Aviano e Ghedi), altrettante in Turchia e il resto spartito tra Germania, Belgio e Olanda. Tutti Paesi, Italia compresa, che non a caso hanno boicottato il Trattato per la messa al bando degli armamenti nucleari approvato a luglio dall’Assemblea generale Onu.
Stati Uniti. Obama aveva avviato – e Trump sta portando avanti – un poderoso programma di ammodernamento nucleare da 400 miliardi di dollari fino al 2026 (un trilione di dollari in trent’anni) per potenziare le bombe termonucleari tattiche B61 (comprese quelle schierate in Italia), costruire i nuovi bombardieri nucleari a lungo raggio B-21 per rimpiazzare i vecchi B-52 e B-1, i nuovi missili nucleari da crociera Long-Range Standoff, i nuovi missili nucleari balistici intercontinentali Ground Based Strategic Deterrent destinati a sostituire i vecchi Minuteman III e infine i nuovi sottomarini lanciamissili nucleari classe Columbia che prenderanno il posto della classe Ohio.
Russia. Anche Putin, in risposta al dispiegamento dello scudo antimissile americano in Polonia e Romania e allo sviluppo del programma Usa Prompt Global Strike (Attacco Globale Fulmineo), sta investendo molto nell’ammodernamento dell’arsenale nucleare ex-sovietico. Dopo aver costruito i nuovi missili nucleari balistici intercontinentali semoventi RS-24 Yars in grado di trasportare sei testate termonucleari capaci di colpire obiettivi diversi, il Cremlino sta testando gli ancor più potenti missili intercontinentali pesanti da silos RS-28 Sarmat, che di testate ne potranno trasportare addirittura quindici e che pare abbiano capacità di condurre bombardamenti atomici orbitali. Senza dimenticare i nuovi bombardieri nucleari Tu-160 e i nuovi sottomarini lanciamissili nucleari classe Borei.
Gran Bretagna. Nel 2015 il governo conservatore del primo ministro David Cameron, su proposta del segretario alla Difesa Michael Fallon, ha avviato il discusso programma di sostituzione della flotta di sottomarini lanciamissili nucleari classe Vanguard con i nuovi sottomarini classe Dreadnought che verranno armati con missili Trident II dotati di nuove testate Mark 4A, più potenti e precise. Il costo complessivo del programma è stimato in 45 miliardi di dollari.
Francia. La Difesa francese, oltre a portare avanti il programma di ammodernamento dell’arsenale missilistico nucleare sottomarino con i nuovi missili balistici intercontinentali M51, ha avviato dal 2012 lo studio per la sostituzione dei sottomarini lanciamissili nucleari classe Triomphant. Analogamente, per la componente aerea, Parigi ha deciso l’ammodernamento del missili nucleari da crociera a medio raggio ASMP-A in dotazione ai bombardieri Mirage e Rafale e la loro sostituzione con missili nucleari supersonici e stealth ASN4G (prodotti da MBDA, partecipata da Leonardo).
Cina. La Repubblica popolare cinese sta testando i nuovi missili nucleari balistici intercontinentali semoventi Dongfeng-41 (DF-41) ognuno in grado di trasportare una dozzina di testate termonucleari: una volta operativi, saranno i missili a più lunga gittata esistenti al mondo, in grado di colpire il territorio americano. Grande importanza riveste per Pechino lo sviluppo di un’effettiva deterrenza nucleare marittima basata sulla creazione di una flotta di moderni sottomarini lanciamissili nucleari, i Type 094 classe Jin, armati con i nuovi missili nucleari intercontinentali JL-2. La Cina si sta dotando anche di un bombardiere strategico nucleare stealth a lungo raggio Xian H-20 per rimpiazzare gli H-6 di vecchia concezione, così da mettersi al pari con i B-21 americani.
India e Pakistan. I due storici nemici (non firmatari del Trattato di non proliferazione nucleare del 1970) stanno entrambi lavorando per accrescere i loro arsenali, oltre a potenziare le rispettive forze nucleari, non solo per deterrenza reciproca. Nuova Delhi sta sviluppando i nuovi missili nucleari balistici intercontinentali Agni-V in grado di colpire anche la Cina e si sta dotando per la prima volta di una flotta di sottomarini lanciamissili nucleari, classe Arihant, armati con i nuovi missili K-4, attualmente in fase di test. Islamabad rincorre il nemico lavorando ai nuovi missili nucleari balistici Shaheen-III, e alla costruzione di una deterrenza nucleare marittima, ma soprattutto allo sviluppo di piccoli ordigni nucleari tattici da impiegare contro l’India.
Israele. I progetti nucleari militari israeliani rimangono avvolti nel mistero, a partire dal reale numero di testate (il doppio delle 80 dichiarate secondo alcune fonti). Si sa solo che Tel Aviv (non aderente al Tnp) sta testando un nuovo missile nucleare balistico intercontinentale, il Jericho IV, in grado di colpire qualsiasi bersaglio sul pianeta, e sta continuando ad accrescere la sua flotta di sottomarini tedeschi classe Dolphin, in grado di lanciare missili Popeye armabili con testate nucleari.
Corea del Nord. Come noto, il regime di Kim Jong-un ha condotto negli ultimi mesi una serie di test con missili balistici Hwasong che gli consentono di minacciare con armi nucleari non solo il Giappone e la base americana di Guam nel Pacifico, ma addirittura la costa ovest degli Usa e l’Europa. Non è chiaro se, oltre alla gittata, questi missili siano anche in grado di colpire accuratamente il bersaglio.
 «Alleanza “tattica”. I talebani sono agli antipodi rispetto allo Stato Islamico su fini e metodi, ma si è creato un interesse obiettivo di venire a patti».
«Alleanza “tattica”. I talebani sono agli antipodi rispetto allo Stato Islamico su fini e metodi, ma si è creato un interesse obiettivo di venire a patti».
il Fatto Quotidiano, 1°settembre 2017 (p.d.)
31.7. Attacco a Kabul a un
compound della polizia afghana vicino all’ambasciata irachena (rivendicazione Isis). 25.8. Attacco alla moschea sciita di Imam Zaman. Venti morti e 35 feriti (attacco Isis). 29.8. Attacco alla filiale della Kabul Bank dove soldati e poliziotti stavano ritirando il salario. Cinque morti e nove feriti. Rivendicato dai talebani. Kabul brucia. Per i talebani e i jihadisti concentrare i propri sforzi sulla capitale afghana, oltre che un importante valore simbolico ne ha uno, ancor più importante, strategico. Infatti tutte le volte che i talebani sono riusciti a riconquistare una città di piccole o medie dimensioni sono stati spazzati via dall’aviazione americana che bombarda a chi
cojo cojo, come avvenne a Kunduz il 3 ottobre 2015 quando riuscirono a centrare, con precisione chirurgica, anche un ospedale di Medici senza frontiere, che da quelle parti, e non sul Mediterraneo, ha una funzione insostituibile.
A Kabul gli americani e le forze della Nato non possono comportarsi con la stessa criminale disinvoltura, non perché colpirebbero sicuramente dei civili (dei civili afghani non gli potrebbe fregar di meno, in sedici anni di guerra ne sono stati uccisi dai 200 ai 300 mila senza che nemmeno Amnesty International osasse emettere un solo lamento) ma sicuramente dei soldati “regolari”, poliziotti, spie, infiltrati, Ong, collaborazionisti di ogni genere, imprenditori “amici”. Devono quindi agire con più cautela, con uomini sul terreno.
Si è detto che sarebbe in corso un’alleanza fra talebani e gli uomini di Al-Baghdadi. Un’alleanza in senso stretto non è possibile, allo stato. Perché diversi sono gli obiettivi dei due movimenti. I talebani vogliono ridare all’Afghanistan la sua indipendenza. La loro è una guerra ‘laica’. Quella jihadista è una guerra religiosa per piegare al verbo sunnita, in salsa wahabita, il mondo intero. Questo almeno in superficie, perché i moti più profondi del jihadismo sono sociali, come ho scritto più volte e come adesso è stato ammesso anche dal Procuratore della Repubblica di Trieste Carlo Mastelloni: “L’islamizzazione eversiva di ogni disagio, sia esso sociale, etnico che esistenziale sembra un dato ormai accertato idoneo a collocare in secondo piano persino la stessa conversione religiosa”.
A obiettivi diversi corrispondono metodi diversi. I talebani hanno sempre mirato a colpire obiettivi militari e politici, risparmiando il più possibile i civili, perché non hanno alcun interesse a inimicarsi la popolazione afghana sul cui appoggio si sostiene, da sedici anni, la loro resistenza. I jihadisti non hanno nessuna remora a colpire la popolazione, in particolare quella sciita (numerosi sono stati in Afghanistan gli attentati alle moschee sciite durante le funzioni, con centinaia di morti). Faccio notare che nei sei anni e mezzo di governo talebano la consistente minoranza sciita non è mai stata toccata. Nell’Afghanistan del Mullah Omar si poteva essere sunniti, sciiti, hazara e anche laici (Gino Strada era lì con i suoi uomini, e donne, di Emergency). L’importante era che tutti rispettassero la legge. Punto e basta.
Qualcosa però è cambiato nello scenario afghano. I Talebani, pur rimanendo militarmente, socialmente, culturalmente egemoni in tutta la vastissima area rurale del Paese (mentre la presenza dell’Isis, quasi esclusivamente militare, è assai più ridotta) si sono indeboliti. Non è stato facile per loro fronteggiare contemporaneamente gli occupanti occidentali e gli invasori dell’Isis. Inoltre la morte del Mullah Omar è stato un colpo durissimo per il movimento talebano. Omar con l’enorme prestigio che si era conquistato combattendo contro i sovietici, combattendo i “signori della guerra” che avevano fatto dell’Afghanistan terra di assassinii, di stupri, di taglieggiamenti e di ogni sorta di abuso sulla povera gente, riportando la pace e l’ordine nel Paese, governandolo saggiamente, senza inutili ferocie che gli erano estranee e guidando poi per quattordici anni la resistenza agli occupanti occidentali, riusciva a tenere compatto il movimento e coerente con i suoi obiettivi. I successori non sono alla stessa altezza.
Inoltre gli americani, con grande intelligenza, sono riusciti a far fuori, col solito drone teleguidato, il suo “numero due”, Mansour, che, se non aveva lo stesso prestigio di Omar, appartenendo alla “vecchia guardia” ne condivideva le idee e le linee politiche e militari, che possiamo definire, con tranquilla coscienza, moderate. Quindi molti giovani talebani, che non hanno fatto la resistenza, vittoriosa, agli invasori sovietici, la guerra, altrettanto vittoriosa, contro i “signori della guerra”, che non conoscono la rigida etica talebana, così puntigliosamente precisata dal “libretto azzurro” del 2009 del Mullah Omar, più che dalla moderazione della dirigenza talebana sono attratti dalla ferocia senza limiti, ma efficace, dell’Isis di cui vanno a ingrossare le fila. Inoltre molti foreign fighters che hanno perso la partita in Iraq stanno convergendo in Pakistan e in Afghanistan.
C’è quindi un interesse obiettivo dei Talebani di venire a patti con l’Isis. Per il momento sembra che abbiano smesso di combattersi fra di loro, finendo di fare il gioco dei loro nemici comuni, anche se per motivi diversi: gli occidentali. Ma qualche alleanza “tattica” è probabilmente già in atto. L’ultimo attentato alla Kabul Bank è stato rivendicato dai talebani ma ha anche modalità Isis (il kamikaze, l’autobomba, il fatto che a ritirare i salari c’erano sì soldati, poliziotti, collaborazionisti, ma anche molti civili afghani). Un’alleanza strategica è possibile, ma solo sulle basi poste dal nuovo leader talebano, che ha preso il posto di Mansour, Maulvi Haibatullah Akhundzada: “Voi ci aiutate a combattere gli occupanti occidentali, ma con i nostri metodi non con i vostri. Niente obiettivi civili”, la sua linea. Che ha il seguito seguente: “Una volta cacciati gli occidentali, noi vi permettiamo di attraversare l’Afghanistan e di entrare in Turkmenistan, Uzbekistan, Tagikistan che sono fra i vostri obbiettivi” (Progetto Khorasan, con esclusione ovviamente dell’Afghanistan). Vedremo. Speriamo.
 L'imprevedibile Trump prende la svolta interventista e concede maggiori poteri ai suoi generali.
L'imprevedibile Trump prende la svolta interventista e concede maggiori poteri ai suoi generali.
La Repubblica, 22 agosto 2017 (p.d.)
C'era una volta il Donald Trump isolazionista. In campagna elettorale diceva: «Basta missioni all’estero, è l’America la nazione che dobbiamo ricostruire». La guerra in Afghanistan? «Denaro sprecato, ritiriamoci subito» (un tweet del 2016). E c’è adesso il presidente Trump che rinuncia a un’altra delle sue promesse. Con il risultato paradossale che l’Afghanistan diventa da oggi una “sua” guerra. Qualsiasi rovescio sul terreno entrerà nel bilancio della sua presidenza. Il frastuono delle armi copre per un attimo gli ultimi due scandali: il Russiagate; e l’inaudita indulgenza verso i neo-nazisti di Charlottesville. Mentre il terrorismo islamico insanguina l’Europa, ecco un presidente americano che torna a parlare di talebani, di guerra al fondamentalismo, di nuove truppe da mandare al fronte. Nello stesso giorno in cui partono le grandi manovre militari congiunte con la Corea del Sud, in un altro teatro geostrategico ad alta tensione. (E sullo sfondo, c’è pure il mistero degli incidenti a ripetizione che colpiscono la Settima Flotta, proprio quella di stanza nell’Asia- Pacifico).
La decisione di inviare nuovi soldati americani in Afghanistan, in contro-tendenza rispetto ai piani di disimpegno totale annunciati da Barack Obama, è un prezzo che Trump paga per il suo strisciante “commissariamento” da parte dei militari. Avviene in una fase di difficoltà acuta della sua presidenza, coi sondaggi che scivolano ai minimi storici perfino negli Stati operai come il Michigan che lo avevano miracolato l’8 novembre. I mesi passano e il bilancio di governo è magrissimo, la contro-riforma sanitaria non c’è stata, la riduzione delle tasse dipende da quei gruppi parlamentari repubblicani che ormai diffidano apertamente del loro presidente. Nel caos di una Casa Bianca dove si susseguono i licenziamenti in tronco, restano gli uomini in divisa a garantire un sembiante di solidità, sangue freddo, disciplina. Lo spostamento del baricentro di potere verso i militari è confermato dal licenziamento di Stephen Bannon venerdì scorso. Bannon è un estremista di destra ma anche un tenace isolazionista. E’ contrario ad aumentare le truppe americane in Afghanistan e su questo aveva avuto vari scontri con la terna di generali che circondano Trump: McMaster capo del National Security Council, Mattis alla Difesa, Kelly capogabinetto. La cacciata di Bannon è una vittoria dei generali, che ora incassano un invio di nuove truppe americane all’estero.
L’Afghanistan è un conflitto interminabile, ormai più lungo del Vietnam. Iniziò con George W. Bush poco dopo l’attacco dell’11 settembre 2001, si trascina da quasi 16 anni con risultati alterni ma per lo più deludenti. Ogni volta che gli americani stanno per ritirarsi o comunque riducono sostanzialmente la loro presenza, i talebani rialzano la testa. L’idea di “nazionalizzare” la guerra delegando tutte le responsabilità al governo di Kabul e alle sue forze armate, si è rivelata fin qui un’illusione. Obama fu a suo tempo protagonista di un memorabile braccio di ferro con il Pentagono che voleva a tutti i costi un “surge”, un forte incremento del dispositivo militare, al termine del primo mandato. Obama cedette alle richieste dei generali a condizione che il “surge” fosse temporaneo e accompagnato da una data certa per il ritiro. Sembrò sul punto di mantenere la promessa fatta agli americani, alla fine del suo secondo mandato la presenza di soldati Usa era diventata quasi simbolica. Ma non c’era stato un ritiro totale. Ad oggi restano circa 9.000 militari Usa in Afghanistan, su una presenza Nato di 13.000. Già a giugno il segretario alla Difesa Mattis aveva convinto Trump ad autorizzare l’invio di altri 4.000 soldati. A questo si aggiunge un ripensamento di strategia complessiva che abbraccia tutto il teatro “AfPak”, cioè Afghanistan più Pakistan. Da anni infatti il Pakistan è un santuario di protezione di forze integraliste, inclusi i talebani. Fin dai tempi dell’uccisione di Osama Bin Laden che si nascondeva sul territorio pakistano, l’opinione pubblica americana scoprì quanto poco affidabile fosse un paese teoricamente alleato degli Stati Uniti, al quale Washington continua a fornire aiuti militari.
Bannon ha precipitato i tempi del suo licenziamento con un’intervista in cui ridicolizzava l’opzione militare in Corea del Nord… minacciata dallo stesso presidente. Gaffe, peccato di presunzione? Forse no. L’ex consigliere dell’estrema destra sentiva arrivare il conto per la “militarizzazione” di questa Casa Bianca allo sbando. Trump sembra rispettare ormai solo due gruppi di persone: i familiari stretti e gli alti comandi delle forze armate. Questi ultimi lo risucchiano verso una logica imperiale, una continuità nella politica strategica. Tutto il contrario dell’America First che l’operaio di Detroit attende con impazienza da sette mesi.

«». il manifesto, 20
agosto 2017 (c.m.c.)
Brava Ada Colau a convocare subito una manifestazione a Piazza de Catalunya, nemmeno 24 ore dopo l’orribile massacro. Bravi i barcellonesi che a centinaia di migliaia hanno risposto all’appello gridando «no tinc por». E bravi i cittadini globali che si sono uniti a loro, piangendo per la ferita inferta alla città simbolo dell’accoglienza e dell’inclusione, ma anche per le proprie vittime: impressionante la cifra di 35 nazionalità. Hanno espresso, oltre alla pena per i corpi maciullati, la protesta per l’insulto che è stato fatto a quello che viene chiamato il «nostro libero modello di vita».
E però c’è qualcosa che non mi convince nella ormai ripetuta proclamazione dei nostri valori, non sono certa che la nostra idea di libertà sia davvero così acriticamente proponibile ad un mondo in cui la maggioranza degli esseri umani ne sono stati privati.
So bene che a proporre questo discorso si entra su un terreno scivoloso, quasi si volesse negare l’importanza dei diritti e delle garanzie individuali che la Rivoluzione francese ci ha conquistato, così come il sistema democratico-borghese che accorpa oramai quasi tutto l’occidente. Non vorrei scambiarlo con nessun altro sistema attualmente vigente, quale che sia la sua denominazione. Per questo, del resto, penso si debba difendere un’idea di Europa che lo salvaguardi dal vortice terrificante che attraversa il mondo.
E però non posso non chiedermi se questo modello, questa idea di libertà, possono davvero risultare convincenti per chi ne vive la contraddizione, per chi abita l’altra faccia del modello: una moltitudine di esseri umani, quelli che disperatamente attraversano il Mediterraneo e vengono respinti; chi vive nelle desolate periferie urbane e patisce una discriminazione di fatto (no, non «legale», per carità!); chi abita i villaggi del Sahel o mediorientali.
La nostra orgogliosa riaffermazione «non abbiamo paura» ha certamente un senso molto positivo: vuol dire non sopprimeremo la libertà, non ricorreremo ad antidemocratiche misure di polizia, non ridurremmo per garantirci sicurezza le nostre libertà. È un messaggio importante ed è bello che a Barcellona sia stato riaffermato a Piazza de Catalunya. Ma non basta, e, anzi, ripeterlo, se non ci si aggiunge qualche cos’altro, rischia di essere controproducente.
Siamo tutti consapevoli che la disfatta che l’Isis sta subendo sul territorio non rappresenta affatto la fine della minaccia terrorista. Che, anzi, lo smantellamento delle sue roccaforti potrebbe rendere anche più intenso il ricorso alle azioni di gruppo, o persino individuali, che colpiscono senza possibilità di prevedere come e dove. Sappiamo oramai anche che è ben lungi dall’essere esaurito il reclutamento di giovani jihadisti pronti a morire. Che provengono dall’Oriente, dal Sud, ma sempre più spesso anche dalla strada accanto. Contro di loro non c’è polizia che tenga, una sicurezza militare è impossibile.
La sola ancorché ardua via da imboccare sta innanzitutto nell’interrogarsi su cosa muove l’odio di questi ragazzi. Non l’abbiamo fatto abbastanza. Non ci riproponiamo la domanda con altrettanta forza quando ribadiamo la superiorità della nostra idea di libertà. E così questo nostro atto di coraggiosa resistenza rischia di suonare inintellegibile a chi di quella libertà gode così poco. Perché chiama in causa non solo il nostro orrendo passato coloniale, le responsabilità per le rapine neocoloniali del dopoguerra, il razzismo di fatto, le sanguinose, offensive guerre che continuiamo a produrre con la scusa di portar la democrazia. Queste sono responsabilità di governi che anche noi combattiamo, anche se dovremmo farlo con maggiore vigore. ( Ha ragione Ben Jelloun che si è chiesto perché non abbiamo portato dinanzi alla Corte per i delitti contro l’umanità il presidente Bush, il maggiore artefice dell’esplosione jihadista).
E però c’è qualcosa che tocca a noi, proprio a noi di sinistra, fare: ripensare il nostro stesso, superiore modello di democrazia, ripensarlo con gli occhi dell’altro, dell’escluso, sforzarsi di capire la rabbia che induce al martirio. Non per giustificarlo, per carità, e neppure per chiudere gli occhi sulle occultate manovre di potere che guidano e finanziano il terrorismo. Ma – ripeto – per capire e impegnarsi a ripensare il nostro stesso modello di civiltà, all’ individualismo che la caratterizza, tant’è che la democrazia la decliniamo sempre più in termini di diritti e garanzie personali, non come rivendicazione di un potere che deve riuscire a liberare l’intera umanità.Penso che questo bisognerebbe gridarlo nelle piazze, aggiungendo un impegno politico al «non abbiamo paura».
L’Europa, che gli attentati vogliono colpire, è forse il meglio di questo orrendo mondo globale, ma non è innocente, non può essere riproposta semplicisticamente come punto d’approdo del processo di civilizzazione.

Un articolo spietatamente veritiero sulle ragioni degli attentati in Europa e sulle morti, anche quelle taciute, che la folle crescita economica sta producendo. Il Fatto Quotidiano online, 19 Agosto 2017 (i.b.)
La notizia dell'ennesimo attentato che ha colpito l'Europa sta riempiendo giornali, tv e blog di immagini e video. All’indignazione per le tante vittime innocenti si intrecciano i commenti di intellettuali, giornalisti e politici. Purtroppo, come al solito, si tratta di commenti fuorvianti che cavalcano l’emozione del momento, completamente incapaci di mostrare una visione d’insieme. La quasi totalità delle opinioni che ci apprestiamo ad ascoltare nello tsunami dis-informativo che giungerà nelle nostre case non ci spiegheranno i perché di tali gesti che sono solo sintomi di una grave malattia. Una malattia che è la fine del modello di sviluppo del mondo occidentale che, per perseverare nella sua folle crescita economica, deve depredare nuovi territori sempre con maggiore voracità.
Il fine nei prossimi giorni sarà sempre lo stesso: dividere in modo ipocrita il mondo tra buoni e cattivi, in modo da permettere a coloro che esercitano il vero potere di raggiungere gli obiettivi prefissati. Obiettivi atti a giustificare nuove spese militari, ulteriori restrizioni delle libertà in Occidente e la possibilità di usare, ancora un volta, la religione come maschera per celare la vera posta in palio che è la razzia di petrolio, gas e stupefacenti. Negli ultimi anni pianificate guerre dirette e per procura hanno destabilizzato un’importante area geografica. Le aggressioni all’Iraq, all’Afghanistan, alla Libia, alla Siria hanno fatto montare la rabbia. Rancori e odi che si sono incanalati in tanti disadattati europei usati come concime per seminare paura ma anche in gruppi radicali e terroristici. Gruppi come Al Qaeda e Isis, che però sono stati usati e finanziati, come è accaduto in Siria, in maniera strumentale dagli Stati Uniti che si sono autoproclamati portatori sani di democrazia e libertà.
L’invito che sento di rivolgere è di non limitarsi a volerinterpretare l’immagine di un puzzle solo con l’ultimo pezzo che ci viene mostrato dai mass media. Per rispettare le vittime degli attentati non serve essere informati su che musica ascoltassero e di quali film fossero appassionati, la vera sfida è spegnere la Tv e trovare gli altri tasselli del puzzle, quelli che poi danno la possibilità di vedere il quadro d’insieme, quello che è vietato mostrare. Secondo uno studio dell'associazione privata Council on Foreign Relations, solo nel 2016 il premio Nobel per la Pace, Obama, ha permesso che fossero sganciate ben 26.172 bombe su ben sette Paesi sovrani (Siria, Iraq, Afghanistan, Libia, Yemen, Somalia e Pakistan). Si tratta di tre bombe ogni ora per 24 ore al giorno che hanno ucciso migliaia e migliaia di civili innocenti come coloro che passeggiavano sulla Rambla a Barcellona.
Secondo un rapporto del 2014 dell'Ong britannica Reprive, per ogni “terrorista” ucciso nella guerra dei droni combattuta dagli Usa, le vittime civili sono state 28. In dieci anni, su 41 terroristi assassinati i droni hanno ucciso 1.147 innocenti. Uomini, donne e bambini di cui giornali e Tv non ci renderanno mai conto.
 Nulla richiama guerra come altra guerra, a parte i soldi. Tutto il resto non conta.
Nulla richiama guerra come altra guerra, a parte i soldi. Tutto il resto non conta.
il Fatto Quotidiano online, 10 agosto 2017 (p.d.)
Gli Stati Uniti vendono 110 miliardi di armi all’Arabia Saudita. Anzi no, forse molti di più. E il presidente Donald Trump nello stesso giro di ore se la prende con l’Iran che, secondo lui (ma anche secondo molti tra noi… che però non andiamo in giro per il mondo a vendere armi e ad ammazzare la gente) è un paese pericoloso.
Poi oggi sempre lui, Trump, dichiara “faremo fuoco e furie mai viste” contro la Corea del nord che non è meno bellicoso di lui, dell’Arabia Saudita e dell’Iran. Criminali si confrontano sul tavolo del loro Risiko infame. E versano qualche lacrima sintetica via Twitter per lo sterminio americano di Nagasaki ricordato ieri.
Joe O’Donnell fotografò un bambino che portava il fratello piccolo sulle spalle. Sembrava addormentato. Mia figlia si addormenta spesso così. Anche a me succedeva. Mio padre diceva che ero un sacchetto di patate. Anche io lo dico dei miei figli. Due. Uno dell’età che ha il più grande nella foto. L’altra più o meno di quella che ha il sacchetto che stava sulle spalle. Ma il sacchetto di patate era morto e suo fratello lo accompagnava alla cremazione. Erano bambini di Nagasaki.
Scriveva il poeta
“apritemi sono io…
busso alla porta di tutte le scale
ma nessuno mi vede
perché i bambini morti nessuno riesce a vederli”.
Non li vedono i presidenti. Non li vedono i commentatori. Non li vedono gli elettori. Non li vede quasi nessuno. Speriamo nella bontà dei “quasi”.

Italia e Francia in rissa concorrenziale per vincere il primato di chi è più dtupido nel comprendere che cos'è l'Esodo del XXI secolo. il manifesto, 29 luglio 2017 (p.d.)
Quello che succede tra Francia e Italia è un groviglio grottesco di velleità geopolitiche, interventismo militare da due soldi, rivalità industriali e diplomatiche. Ma tutto questo contro le azioni umanitarie delle Ong e sulla pelle di migliaia di esseri umani, i migranti che si imbarcano in Libia alla volta dell’Europa. Ma andiamo con ordine.
La nazionalizzazione dei cantieri di Saint Nazaire, da cui escono navi da crociera e militari, è solo un aspetto della politica francese di piccola grandeur nel Mediterraneo e in Africa. La Francia, che nel 2011 aveva lanciato la demenziale guerra in Libia, che ha portato al caos attuale, non poteva tollerare che Fincantieri mettesse le mani su un settore strategico così importante. Alla stessa logica appartiene l’incontro di “pacificazione” promosso da Macron tra Serraj e Haftar, un colloquio che, come ha notato Angelo Del Boca intervistato da Tommaso Di Francesco sul manifesto di giovedì, non cambia nulla dal punto di vista del conflitto di potere in Libia, ma è un affronto evidente all’Italia e alla sua pretesa di rappresentare gli interessi d’Europa nel tratto di mare delicatissimo tra Sicilia e Africa.
Ma sottolineare una volta di più il nazionalismo francese non significa assolvere quello italiano, con la semplice differenza che l’apparato militare gestito dal ministro Pinotti non è paragonabile a quello francese, che già opera in Niger, Ciad e altre zone dell’Africa sub-sahariana. La proposta, da parte di Gentiloni, di inviare le nostre navi nelle acque della Libia contro i «trafficanti», ha il significato di una risposta alla Francia, sia per la questione Fincantieri, sia per il ruolo che Macron vorrebbe in Libia. Come dire: «Macron, stai attento, ci siamo anche noi!». La mossa italiana si situa nel solco delle iniziative di Minniti per far gestire ai libici il controllo dei migranti. E come quelle, creerà solo nuova confusione e sofferenze. Insomma, ruggiti di un topo.
La verità è che la Libia è in mano ai signori della guerra, che Serraj conta sempre meno e che Haftar, il suo rivale in Cirenaica, sostenuto dai francesi (nonché da egiziani e russi) è sempre più potente. Di conseguenza, giorno dopo giorno, si scopre che l’Italia ha puntato sui cavalli perdenti, soprattutto per quanto riguarda il controllo delle risorse petrolifere. La debolezza strategica si somma in questo caso all’incapacità politica (tra l’altro, che fine ha fatto in tutto questo il ministro Alfano?).
La smentita-conferma di Serraj - che, tornato a Tripoli ha prima negato di aver richiesto l’intervento italiano per poi confermare ma precisando che avrà solo una funzione di «supporto» - getta una coltre di ridicolo sull’intera vicenda. È possibile che Serraj si sia accorto che Macron è un po’ più potente di Gentiloni e ora ci abbia ripensato. O magari che tema di sbilanciarsi troppo dalla parte dell’Italia. E comunque di rivelarsi alle fazioni libiche come troppo subalterno all’occidente. Ma, in ogni caso, la faccenda delle navi italiane è un segnale gravissimo per le Ong, a cui si vuole già imporre un insensato codice di comportamento. Se la storia della guerra ai «trafficanti» si tramutasse in un blocco di gommoni e carrette del mare, i costi umani sarebbero enormi. Non solo perché le navi delle Ong sarebbero spinte a diradare o annullare gli interventi, ma perché i migranti sopravvissuti a possibili naufragi sarebbero ricacciati nell’inferno libico.
Ecco un altro risultato dell’ottusità europea e del ruolo delle destre nel condizionare le politiche migratorie. I migranti continueranno ad arrivare in Libia. Ma troveranno un mare pullulante di navi militari pronte a respingerli. Un lavoro sporco che l’Italia, potenza di terz’ordine, vuole svolgere per un’Europa, Francia compresa, incapace di affrontare la questione delle migrazioni. In questi giochi di guerra e di petrolio tutti hanno qualcosa da guadagnare, tranne l’umanità.
A Gerusalemme, nel luogo sacro a più religioni, ciò che si oppone alla pace e fomenta lo scontro non è il contrasto tra le fedi, ma la lotta di Israele per imporre il proprio potere oltre ogni limite. Articoli di Michele Giorgio, Zvi Schuldiner e intervista a Uraib al Rintawi. il manifesto, 22 luglio 2017
TRE PALESTINESI UCCISI
DAL FUOCO DEI COLONI
E DAI PROIETTILI DELLA POLIZIA
di Michele Giorgio
«Gerusalemme. Scontri intorno alla Spianata delle moschee e in Cisgiordania. Oltre ai tre morti la Mezzaluna rossa parla di 390 feriti. E ora si parla di una nuova Intifada in risposta alle politiche di Netanyahu»
Quattro giovani palestinesi uccisi, 390 feriti o contusi. Per Gerusalemme Est è stata una delle giornate più insanguinate degli ultimi anni. Cariche della polizia israeliana contro manifestanti palestinesi, con fuoco ad altezza d’uomo, come quelle di ieri non si vedevano dal 2014, quando le tensioni e la rabbia innescate dall’omicidio del 15enne Mohammed Abu Khdeir, compiuto da estremisti israeliani per vendicare il sequestro e l’assassinio di tre adolescenti ebrei, per giorni trasformarono la zona araba di Gerusalemme Est in un campo di battaglia. Quanto si è visto ieri è stata la ovvia conseguenza della decisione del premier israeliano di non rimuovere – malgrado, secondo i media, il parere favorevole dei servizi di sicurezza – i metal detector installati ad alcuni degli ingressi della Spianata delle moschee di al Aqsa e della Roccia dopo l’attacco armato palestinese della scorsa settimana (due poliziotti uccisi).
Giorni di trattative frenetiche e di pressioni arabe su Washington per spingere Israele a revocare le nuove misure, gli scontri notturni tra palestinesi e polizia nei quartieri di Silwan e Issawiyeh, non hanno scosso in alcun modo Benyamin Netanyahu che ha confermato, «per ora», l’impiego dei metal detector e di altri sistemi di controllo di chi varca gli ingressi della Spianata. È stata una decisione politica anche se il premier spiega di aver fatto la sua scelta sulla base delle motivazioni offerte dalle forze dell’ordine. Una prova di forza in realtà, per dire ad arabi e palestinesi che Israele non cede alle pressioni e conferma le sue rivendicazioni sulla Spianata, che per gli ebrei è il Monte del Tempio. Il portavoce della polizia, Micky Rosenfeld, ha parlato chiaro: «I metal detector rimarranno dove sono per settimane, per mesi se necessario». Per i palestinesi si tratta di una palese violazione di uno status quo che non assegna in alcun modo a Israele l’esclusiva della sicurezza e del controllo del sito religioso.
L’esercito israeliano ieri aveva predisposto dozzine di posti di blocco ovunque in Cisgiordania per fermare i palestinesi diretti a Gerusalemme, in risposta all’appello lanciato dalle autorità islamiche e dai partiti politici in difesa di al Aqsa. I militari hanno bloccato prima degli ingressi in città decine di autobus e automobili. La polizia da parte sua ha negato l’accesso all’area delle moschee ai palestinesi maschi con meno di 50 anni. Nonostante ciò migliaia di palestinesi residenti a Gerusalemme si sono diretti in massa verso la Spianata, con l’intenzione però di pregare in strada, in modo da non legittimare i metal detector installati da Israele. Ad attenderli c’erano circa 3mila poliziotti schierati prima dell’alba in tutta la zona. Già prima della preghiera erano scoppiati scontri davanti alla Porta di Damasco e alla Porta dei Leoni, la più vicina alla Spianata. Piano piano si sono diffusi in vari quartieri della zona araba di Gerusalemme, infine hanno raggiunto Betlemme, Hebron, Qalandiya e altri centri abitati della Cisgiordania. La polizia a Gerusalemme ha prima lanciato granate assordati e lacrimogeni, poi ha aperto il fuoco. Filmati che girano in rete mostrano la violenza delle cariche dei poliziotti in assetto antisommossa e appoggiati da automezzi pesanti. Si sono riviste scene dell’Intifada e degli scontri del 2014 in una città che si vorrebbe “pacificata” sotto il controllo totale di Israele. Non a caso il ministero degli esteri israeliano ieri diffondeva tweet per invitare i turisti a visitare la città vecchia perché era tutto «sotto controllo».
La prima vittima, Mohammad Sharaf, però non è stata colpita dalla polizia nei pressi della Spianata ma nel quartiere di Ras al-Amud, di fronte alla città vecchia, da spadi un “civile” israeliano – probabilmente un abitante della colonia ebraica costruita in quella zona qualche anno fa dal miliardario australiano Mosckoviz – in circostanze che ieri sera non erano state ancora chiarite. Un altro giovane palestinese, Muhammad Abu Ghanam, ferito al Monte degli Ulivi durante gli scontri con la polizia, si è spento all’ospedale Makassed. Entrambi sono stati seppelliti subito dalle famiglie timorose che la polizia potesse confiscare i loro corpi. Gli agenti in ogni caso non hanno mancato di lanciarsi in blitz negli ospedali per arrestare i feriti, 390 secondo fonti della Mezzaluna rossa: la maggior parte intossicati dai gas lacrimogeni, 38 a Gerusalemme e 66 in Cisgiordania da pallottole vere e proiettili di gomma. Tra i feriti ci sono anche cinque gli agenti di polizia israeliani. Il terzo palestinese ucciso, Muhammad Khalaf, è stato colpito durante una manifestazione ad Abu Dis, un sobborgo di Gerusalemme che si trova dietro il Muro costruito da Israele intorno alla città. Khalaf era un attivista del Fronte democratico per la liberazione della Palestina.
Una notte gonfia di dolore e rabbia è scesa ieri sera su Gerusalemme Est. L’inizio di una nuova Intifada non è più lontano.
GUIDA AI CONFUSI
SU ULTRADESTRA E ISLAMOFOBIA
di Zvi Schuldiner
«Il gioco di Tel Aviv: la questione è non il metal detector sulla Spianata o la telecamera di sorveglianza. Il governo Netanyahu sfrutta l’apatia generale e l’islamofobia europea per proseguire con l’occupazione»
Che cosa sta davvero accadendo nella discussa e sacra Spianata delle Moschee – per i musulmani – o Monte del Tempio – per gli israeliani?
Mentre scrivo queste righe, in questo venerdì problematico e pieno di tensione, sono già tre i palestinesi morti, oltre a due feriti gravi e vari altri feriti leggeri. È il bilancio degli scontri registrati durante le preghiere del venerdì, stavolta recitate all’esterno della Spianata delle Moschee.
All’inizio della guerra del 1967, le truppe israeliane conquistano la città vecchia di Gerusalemme. Un soldato patriota ed entusiasta sale sul tetto della sacra Moschea di Al Aqsa e issa la bandiera israeliana. Il ministro della difesa Moshe Dayan ordina di toglierla immediatamente; capisce bene che si tratta di un affronto a uno dei luoghi più sacri per i musulmani.
Dayan, insomma, avviava un’occupazione dai risvolti drammatici, da un lato con pugno di ferro ma dall’altro con passi pragmatici e concilianti. I vari governi israeliani succedutisi nel tempo hanno sempre mostrato di rendersi conto che la Spianata delle Moschee era un luogo potenzialmente esplosivo; innescarlo poteva avere conseguenze terribili.
Dunque, badarono a frenare i fondamentalisti ebrei che sognavano il ripristino del tempio, elemento centrale delle concezioni messianiche – il tempio la posto delle moschee. Ma nel 1996, poco dopo essere diventato primo ministro, Benjamin Netaniahu, ebbro del successo elettorale, ordina di aprire un tunnel che porta alla Spianata.
Esplodono gli scontri: cento palestinesi e 17 soldati israeliani rimangono uccisi. Il premier è costretto a fare alcune concessioni ad Arafat rispetto a Hebron. Nel 2000, il premier Ehud Barak autorizza la visita di Ariel Sharon alla Spianata e la provocazione innesca la seconda Intifada. Nel frattempo altri incidenti provocano non poche vittime.
La settimana scorsa, tre israeliani, arabi palestinesi della città di Um El Fahem, imbevuti di ideologia fondamentalista (oppure no) portano nottetempo armi nella moschea e il giorno seguente attaccano i poliziotti in servizio, uccidendone due; gli aggressori sono a loro volta uccisi.
Come se non bastasse, i tre poliziotti morti sono drusi; un fatto che aggiunge benzina al fuoco delle tensioni fra arabi israeliani e drusi israeliani.
L’impulsivo ministro della polizia Gilard Ardan, schierato all’estrema destra, è il nuovo eroe. Più veloce di qualunque pensiero – va detto che l’attuale governo israeliano si distingue per l’incapacità di riflettere – induce Netanyahu a compiere passi che aggravano la tensione in un luogo pericoloso come la dinamite.
Senza consultare i giordani – con i quali, seppure in modo semiufficiale, vengono in genere prese le decisioni rispetto alla Spianata –, il governo israeliano dichiara il divieto di accesso alle moschee per due giorni, «per ragioni di sicurezza» e fa disporre telecamere di sorveglianza e metal detector, destinati a controllare e a bloccare l’ingresso di altre armi.
I leader religiosi musulmani non accettano queste apparecchiature, sostenendo che si tratta di una violazione dello status quo deciso fra le parti – israeliani, palestinesi, giordani. La polizia – grazie al suo problematico ministro – sostiene che si tratta di un passo minimo necessario per questioni di sicurezza e che ci sono telecamere sul Muro del Pianto, a cento metri di distanza, come negli aeroporti, nei supermercati e via dicendo.
Ma l’esercito israeliano e i servizi segreti fanno notare che, benché in effetti le apparecchiature di sicurezza siano in uso in molti luoghi, nel caso specifico sarebbe raccomandabile rimuoverle perché provocano tensioni e potrebbero far deflagrare nuovamente la situazione. Insomma, suggeriscono una visione strategica e chiedono al primo ministro di trovare la formula per una «ritirata onorevole».
Sabato notte il premier va in Francia, baci e abbracci con il giovane presidente; poi si reca da amici veri, in Ungheria. Netanyahu si sente a proprio agio con gli ultrà di Ungheria, Polonia, Repubblica Ceca e Slovacchia.
Beh, certo, Orbán ha ordinato una campagna dai tratti antisemiti contro quell’orribile ebreo, George Soros, ma Soros per Netanyahu è una vergogna, un vero nemico che appoggia gruppi antiisraeliani, come ad esempio le organizzazioni per i diritti umani in Israele.
Ebbene, l’Europa deve capire che Israele è la frontiera che bloccherà la barbarie musulmana; invece di criticare lo Stato ebraico, gli europei devono rendersi conto che è una ricetta per la vittoria, altrimenti saranno sconfitti. In soldoni, è questo l’ammonimento che il grande premier dà agli statisti europei che non capiscono troppo bene la situazione laggiù.
Poi Netanyahu torna in patria e si trova di fronte a un grave dilemma. L’ultradestra spiega che la discussione non verte intorno alle telecamere e ai metal detector; piuttosto, è in gioco la sovranità del paese e il governo deve sottolineare con forza che Israele è sovrana anche sulla Spianata, senza arrendersi alle pressioni dall’estero o alla minaccia di situazioni esplosive.
Netanyahu non può mostrarsi meno radicale dei suoi alleati di destra e va avanti nella direzione suggerita dalla polizia.
Un morto, due, venti? Non ha importanza. Il punto è come fare per impedire qualunque accordo suscettibile di portare a una pace israelo-palestinese. Stavamo dimenticando l’annuncio del ministro dell’habitat che ha un magnifico programma: costruire case secondo piani che dividerebbero ulteriormente la Cisgiordania occupata.
Grazie all’apatia generale e all’islamofobia europea, il governo di Israele potrà proseguire con l’occupazione. Una politica che rende la pace impossibile.
LA SPARTIZIONE DI AL AQSA
È UN PROCESSO GIÀ IN ATTO
intervista di Michele Giorgio
«Intervista. Parla l'analista Uraib al Rintawi: il governo israeliano punta a dividere la Spianata delle moschee ma le sue politiche aggressive a Gerusalemme frenano la "normalizzazione" con i Paesi arabi»
Sulle ragioni delle proteste palestinesi e le implicazioni in Medio Oriente della crisi a Gerusalemme e delle politiche del governo Netanyahu, abbiamo intervistato l’analista arabo ed editoralista del quotidiano al Dustour Uraib al Rintawi.
Le nuove misure israeliane per la Spianata delle moschee hanno innescato proteste e manifestazioni a Gerusalemme che non si vedevano dal 2014.
«L’escalation era inevitabile. Ed è destinata ad aggravarsi se il governo Netanyahu non revocherà subito le misure che ha annunciato per la Spianata della moschea di al Aqsa e non farà rimuovere subito i metal detector installare sul sito religioso. I palestinesi sanno che sul piatto c’è la difesa dello status quo per la Spianata delle moschee che è in vigore da 50 anni. Il fatto che Netanyahu descriva come temporanee le misure varato è un altro campanello d’allarme perché tutto ciò che per Israele ha un carattere transitorio nei Territori palestinesi occupati poi si è rivela permanente«.
I palestinesi denunciano un tentativo di Israele di creare sulla Spianata delle moschee una situazione simile a quella della Tomba dei Patriarchi ad Hebron, ossia la spartizione dell’area in cui sorgono le moschee di Al Aqsa e della Roccia di Gerusalemme considerata dall’Ebraismo il Monte del biblico Tempio.«Non si tratta di un tentativo ma di un piano a mio avviso molto concreto e in atto. La storia insegna come l’applicazione di presunte misure di sicurezza da parte Israele si sia poi rivelata il percorso per realizzare progetti politici. I segnali sono chiari, è sufficiente osservare in quali aree sono stati installati i metal detector sulla Spianata per rendersi conto, che di fatto, tracciano una bozza di divisione del sito. Ed è significativo che, nel frattempo, nonostante la tensione, sia garantito l’accesso sulla Spianata ai turisti israeliani che in realtà non sono turisti ma estremisti religiosi che spingono per la ricostruzione del Tempio ebraico, coloni ed esponenti della destra radicale. L’attacco armato della scorsa settimana in cui sono stati uccisi due poliziotti ha fornito alle autorità israeliane un pretesto per avviare la realizzazione di piani che erano nel cassetto da tempo».
Come valuta la reazione della Giordania, paese che si proclama custode di al Aqsa. Qualcuno la considera fiacca.
«Non sono d’accordo. La Giordania sul piano diplomatico sta facendo quanto è nei suoi poteri per persuadere gli Usa, l’Europa e altri Paesi a fare il possibile per imporre la retromarcia a Netanyahu. L’importanza della Spianata e il mantenimento dello status quo all’interno della mura antiche di Gerusalemme restano un punto fermo nella politica del Regno. A ciò si aggiunge il fatto che il governo deve tenere conto anche dei sentimenti popolari. Oggi (ieri per chi legge, ndr) sono scesi strada ad Amman e in altre città migliaia di giordani per protestare contro Israele e in difesa delle moschee di Gerusalemme. Non si vedevano dimostrazioni tanto ampie e le autorità ne devono tenere conto. E non si può dimenticare che la Giordania ospita milioni di palestinesi».
I passi fatti da Netanyahu avranno un impatto negativo sulle relazioni dietro le quinte che Israele ha allacciato con alcuni Paesi arabi, a cominciare dall’Arabia saudita.
«È inevitabile. Persino quei Paesi arabi che con entusiasmo procedono verso la normalizzazione dei rapporti con Israele saranno costretti a frenare, sotto l’onda di sdegno che attraversa le loro opinioni pubbliche. Senza dimenticare che quanto accade in questi giorni a Gerusalemme rafforza gli islamisti più radicali che accusano i loro governi di collaborazionismo con Israele. Per chi governa nel Golfo è una brutta notizia vedere i palestinesi in strada a manifestare per i loro diritti e contro le politiche di Israele. Vuol dire che dovranno mettere in frigorifero i loro piani».
LE CHIESE CRISTIANE
A DIFESA DEI LUOGHI DELL'ISLAM
di red.
«Gerusalemme. I patriarchi e gli arcivescovi delle chiese della Città Santa chiedono il rispetto di al-Aqsa e il diritto dei musulmani alla preghiera. E ieri, a pregare fuori dalla Spianata, accanto ai fedeli musulmani anche palestinesi cristiani»
«Noi, capi delle chiese di Gerusalemme, esprimiamo la nostra grave preoccupazione per la recente escalation di sviluppi violenti intorno a Haram ash-Sharif [la Spianata delle Moschee] e il nostro dolore per la perdita di vite umane». Così inizia il comunicato congiunto delle chiese cristiane della Città Santa, firmato dai patriarcati greco-ortodosso, cattolico, armeno ortodosso, copto, siriano ortodosso, etiope ortodosso, maronita, luterano evangelico, greco-melchita-cattolico, siriano cattolico e armeno cattolico e dalla Custodia di Terra Santa e la Chiesa episcopale di Gerusalemme e Medio Oriente
Una presa di posizione importante, che si unisce alle immagini che ieri giungevano da Gerusalemme: palestinesi cristiani che pregavano accanto ai musulmani fuori dalla Spianata. «Siamo preoccupati per ogni cambiamento dello status quo della Moschea di al-Aqsa e della Città Santa di Gerusalemme – scrivono i patriarchi e gli arcivescovi – Ogni minaccia alla sua integrità potrebbe condurre facilmente a serie e imprevedibili conseguenze. Riteniamo che la custodia del regno hashemita di Giordania sulla Moschea di al-Aqsa e sui luoghi sacri di Gerusalemme e della Terra Santa garantisca il diritto di tutti i musulmani ad accedere liberamente e a pregare ad al-Aqsa, secondo quanto previsto dallo status quo».
 Sferzante denuncia dell'ipocrisia dei falsi buonisti alla Renzi che guardano a una tragedia umanitaria con l'occhietto rivolto ai voti da acchiappare agli affari dei mercanti di armi.
Sferzante denuncia dell'ipocrisia dei falsi buonisti alla Renzi che guardano a una tragedia umanitaria con l'occhietto rivolto ai voti da acchiappare agli affari dei mercanti di armi.
il Fatto Quotidiano online, 9 luglio 2017
Mi permetto di parafrasare così le parole del Segretario del Partito di centrosinistra, ossatura della maggioranza di Governo: Se vi considerate di sinistra non dovete sentirvi moralmente in colpa se iniziate ad avvertire impulsi razzisti. Non siete voi a essere razzisti, sono i negri a essere troppi. Ma vi assicuro che continuerò ad avere moralmente a cuore gli affari di chi tra voi produce armi da vendere ai Paesi in guerra, impedendo che si creino condizioni di vita accettabili per i negri "a casa loro". Per Renzi dunque l'Italia non ha il "dovere morale di accogliere" ma di "aiutare a casa loro".
Eppure Renzi sa perfettamente che l'Italia realizza l'esatto contrario perché aiuta sì chi decide di lasciare il proprio Paese, ma ad ammazzarsi a casa propria. La prova? Le esportazioni di armi italiane". Così Roberto Saviano su Facebook.
2,7 miliardi di euro nel 2014, 7,9 miliardi di euro nel 2015, 14,6 miliardi di euro nel 2016. Queste cifre mostrano come è cresciuto negli ultimi 3 anni (e Renzi ne è al corrente) il valore complessivo delle esportazioni di armi dall'Italia. Ma il dato politicamente importante è il boom di vendite verso Paesi in guerra in violazione della legge 185/1990, che vieta l'esportazione e il transito di armamenti verso Paesi in stato di conflitto e responsabili di gravi violazioni dei diritti umani. L'Italia nel 2014-2015 è stato l'unico Paese della UE ad aver fornito pistole, revolver, fucili e carabine alle forze di polizia e di sicurezza del regime di Al Sisi (con quale faccia chiedono verità per Giulio Regeni!).
Nigrizia denuncia forniture militari a Paesi dell'Africa settentrionale, a regimi autoritari, all'Arabia Saudita, condannata dall'Onu per crimini di guerra e per la quale il Parlamento europeo ha chiesto un embargo sulla vendita di armamenti.Quanta ipocrisia dunque nell'affermare di voler aiutare i migranti a casa loro. Ma attenzione, quella di Matteo Renzi non è una gaffe o un errore di comunicazione, è piuttosto un frettoloso e maldestro tentativo di dare in pasto una risposta alla ferocia della piazza.Matteo Renzi e il suo entourage non stanno capendo nulla della attuale fase politica. Se fosse un giocatore di calcio, il mister l'avrebbe fatto accomodare in panchina da un bel po'. Ma purtroppo l'allenatore è lui e la prima cosa che ha fatto da allenatore è stata liquidare Emma Bonino, risorsa vera della Repubblica.
 La strategia di potere mondiale della Germania di Merkel sembra aprire una nuova fase nel colonialismo del Primo mondo. Compatibile o meno con il Migration Compact di Renzi &Co? Articoli di Alessandro Alviani, Tonia Mastrobuoni, Fabio Celestino, edizioni online de
La strategia di potere mondiale della Germania di Merkel sembra aprire una nuova fase nel colonialismo del Primo mondo. Compatibile o meno con il Migration Compact di Renzi &Co? Articoli di Alessandro Alviani, Tonia Mastrobuoni, Fabio Celestino, edizioni online de
La Stampa, la Repubblica, BlastingNews, 13 giugno 2017
La Stampa online
MERKEL, UN PIANO PER L’AFRICA
TEST PER LA LEADERSHIP GLOBALE
di Alessandro Alviani
«A Berlino vertice in vista del G20. Aiuti economici per le riforme. La Cancelliera tedesca Angela Merkel ha incontrato, tra gli altri, a Berlino, i leader di 7 Paesi africani, tra cui quello della Guinea e presidente dell’Unione africana, Alpha Condé
Altro che «Piano Marshall con l’Africa», come lo chiama da mesi il ministro tedesco per la Cooperazione economica, Gerd Müller. Il presidente della Costa d’Avorio, Alassane Ouattara, non ha dubbi: «Direi volentieri al ministro Müller che si potrebbe parlare quasi di un Piano Merkel al posto di un Piano Marshall», spiega, tra gli applausi, Ouattara alla conferenza sull’Africa, organizzata ieri a Berlino nel quadro della presidenza di turno tedesca del G20. E anche il presidente del Niger, Mahamadou Issoufou, non ha dubbi: «Il Piano Merkel per l’Africa richiederà più tempo» del Piano Marshall originale, «ma abbiamo bisogno di sforzi da entrambe le parti, serve una partnership che sia vantaggiosa per tutti».
E pazienza che il «Piano Merkel», in sé, non esista, ma sia la sintesi di strumenti elaborati da Müller e dal suo collega delle Finanze, Wolfgang Schäuble: da un lato 300 milioni di euro per programmi di formazione professionale e occupazione, destinati ai Paesi – si parte con Tunisia, Ghana e Costa d’Avorio, mentre Marocco, Ruanda, Senegal ed Etiopia potrebbero seguire – che si impegnano a rispettare i diritti umani, combattere la corruzione e garantire lo stato di diritto, creando così un clima economico più favorevole; dall’altro i «Compact with Africa», che puntano a incentivare le riforme sul posto, per attirare maggiori investimenti privati. Il fatto che molti politici africani, ieri, abbiano parlato di «Piano Merkel» non fa che riflettere la centralità di una leader che ha deciso di porre l’Africa in cima all’agenda del G20.
E che ha riunito a Berlino una platea impressionante: dal premier Gentiloni, che ha insistito sulla necessità di un «miglioramento del contesto per gli investimenti privati» in Africa, al ministro dell’Economia Padoan, dalla direttrice del Fmi, Christine Lagarde, al presidente della Banca mondiale Jim Yong Kim, dal Commissario europeo agli Affari economici Moscovici, fino al presidente della Bundesbank Weidmann, atteso stamattina. E che si è spostata poi in cancelleria per una nuova girandola di incontri: Merkel ha visto tra gli altri il presidente egiziano al-Sisi, i capi di Stato di Costa d’Avorio, Ghana, Niger, Mali, Ruanda, Senegal e Tunisia. Interlocutori centrali, agli occhi della cancelliera: Merkel è convinta da tempo che sia necessario contrastare direttamente sul posto le cause delle migrazioni, creando chance e posti di lavoro soprattutto per i più giovani. Lavorare insieme per migliorare la situazione nei Paesi africani significa anche «creare più sicurezza per noi» e combattere i trafficanti, ha notato la cancelliera. Non risparmia critiche: «Nei Paesi industrializzati dobbiamo chiederci se abbiamo seguito sempre la strada giusta coi classici aiuti allo sviluppo. Non credo. Dobbiamo concentrarci di più sullo sviluppo economico dei singoli Stati». Merkel vuole iniziare. E spera, fino al summit di luglio ad Amburgo, di convincere quanti più Paesi del G20 ad affiancarla.
La Repubblica
INVESTIMENTI E ALLEANZE
ECCO IL PIANO DEL G20
BERLINO IN PRIMA LINEA
di Tonia Mastrobuoni
«Il continente avrà una popolazione di 2,5 miliardi nel 2050. Per prevenire l’ondata migratoria, o renderla un’opportunità, servono accordi di sviluppo»
«Chiamiamolo Piano Merkel, non Piano Marshall» sorride Alassane Ouattara, il presidente della Costa D’Avorio, e qualche timido applauso si leva dalla platea del G20 per l’Africa. L’iniziativa berlinese dimostra la serietà d’intenti del governo tedesco, che ha voluto porre lo sviluppo in Africa al centro della propria presidenza del summit dei Grandi. In piena sintonia, ha ricordato ieri Paolo Gentiloni, con il G7 italiano. Non c’è argomento su cui Berlino e Roma siano più concordi: aiutare un continente in crescita demografica esponenziale — entro il 2050 la popolazione sarà raddoppiata a 2,5 miliardi — significa anche prevenire migrazioni di massa verso l’Europa. Soprattutto perché è una popolazione giovane: «ricordiamoci — ha detto Merkel — che l’età media in Germania è 43 anni, in Niger o in Mali è 15».
Per la cancelliera «servono iniziative che parlino non tanto dell’Africa ma con l’Africa». E «se c’è troppa disperazione in Africa, è ovvio che i giovani si cercano un’alternativa». Le ha fatto eco Gentiloni — era a Berlino per la concomitante presidenza italiana del G7 — che ha messo in evidenza come «per affrontare con efficacia il problema delle migrazioni occorra sostenere uno sviluppo duraturo e stimolare gli investimenti nei Paesi d’origine». Anche il ministro dell’Economia Pier Carlo Padoan ha sottolineato da Berlino come lo sforzo sia di «renderla la principale destinazione delle partnership bilaterali ».
D’altra parte, come ricorda l’organizzazione umanitaria One, proprio l’invecchiamento rapido delle società europee creerà un crescente fabbisogno di forza lavoro. Entro il 2050, per scongiurare il collasso economico, l’Europa avrà bisogno di 100 milioni di migranti, circa 2,5 milioni all’anno. L’Africa va vista anche come un’opportunità.
Soprattutto, anche le organizzazioni umanitarie ammettono ormai che la chiave per il futuro dell’Africa è il coinvolgimento dei privati. Come ha riconosciuto il presidente del Ruanda Paul Kagame, «se gli aiuti tradizionali sono utili, non potranno mai essere sufficienti per uno sviluppo duraturo ». E dunque il ministro delle Finanze, Wolfgang Schaeuble, ha spiegato come «il “Compact con l’Africa punti sulla responsabilità dei singoli Paesi africani: sono loro a decidere con quali partner collaborare e sono loro a dover creare le condizioni per attrarre investimenti privati».
Scopo dell’iniziativa è quello di favorire una collaborazione più stretta anche tra le istituzioni presenti in Africa come il Fmi o la Banca mondiale, perché aiutino a disegnare le riforme che creino un ambiente più favorevole agli investimenti — quelle fiscali, della giustizia o quelle per favorire le energie rinnovabili o sviluppare le economie digitali, solo per fare qualche esempio. E Christine Lagarde, sempre dal palco berlinese del G20 per l’Africa, ha raccontato che «in base alla mia esperienza di 25 anni nel settore privato posso dire che se un investitore sa che ci sono regole, c’è certezza del diritto, e non c’è corruzione, gli investimenti arrivano».
BlastingNews online
IL PIANO MERKEL PER L'AFRICA
TRA I PUNTI DEL PROSSIMO G20 DI AMBURGO
di Fabio Celestino
«Il 6 e 7 luglio Amburgo si prepara a ospitare il G20. Il piano di sviluppo in Africa è il tema centrale presentato dalla Cancelliera Angela Merkel»
Il 6 e 7 luglio si apre ad Amburgo il G20 e alte sono le aspettative, come dimostrano anche le azioni in fase di preparazione all'evento. Ieri, lunedì 12 giugno, si è tenuta a Berlino una pre-conferenza cui erano presenti alcuni dei massimi rappresentanti della politica internazionale: tra gli altri, per l'Italia, il presidente del Consiglio Gentiloni e il ministro dell'Economia Padoan; la direttrice del FMI (Fondo Monetario Internazionale), Christine Lagarde; il presidente della Banca Mondiale, Jim Yong Kim; il Commisssario europeo agli Affari economici, Moscovici, e il presidente della Bundesbank, Weidmann. Durante la conferenza è emerso più degli altri quello che sarà uno dei fulcri dominanti del summit di luglio, ossia lo sviluppo dell'Africa.
Si è parlato di un "#Piano Merkel", per fare riferimento a un piano di investimenti voluto dalla leader tedesca in favore della crescita del continente africano.
Il Piano per l'Africa della Cancelliera tedesca
Il nuovo Piano di investimenti in Africa prende il nome da un altro che ha segnato la storia passata - il Piano Marshall dopo la seconda guerra mondiale - e corrisponde a uno stanziamento di 300 milioni di euro per l'occupazione in Africa. Una cifra considerevole che, come previsto dal ministro dello Sviluppo tedesco, servirà a: sostenere programmi di formazione professionale e occupazione locale e coinvolgerà paesi come Tunisia, Ghana, Costa d'Avorio, prima di tutto. A cui seguiranno, in un secondo momento, Marocco, Ruanda, Senegal ed Etiopia; stimolare le riforme sul territorio africano, tali da "attrarre un numero maggiore di investimenti privati" (tale misura prende il nome di "Compact with Africa".)
Il Piano per l'Africa è ambizioso e prevede un impegno ingente da ambo le parti.
Se da un lato si prevedono forti investimenti per favorire lo sviluppo dei paesi africani, dall'altro lato sono richiesti profondi cambiamenti strutturali da parte delle nazioni africane, che sono chiamate a un impegno oggettivo per il rispetto dei diritti umani, per la lotta alla corruzione e per la salvaguardia dello stato di diritto.
Ragioni per investire in Africa secondo Angela Merkel
Il Piano prende il nome dalla leader tedesca in segno d'omaggio al suo impegno di mettere l'Africa al centro del dibattito in preparazione del summit che la Germania sarà chiamata a presiedere a luglio. Nel vertice di Berlino di ieri, la Merkel ha spiegato le ragioni per un tale investimento. Non si tratta di un banale aiuto economico a paesi emergenti. Un lavoro sinergico di quanti più paesi possibili per migliorare le condizioni in Africa equivale, infatti, a "creare più sicurezza anche per noi", ha spiegato. In questo senso, la Merkel ha messo in dubbio l'efficienza degli aiuti stanziati fino adesso.
"Nei paesi emergenti dobbiamo chiederci se abbiamo seguito sempre la strada giusta. Non credo". Il suo suggerimento è, piuttosto, quello di orientarsi maggiormente "sullo sviluppo economico dei singoli Stati". Nel prossimo G20 di Amburgo il suo intento principale sarà quindi quello di coinvolgere quanti più paesi possibile in questa direzione.
 «C’erano solo individui. Atomi solitari, ognuno accecato da un "si salvi chi può" esclusivo, arrestato al confine del proprio Io. Ognuno in guerra disperata col proprio vicino in una fuga da non-si-sa-cosa verso non-si-sa-dove…».
«C’erano solo individui. Atomi solitari, ognuno accecato da un "si salvi chi può" esclusivo, arrestato al confine del proprio Io. Ognuno in guerra disperata col proprio vicino in una fuga da non-si-sa-cosa verso non-si-sa-dove…». il manifesto,
8 giugno 2017 (c.m.c.)
Il surplus – l’eccedenza – di messaggi e di energia negativa dell’evento, e il deficit di pensiero con cui è stato elaborato. L’accaduto è (non riesco a trovare altra parola) “inusitato”: una folla ferma, ordinata, fino ad allora tranquilla d’improvviso impazzisce, senza altra apparente ragione se non la folla stessa. Qui non ci sono hooligans che aggrediscono, come all’Heysell trent’anni fa. E nemmeno un attacco terroristico: di terroristi nemmeno l’ombra, solo molto terrore sottocutaneo che evidentemente attraversava come una corrente elettrica quella massa di corpi assiepati. Per tre giorni si è cercato un episodio,anche minimo, che possa aver scatenato il panico: un petardo, uno spray urticante, delle urla minacciose, un gesto provocatorio. Nulla. Almeno fino ad ora. Tutto sembra parlare di un fenomeno (“inusitato”, appunto) di autocombustione della folla. Di un evento (terribilmente distruttivo) privo di causa efficiente. E di un “autore”.
È questa la cosa – il monstrum, grande come una piazza grande – su cui dovremmo alzare l’allarme e applicare il cervello: questa gigantesca sindrome mentale che ci rende irriconoscibili a noi stessi (e inspiegabili), materializzatasi nel cuore di Torino. E invece è partita subito la banale caccia all’errore da cronaca quotidiana, la più trita polemica politica sulle colpe amministrative e sui loro colpevoli: il prefetto, il questore, il sindaco, il capo dei vigili, che pure qualche errore avranno fatto se alla fine si sono contati oltre 1500 feriti (in gran parte, bisogna dirlo, non gravi). Ma che non possono certo essere indicati all’origine del disastro (a meno di pensare che un’ordinanza, qualche transenna meglio posizionata, un centinaio di vigili o agenti in più avrebbero potuto per miracolo arginare quel fiume di folla impazzita). E la focalizzazione sui quali serve solo a rassicurare e rimuovere il carattere tremendamente perturbante dei fatti.
Invece quel perturbante dobbiamo tenerlo ben fermo davanti agli occhi. Per decodificare ciò di cui ci parla. E la prima cosa che ci dice, attraverso quelle immagini notturne, un po’ gotiche, di quella piazza in preda ai fantasmi, è che siamo cambiati. Nel profondo. La guerra a bassissima intensità che da anni si combatte nel cuore d’Europa (a fronte di quella ad altissima intensità che si consuma oltre i suoi confini), questa guerra le cui armi sono coltelli, martelli, furgoni, Suv Van e Tir, oggetti domestici o quasi, ha avuto in realtà un fortissimo impatto mentale, sulla nostra sfera psichica. Quello stillicidio di attacchi, da Charlie Hebdo a Bataclan a Nizza Berlino Londra Manchester… ha depositato sul nostro sistema nervoso collettivo una pellicola tossica. Ha riconfigurato i nostri neuroni-specchio sui codici del panico. E ha abbassato la soglia di allarme fin quasi a zero, così che il meccanismo della chiusura difensiva verso ogni altro scatta pressoché “per nulla”. Siamo davvero tutti dei “mutanti”, anzi ormai dei mutati.
La seconda cosa che Torino ci dice è che la profezia annunciata dalla signora Thatcher all’inizio degli anni ’80, si è pienamente adempiuta. «La società non esiste, esistono solo gli individui», predicava. E in effetti in quello spazio pubblico per eccellenza che è la piazza centrale della città la Società non c’era. C’erano solo individui. Atomi solitari, ognuno accecato da un «si salvi chi può» esclusivo, arrestato al confine del proprio Io. Ognuno in guerra disperata col proprio vicino in una fuga da non-si-sa-cosa verso non-si-sa-dove… Chi c’era racconta cose che chiede di non ripetere, di nasi fratturati a gomitate, gambe storpiate, bambini calpestati e neppur visti, abiti stracciati nel tentativo di sopravanzare chi era davanti come ostacolo, i più fragili abbattuti dai più muscolosi, i più lenti dai più veloci… È come se lì si fosse materializzata, in forma di girone infernale, l’immagine plastica del paradigma che definiamo “neo-liberista”. La potenza dissolvente del suo negativo, in una rappresentazione drammaturgica del suo individualismo possessivo, anzi predatorio.
La sua competitività – il suo
mors tua vita mea – eletta a dato strutturale e naturale. La rottura dei legami sociali visti come ostacolo e rallentamento. L’assenza di senso che non sia quello del mero sopravvivere. La dissoluzione di ogni lavoro – anzi “mestiere” – in astratta ed effimera funzione. Non è senza significato che gli unici “eroi” di quella notte, coloro che hanno fatto scudo e salvato Kelvin, il bambino di origine cinese, siano un
bodyguard nero e un ex soldato italiano, due che hanno ritrovato nella propria “professione” la risorsa per “restare umani”. E che il giovane che, a braccia larghe, si sforzava di calmare i vicini perché non era “successo niente” – uno dei pochi “spiriti critici” in quella follia – sia stato selezionato come possibile colpevole, fermato e interrogato per ore.
Curare questa doppia sindrome dovrebbe essere compito della politica. Che invece oggi più che mai mostra la propria miseria, miopia e, in qualche caso, vocazione sciacallesca, nel ricercare nel proprio competitor immediato il colpevole di tutti i mali.
 «In origine fu Al Qaeda, poi vennero i video del Califfato: “Kill them wherever you can”, uccidili ovunque tu possa». Perchè Londra è l'obiettivo preferito dei terroristi. Perchè e come la strategia della "cupola" del terrorismo voglia favorire la reazione violenta della nazioni colpite.
«In origine fu Al Qaeda, poi vennero i video del Califfato: “Kill them wherever you can”, uccidili ovunque tu possa». Perchè Londra è l'obiettivo preferito dei terroristi. Perchè e come la strategia della "cupola" del terrorismo voglia favorire la reazione violenta della nazioni colpite.
il Fatto Quotidiano online, 5 giugno 2017
Al-Hayat, testata web che è portavoce del Califfato, 24 gennaio 2016. In un nuovo video di rivendicazione degli attentati del maledetto venerdì 13 novembre 2015 a Parigi, due dettagli allarmano l’intelligence inglese. Il primo è il nome in codice dell’operazione: “Kill them wherever you can”. Uccidili ovunque tu possa. Il secondo è nel finale del video: in cui, successivamente, appaiono le immagini di David Cameron, allora premier inglese, la Camera dei Lord e alcune zone turistiche britanniche. Gli analisti non hanno dubbi: “Si tratta di una conclamata minaccia agli interessi britannici”. Del resto, il Regno Unito era tra i bersagli prioritari previsti da Abdelhamid Abaaoud, il capo dei terroristi che avevano attaccato Parigi e che verrà ucciso in un raid della polizia francese pochi giorni dopo, a Saint-Denis.
Dieci anni prima, il 7 luglio del 2005, era stata al-Qaeda a colpire Londra con attentati alla rete dei trasporti (metro, bus) causando la morte di 56 persone. Il terrorismo islamico presentava il macabro conto dell’alleanza Bush-Blair, del fatto che la Gran Bretagna era il più fedele alleato degli Stati Uniti nella coalizione internazionale che aveva anche come obiettivo non secondario la distruzione della rete di Osama bin Laden. Londra aveva pesantemente contribuito all’eliminazione di numerosi centri di addestramento dei quadri di al-Qaeda, nonché allo smantellamento di molti gruppi estremisti islamici che ad essa facevano riferimento. Tuttavia, grazie alla struttura proteiforme di al-Qaeda e alla forte esposizione mediatica degli attentati in Europa, in Medio Oriente e in India, l’organizzazione si trasforma poco per volta in una sorta di vasta confederazione che aggrega militanti in nome “dello jihad dal basso”, e che attua operazioni condotte da individui isolati o da piccoli gruppi, spesso autoradicalizzati, che vivono nella clandestinità e che non hanno legami diretti con il centro dell’organizzazione. È da questa eredità logistica che parte l’Isis, nei cui ranghi s’inseriscono tra il 2013 e il 2014 numerosi jihadisti anglofoni, come il boia “Jihad John”, al secolo Mohamed Emzawi, ucciso alla fine del 2015.
Negli ultimi tre mesi le minacce si sono concretizzate con tre attacchi (a marzo, la folle corsa del suv sul ponte di Westminster, poi la recente strage alla Manchester Arena, infine Londra), in altre cinque occasioni i servizi segreti sono riusciti a sventare altrettanti complotti terroristici. Non è un caso: l’8 giugno ci saranno le elezioni anticipate volute dalla premier Theresa May. Gli attacchi di Londra arrivano quando mancano cinque giorni al voto, coi sondaggi che danno i laburisti in grande rimonta rispetto ai conservatori e il rischio di una svolta imprevista rispetto ai calcoli della May.
Non è la prima volta che il terrorismo cerca di radicalizzare la situazione politica. Di recente, ci ha provato in Francia, alla vigilia delle primarie presidenziali, con la sparatoria agli Champs Elysées. Lo scopo è forzare le decisioni di chi governa in senso autoritario. Il terrorismo – quale che sia la sua matrice e i suoi mandanti – punta a destabilizzare. Gli attentati spesso diventano pretesti per adottare leggi più restrittive in nome dell’emergenza. Infatti, la May ha avvisato ieri l’opinione pubblica: “Non “possiamo e non dobbiamo far finta che le cose possano continuare come sono, no, le cose devono cambiare”. Convinta che dietro tutto ci sia l’estremismo islamista, ha proposto un piano articolato in quattro punti. Solo che non c’è nulla di nuovo, è aria fritta in funzione elettorale: “Li affronteremo sul terreno delle idee e di Internet”. Putin queste cose le sostiene dai tempi di Beslan…Vuole rilanciare la cooperazione antiterroristica tra l’Unione Europea e Londra, dimenticando che la condivisione delle informazioni non passa da Bruxelles e che per il momento solo Francia e Germania lo fanno, ma fra di loro. Pure la lotta al net-terrorismo (col blocco amministrativo dei siti che ospitano materiale apologetico) risale, in Gran Bretagna, al 2005-2007, e si è visto come funziona…
La May, infine, scopre che il terrorismo si è evoluto e che c’è una nuova “tendenza dell’estremismo: i terroristi si ispirano non solo sulla base di un complotto pianificato, ma si copiano gli uni con gli altri”. Dicasi emulazione. Insomma, per riassumere, la premier vuole sconfiggere l’ideologia islamista per far capire che i valori occidentali sono superiori, mettere fine allo spazio sicuro offerto i terroristi della rete on-line, continuare l’azione militare contro l’Isis in Iraq e in Siria, garantire pene detentive più lunghe e collaborare con gli alleati per regolare il cyber-spazio “in modo da evitare il diffondersi dell’estremismo e la pianificazione degli attentati”. Un replay dell’intervento al G7 di Taormina.
 Una delle tante storie che dovrebbero farci comprendere che abbiamo costruito noi stessi - nella nostra superbia di "civilizzatori"gli incubatori dell’odio, di cui il terrorismo è l'espressione disperata.
Una delle tante storie che dovrebbero farci comprendere che abbiamo costruito noi stessi - nella nostra superbia di "civilizzatori"gli incubatori dell’odio, di cui il terrorismo è l'espressione disperata.
Corriere della Sera, 29 maggio 2017
Mamma, mi dai il pallone? «No, Ashraf. Tu devi stare con me». Posso giocare almeno con le guardie? «No, ho paura che ti violentino». Mamma, ma quando andrò a scuola? «Mai». A Jamina la marocchina è rimasto solo Ashraf, 7 anni, e tutta sola se lo tiene tutto il giorno nel buio del capannone delle sudanesi, nel pozzo nero delle sue angosce.
I materassi per terra, qualche sporta di plastica, un pallone mezzo sgonfio, mezz’ora d’aria, la puzza densa dei disperati ammassati da mesi. Guai a chi l’avvicina. Jamina non vuole andare in Europa, né tornare in Marocco: dice che vivrà per sempre qui con Ashraf, nel campo-carcere di Sikka, lungo la vecchia ferrovia di Tripoli. Ne ha viste troppe, la sua storia scuote perfino le guardie che ne hanno viste molte: abbandonata incinta da un francese, cacciata dalla famiglia, passata per la Libia con la speranza d’arrivare in Francia assieme ad Ashraf, prima è finita schiava nel Sahara di Sebha («un giorno mi hanno stuprato 36 camerunesi») e poi è stata venduta a un bordello dell’Isis a Sirte. Quando l’hanno arrestata, il figlio sempre con lei, stava in una casa di jihadisti e ha dovuto spiegare il perché.

Nessuno ora sa che farne: la famiglia la disconosce, il francese è sparito, il governo marocchino non vuole riavere chi ha frequentato terroristi. «Ma lei non sa nulla del mondo - dice Adel Mustafa, il direttore -, è stata solo sfortunata». In che casella mettiamo questa donna e suo figlio? Rifugiati di guerra? Migranti economici? Gente che poteva starsene a casa sua? Oggi Jamina ha 34 anni, è disturbata e spesso straparla, un giorno si vela e l’altro si spoglia, spesso picchia il bambino per niente. «Ci vorrebbe uno psicologo. L’abbiamo chiesto all’agenzia Onu per i profughi, l’Unhcr, ma non hanno mandato nessuno. Noi scoppiamo di gente, da sei mesi non paghiamo nemmeno chi ci fornisce i pasti… Chi può occuparsene?».
 Bisogna comprendere la strategia del terrorismo per vincerlo. «Se il terrorismo colpisce qui, le sue leve sono nei campi di battaglia siriani, iracheni, yemeniti e libici. Chissà se a Taormina qualcuno dei piccoli leader europei avrà il coraggio di dirlo al nuovo e lunatico padrone del mondo».
Bisogna comprendere la strategia del terrorismo per vincerlo. «Se il terrorismo colpisce qui, le sue leve sono nei campi di battaglia siriani, iracheni, yemeniti e libici. Chissà se a Taormina qualcuno dei piccoli leader europei avrà il coraggio di dirlo al nuovo e lunatico padrone del mondo».
il manifesto, 24 maggio 2017
C’è qualcosa di nazista nelle tattiche terroristiche promosse dall’Isis. Colpire la folla dei concerti, composta da adolescenti e da ragazzini o bambini, a Parigi o Manchester, per fare più vittime possibile, significa mirare alla popolazione civile, perché se ne stia a casa e non faccia uscire i figli. Allo stesso modo, gli attentati di Nizza e Berlino e tanti altri avevano lo scopo di far rinunciare alla partita del sabato o della domenica, alla festa in piazza, a prendere un treno o a salire su un aereo.
Per quanto i lutti siano atroci, questa è la conseguenza strategica più grave della guerriglia contro le popolazioni dell’occidente: farle vivere perennemente nella paura. Gli appelli dei governi del tipo «la vita deve continuare come prima» o «combattiamo la paura» sono inevitabili, ritualistici e inutili. Possono ben poco contro un terrorismo ubiquo, probabilmente in franchising, i cui attori sono per lo più cittadini europei da lunga data (con buona pace di Le Pen e Salvini, che se la prendono con i migranti). Gente che può aver combattuto in Siria, Libia o Iraq per l’Isis o qualche altra sigla, ma che forse è anche composta di sbandati delle banlieue o di quartieri satellite che decidono di fare il salto della morte per la morte, in nome dell’Islam, dell’odio per la loro esistenza o dell’occidente.
A onta tutta la loro sorveglianza, degli infiltrati, dei monitoraggi delle moschee e degli imam estremisti, nonché delle espulsioni dei sospetti, i servizi occidentali non sembrano in grado di mettere le mani in questi mondi circoscritti, ma dissimulati e sfuggenti. E capaci di rinnovarsi in continuazione. Ma manca anche un’analisi della strategia dell’Isis, senza la quale nessuna contromisura politica efficace può essere davvero presa. Ora, è abbastanza evidente che l’Isis, attraverso l’organizzazione o la rivendicazione degli attentati, vuole provocare i governi occidentali, perché reagiscano scompostamente, facciano arresti nel mucchio, magari decidano qualche nuovo intervento militare contro l’Isis. E soprattutto perché attacchino l’Islam in quanto tale, come predicano Le Pen, Salvini, Farage e tanti altri. Aumentando così un risentimento che, per quanto minoritario, può alimentare il reclutamento di terroristi, kamikaze o no che siano.
In questo senso, il «muslim ban» di Trump ha già fatto danni enormi, anche se bocciato dalle corti federali americane. Ma anche la sua incursione in Arabia saudita è molto meno astuta di quanto non pensino i trumpiani, anche in Europa. Certo, The Donald ha firmato contratti miliardari, vendendo armi che finiranno in Yemen e, forse, per vie traverse e oscure, nelle mani dell’Isis. Nello stesso momento in cui chiede di cacciare i terroristi Donald Trump riconosce il coinvolgimento dei governi arabi, a cui però fornisce armi di ogni tipo. Poi, scagliandosi contro l’Iran e gli sciiti, fa una bella piroetta in chiave anti-iraniana e anti-siriana, cioè anti-russa. Una strategia velleitaria e contraddittoria, che radicalizza quella dei neo-cons di Bush.
Una strategia che inevitabilmente porterà all’inasprimento della guerra in Siria e nello Yemen, e forse in Libia, e a ulteriori conflitti con Putin. L’Isis non chiede di meglio che la radicalizzazione dei conflitti, perché questo è il suo terreno di propaganda e reclutamento. Con la conseguenza di minacciare ulteriormente la nostra vita quotidiana.
Infatti, se il terrorismo colpisce qui, le sue leve sono nei campi di battaglia siriani, iracheni, yemeniti e libici. Chissà se a Taormina qualcuno dei piccoli leader europei avrà il coraggio di dirlo al nuovo e lunatico padrone del mondo. C’è da dubitarne.
 L'orgoglio di servire i padroni del mondo nel saccheggiare la risorse altrui e nel fomentare guerre per rendere le rapine più facili (poiché questo è oggi la Nato), e di rendere con questo più poveri i sudditi di Palazzo Chigi.
L'orgoglio di servire i padroni del mondo nel saccheggiare la risorse altrui e nel fomentare guerre per rendere le rapine più facili (poiché questo è oggi la Nato), e di rendere con questo più poveri i sudditi di Palazzo Chigi.
il manifesto, 29 aprile 2017
«L’Italia partecipa a testa alta all’Alleanza Atlantica, nella quale è il quinto maggiore contributore, e conferma l’obiettivo di raggiungere il 2 per cento del Pil nelle spese militari»: lo ha dichiarato il presidente del consiglio Gentiloni.
Proprio ricevendo il 27 aprile a Roma il segretario generale della Nato Stoltenberg. Ha così ripetuto quanto già detto al presidente statunitense Donald Trump, ossia di essere «fiero del contributo finanziario dell’Italia alla sicurezza dell’Alleanza», garantendo che, «nonostante certi limiti di bilancio, l’Italia rispetterà l’impegno assunto».
I dati sulla spesa militare mondiale, appena pubblicati dal Sipri, confermano che Gentiloni ha ragione ad andare fiero e a testa alta: la spesa militare dell’Italia, all’11° posto mondiale, è salita a 27,9 miliardi di dollari nel 2016. Calcolata in euro, corrisponde a una spesa media giornaliera di circa 70 milioni (cui si aggiungono altre voci, tra cui le missioni militari all’estero, extra budget della Difesa). Sotto pressione Usa, la Nato vuole però che l’Italia arrivi a spendere per il militare il 2% del Pil, ossia circa 100 miloni di euro al giorno.
Su questo, Trump è stato duramente esplicito: ricevendo Gentiloni alla Casa Bianca, riferisce lui stesso in una intervista alla Associated Press, gli ha detto: «Andiamo, devi pagare, devi pagare…».
E, nell’intervista, Trump si dice sicuro: «Pagherà». Non è però Gentiloni a pagare, ma la stragrande maggioranza degli italiani, direttamente e indirettamente attraverso il taglio delle spese sociali.
C’è però, evidentemente, chi ci guadagna. Nel 2016, l’export italiano di armamenti è aumentato di oltre l’85% rispesso al 2015, salendo a 14,6 miliardi di euro. Un vero e proprio boom, dovuto in particolare alla vendita di 28 cacciabombardieri Eurofighter al Kuwait, che diviene primo importatore di armi italiane. Un maxi-contrattto da 8 miliardi di euro, merito della ministra Roberta Pinotti, efficiente piazzista di armi (v. il manifesto del 23 febbraio 2016). Si tratta della più grande commessa mai ottenuta da Finmeccanica, nelle cui casse entra la metà degli 8 miliardi. Garantita con un finanziamento di 4 miliardi da un pool di banche, tra cui UniCredit e Intesa Sanpaolo, e dalla Sace del gruppo Cassa depositi e prestiti.
Si accelera così la riconversione armata di Finmeccanica, con risultati esaltanti per i grossi azionisti: nella classifica delle 100 maggiori industrie belliche mondiali, redatta dal Sipri, Finmeccanica si colloca nel 2015 al 9° posto mondiale con una vendita di armi del valore di 9,3 miliardi di dollari, equivalente ai due terzi del suo fatturato complessivo.
L’azienda accresce fatturato e profitti puntando su industrie come la Oto Melara, produttrice di sistemi d’arma terrestri e navali (tra cui il veicolo blindato Centauro, con potenza di fuoco di un carrarmato, e cannoni con munizioni guidate Vulcano venduti a più di 55 marine nel mondo); la Wass, leader mondiale nella produzione di siluri (tra cui il Black Shark a lunga gittata); la Mbda, leader mondiale nella produzione di missili (tra cui quello anti-nave Marte e quello aria-aria Meteor); l’Alenia Aermacchi che, oltre a produrre aerei da guerra (come il caccia da addestramento avanzato M-346 fornito a Israele), gestisce l’impianto Faco di Cameri scelto dal Pentagono quale polo dei caccia F-35 schierati in Europa.
Poco importa che Finmeccanica – in barba al «Trattato sul commercio di armamenti» che proibisce di fornire armi utilizzabili contro civili – fornisca armi a paesi come il Kuwait e l’Arabia Saudita, che stanno facendo strage di civili nello Yemen. Come stabilisce il «Libro Bianco per la sicurezza internazionale e la difesa» a firma della ministra Pinotti, convertito in disegno di legge, è essenziale che l’industria militare sia «pilastro del Sistema Paese», poiché «contribuisce, attraverso le esportazioni, al riequilibrio della bilancia commerciale e alla promozione di prodotti dell’industria nazionale in settori ad alta remunerazione», creando «posti di lavoro qualificati».
Poco importa naturalmente che si spendano per il militare, con denaro pubblico, oltre 70 milioni di euro al giorno, ormai in continuo aumento. Essenziale, stabilisce il «Libro Bianco», è che l’Italia sia militarmente in grado di tutelare, ovunque sia necessario, «gli interessi vitali del Paese». Più precisamente, gli interessi vitali di chi si arricchisce con la guerra.
 «». il manifesto, 20 agosto 2017 (c.m.c.)
«». il manifesto, 20 agosto 2017 (c.m.c.)