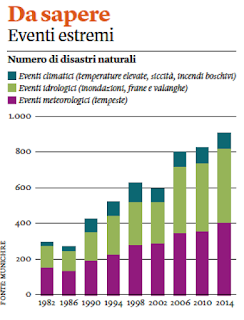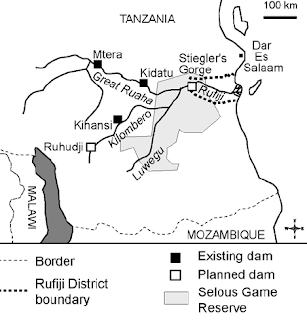Riprendiamo da Internazionale (8 settembre 2017) articoli di J. Watts, J. Adhikari, G. Ansaldi e G Milani sugli ultimi disastri ambientali. Siano conseguenze del cambiamento climatico o dell'espansione scellerata di attività umane che rendono fragili i territori, è chiaro che questo sviluppo ci mette sempre più in pericolo. (i.b.)
Una spiegazione agli uragani, cicloni, tempeste e inondazioni che
hanno colpito Stati Uniti, Nepal, India e Bangladesh. E una recensione del libro "Storia culturale del clima" di Wolfgang Behringer, utilissimo per orientarsi su un tema, quello dei cambiamenti climatici, complesso, dibattuto e contrastato (i.b). A questo proposito rimando all 'articolo di Naomi Klein, "L'apartheid climatico e i media", qui su eddyburg.
Sull'uragano Harvey che ha colpito le zone del sud-est del Texas, incluso Houston, e della Louisiana si legga anche l'articolo "Houston, la fragilità del capitalismo senza limiti" pubblicato qui, dal manifesto
. (i.b.)
The Guardian
UN FUTURO PERICOLO
di Jonathan Watts
I 64 miliardi di metri cubi di pioggia (più o meno l’equivalente di 26 milioni di piscine olimpioniche) rovesciati sul Texas dall’uragano Harvey alla fine di agosto hanno stabilito un nuovo record per un ciclone tropicale negli Stati Uniti. Ma è un record che difficilmente durerà a lungo, visto che le emissioni di anidride carbonica provocate dagli esseri umani stanno spingendo il clima in un territorio sconosciuto.
Le immagini delle strade allagate in Texas fanno pensare a quelle delle comunità colpite dalle inondazioni in India e in Bangladesh, alle recenti valanghe di fango in Sierra Leone e all’esondazione di un affluente del fiume Yangtze, in Cina, che ha provocato decine di morti ad agosto. In parte si tratta di calamità stagionali, e le loro conseguenze dipendono anche da fattori locali. Ma gli scienziati sostengono che gli eventi estremi di questo tipo diventeranno sempre più frequenti e devastanti a causa dell’aumento delle temperature globali e dell’intensità delle precipitazioni.
Il nostro pianeta sta vivendo un’era di record spiacevoli. Ogni anno, dal 2015 a oggi, le temperature hanno toccato picchi mai visti dalla nascita della meteorologia, e probabilmente da 110mila anni. La quantità di anidride carbonica nell’aria è ai livelli più alti degli ultimi quattro milioni di anni. Non è questo a provocare eventi come l’uragano Harvey: in questo periodo dell’anno nel golfo del Messico ci sono sempre tempeste e uragani. Ma l’aumento delle temperature rende questi eventi più piovosi e potenti.
Più l’acqua degli oceani si riscalda, più evapora facilmente e fornisce energia alle tempeste. E, scaldandosi, l’aria sui mari trattiene una quantità maggiore di vapore acqueo. Ogni mezzo grado in più fa aumentare di circa il 3 per cento l’umidità dell’atmosfera. Questo vuol dire che i cieli si riempiono prima di acqua e ne hanno una quantità maggiore da scaricare. Oggi nel golfo del Messico si registrano temperature di superficie superiori di un grado rispetto a trent’anni fa.
A contribuire all’aumento delle tempeste c’è anche il fatto che, negli ultimi cento anni, il livello dei mari si è alzato di venti centimetri a causa del riscaldamento globale provocato dall’uomo. I ghiacciai si sono sciolti e le acque marine hanno subìto un’espansione termica. Quando le piogge in Texas si sono avvicinate al record statunitense di 120 centimetri di precipitazioni registrato nel 1978, i meteorologi hanno dovuto introdurre un nuovo colore nei graici. Potrebbe non essere l’ultima revisione.
“Probabilmente i paesi grandi come gli Stati Uniti raggiungeranno altri record di precipitazioni, e non solo a causa degli uragani”, ha affermato Friederike Otto, vicedirettrice dell’Environment change institute dell’università di Oxford. Si tratta di una tendenza globale. “Nell’immediato futuro in tutto il pianeta toccheremo nuovi picchi di caldo e precipitazioni estreme”. La situazione potrebbe cambiare da un paese all’altro, avverte Otto. I fattori in gioco sono molti, ma le conseguenze dell’attività umana sul clima hanno contribuito a scatenare tempeste più violente e siccità più gravi.
Una questione nuova
Nelle ultime settimane in India e in Bangladesh l’aumento del livello dei mari si è aggiunto a un monsone particolarmente forte, che ha inondato alcune regioni uccidendo circa 1.200 persone e costringendone milioni a lasciare le loro case.
Ora è importante capire se il cambiamento climatico ha a che fare con la “sedentarietà” delle tempeste. Negli Stati Uniti gli uragani di solito si spostano verso l’interno e la loro potenza diminuisce man mano che si allontanano dal mare. Ma Harvey è rimasto nella stessa area per giorni, e questo spiega il record di precipitazioni in Texas. Secondo gli scienziati potrebbe essere la questione più grande sollevata da Harvey. “Non credo che qualcuno si sia mai posto il problema. E non credo che qualcuno avesse previsto un evento di questo tipo”, ha detto Tim Palmer, ricercatore della royal society all’università di Oxford.
Di recente i ricercatori hanno individuato un rallentamento nella circolazione atmosferica estiva alle medie latitudini, conseguenza del forte riscaldamento dell’Artico. Secondo Palmer, tuttavia, per studiare gli schemi della pressione servono strumenti analitici più potenti, tra cui i supercomputer. Ma negli Stati Uniti la ricerca è condizionata dalla politica: il presidente Donald Trump sostiene che il cambiamento climatico è una truffa inventata dalla Cina, e ha annunciato che Washington si ritirerà dal trattato di Parigi sul clima e taglierà i fondi per la ricerca sul clima. “Cercare di capire quanto saranno frequenti eventi come Harvey in futuro non dovrebbe essere oggetto di discussioni politiche”, conclude Palmer.
Internazionale
SVILUPPO INSOSTENIBILE
Giovanni Ansaldi
Mentre a Houston le acque portate dall’uragano Harvey si ritirano, una cosa è chiara: una parte dei danni – umani ed economici – poteva essere evitata”, scrive il New York Times. Uno dei problemi principali è lo sviluppo urbanistico. Negli ultimi trent’anni il boom dell’industria petrolifera ha causato una forte crescita immobiliare: a Houston sono nati nuovi quartieri residenziali e di uffici in zone a forte rischio di inondazioni. In tutta la città sono stati costruiti parcheggi, strade ed edifici che hanno cancellato la vegetazione fondamentale per facilitare il drenaggio. A questo si aggiunge il fatto che le mappe della federal emergency management agency (Fema, l’agenzia statunitense che si occupa di gestire e prevenire le emergenze), create per evidenziare le zone a rischio in caso di catastrofe, non sono mai state aggiornate. Confrontando le mappe con le foto scattate dopo il passaggio dell’uragano, si vede che alla fine di agosto sono state inondate zone che secondo la Fema avevano lo 0,2 per cento di possibilità di essere invase dall’acqua. Le mappe non sono aggiornate perché il congresso non assegna abbastanza fondi all’agenzia. Inoltre non tengono conto degli effetti futuri dei cambiamenti climatici. “Ancora più preoccupante è il fatto che il Texas non sembra preparato ad affrontare la ricostruzione”, osserva il New York Times. “La maggioranza dei residenti della regione colpita non era assicurata”.
Secondo The Atlantic, quello che è successo a Houston è un segnale d’allarme per tutto il paese e mette in discussione una certa idea di sviluppo: “Quando si parla di gestione degli uragani, l’aspetto più difficile da affrontare è la convinzione degli statunitensi di poter vivere e lavorare dove preferiscono. Nel paese ci sono zone – come alcuni quartieri di Houston e di New Orleans o intere regioni della florida – che non dovrebbero essere abitate”. E che in futuro saranno sempre più a rischio a causa dell’innalzamento del livello dei mari e dei disastri naturali causati dai cambiamenti climatici.
The Conversation
I DISASTRI DELLA POLITICA
IN ASIA MERIDIONALE
di Jagannath Adhikari
Nelle ultime settimane il Nepal è stato colpito da forti inondazioni che hanno alimentato le tensioni regionali. I politici e i mezzi d’informazione locali sostengono che le infrastrutture indiane lungo il confine hanno reso il Nepal più vulnerabile.
Durante un incontro in India alla fine di agosto, il primo ministro nepalese Sher Bahadur Deuba e l’indiano Narendra Modi hanno rilasciato un comunicato in cui promettono che lavoreranno insieme per evitare nuove alluvioni. Ma i rapporti tra i due paesi restano tesi.
La tensione è dovuta in parte alla geografia dell’Himalaya: una diga o una strada costruita nel paese può provocare un’inondazione in un paese confinante. Così India, Cina e Nepal si accusano a vicenda di politiche egoiste e poco lungimiranti. La mancanza di un’organizzazione regionale che raccolga le informazioni e coordini le operazioni di soccorso ha sicuramente aumentato le sofferenze della popolazione.
Miniere illegali
Nella regione dell’Himalaya le inondazioni sono eventi quasi annuali. Grandi fiumi che nascono nella catena montuosa attraversano le popolose pianure del Terai, che si estendono sia in India sia in Nepal, e durante la stagione dei monsoni il livello dell’acqua cresce notevolmente.
Ma le inondazioni di quest’anno sono state particolarmente devastanti. Negli ultimi due mesi in Nepal, India e Bangladesh hanno colpito venti milioni di persone e ne hanno uccise almeno 1.200.
Questi eventi sono un problema politico ma anche logistico. Nel caso delle ultime inondazioni, il ministro dell’interno nepalese ha puntato il dito contro due grandi dighe costruite dall’India lungo i fiumi Koshi e Gandaki, e anche contro le strade, gli argini e i canali costruiti lungo i 1.751 chilometri del confine tra India e Nepal, sottolineando che queste infrastrutture hanno ostacolato il corso naturale dell’acqua.
L’India accusa a sua volta il Nepal, e molti sono convinti (anche se negli ambienti scientifici la tesi è discussa) che la deforestazione in corso in Nepal contribuisca alle piene in India. Il problema è che la costruzione di infrastrutture di un paese può avere conseguenze importanti per i paesi vicini, soprattutto nella stagione dei monsoni. Almeno una decina di persone sono rimaste ferite l’anno scorso negli scontri durante le proteste contro la costruzione di una diga in India che, secondo il Kathmandu Post, causerà l’inondazione di alcune aree del Nepal una volta completata.
I problemi non sono causati solo dalle dighe. Gli esperti di disastri e gli idrologi nepalesi sostengono che le recenti inondazioni sono state aggravate dall’intensa attività mineraria illegale sulle colline Churia per estrarre sassi e sabbia da usare nell’edilizia indiana, in rapida espansione.
E le dispute non riguardano solo India e Nepal. Nel 2006 India e Cina hanno firmato un accordo per la condivisione di informazioni idrologiche sui grandi fiumi che scorrono in entrambi i paesi, per rispondere meglio alle piene annuali. Ma all’inizio dell’anno il ministro degli esteri indiano ha accusato la Cina di non aver condiviso dati essenziali, e di aver così peggiorato gli effetti delle inondazioni nell’India nordorientale.
Prospettiva regionale
Non è un incidente isolato. Nel 2013 una grande inondazione in quella zona dell’India ha ucciso circa seimila persone. All’epoca le autorità indiane hanno sostenuto di non aver ricevuto informazioni dal Nepal sulle forti piogge in collina o sulle condizioni dei ghiacciai. Le autorità nepalesi hanno risposto che la Cina era in una posizione migliore per condividere le informazioni sulle condizioni climatiche in quell’area dell’Himalaya. Alcuni studi condotti in seguito hanno stabilito che un’efficiente condivisione delle informazioni e un’allerta tempestiva avrebbero potuto ridurre sensibilmente i danni.
Il problema è particolarmente urgente in un momento in cui la regione dell’Himalaya è colpita dagli effetti del cambiamento climatico. I climatologi hanno sottolineato che qui le “inondazioni estreme” sono aumentate, a causa di piogge meno frequenti ma più intense.
Bisogna cambiare il modo in cui le istituzioni gestiscono questi disastri. Alla fine di agosto India e Napal hanno annunciato che creeranno una commissione congiunta per la gestione delle inondazioni e delle alluvioni, e una squadra di esperti per “migliorare la cooperazione bilaterale” nella gestione dell’acqua. È un segnale positivo.
Ma nella regione dell’Himalaya c’è urgente bisogno di istituzioni con competenze regionali invece che nazionali. Queste organizzazioni potrebbero condividere le informazioni sul clima, agire per ridurre i danni causati dalle inondazioni e consultarsi durante la costruzione di infrastrutture che potrebbero avere conseguenze per gli stati vicini.
Le attività umane e la miopia della politica hanno aumentato gli effetti negativi delle inondazioni. È ora che tutti i paesi della regione accettino di condividere le responsabilità e s’impegnino per aiutare le persone colpite, a prescindere dalla nazionalità.
Internazionale
CLIMA, STORIA E CULTURA
di Giuliano Milani
Wolfgang Behringer, "Storia culturale del clima", Bollati Boringhieri, 349 pagine, 14 euro
Mentre negli ultimi anni si sono aperte feroci polemiche sul riscaldamento globale, la storia del clima ha assunto una nuova importanza. Capire se in passato ci sono stati periodi in cui la temperatura è cambiata, quantiFicare il cambiamento e comprenderne le ragioni è diventato importante per affrontare le side che ci pone il presente. Non sempre è facile accedere alle ricerche che permettono di capire come si è evoluto il clima del nostro pianeta. Ecco perché è utile questo libro che, dopo aver spiegato come il clima cambia, ricostruisce questa vicenda dall’inizio della Terra a oggi, con sempre maggiore dettaglio avvicinandosi al nostro tempo. Si segue il riscaldamento dell’olocene, cominciato
12mila anni fa e i vari, occasionali raffreddamenti che in quel periodo si alternarono ai momenti più caldi (nell’età romana e nel basso medioevo).
Per la “piccola età glaciale”, cominciata nel trecento e terminata nel corso del novecento, il maggior numero di fonti e dati consente a Behringer alcune ipotesi sulla relazione tra clima e fenomeni sociali
e politici come la stregoneria, la democratizzazione, l’illuminismo. La cautela con cui questi collegamenti sono fatti e la quantità d’informazioni fornite al lettore rendono questo libro un’efficace chiave di lettura per orientarsi in un campo di studi nuovo, complesso e già al centro di molte
discussioni.

«Le previsioni oggi permettono di dare l’allerta in tempo ma poi bisogna ragionare: dove sarò quando arriverà la pioggia? Che precauzioni prendere? Guai a pensare “non capiterà mai a me”». il Fatto Quotidiano, 3 settembre 2017 (p.d.)
Dopo un’estate italiana tra le più calde e asciutte di sempre, arriverà l’autunno con le sospirate piogge. Magari un po’ troppo intense, e ci troveremo così a scrivere gli articoli sull’emergenza alluvione. Nel Paese delle inutili polemiche del dopo-evento, proviamo per una volta fin da oggi a prevenire, a riflettere prima che ciò avvenga. Otto von Bismarck disse che è stupido imparare dai propri errori, è meglio imparare da quelli degli altri! Prendiamo come esempio l’enorme inondazione texana provocata dalla tempesta Harvey.
Oggi le previsioni meteo funzionano e l’allerta è stata data con successo con alcuni giorni di anticipo. Ma le piogge hanno superato le attese, con valori fino a circa 1300 millimetri caduti in pochi giorni su vasti bacini pianeggianti, e gli allagamenti sono stati molto più estesi del previsto. Gli abitanti si sono così trovati isolati, senza luce, acqua potabile e cibo, e con il pian terreno invaso da fango inquinato. Le vittime sono state poche decine grazie alla relativa calma della piena, a differenza di quanto avvenuto nel 2005 a New Orleans, dove l’uragano Katrina aveva divelto le dighe costiere e l’invasione delle acque in città era stata repentina e irruenta, con oltre 1800 vittime.
In Italia abbiamo sia la piena fluviale lenta e prevedibile, come quella del Po, sia le piene-lampo (flash-flood) dei territori montuosi, dove in pochi minuti insieme all’acqua precipitano anche detriti rocciosi e alberi, come frequentemente avviene a Genova. Anche le zone percorse dagli incendi di quest’estate, specie se vicine a centri abitati, dovranno essere tenute sotto controllo in quanto potrebbero essere soggette a rapida erosione durante forti precipitazioni.
Ma veniamo alle istruzioni per ridurre il rischio: all’emissione di un bollettino meteo di allerta (intensità crescente da gialla-arancione-rossa), prima di tutto bisogna chiedersi: dove sarò io in quel momento? Se in casa, conviene già alcuni giorni prima farsi uno scenario mentale: ho cose preziose al pian terreno facilmente allagabili? Le porto a un piano superiore. Dove è parcheggiata l’auto? La sposto in luogo sicuro (molte vittime sono annegate in garage sotterranei nel tentativo di salvare la loro tonnellata di ferraglia invece della vita, come in Costa Azzurra a inizio ottobre 2015). Ho riserve di cibo in caso rimanga isolato per alcuni giorni? Faccio una piccola riserva di scatolame non deperibile, pensando pure a un’avaria del frigo per mancanza di elettricità. Ho messo da parte qualche tanica di acqua potabile? E se la mia casa è esposta a frane, ho considerato l’opzione di andarmene da parenti o amici in zona più sicura? Se ho in programma di essere in auto, posso annullare il viaggio e starmene a casa per sorvegliare che non ci siano grane?
Se devo per forza muovermi, so che non devo mai entrare in un sottopassaggio che si sta allagando? L’auto galleggia in mezzo metro d’acqua e resterei imprigionato sul fondo senza poter risalire, con elevato rischio di annegamento, come dimostrano decine di banali incidenti simili. Se passo su un ponte su un fiume in piena, non mi fermo a guardare: potrebbe crollare o essere sormontato dalle acque. Se è già stato transennato dalle autorità, non forzo il blocco, perché è meglio attendere mezza giornata che morire tra i flutti: accadde durante l’alluvione del Tanaro nel novembre 1994.
Dedicare un po’ di tempo alla simulazione mentale di un evento meteorologico estremo è sempre molto utile sia per evitare di cacciarsi nei pasticci con le proprie mani, cioè scansandoli a priori, sia per cavarsene fuori nel modo migliore in caso si venisse sorpresi. Molte persone nella loro vita non ci hanno mai pensato, prigionieri dei meccanismi psicologici di rimozione del tipo “tanto a me non capiterà” o “sono brutte cose, meglio non pensarci, ridiamoci su e tocchiamo ferro”. Una volta acquisito questo allenamento mentale, in caso di allerta l’altro ingrediente è l’attenzione a ciò che capita attorno a noi: essere vigili, osservare come sta piovendo, ascoltare i rumori, tener d’occhio quel ruscello che scorre sotto casa, sempre quieto, non ha mai fatto danni (nello spazio della tua breve vita…). Molto importante cogliere un’eventuale improvvisa riduzione della portata di un corso d’acqua: potrebbe essersi formata una diga di detriti a monte, o un tappo su un ponte, che poi cedendo di colpo provocherebbe un’onda di piena devastante: scappare a gambe levate dalle adiacenze del torrente. E mai campeggiare sulle rive di un corso d’acqua in tempo di pioggia: una piena notturna avrebbe esiti drammatici, già successo per esempio con i 13 morti di Soverato il 10 settembre 2000.
Le nostre cronache sono piene di alluvioni di tutti i tipi, basterebbe studiarsele per capire le varie situazioni da evitare. Purtroppo questo non allevia i rischi infrastrutturali dovuti agli abusivismi, alla cementificazione selvaggia degli ultimi cinquant’anni. Quella può soltanto essere arrestata, e il rischio può essere leggermente diminuito con opere idrauliche (argini, canali scolmatori). Ma di nuovo Houston insegna: anni di spregiudicata urbanizzazione senza limiti condita da qualche piccolo canale di scolo che ha diffuso un senso di falsa sicurezza accelerando l’ulteriore occupazione di suolo, e poi ti arriva la pioggia mai vista e succede un disastro.
Il problema della vulnerabilità è sempre sottovalutato: il pericolo è rappresentato dall’evento estremo, ma se non c’è nulla da distruggere il rischio è nullo. Se invece su quel territorio ci aggiungo condomini, villette, auto, strade, gasdotti, linee elettriche, industrie, centri commerciali e chi più ne ha più ne metta, la vulnerabilità cresce a dismisura e con essa il rischio di danni e vittime. Quindi laddove possibile, se si diminuisce il capitale esposto invece di accrescerlo, si può ridurre il rischio. Ma questi sono discorsi difficili da fare e ancor più da attuare nella terra dell’improvvisazione e dei piccoli e grandi interessi di parte.
 «Si chiude la peggiore stagione degli incendi in Italia da 30 anni a questa parte. Le cause si possono riassumere in cinque punti. Tutti hanno a che fare con la scarsa attenzione al territorio e al bene comune».
«Si chiude la peggiore stagione degli incendi in Italia da 30 anni a questa parte. Le cause si possono riassumere in cinque punti. Tutti hanno a che fare con la scarsa attenzione al territorio e al bene comune». lavoce.info,
1° settembre 2017 (c.m.c)
Quasi a termine della peggiore stagione negli ultimi 30 anni per gli incendi in Italia, vediamo di analizzare le cause di questo fenomeno, cercando di fare una valutazione più ampia sullo stato delle risorse boschive Possiamo raggruppare le cause di questo fenomeno in cinque categorie, di cui le ultime due collegate a problemi generali del settore forestale che travalicano lo specifico tema degli incendi boschivi.
Condizioni meteorologiche
La prima causa, quasi un prerequisito per lo sviluppo degli incendi, sono le condizioni meteorologiche: aridità, alte temperature, bassa umidità, forte vento con il maggior numero di eventi estremi, come le sette ondate di caldo di questa estate, tutti fenomeni collegati ai cambiamenti climatici. L’eccezionalità climatica sarà sempre più norma; tra l’altro gli scenari di cambiamento climatico prevedono che la regione del Mediterraneo sia più esposta a fenomeni di riscaldamento di altre regioni, con una maggiore riduzione delle precipitazioni nella primavera e con maggiori ondate di caldo in estate, con incendi quindi potenzialmente più rapidi, intensi e di larghe dimensioni.
Incendiari volontari e no. E rari piromani
La seconda causa è legata alla diffusione dei casi di incendi volontari o da comportamento irresponsabile. Non si tratta della diffusione della piromania, una malattia mentale molto rara, ma si tratta di comportamenti dolosi di una moltitudine di soggetti: pastori in cerca di pascoli più ricchi e “puliti”, incendiari con motivazioni vendicative, operai forestali stagionali in cerca di future opportunità di impiego, cacciatori interessati a controllare e concentrare le aree di rifugio della selvaggina, raccoglitori di prodotti selvatici. Ma la causa prevalente sono i comportamenti colposi collegati a noncuranza, negligenza, imperizia e sottovalutazione del rischio. Nell’Europa meridionale quasi il 70 per cento degli incendi sono legati a bruciature di residui vegetali e al desiderio di rigenerare e rendere più produttivi i pascoli.
Prevenzione e spegnimento
Una scarsa attenzione alla prevenzione attiva degli incendi è la terza causa. Nulla di nuovo nel panorama della gestione del territorio in Italia: alla prevenzione viene data una minor attenzione rispetto al ripristino. La prevenzione può essere indiretta o diretta. Per prevenzione indiretta si intendono pratiche quali la scelta delle specie appropriate, la realizzazione di diradamenti e di interventi di pulizia del sottobosco, interventi che hanno anche una importanza fondamentale per aumentare la resistenza e la resilienza delle formazioni forestali. Prevenzione diretta significa realizzazione e manutenzione di fasce tagliafuoco, riduzione del materiale combustibile, pulizia delle fasce laterali delle strade e di quelle sottostanti le linee di comunicazione. Nel considerare l’antitesi prevenzione-spegnimento degli incendi non vanno trascurate le differenze in termini di investimento economico delle due opzioni: la prima interessa soprattutto i piccoli operatori del mondo rurale, il secondo coinvolge soggetti esterni al settore forestale e in particolare l’area del business connessa alla flotta aerea e ai sistemi di monitoraggio, settori fortemente legati all’industria militare.
La foresta abbandonata
Le ultime due cause hanno una rilevanza più ampia, che va ben al di là dello specifico caso degli incendi e interessano le modalità organizzative del settore forestale italiano, negletto dalla politica (in parte perché rappresenta lo 0,08 per cento del valore aggiunto nazionale), nonostante le superfici forestali coprano più di un terzo del territorio e rappresentino quella che è stata definita la più grande infrastruttura verde del paese. Una infrastruttura che, nonostante incendi e attacchi parassitari, è in espansione a seguito della ricolonizzazione di terreni agricoli abbandonati. La prevenzione a costi minori è quella connessa alla rivitalizzazione dell’economia del settore: un bosco che produce valore è un bosco che viene difeso e che difficilmente brucia. In effetti tutto il settore è ancora condizionato da una cultura che è quella dell’Italia della fine dell’Ottocento quando il paese si era dotato di una rigida normativa di vincolo dei territori boscati e di una forza di polizia specializzata nella tutela delle risorse forestali. Di fatto il singolo, più potente, strumento di politica forestale sono ancora i diversi tipi vincoli (idrogeologico, paesaggistico, naturalistico). Negli ultimi 50 anni la superficie forestale è raddoppiata. C’è bisogno di un cambiamento di paradigma di riferimento nella politica forestale: dal “vietare per proteggere e ricostruire il patrimonio” a “gestire il patrimonio, valorizzandolo anche economicamente, per ridurre i costi della sua tutela”.
Un problema di governance
E qui entra in gioco il quinto e ultimo fattore: l’assetto istituzionale del settore, profondamente modificato dalla Legge Madia di riforma della pubblica amministrazione, e in particolare dal Decreto Legislativo 177/2016 che ha ridefinito le istituzioni che operano nel settore forestale a livello centrale. Come spiegato nella scheda tecnica che ha accompagnato il fact-checking sulle attività di spegnimento degli incendi, con il Decreto 177 è stata fatta la scelta di militarizzare il Corpo forestale dello stato (Cfs) inglobando gran parte dei componenti nell’Arma dei Carabinieri. Il Decreto 177 ha avuto uno specifico effetto sull’organizzazione della difesa dagli incendi boschivi nelle regioni a statuto ordinario. Attualmente le competenze risultano divise tra regioni, Vigili del fuoco, i Protezione Civile e Carabinieri forestali, secondo la ripartizione riportata nella scheda tecnica. Con la riforma delle competenze definita dal Decreto si rendono necessarie nuove convenzioni tra Regioni e Vigili del fuoco i quali, tuttavia, in molte Regioni dovrebbero ereditare le competenze negli interventi avendo problemi organizzativi e di personale.
Il rischio che vada sempre peggio
Infine, da una lettura del Decreto, si potrebbe ipotizzare che la prevista Direzione foreste del ministero delle Politiche agricole, forestali e alimentari assuma una funzione di indirizzo delle attività anti-incendio. Questa Direzione è ancora in attesa di una definitiva strutturazione. Con il Decreto 177 si è così riusciti a fare due significativi errori con una sola decisione: si sono affidate responsabilità operative ad una organizzazione (i Vigili del fuoco) che non ha una struttura logistica diffusa sul territorio rurale perdendo le competenze nel coordinamento sul campo accumulate da alcuni decenni di attività antincendio del Cfs. Nello stesso tempo si è accentuato quel processo di securizzazione e, più specificamente, di militarizzazione dell’apparato centrale dello stato nel campo della gestione delle risorse naturali proprio in un momento in cui sarebbe fondamentale avere una pubblica amministrazione che accompagni sul piano tecnico e amministrativo la gestione dei beni comuni, che privilegi la prevenzione sulla repressione, i rapporti di cooperazione e responsabilizzazione con i portatori di interesse sugli interventi securitari. Se questa strada, prepariamoci a molte altre estati di fuoco.

Anche nel cuore dell’Asia c’è il rischio di una guerra per il controllo dell’acqua. Alla base del conflitto: usi contrastanti (acqua per energia e irrigazione), un bene non disponibile omogeneamente e uno sfruttamento legato a interessi particolari. Internazionale, 25 Agosto 2017. (i.b)
Il 17 maggio del 2017 il ministro degli esteri del Tagikistan, Sirodjidin Aslov, è volato a Bruxelles per promuovere, di fronte a un gruppo di funzionari dell’Unione Europea, il progetto per la costruzione della centrale idroelettrica di Rogun, sul fiume Vachš. Ma per quale motivo l’Unione europea dovrebbe essere interessata a una centrale elettrica sulle remote montagne dell’Asia centrale? E perché mai un rappresentante del governo di Dušanbe si è recato fino in Belgio per ottenere il via libera alla realizzazione di un’infrastruttura nel suo paese?
Il punto è che questa banale iniziativa è in realtà la testimonianza del fatto che nel cuore dell’Asia i rischi di una guerra sono concreti. Non si può escludere, infatti, che le ex repubbliche sovietiche della regione possano entrare in conflitto per il controllo di una risorsa molto preziosa: l’acqua.
Irrigazione ed energia
Ormai da qualche tempo sia i mezzi d’informazione occidentali sia quelli dei paesi ex sovietici si occupano regolarmente del rischio, tutt’altro che remoto, di una guerra per l’acqua in Asia centrale. Non sono previsioni infondate, considerato che questa risorsa è distribuita tra i paesi della regione in modo estremamente disomogeneo.
L’alto corso dei fiumi che nascono nel territorio del Kirghizistan e del Tagikistan garantisce enormi riserve d’acqua. Ma più a valle, in Uzbekistan, Turkmenistan e Kazakistan, l’acqua non basta: il 77 per cento delle risorse idriche consumate dagli uzbechi arriva dall’estero, in Turkmenistan la percentuale supera il 90 per cento e in Kazakistan è il 40 per cento.
Le tensioni legate al controllo dell’acqua, che non hanno ancora raggiunto la fase più critica, sono cominciate subito dopo l’indipendenza delle cinque repubbliche sovietiche, nel 1991. Alla radice dei contrasti c’è il fatto che i fiumi possono essere sfruttati sia per l’irrigazione sia per produrre energia elettrica, e se l’acqua destinata a irrigare i campi è necessaria d’estate, i consumi di elettricità aumentano invece d’inverno, cosa che costringe le aziende energetiche a impiegare nella stagione fredda le risorse di cui avrebbero invece bisogno gli agricoltori con l’arrivo del caldo. In epoca sovietica la gestione centralizzata del settore idrico-energetico consentiva di agire nell’interesse di tutte le parti coinvolte, ma oggi i nuovi stati indipendenti nati dalla disgregazione dell’Unione Sovietica non riescono ad amministrare insieme le risorse.
Negli anni novanta il Kirghizistan e il Tagikistan approvarono progetti per la costruzione di grandi centrali idroelettriche sui fiumi che proseguono il loro corso in Uzbekistan. In Kirghizistan fu pianificata la realizzazione della centrale di Kambara tin 2, sul fiume Naryn; in Tagikistan fu invece varato il progetto della già citata centrale di Rogun, sul fiume Vachš. L’Uzbekistan considerò quei progetti come una minaccia alla sicurezza nazionale: le nuove dighe avrebbero infatti interrotto i lussi, lasciando i contadini uzbechi senz’acqua per l’irrigazione. Inoltre, cosa di cui rara mente si parla in modo esplicito, le dighe avrebbero costituto una gravissima minaccia per i centri abitati lungo il corso inferiore dei due fiumi: nel caso di un cedimento tecnico o di un attentato terroristico la violenza dell’acqua avrebbe distrutto tutto. Negli anni novanta il Tagikistan visse una guerra civile che oppose il governo agli estremisti islamici (ancora non del tutto sconfitti), mentre il Kirghizistan era un paese molto instabile, anche per gli standard postsovietici.
In questo contesto, per l’Uzbekistan i grandi progetti di Dušanbe e Biškek rappresentavano un rischio enorme. Da allora le cose non sono molto cambiate: Tagikistan e Kirghizistan sono paesi tuttora imprevedibili e potrebbero entrare in possesso di uno strumento per ricattare gli stati a valle. Per questo nel 2015 il presidente uzbeco di allora, Islam Karimov, dichiarò senza mezzi termini che i problemi idrici nella regione sarebbero potuti “peggiorare fino al punto di generare non solo gravi tensioni, ma perfino una guerra”. E aggiunse che la realizzazione della centrale di Kambaratin avrebbe dato un duro colpo alla produzione agricola dell’Uzbekistan, una delle principali voci d’esportazione del paese.
Il chiodo fisso
Nel marzo del 2016 il governo kirghiso ha constatato con preoccupazione che il tentativo di riprendere il controllo degli impianti lungo il confine aveva avuto come conseguenza un’intensificazione delle attività militari dell’Uzbekistan alla frontiera. Poco dopo i rapporti si sono ulteriormente inaspriti a causa della disputa sul controllo del bacino idrico di Kosonsoy, al confine tra i due paesi. Ad agosto sia il governo di Biškek sia quello di Taškent hanno inviato militari e poliziotti in questa striscia di terra la cui sovranità è ancora indefinita.
Nell’ottobre del 2016 il presidente del Tagikistan, Emomali Rahmon, si è messo alla guida di un bulldozer per gettare il primo carico di terra nelle acque del iume Vachš e inaugurare così la costruzione della centrale idroelettrica di Rogun. Secondo i suoi avversari, Rahmon si è potuto permettere un simile gesto simbolico solo dopo la morte, nel 2016, di Karimov, il presidente uzbeco considerato di fatto il patriarca dell’intero spazio postsovietico, che era sempre stato inflessibile nella difesa degli interessi di Taškent. Già nel 2009, infatti, Rahmon aveva costretto i cittadini tagichi ad acquistare azioni della centrale. Per Dušanbe il progetto è da tempo un chiodo fisso.
Nel frattempo il nuovo presidente uzbeco, Shavkat Mirziyoyev, ha dimostrato di non avere nessuna intenzione di cambiare la linea seguita di Karimov. Durante una visita ad Astana, a marzo, ha ribadito, insieme al presidente kazaco Nursultan Nazarbaev, che le risorse idriche sono un patrimonio comune di tutti i paesi della regione. La questione è di grande importanza anche per il Kazakistan, considerato che l’acqua consumata nel paese arriva non solo dall’Uzbekistan e dal Kirghizistan, ma anche dalla Cina. Le sorgenti dei fiumi Ili, Irtyš e Tekes, che riforniscono d’acqua alcune regioni del Kazakistan, si trovano infatti nel nordest della Cina, proprio l’area in cui Pechino negli ultimi tempi sta concentrando i suoi progetti di sviluppo. L’economia della regione autonoma dello Xinjiang, abitata dalla minoranza musulmana degli uiguri, ha grande bisogno d’acqua, che però nella zona scarseggia. L’Irtyš e l’Ili risentono già delle conseguenze dello sviluppo frenetico della regione, e la loro portata sta diminuendo. Il problema di questi fiumi è aggravato anche dal rapido scioglimento dei ghiacciai, legato al riscaldamento globale.
Secondo il sinologo russo Konstantin Syroežkin, il Kazakistan è in una posizione di debolezza nei negoziati con Pechino sulle risorse idriche. “Ha giocato tutti gli assi nella manica che aveva”, spiega. “Non gli rimane che fare aidamento sulla disponibilità dei cinesi”. Considerato che la Cina ha investito nell’economia kazaca tra i 24 e i 27 miliardi dollari, stando ai dati del 2016, per Astana non è facile aprire una disputa con Pechino. La Cina, tuttavia, ha importanti investimenti anche negli altri paesi della regione. Dopo la visita di Mirziyoyev, Cina e Uzbekistan hanno concluso un accordo del valore di 22 miliardi di dollari.
Durante il viaggio a Pechino, il presidente uzbeco ha partecipato anche al forum della nuova via della seta, cioè la strategia di Pechino per sviluppare nuovi collegamenti con i paesi dell’Eurasia e trovare un’alternativa alle rotte marittime tradizionali, che sarebbero vulnerabili in caso di un conflitto.
Ma la presenza della Cina nella regione può davvero contenere il rischio di una guerra per l’acqua? A giudicare dal tono degli esperti interrogati dai giornali occidentali, la risposta è no.
Riserve di stabilità
Come ha scritto alla fine del 2016 l’agenzia d’intelligence privata Stratfor, “l’Asia centrale sta consentendo alla Cina di sviluppare una rotta verso l’Europa più distante dai mari in cui sono presenti gli Stati Uniti. Se quindi la stabilità dell’Asia centrale dovesse crollare, per Pechino sarebbe un incubo. E le regioni confinanti diventerebbero un bacino di fuga per le organizzazioni separatiste armate”.
Alcuni anni fa gli esperti della Stratfor avevano anche previsto che nella regione centrosiatica le tensioni legate alla gestione dell’acqua non sarebbero finite presto. A gennaio del 2017, inoltre, un esperto della Harvard International Review, la rivista dell’università di Harvard, ha ammesso di essere “scettico sulla possibilità di risolvere i problemi dell’acqua nella regione, problemi che stanno assumendo dimensioni preoccupanti”. Secondo le sue previsioni, in futuro le dinamiche politiche della regione saranno dominate dal principio del “tanto peggio, tanto meglio”.
A marzo The Diplomat, una rivista online che ha la redazione a Tokyo, è arrivata a chiedersi in un articolo se le guerre per l’acqua possano mandare a monte i piani della Cina in Asia centrale. La risposta dell’autore è stata chiarissima: “Pechino deve prendere atto che sono ormai mature le condizioni per lo scoppio di conflitti e per una destabilizzazione della regione”. Oggi né i paesi dell’Asia centrale né le vicine Cina e Russia vogliono un conflitto nella regione. Tuttavia, come ha ricordato qualcuno parlando della vigilia della prima guerra mondiale, anche allora “nessuno voleva la guerra. Ma la guerra era inevitabile”.
Non si può escludere che alla fine le previsioni più catastrofistiche si riveleranno sbagliate. Una cosa è certa, però: nella regione le riserve di stabilità si stanno esaurendo.

«Défilé di politici, ricchi buffet e vecchie glorie in mostra, da Leonardo a Enrico Fermi. Eppure alla fiera internazionale in Kazakistan siamo l’unico Paese senza un progetto». la Repubblica, 28 agosto 2017 (p.d.)
Come trasformare un’esposizione universale sull’energia del futuro nell’Expo degli assessori. Se anche questo è genio italico, allora abbiamo fatto centro con la passerella interminabile di presidenti e vicepresidenti dei consigli regionali, membri delle giunte e funzionari locali, burocrati periferici con assistenti, collaboratori e portaborse. Chi impegnato a testimoniare l’esistenza di una improbabile «via toscana all’energia del futuro», chi a illustrare la strategia siciliana della «specializzazione intelligente», chi più modestamente a confidare nella scossa energetica di una mostra di acquerelli di paesaggi lucani di Fabrice Moireau. Ma si può star certi che nessuna Regione, delle 15 partecipanti, ha rinunciato alla scampagnata asiatica settimanale.
La prova del pasticcio che abbiamo combinato con il federalismo straccione partorito nel 2001 si trova a seimila chilometri da qui, in una città che venticinque anni fa neppure esisteva: Astana, attuale capitale del Kazakistan. Questo Paese è uno dei maggiori produttori di idrocarburi del mondo, ma per ragioni che vanno ben oltre tale aspetto ha avuto in carico l’organizzazione dell’Expo mondiale che ha per tema l’energia del futuro. Tre miliardi di dollari investiti in una formidabile operazione di propaganda interna per una repubblica grande dieci volte l’Italia, che ha seguito il destino di altri pezzi dell’Asia centrale dopo la dissoluzione dell’Urss. Il potere è rimasto da trent’anni nelle mani della stessa persona, con relativi strascichi familiari. Nursultan Nazarbayev era il segretario del partito comunista prima del crollo dell’Urss, ed è presidente ininterottamente da 27 anni. L’aeroporto di Astana porta il suo nome. Come il Museo e l’Università. C’è perfino una banca che sembra ispirarsi al nome del leader: Nurbank. La nuova capitale l’ha fondata lui, nel cuore della steppa asiatica. Quella di prima, Almaty, nata nel 1854, era troppo vicina al confine della Cina. Dal 2010, per decisione del parlamento da lui controllato, Nazarbayev ha l’appellativo di padre della nazione, che lo ha trasformato in intoccabile, garantendogli l’immunità giudiziaria perpetua. L’ultima volta è stato riconfermato con il 96 per cento dei voti e uno dei suoi (tre) avversari alle elezioni ha dichiarato di aver votato per lui. L’opposizione semplicemente non esiste. Le procedure sovietiche, invece, sono tuttora pienamente in auge nonostante l’invasione del wifi gratuito e strade immense stracolme di immensi suv Toyota con qualche Ferrari che sfreccia di tanto in tanto.
Maturati nel decennio berlusconiano segnato dalle solide amicizie del Cavaliere con certi residui dittatoriali dell’ex impero sovietico, tipo quel Lukashenko che comanda in Bielorussia dal 1994, i rapporti fra Italia e Kazakistan non potrebbero essere migliori. L’Eni coltiva da anni interessi enormi. E fino allo scorso anno avevamo il primato del commercio con i kazaki, che ora hanno i russi. Ed è qui che la storia dell’Expo prende una piega ben diversa dalle premesse. Intanto i soldi. Dallo Stato italiano arrivano un paio di milioncini, lordi, in tutto. Briciole, in confronto alle risorse messe in campo dagli altri. Non parliamo del Kazakistan, o della Cina, oppure della Russia. Ma di Francia, Germania, Giappone, Israele, Corea… E poi i tempi con l’acqua alla gola, un classico italiano. Il commissario Stefano Ravagnan, l’ambasciatore italiano, e il suo vice Salvatore Parano, responsabile dell’ufficio Ice, fanno letteralmente i salti mortali e riescono a far quadrare il cerchio. Tanto che il padiglione italiano, a due settimane dalla chiusura dell’Expo, è uno dei più frequentati. Gli ambienti disegnati da Paolo Desideri, piacevoli e accoglienti. Lo stile, al livello made in Italy. L’organizzazione, impeccabile.
Una specie di miracolo, insomma. Che tuttavia non risolve il problema di fondo. Qui ogni Paese avrebbe dovuto presentare la propria idea per l’energia del futuro. La Cina, per esempio, dichiara apertamente di puntare sulla fusione nucleare. Idem la Francia. La Russia di Vladimir Putin espone ad Astana un enorme pezzo di iceberg: la sua strategia è senza infingimenti per lo sfruttamento delle risorse petrolifere artiche. La Corea investe sull’intera gamma delle energie alternative. E dopo Fukushima anche il Giappone ha voltato pagina. La Germania, dove Angela Merkel ha decretato che entro il 2050 l’energia sarà prodotta solo da fonti rinnovabili, scommette sull’efficienza. Perfino il Kazakistan si interroga sul superamento dei combustibili fossili. E l’Italia? L’Italia mette in bella mostra Duomo di Milano, Torre di Pisa, Fontana di Trevi e piazza San Marco. Tutto magnifico. Peccato solo che manchi l’idea. Semplicemente perché quella idea non c’è.
Intendiamoci, non che altri Paesi abbiano poi fatto tanto meglio. Il padiglione dell’India, per dirne una, sfocia in un mercatino di bigiotterie. Ma da Astana giunge implacabile il messaggio che siamo l’unico Paese del mondo sviluppato a non avere un preciso disegno di politica energetica. Per legge. Lo abbiamo deciso nel 2001 con la riforma del titolo V voluta dal centrosinistra che per inseguire le spinte leghiste ha devoluto troppi poteri alle regioni. Compreso questo: «produzione, distribuzione e trasporto dell’energia». Una prerogativa insensata. Ma impossibile da mettere in discussione, dopo la bocciatura del referendum costituzionale che l’avrebbe riportata in capo allo Stato.
Inutile allora stupirsi se anziché un grande progetto italiano, che non esiste, all’Expo sull’energia ci presentiamo con mandrie di assessori e buffet di prodotti tipici regionali come intermezzo fra le foto di una turbina piemontese e le immagini di un campo eolico siciliano. Mentre le pubblicazioni specialistiche titolano trionfanti: «L’Umbria sbarca ad Astana 2017», «La Liguria protagonista all’Expo di Astana», «Astana Expo, ecco le eccellenze laziali ». E via di questo passo. Soltanto Valle D’Aosta, Abruzzo, Molise, Calabria e Trentino Alto Adige si sono chiamate fuori da questa giostra grottesca e ben più costosa dei 10 mila euro di contributo iniziale uguale per tutti. Ad Astana financo la Confindustria è regionale: Assolombarda.
E siccome un’idea nazionale non c’è, la soluzione per dare un’immagine comunque italiana è l’armamentario delle care vecchie glorie. Antonio Pacinotti, Alessandro Volta, Enrico Fermi, Leonardo da Vinci… L’Eni proietta un filmato su Enrico Mattei, l’uomo che ebbe il coraggio di contrastare le Sette Sorelle e ci lasciò la pelle. Mentre fuori dal padiglione un giovane artista che ha fatto la scuola di Brera, Ottavio Mangiarini, ha la fila incessante di chi vuole il ritratto. Ed è forse l’attrazione più sorprendente. Del resto i visitatori non sono quasi tutte famiglie locali, comitive e scolaresche? Già. Ma siamo sempre l’Italia, ed essere qui è obbligatorio. Anche perché le imprese italiane fanno un sacco di affari. Chiedere per conferma al ragionier Giuseppe Bergamin, la cui azienda veneta Sunglass ha fornito i vetri curvi per l’immensa sfera di cristallo del padiglione kazako. Ragion per cui se c’è qualcuno che con questa storia porta a casa qualcosa di concreto è soprattutto lui.

«Il presidente liberalizza un’enorme riserva istituita ai tempi della dittatura con giacimenti d’oro, rame e ferro». il Fatto Quotidiano, 27 agosto 2017 (p.d.)
Non è stata certamente una bella settimana per i difensori dell'ambiente in Brasile, dove un’area della foresta amazzonica superiore al territorio della Danimarca sarà presto ceduta a multinazionali dell’industria mineraria e affamati broker della finanza, i quali sfrutteranno giacimenti d’oro, manganese, rame e ferro celati tra gli Stati del Pará e dell’Amapá. Non finisce qui. Mercoledì, nello stesso giorno in cui Temer dava un ’altra spallata alla distruzione dell'Amazzonia, firmando il decreto con cui liberalizzava lo sfruttamento minerario nell’area, il Supremo tribunale federale ha votato a favore della continuazione dell'uso dell'amianto, nonostante il minerale sia considerato cancerogeno in più di 60 Paesi del mondo.
L’amianto continua a essere prodotto da 16 aziende multinazionali in Brasile, inclusa l'Eternit (assolta due anni fa in Italia a Torino, per prescrizione, ma ancora sotto processo per omicidio colposo nel processo “Eternit bis”), che produce tetti e rivestimenti usati nelle sterminate e popolose favelas brasiliane.
Le grandi imprese d’estrazione mineraria internazionali - soprattutto nordamericane, canadesi, australiane e sudafricane - hanno estremo interesse a sfruttare i giacimenti all’interno dell’area di 46.450 chilometri quadrati che circoscrive l’estinta Riserva Nacional de Cobre e Associados, creata nel 1984 durante la dittatura militare. Nel suo perimetro esistono nove aree di biodiversità considerate uniche al mondo. Le zone di preservazione sono il Parco nazionale delle montagne del Tumucumaque, le foreste statali del Paru e di Amapá, la riserva biologica di Maicuru, la stazione ecologica del Jari, la riserva estrattiva del Rio Cajari, la riserva di sviluppo sostenibile del Rio Iratapuru e le terre indigene Waiãpi Aparai e Wayana.
Le organizzazioni ambientaliste, come il Wwf, ma anche intellettuali e artisti mobilitatisi contro il decreto Temer, sostengono che la liberalizzazione dell’attività mineraria nell’area causerà danni irreversibili all'ambiente e alla popolazione indigena. “Il decreto è il maggiore attacco all’Amazzonia negli ultimi cinquant’anni. Né la dittatura militare ha osato tanto, né la Transamazzonica è stata così offensiva”, ha affermato il senatore Randolfe Rodrigues che ha presentato un’iniziativa popolare contro il decreto alla giustizia di Amapá. Nuove strade saranno tracciate, facilitando l’esodo di migliaia di lavoratori disoccupati a causa della recessione brasiliana che ha eliminato 14 milioni di posti di lavoro.
Il decreto Temer giunge dopo altri recentemente firmati dal presidente, che ha chiaramente negoziato con i deputati in cambio della sua assoluzione nella votazione per la richiesta d’impeachment avvenuta contro di lui il 3 agosto a Brasilia. Il 60 per cento dei deputati e senatori del governo, secondo la Ong Trasparencia Brasil, sono accusati a vario titolo di corruzione, broglio elettorale, omicidio e sequestro.
Alla Camera e al Senato è tracciata in modo chiaro la presenza della lobby dell’industria mineraria, dell’agrobusiness ed evangelica. Sono settori dichiaratamente contrari alla causa dell’ambiente, degli indigeni e dei quilombo (comunità di origini africane) e hanno guadagnato ulteriormente potere negli ultimi anni di grande kermesse delle rinomate alleanze politiche. Le lobby sono compatte tra loro e possiedono un potere economico fortissimo, con cui dominano la politica nazionale.
Le imprese produttrici di amianto finanziano tutti i partiti politici in occasione di ogni campagna elettorale, e l’ultima raffica di decreti è parte di un più ampio pacchetto di iniziative nel settore dello sfruttamento minerario che il governo del presidente Temer porta avanti nell'ambito del “Programma di rivitalizzazione dell’industria mineraria brasiliana”, il quale include anche la creazione della Agência Nacional de Mineração. In sostanza, l'ambiente e le riserve indigene sono oggi la moneta di scambio impiegata dai politici, non solo per salvarsi da processi giudiziari, ma soprattutto per gratificare i loro padrini, multinazionali e latifondisti, che sfruttano la recessione per impadronirsi dei territori federali e riserve indigene dove sono presenti giacimenti minerari.
Nessuna anomalia sismica, le responsabilità sono tutte umane. il Fatto Quotidiano, 23 agosto 2017 (p.d.)
Niente di nuovo, anche dal punto di vista geologico, all’ombra del monte Epomeo, la sommità del grande vulcano sottomarino su cui si è moltiplicata la caotica edilizia ischitana. La zona è stata scossa ancora una volta da un’inquietudine antica che non ha molto a che spartire con gli altri due grandi “osservati speciali” dell’area partenopea, il Vesuvio e il supervulcano dei Campi Flegrei, osserva Carlo Meletti, responsabile del centro di pericolosità sismica dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia che segnala: “Terremoti di questa intensità ne capitano in Italia decine l’anno e non fanno questi danni”.
Ischia si trova sulla sommità emersa di un vulcano spento da millenni, è il segnale che si sta risvegliando?
Non è magma che sta risalendo verso la superficie, quello che ha scosso l’isola il 21 agosto. Ischia è sotto monitoraggio continuo e non si segnala nessuna ripresa dell’attività eruttiva, a scuotere la terra e il fondo marino è stato un sisma di natura tettonica scatenato da una faglia che si è rotta a nord dell’isola e molto in superficie.
È stato un fenomeno anomalo rispetto alla storia sismica dell’isola?
No, è molto simile ai terremoti avvertiti in passato, almeno dal 1200 in poi; lo stesso sisma del 1883, che ha causato la distruzione della cittadina di Casamicciola e oltre 2 mila morti, non aveva una magnitudo molto più elevata di quello dell’altro ieri ed era anch’esso molto concentrato nella stessa zona.
Il terremoto di Ischia c’entra qualcosa con i movimenti dei Campi Flegrei che in quste settimane hanno rimesso in allerta vulcanologi e protezione civile?
No, l’ultimo terremoto non è collegato a quei fenomeni e non si registra nessuna anomalia: tutta la zona è sotto un monitoraggio capillare, l’osservatorio vesuviano è dotato di strumenti di tutti i tipi per cogliere anche la minima ripresa dell’attività vulcanica e recentemente abbiamo rivisto e aggiornato tutti i piani di intervento con la Protezione civile che riguardano i tre vulcani della zona.
Ma allora che tipo di terremoto ha colpito Ischia?
Rientra nella tipologia dei terremoti che si verificano in una zona vulcanica: sono molto superficiali e hanno un impatto maggiore e circoscritto intorno all’epicentro, basti pensare che a sud di Ischia non si è avvertito nulla; poi molto dipende dalla struttura geologica, se i terreni sono sciolti, di consistenza sabbiosa e argillosa, possono amplificare l’onda sismica. Casamicciola è costruita su una grande frana che prosegue anche in mare, non su rocce compatte e anche se la magnitudine è stata abbastanza contenuta lo scuotimento prodotto sull’isola è stato molto forte.
La magnitudo allora non basta a spiegare tutto.
Gli effetti del sisma non dipendono solo dall’in tensità: oltre alla natura del terreno su cui sono state costruite le case, bisogna considerare anche la qualità edilizia, come abbiamo visto ne crollano alcune ma non tutte.
Ieri si è scatenato un piccolo giallo sulle misurazioni dell’intensità della prima scossa: l’Ingv ha fornito in sequenza tre valori diversi.
Non c’è stata nessuna approssimazione o inesattezza da parte dei tecnici dell’istituto, sono semplicemente stime diverse fatte in momenti e con parametri diversi: il primo valore, 3,6 sulla scala Richter, è stato rilevato in automatico al momento della prima scossa dalla sala sismica di Roma; la seconda, di grado 4, è stata definita con un’altra scala più dettagliata basata anche sulla durata, più significativa per le zone vulcaniche e usando i dati dell’osservatorio vesuviano che tengono conto anche della struttura del sottosuolo; adesso stiamo applicando un’altra misurazione ancora più raffinata, la cosiddetta “magnitudine momento” utilizzando i parametri applicati per i terremoti molto forti, tenendo conto della saturazione delle stazioni di rivelazione più vicine e analizzando tutta la traccia; con questo ultimo calcolo abbiamo definito una magnitudo che rimane compresa tra il 3,8 e il 4.
Anche i sismografi dell’agenzia degli Stati Uniti hanno registrato un picco diverso, 4,3 gradi.
Gli americani rilevano le scosse con sismografi lontani e con modelli della crosta terrestre standardizzati per tutto il pianeta, ma non sono i decimali in più o in meno che contano: in Italia registriamo ogni anno decine di terremoti di magnitudo 4, la differenza è l’effetto che scatenano da un territorio all’altro e qui ha fatto morti e feriti.
«Un danno ambientale di almeno 1,5 miliardi di euro: 300 ettari di terreno inquinato, 25 mila abitanti coinvolti. Per quasi vent'anni la produzione è andata avanti nonostante i documenti interni avessero lanciato l'allarme». L'Espresso online, 17 agosto 2017 (p.d.)
Più di 20 mila documenti dell'industria dei veleni. Note riservate, lettere interne, verbali di riunioni e studi scientifici che mostrano le avanzate conoscenze che i grandi gruppi della chimica mondiale, dalla Monsanto alla DuPont, dalla Union Carbide alla Dow, avevano a disposizione già negli anni ‘70 sulla tossicità di erbicidi, pesticidi e composti chimici. Li hanno chiamati
"The Poison papers", le “carte dei veleni”. Un vasto archivio formatosi negli anni grazie alle richieste inoltrate alle agenzie federali statunitensi e alle cause intentate contro le industrie chimiche, raccolto dalla scrittrice e attivista Carol Van Strum e pubblicato dal Bioscience Resource Project e dal Center for Media and Democracy. E da questa immensa mole di documenti, che risalgono fino agli anni '20, emergono i primi risvolti italiani.
Basta seguire la storia dei Pcb, i policlorobifenili, composti brevettati nei primi anni '30 dalla Monsanto, per arrivare a una fabbrica chimica alle porte di una laboriosa città del nord Italia. Alcune note confidenziali della Monsanto rivelano che anche la società che ha prodotto quelle sostanze in Italia tra il 1938 al 1984 grazie a un brevetto della Monsanto, la Caffaro di Brescia, era stata informata da tempo dagli americani della pericolosità dei Pcb usati fino agli anni '80 dall'industria elettrica come isolanti nei trasformatori. Almeno tre documenti riferiscono gli esiti di incontri riservati avvenuti all'inizio degli anni ‘70 in Europa tra gli statunitensi e gli altri produttori europei di Pcb, tra cui la Caffaro, per discutere l'opportunità di abbandonare quelle sostanze di cui ormai si conosceva ampiamente la dannosità. Come diverrà di pubblico dominio solo anni dopo, i Pcb sono inquinanti organici persistenti e cancerogeni tra i più pericolosi insieme alle diossine.
Stando alle minute della Monsanto, la Caffaro partecipò nel febbraio e nel maggio del 1970 a due incontri riservati a Francoforte e a Bruxelles, insieme alla tedesca Bayer e alla francese Prodelec sul problema ambientale del Pcb. Ma anziché lavorare per la dismissione della produzione e la riconversione industriale, decise di proseguire come se niente fosse: «Il 9 e 10 febbraio si è tenuta a Francoforte una riunione speciale - si legge in un documento confidenziale del 9 marzo '70 firmato da H. A. Vodden - per discutere il problema dei Pcb nell'ambiente. Pare non vi sia ancora preoccupazione pubblica in Germania, Francia o Italia».
Mentre i tedeschi della Bayer temono ripercussioni internazionali e sembrano voler correre ai ripari, l'azienda francese e quella italiana non vogliono sentir ragioni: «La Prodelec e la Caffaro - prosegue Vodden - non hanno ancora cominciato alcun lavoro su questo tema e il loro principale contributo pare sia stato sollecitare la bonifica, in particolare degli askarel dei trasformatori».
Alla fine, nel piano d'azione predisposto dalla Monsanto viene annotata la decisione: «Scambio di informazioni con Bayer, Prodelec e Caffaro come stabilito». Già nel 1970 dunque la Caffaro aveva avuto accesso agli studi statunitensi sulla dannosità per l'uomo e per l'ambiente dei Pcb, e scambiava informazioni privilegiate con gli altri produttori europei e con la “casa madre” americana.
Un secondo incontro, sempre tra Monsanto, Prodelec, Bayer e Caffaro, si sarebbe svolto poi a Bruxelles il 14 maggio 1970. Pochi mesi dopo Monsanto, nel fare il punto sulla necessità di riformulare i suoi prodotti escludendo i Pcb, sottolineava ancora una volta la linea degli italiani: «Progil/Caffaro non sono ancora d'accordo - è riportato in un documento dell'8 dicembre '70 firmato W. B. Papageorge - e vogliono studiare ulteriormente la questione. Abbiamo invitato i loro rappresentanti a Ruabon per una discussione tecnica».
Nonostante l'attenzione riservata alla pericolosità dei Pcb, anche negli Usa la produzione si è protratta fino al 1977, dunque ben otto anni dopo la pubblicazione del primo documento interno dell'11 ottobre del 1969 - il Monsanto Pollution Abatement Plan - in cui il gruppo chimico cominciava a discutere la necessità di mettere al bando quelle sostanze a causa dei rischi ambientali, sanitari e finanziari che avrebbero potuto travolgere l'azienda.
In Italia, invece, la produzione di “Fenclor” (una delle denominazioni commerciali del Pcb della Caffaro) è proseguita per altri 15 anni, fino al 1984, provocando a Brescia un danno ambientale che il Ministero dell'Ambiente oggi stima in almeno 1,5 miliardi di euro: 300 ettari di terreno inquinato, 25 mila abitanti coinvolti, 10 kg al giorno di Pcb fuoriusciti dallo scarico della fabbrica secondo le stime dello storico Marino Ruzzenenti, che con la sua ricerca Un secolo di cloro…e Pcb nel 2001 fece esplodere il caso del grave inquinamento nella città lombarda.
Dal 2002, una vasta area a sud del centro storico della città di Brescia a valle dello stabilimento Caffaro è stata inserita tra i Siti inquinati di interesse nazionale in base a un decreto del Ministero dell'Ambiente. Interi quartieri sono colpiti da allora da un'ordinanza del sindaco che vieta di coltivare orti, asportare il terreno, far giocare liberamente i bambini nei parchi pubblici e nei cortili delle scuole.
Gli ultimi studi confermano che i livelli di Pcb nel sanguesia della popolazione di Brescia esposta che di quella non esposta direttamente agli inquinanti sono tra i più elevati al mondo. E sul fronte sanitario, lo studio Sentieri coordinato dall'Istituto Superiore di Sanità nel 2014 ha riscontrato un aumento dell'incidenza di alcuni tumori correlati al Pcb: i melanomi cutanei (uomini +27 per cento, donne +19 per cento), i linfomi non-Hodgkin (uomini +14 per cento, donne +25 per cento) e i tumori della mammella (donne + 25 per cento).
Non è dato sapere se il consiglio di amministrazione della Caffaro dell'epoca fu informato degli incontri riservati di Francoforte e Bruxelles con la Monsanto della primavera del '70 riportati nell'archivio Usa. All'inizio degli anni '70 e fino all'84 la Caffaro era di proprietà degli azionisti Mediobanca, Pechiney-Ugine-Kuhlmann, Finanziaria Pas, gruppo Oronzo De Nora, Feltrinelli, Loro e il Cda - allora presieduto da Gianbattista Loro, consigliere delegato Paolo Fontana - potrebbe anche essere stato tenuto all'oscuro sui dettagli del dibattito scientifico e strategico sulla dannosità dei policlorobifenili.
Di certo la produzione di Pcb assicurò alla proprietà importanti profitti: secondo le relazioni di Mediobanca sulle società quotate in borsa, il fatturato della Caffaro aumentò dai 13 miliardi e 134 milioni di vecchie lire del '69 ai 54 miliardi e 450 milioni del '77, i dividendi da 324 a 608 milioni.
Nel frattempo sono passati più di 33 anni dalla dismissione dell'impianto dei Pcb alla Caffaro, ma nessuno è stato condannato in sede penale né in quella civile per l'inquinamento e nessuna bonifica è stata ancora avviata, eccezion fatta per la messa in sicurezza di un parco pubblico e dei giardini di due scuole comunali. E mentre negli Usa lo stato di Washington nel 2016 ha citato in giudizio la Monsanto per l'inquinamento da policlorobifenili, trascinandola in una causa che potrebbe costare alla multinazionale diversi miliardi di dollari, in Italia dall'entrata in vigore della legge Merli nel ‘76 nessun governo ha stabilito i limiti per lo scarico di Pcb nei corpi idrici superficiali (rogge, fiumi e laghi).
E così la Caffaro, fallita nel 2010, continua ad inquinare: dallo scarico dello stabilimento, da dove vengono emunti e filtrati costantemente milioni di metri cubi d'acqua, secondo l'Agenzia regionale per l'ambiente continuano ad uscire circa 2 etti di Pcb all'anno.

«Equazione Secondo gli scienziati le temperature saliranno costantemente provocando sempre più profughi ambientali». il Fatto Quotidiano, 9 agosto 2017 (p.d.)
Emissioni: questa è la parola chiave da cui dipende il nostro futuro, anzi la nostra stessa sopravvivenza. Lo dicono le 545 pagine dello studio statunitense – studio che rientra nel National Climate Assessment, la valutazione sul clima richiesta dal Congresso ogni 4 anni – redatto da 13 agenzie federali che si occupano di cambiamento climatico e pubblicato ieri, ancora sotto forma di bozza, dal New York Times”, nel timore che Trump possa insabbiarne le conclusioni. Conclusioni che affermano con certezza che gli effetti del cambiamento climatico, di cui è causa sicura e diretta l’uomo, sono già reali, visto che le temperature medie negli Usa hanno toccato il loro livello più alto da 1.500 anni, con un aumento di 0,9 gradi dal 1880 al 2015 e che potrebbe arrivare, se non si riducono radicalmente le emissioni, a superare i 2 gradi entro fine secolo, con conseguenti ondate di calore sempre più intense alternate a violente tempeste di pioggia.
Mentre tutto tace sia dalla Casa Bianca – colpevole della scelerata decisione di uscire dagli accordi di Parigi - che dalla governativa Environmental Protection Agency, alla cui direzione Trump ha messo un negazionista del legame tra cambiamento climatico ed emissioni, in Italia è partita da pochi giorni la consultazione pubblica avviata dal ministero dell’Ambiente sulla prima stesura del Piano Nazionale di Adattamento ai Cambiamenti climatici, elaborato con il coordinamento del Centro Euro-Mediterraneo sui Cambiamenti Climatici (Cmcc), che terminerà in ottobre. “Abbiamo diviso l’Italia in macro aree che hanno risposte simili agli impatti del cambiamento climatico”, spiega Paola Mercogliano, studiosa del Cira (Italian Aerospace Research Center) e del Cmcc. “E stabilito per ciascuna area delle priorità in termini di adattamento, suggerendo misure che i politici dovrebbero mettere in pratica a livello locale”.
Ma quali saranno le conseguenze concrete sulle nostre vite? Una risposta esatta, in questa estate angosciosamente torrida, purtroppo non c’è. Perché gli scienziati del clima lavorano su modelli matematici che si basano su ipotesi di emissioni dei gas serra. Ma non sapendo effettivamente se queste ultime verranno ridotte o meno, non possono dare risposte certe, “anche se la tendenza all’aumento delle temperatura legata ai gas serra è chiarissima”, spiega Mercogliano.
Uno scenario realistico – nel quale ci siano misure di contrasto, ma non radicali, alle emissioni, insomma non si spengano tutte le fabbriche ma neanche si faccia nulla – prevede che nel periodo tra il 2020 e il 2050 le temperature in Italia subiranno un aumento di 1,5-2 gradi, le precipitazioni d’estate una diminuzione del 22% (con picchi del 24% al Sud), mentre i giorni con una temperatura massima superiore ai 29 gradi saranno 9 in più per ogni estate, e 20 dal 2050 in poi. La pioggia aumenterà invece dell’8% in autunno (11% al sud), il che vuol dire che “l’acqua va ottimizzata il più possibile nei mesi in cui c’è”. “Quello che possiamo vedere”, spiega a sua volta Silvio Gualdi, direttore della divisione Climate Simulation and Prediction del Cmcc, “è che eventi considerati finora statisticamente estremi, cioè rari, stanno diventando sempre più frequenti e in futuro potrebbero diventare la normalità”. Siamo dunque costretti a subire le conseguenze di un riscaldamento inarrestabile? “Assolutamente no. Da un lato”, continua Gualdi, “servono politiche di adattamento che cerchino di ridurre gli impatti che i cambiamenti hanno sulla nostra salute, ma anche sulle attività economiche e sugli ecosistemi in generale. Dall’altro, però, esiste un livello di cambiamento più radicale che avrà dei costi difficili da sostenere come il ritorno al carbone”.
In conclusione si può parlare o no di probabile desertificazione dell’Italia e di possibili, preoccupanti, migrazioni a causa del clima? “Più che di desertificazione”, chiarisce Mercogliano, “parlerei di tropicalizzazione del bacino del Mediterraneo, con tanta eventi anche violenti di pioggia localizzata e una diminuzione delle piogge medie. Quanto alle migrazioni, i cambiamenti climatici sono certamente un acceleratore di crisi, ma al momento soprattutto per i paesi di provenienza degli attuali migranti. Fondamentale, comunque, è aumentare i soldi per la ricerca, che oggi può dire anche in che modo le città andrebbero pianificate in relazione al clima”, sostiene Gualdi. “Gli scienziati, comunque, hanno il compito non tanto di orientare direttamente le decisioni ma quello di fornire tutte le conoscenze adeguate perché chi decide lo faccia a partire da informazioni fondate. Per fortuna negazionisti non ce ne sono: la comunità scientifica è ormai compatta nel ritenere che il cambiamento climatico va affrontato subito. E seriamente”.

Interessi economici e ostilità verso la prevenzione. E dabbenaggine. Articoli di Marco Bersani da il manifesto e Luca Mercalli da il Fatto Quotidiano, 25 luglio 2017 (p.d.)
il manifesto
IL FALLIMENTO
DELL'ACQUA PRIVATIZZATA
di Marco Bersani
Dentro l’Italia che brucia, dentro l’agricoltura sfiancata dalla siccità, nel disastro ambientale del lago di Bracciano e del possibile razionamento dell’acqua a Roma Capitale, spiace dover dire ancora una volta «i movimenti l’avevano detto». Ma, per quanto frustrante, è la pura verità. Le dichiarazioni dei politici ai telegiornali, le dissertazioni degli opinionisti nei talk show, le roboanti tabelle degli amministratori delegati delle società privatizzate di gestione dell’acqua si inseguono tra loro, compiendo una consapevole rimozione su un nodo di fondo: l’acqua, bene comune naturale, essenziale alla sopravvivenza delle persone, non può essere gestito, se non tenendo conto dell’interesse generale e della conservazione del bene per le generazioni future.
Siamo da tempo immersi nella drammaticità di cambiamenti climatici in corso, le cui conseguenze peseranno per decenni a venire, eppure periodicamente ci si stupisce del fatto che le stagioni non siano più quelle di una volta e il binomio siccità/alluvioni non sia più un evento straordinario, bensì una nuova normalità con cui dover fare i conti e che solo con adeguata prevenzione può essere affrontata. Con buona pace degli sviluppisti, l’acqua è una risorsa limitata e la natura ha tempi di rigenerazione che non possono essere accelerati: per questo, quando i nodi vengono al pettine, non è possibile affidarne la soluzione al libero conflitto degli interessi particolari e meno che mai agli interessi privatistici di chi dell’acqua ha fatto il nuovo business su cui riprendere l’accumulazione finanziaria. Il fatto è che il modello liberista ha modificato i concetti di spazio e tempo: allargando esponenzialmente il primo, fino a voler fare del pianeta un unico grande mercato, e riducendo esponenzialmente il secondo, fino a farlo coincidere con gli indici di Borsa del giorno successivo.
Occorre aver chiaro come su queste basi nessuna soluzione sia possibile. L’acqua non può essere gestita dal mercato e il mercato dev’essere escluso dall’acqua: questo hanno detto oltre 27 milioni di cittadini nel referendum del giugno 2011 e la mancata attuazione di quella decisione sovrana pesa come un macigno tanto sui drammatici accadimenti di questi giorni, quanto sulla crisi della democrazia, oggi segnata da una crescente disaffezione popolare. In venti anni di privatizzazioni della gestione dell’acqua, gli investimenti sono crollati a un terzo di quelli fatti dalle precedenti società municipalizzate, la qualità del lavoro e dei servizi offerti é nettamente peggiorata e le tariffe sono aumentate senza soluzione di continuità. In compenso, sono saliti esponenzialmente i dividendi degli azionisti, cui tutti gli utili vengono destinati, anziché essere reinvestiti nel miglioramento di infrastrutture a dir poco obsolete.
E’ possibile invertire la rotta? Certo che sì, a patto che tornino al centro l’interesse generale e il diritto al futuro per tutte e tutti. Un intervento pubblico sul dissesto idrogeologico dei nostri territori e un piano per il riammodernamento delle reti idriche costerebbero complessivamente 15 miliardi e produrrebbero 200.000 posti di lavoro pulito e socialmente utile. «Non ci sono i soldi», ripete il mantra liberista, ma intanto sono 17 i miliardi messi a disposizione per regalare Banca Popolare di Vicenza e Veneto Banca al colosso IntesaSampaolo, che produrrà 4000 esuberi. Da qualsiasi punto la si voglia affrontare, è un problema di volontà politica: possiamo continuare a tollerare che siano i vincoli finanziari dell’Unione Europea e la trappola del debito a determinare le scelte politiche collettive o vogliamo mettere finalmente il diritto alla vita, alla dignità e al futuro al primo posto?
Nello specifico: cosa aspetta il Parlamento a legiferare contro il consumo di suolo, per un grande piano di intervento sul dissesto idrogeologico e di intervento sulle infrastrutture idriche? Cosa aspetta per rendere operativa la volontà popolare espressa nei referendum per l’acqua del giugno 2011, sottraendo la gestione dell’acqua e dei beni comuni dalle leggi del mercato? E ancora: quanto tempo dovrà passare prima che la sindaca di Roma avvii in forma partecipativa la ripubblicizzazione del servizio idrico, togliendolo dagli interessi dei Caltagirone e di Suez? O che la Regione Lazio approvi i decreti attuativi di una legge d’iniziativa popolare approvata ormai tre anni or sono? Questi sono i fatti che possono determinare la necessaria inversione di rotta, il resto sono lacrime di coccodrillo o l’ennesima attestazione di complicità con gli interessi finanziari in gioco.
il Fatto Quotidiano
OGGI C’È LA SICCITÀ,
DOMANI LE ALLUVIONI
di Luca Mercalli
Siamo un Paese ostile alla prevenzione. Solo quando l’emergenza ci mette con le spalle al muro affrontiamo la realtà, spesso pure con solidarietà e fantasia, ma appena passato il dolore acuto torniamo in uno stato di indifferente apatia di indolente fatalismo fino alla crisi successiva. E che con l’acqua di crisi ci sia da attendersene continuamente lo si sa almeno dall’epoca degli antichi egizi: siccità e alluvioni costellano le cronache di ogni civiltà. Solo che per millenni si è preso ciò che il cielo dispensava, subendolo e attribuendolo a castigo divino, mentre da un paio di secoli la scienza ha compreso le dinamiche idrologiche e con l’aiuto di meteorologia, climatologia, geomorfologia e idraulica oggi dispone di una capacità previsionale utile a prepararsi al futuro. Ammesso che questo sapere venga utilizzato e non messo in un cassetto, limitandosi a predare i beni comuni con improvvisazione, pigrizia, sovrasfruttamento. Ed è così che in Italia vuoi quando si contano i morti nel fango delle inondazioni, vuoi quando si cercano affannose soluzioni alla penuria d’acqua, il copione è sempre lo stesso: un po’ di cronaca vera “ha avuto paura?”, “rinuncerà all’idromassaggio?”, “mai successo a memoria d’uomo!”, seguita da banali polemiche, ricerca del responsabile diretto da additare alla magistratura (nel tentativo di trovare cause semplici a problemi complessi), e qualche analisi più vasta del problema. Tre giorni, poi tutto finisce e si torna al solito chiacchiericcio politico di fondo che spesso poco ha a che fare con le questioni davvero strategiche per il nostro futuro.
E invece è proprio sulle analisi più ampie dei problemi che tocca soffermarsi, approfondire, pianificare, legiferare, agire. Quando parliamo di acqua, risolta l’emergenza dei soccorsi, tutto si basa su un’accurata preparazione in tempo di pace: formazione della cittadinanza, che ignora completamente tanto i manuali di protezione civile quanto le basi del ciclo dell’acqua, più importante delle oscillazioni del Pil, e lavoro capillare sulle infrastrutture idriche. Sappiamo bene che gli acquedotti d’Italia fanno acqua da tutti i tubi: 38 per cento sono le perdite medie nazionali secondo Istat, ma a Milano sono il 16 per cento, a Roma il 43, a Bari il 50, a Potenza il 64 per cento. E copiare da chi fa meglio, no eh? Ci sono società di servizi idrici come quella di Torino che da anni si preoccupano dei cambiamenti climatici e investono in infrastrutture idrauliche di accumulo,ben sapendo che dovranno servirsene nei prossimi anni, via via che la temperatura e le siccità aumenteranno. Sono tutte cose scritte anche nella Strategia di Adattamento ai Cambiamenti Climatici del Ministero dell’Ambiente, abbiamo i dati, abbiamo le competenze, abbiamo anche esempi di eccellenza già funzionanti, dobbiamo solo applicarli in un quadro coerente e univoco su tutto il territorio nazionale. Invece ciò non avviene, anche perché molti servizi tecnici nazionali di antica data, che avevano doveri e capacità per armonizzare la gestione dell’acqua sono stati sistematicamente smantellati, riaperti sotto altro nome, richiusi, frammentati, a colpi di leggi e decreti sempre più ravvicinati che hanno generato una giungla burocratica, una polverizzazione di responsabilità e spesso una valanga di deresponsabilizzazione, nonché un’oggettiva difficoltà a mettere insieme monitoraggio e previsione meteoidrologica, pianificazione degli usi a scala di bacino, protezione civile, urbanistica e uso del suolo. Un terreno però fertilissimo per l’appalto e il subappalto esterno, che non viene più seguito direttamente dal tecnico governativo con una visione a lungo termine, ma delegato a un esecutore che non ha certo a cuore il futuro dell’umanità, bensì la massimizzazione del suo profitto immediato.
Abbiamo bisogo di tornare alla concretezza delle azioni e al buon senso della pianificazione di lungo periodo, visto che gli scenari climatici impongono una rivisitazione dell’esistente: manutenzione delle reti idriche, adeguamento degli invasi, che sono in gran parte vecchi di un secolo, costruzione di nuove dighe laddove sia possibile, uscendo dalla logica della grande opera colonizzatrice imposta dall’esterno ma entrando nel campo della negoziazione condivisa con il territorio, semplificazione burocratica, diffusione dei contratti di fiume, alfabetizzazione dei cittadini sull’uso prudente e parsimonioso dell’acqua, almeno nei periodi di scarsità. Non sono originale, lo so. Tutte cose già dette e scritte in mille occasioni. Ma forse un po’ di sete in capitale potrà essere utile per occuparsi con lungimiranza di quel bene liquido che tutti diamo per scontato ma che quando manca fa precipitare la qualità della vita a livelli intollerabili. Ci risentiamo in autunno, sicuramente pioverà, la siccità sarà un ricordo e commenteremo l’alluvione!

«Da Brescia a Crotone ecco le bandiere nere su 15 mila siti da bonificare: 7.300 chilometri quadrati di morte». Vedrai che daranno il lavoro agli inquinatori, e pagheremo ancora una volta.il Fatto Quotidiano, 23 luglio 2017 (p.d.)
Il sequestro degli stabilimenti Esso, Isab Nord e Isab Sud del polo petrolchimico di Siracusa è soltanto un granello di sabbia nei numeri devastanti dell’inquinamento italiano: un mostro da 250 miliardi di euro di danno con 15 mila siti da bonificare per 7.300 chilometri quadrati. La cifra di 250 miliardi è l’ammontare del danno ambientale che si ottiene considerando i costi delle bonifiche e l’ospedalizzazione di persone ammalate per colpa dell’inquinamento, considerando solo le aree in emergenza estrema, non tutte inserite nei Sin (siti d’interesse nazionale). Nelle cosiddette aree Sin, appunto, 44 territori da bandiera nera ambientale, il numero stimato di morti per inquinamento è di 10 mila. Poi c’è la direttiva europea 20 04/ 35/C e che applicherebbe il principio “chi inquina paga” ma che è lettera morta. Le bonifiche, in Italia, costano mediamente tra 450 mila e un milione di euro per ogni ettaro inquinato: dal 2002 al 2013 i fondi stanziati dallo Stato per le bonifiche sono stati 2,3 miliardi di euro, a cui vanno aggiunti 1,8 miliardi dei privati. Perché spesso, oltre alla prescrizione penale – che per reati ambientali ammontano a 80 mila casi tra il 2004 e il 2013 – c’è anche la prescrizione economica, nel senso che il principio “chi inquina paga” si perde nel vento. Un elenco parziale dei siti più inquinati del Paese traccia una profonda ferita al veleno dalla Lombardia alla Sicilia.
Dal Sud al Nord l’elenco nero del Paese
Sin di Taranto. L’area, 125 chilometri quadrati, lungo 17 chilometri di costa, comprendente il mostro dell’Ilva, ma non solo, è un danno che ammonta a 9 miliardi di euro. Oltre all’Ilva e alle sue discariche bisogna considerare la raffineria Eni, le due centrali termoelettriche ex Edison passate all’Ilva, la centrale Enipower, la Cementir, due inceneritori, la discarica Italcave, una delle più grandi basi navali militari del Mediterraneo, l’arsenale militare ed altre piccole e medie aziende.
Discarica di Bussi. Il caso dei veleni riversati nel fiume Pescara è stato considerato dal ministero dell’Ambiente un danno vicino ai 9 miliardi di euro.
Centrale Porto Tolle. L’impianto termoelettrico dell’Enel in provincia di Rovigo è causa di un danno ambientale, stimato dall’ente governativo Ispra, vicino ai 3 miliardi di euro.
Ex Pertusola Sud. L’impianto per la produzione dello zinco costruito nel 1928 e dismesso nel 2000 ha provocato danni per 3 miliardi di euro nell’area di Crotone, in Calabria.
Petrolchimico Priolo. Il polo di Augusta, in Sicilia, è uno dei disastri più grandi d’Italia: per disinquinare l’area occorrono almeno 10 miliardi, i danni sanitari e ambientali superano già altri 12 miliardi di euro.
Chimica Caffaro. A Brescia lo stabilimento ha inquinato ininterrottamente dagli anni Trenta del 900 e l’Ispra stima un danno di almeno 1,5 miliardi di euro.
Carbone pugliese. Le centrali di Brindisi, area Sin, provocano un danno di 3,5 miliardi.
Fiume Toce. La Syndial dell’Eni è stata condannata a pagare quasi 2 miliardi di euro per aver contaminato il Lago Maggiore attraverso il Toce tra il 1990 e il 1996.
Frosinate. L’area a sud di Roma è un’emergenza ambientale nazionale, almeno un miliardo il danno provocato da diverse industrie nella Valle del Sacco, tra cui la Caffaro.
Grado e Marano. Le lagune, nel Friuli Venzia-Giulia, sono state vittime della presenza della chimica Caffaro: il danno stimato è di un miliardo.
Cogoleto. Nella riviera genovese c’è uno dei siti più inquinati d’Italia, dove l’ex stabilimento Stoppani per trattamento del cromo ha provocato danni per quasi un miliardo e mezzo di euro.
Bonelli: “I colpevoli non pagano mai”
“Chi ha inquinato – denuncia Angelo Bonelli, coordinatore dei Verdi e autore di uno degli esposti che hanno portato al sequestro del ptrolchimico di Siracusa – e attentato alla salute degli italiani non ha mai pagato. Rimangono ancora da bonificare almeno 7.300 chilometri quadrati in Italia e la popolazione esposta alla contaminazione di queste aree è almeno il 12% dell’intera popolazione nazionale”.

Se il mondo non fosse malato basterebbero tre mosse: prima mossa, abolire il packaging, seconda mossa, abolire l'obsolescenza programmata, terza mossa, produrre e consumare solo ciò che davvero serve. Ma bisognerebbe fare preliminarmente la mossa zero: togliere il potere agli sviluppisti. la Repubblica, 21 luglio 2017
Stiamo diventando un pianeta di plastica. Dagli anni ’50 epoca del boom economico e anche di questo materiale – ne abbiamo prodotti 8,3 miliardi di tonnellate e gettati via 6,3 miliardi. Solo acciaio e cemento – fra i materiali artificiali – pesano di più sul nostro pianeta. È come se ognuno di noi ne portasse sulle spalle una tonnellata e passa. Il 79% di questo carico è distribuito nelle discariche o sporca città, campagne e mari. Il 12% è stato incenerito e solo il 9% riciclato. Il calcolo arriva da uno studio su Science Advances – il più completo mai pubblicato su questo materiale – scritto da ambientalisti e ingegneri delle università della Georgia e della California a Santa Barbara.
Tracce di plastica sono state trovate nei ghiacci antartici e nella fossa delle Marianne, a 10 chilometri di profondità.
Si stima che una tonnellata sia incorporata nel permafrost artico. Alle Hawaii nel 2014 è stato descritto un nuovo tipo di roccia: il plastiglomerato, in cui le alte temperature di un fuoco hanno fuso insieme pietra vulcanica, sabbia e plastica. Sull’isola di Henderson, Pacifico del sud, 40 abitanti in tutto, il punto più lontano da ogni altra terraferma, le onde portano 3.750 frammenti di spazzatura al giorno, per la maggior parte buste e contenitori.
Chi sostiene che l’antropocene – l’epoca dell’uomo – sia una vera e propria era geologica, usa proprio l’argomento della plastica: fra milioni di anni, se mai qualcuno sarà in grado di scavare sottoterra, ne troverà quantità massicce.
I ricercatori americani si sono “divertiti” a tradurre questa cifra al di là dell’immaginabile (gli 8,3 miliardi di tonnellate) in termini più intuitivi. Il nostro mondo di plastica pesa come 1 miliardo di elefanti, 80 milioni di balenottere azzurre, 25mila Empire State Building e 822mila torri Eiffel. Se lo spalmassimo su tutta l’Argentina, ci affonderemmo dentro fino alle caviglie. La quota gettata via come rifiuto potrebbe seppellire Manhattan sotto due miglia di spazzatura.
Il pianeta di plastica è stato creato, per metà, negli ultimi 13 anni. E se l’andamento della produzione proseguirà in maniera esponenziale come ha fatto finora, la massa raggiungerà i 34 miliardi di tonnellate nel 2050, di cui 12 sotto forma di rifiuti. Se nel 1960 questo materiale riempiva solo l’1% del nostro sacchetto della spazzatura, oggi siamo arrivati al 10%. La produzione che nel 1950 era limitata a 2 milioni di tonnellate oggi è schizzata a oltre 400, più di 300 delle quali viene buttata via nello stesso anno in cui è stata fabbricata. Il ritmo con cui sforniamo plastica è cresciuto due volte e mezzo più rapidamente del Pil mondiale.
In mare, ha calcolato sempre lo stesso gruppo di scienziati due anni fa, finiscono attualmente 8 milioni di tonnellate, macerate dal sole, ridotte in microplastiche, ingerite dai pesci.
Uno studio su Plos nel 2014 stima che il numero di frammenti galleggianti in tutti gli oceani del mondo raggiunga i 5 trilioni.
«La stragrande maggioranza di questi materiali in realtà non si biodegrada in modo significativo » spiega Jenna Jambeck, ingegnere dell’università della Georgia, fra gli autori dell’impressionante studio, evidentemente poco convinta della bontà delle plastiche ecologiche. «I rifiuti che abbiamo prodotto ci accompagneranno con tutta probabilità per centinaia o migliaia di anni». Pochi uomini ormai ricordano com’era il mondo prima della diffusione ubiqua di questo materiale.
La facilità di produzione e l’indistruttibilità (solo un trattamento termico particolare riesce a eliminarla davvero) sono state le molle del successo della plastica, dal punto di vista industriale. E del disastro, dal punto di vista ambientale. E se è vero che acciaio e cemento ancora la surclassano in termini di tonnellate prodotte, il coordinatore dello studio Roland Geyer, ecologista industriale, professore dell’ateneo californiano, precisa: «Metà dell’acciaio che fabbrichiamo serve a costruire edifici e resta utile per decenni. Per la plastica è il contrario. Metà di quella creata diventa scarto dopo meno di quattro anni di utilizzo”.
Il 42% della produzione mondiale finisce in packaging e viene buttata via subito dopo il consumo. Il riciclo potrebbe essere una soluzione. Ma i tassi di riutilizzo arrivano al 30% e al 25% rispettivamente in Europa e in Cina. E non superano il 9% negli Stati Uniti. Questo accade da anni, ben prima che alla Casa Bianca arrivasse Donald Trump.
«Esiste a livello globale una guerra del potere contro la società civile, contro i cittadini e cittadine che si organizzano, si attivano, chiedono libertà e giustizia, rispetto dei diritti e protezione della terra». comune-info.net, 19 luglio 2017 (p.d.)
Tra le molte guerre che si stanno combattendo nel mondo, ce n’è una che cresce giorno dopo giorno, inesorabile quanto occultata, grazie al complice disinteresse e allo scarso rilievo con cui ne danno notizia i grandi media e i governi del mondo. Si tratta di quella segnalata – con massima preoccupazione – dall’ultimo Rapporto di Global Witness, una Ong che si occupa dei legami tra lo sfruttamento delle risorse naturali, i conflitti ambientali, la povertà, la corruzione e le violazioni dei diritti umani. Il rapporto è dedicato proprio alle vittime di quella guerra, unilaterale, alle persone che difendono la terra e l’ambiente dall’insaziabile sete di chi li aggredisce e rapina per ricavarne fiumi di denaro. Il settore più insanguinato è quello minerario, 4 persone su 6, tra quelle assassinate, sono indigene, 6 su 10 sono state uccise in América Latina. Le responsabilità vanno attribuite, direttamente o indirettamente, agli apparati dello Stato o della sicurezza e a formazioni non statali, pistoleros, o forze di sicurezza collegate alle imprese. Una strage che chiama in causa in modo evidente i modelli di sviluppo e di consumo e l’ossessione per l’estrazione di valore dalla terra.
In un suo splendido editoriale sull’ultimo numero della rivista
“liberal” statunitense
Harper’s la scrittrice ed attivista Rebecca Solnit si cimenta con il tema dello spazio. Spazio fisico di agibilità, e spazio immateriale di compressione dei diritti. Tutto il potere, dice, “può essere inteso in termini di spazi. Spazi fisici, come anche le economie, le conversazioni, la politica – tutto può essere inteso come aree occupate inegualmente. Una mappa di questi territori costituirebbe una mappa del potere e dello status. Chi ha di più e chi ha di meno”, ed il “dominio dello spazio e del territorio da parte di chi ha potere può essere chiamato violenza strutturale”. La teoria basagliana definiva questa violenza strutturale come “crimine di pace”, altri la chiamano semplicemente, “necropolitica” termine coniato dal sociologo africano Achille Mbembe assieme a quello di “biopotere” . Spazi che si chiudono nella tenaglia tra “necropolitica” e “biopotere”. In gergo il termine usato è
“shrinking space” un termine che però rischia di rielaborare un’urgenza ed un’emergenza politica globale in maniera asettica e per questo “depoliticizzata”. Chi è responsabile del restringimento di questi spazi di agibilità? Chi li occupa e popola quegli spazi? Solo quella che si può considerare secondo norma la società civile? In realtà anche la scelta delle terminologie ormai diventate ricorrenti anche tra fondazioni e agenzie di cooperazione, rischia – come sottolineato in un dossier del Transnational Institute – di invisibilizzare ancor di più quello che già di per sé è invisibile, chi quotidianamente lotta e resiste per i propri diritti e quelli della collettività.
A darci qualche importante e drammatico indizio della guerra nascosta che si combatte, a armi impari, contro chi con la nonviolenza si mobilita per difendere la propria terra, l’ambiente dalle ricadute nefaste del modello di sviluppo estrattivista è l’ultimo rapporto a cura di Global Witness, intitolato “Difensori della terra. Omicidi di difensori della terra e dell’ambiente nel 2016”. Le cifre sono impressionanti: almeno 200 difensori (uomini e donne) sono stati uccisi lo scorso anno, in 24 paesi. Una scia di sangue che si allarga a macchia d’olio, i paesi dove Global Witness aveva registrato omicidi nel 2015 erano 16. Oggi in testa è il Brasile, seguito dall’Honduras, dal Nicaragua, dalle Filippine, la Colombia, l’India, e la Repubblica Democratica del Congo. Il Brasile del grande latifondo e dei mega-progetti di sviluppo del governo Temer, l’Honduras di Berta Caceres e del COPINH – la figlia Bertita di recente oggetto di minacce di morte mentre il governo annunciava la chiusura del contestatissimo progetto idroelettrico di Agua Zarca. Le Filippine di Duterte, o la Colombia dove dopo la firma dell’accordo di pace tra governo e FARC, e lo smantellamento della presenza delle FARC nei territori da loro controllati, si è scatenata una caccia agli attivisti e leader comunitari da parte di formazioni “neo-paramilitari”. Una maniera di “ripulire” il territorio per permettere poi alle imprese del settore estrattivo di fare i loro affari sporchi.
Il rapporto di Global Witness ci dice che il settore minerario è quello più macchiato del sangue degli attivisti uccisi lo scorso anno, 40% dei quali erano uomini e donne indigene. Il 60% dei 200 omicidi è stato registrato proprio in America Latina. E le responsabilità vanno attribuite direttamente o indirettamente agli apparati dello stato o della sicurezza, a formazioni non statali, pistoleros, o forze di sicurezza collegate alle imprese. Il numero però potrebbe essere assai maggiore, visto che secondo quanto registrato dall’Atlante per i Conflitti Ambientali (EJAtlas) almeno 2000 sono i conflitti sulla terra nel mondo. E poi molti di questi omicidi non sono stati denunciati o semplicemente derubricati a fatti di criminalità comune. Per non parlare poi della crescente criminalizzazione dei movimenti sociali e ambientali, non solo nel cosiddetto “Mondo di Maggioranza” ma anche in quello di “Minoranza” il ricco ed opulento “Nord”. Uno su tutti il caso della resistenza contro la Dakota Access Pipeline a Standing Rock. Allora risulta evidente che questo spazio che si restringe ha a che vedere con il modello di sviluppo, con i modelli di consumo e estrazione di valore dalla terra. È pertanto uno spazio “politico” di rivendicazione e di conflitto, dove chi ha il monopolio dell’uso della forza, armata o non, prevarica, comprime, marginalizza, uccide.
Questo nel cosiddetto “Sud”. E a parte il caso di Standing Rock che accade altrove, nel nostro “Nord” che si erge a paladino dei diritti umani e della democrazia? Turchia, Egitto ma anche Polonia, Ungheria per fare qualche esempio? Non ci si faccia illusioni: esiste a livello globale una guerra del potere contro la società civile, contro i cittadini e cittadine che si organizzano, si attivano, chiedono libertà e giustizia, rispetto dei diritti e protezione della terra. Ad aprile di quest’anno CIVICUS ha reso noti i dati raccolti nel corso del 2016. La loro pubblicazione ha un titolo eloquente “People Power under Attack” (il potere del popolo sotto attacco). Secondo CIVICUS, solo il tre percento della popolazione mondiale vive in paesi dove lo spazio di agibilità ed iniziativa “civica” può considerarsi “aperto”. Sono ben 106 i paesi dove chi si mobilita pacificamente rischia la galera, la morte o la repressione. Dei 195 paesi monitorati da CIVICUS in 20 lo spazio di agibilità è chiuso, represso in 35, ristretto in 63, ed “aperto” in solo 26. Oltre sei miliardi di persone vivono in paesi dove l’agibilità politica e civica è chiusa, repressa o ostruita. I dati di CIVICUS rivelano con chiarezza la responsabilità degli apparati di stato nell’assalto sistematico a chi, individui o movimenti, critichi l’autorità, svolga attività di monitoraggio dei diritti umani, o rivendichi i proprio diritti sociali ed economici. Il più recente rapporto sullo stato della società civile nel mondo sempre a cura di CIVICUS, va oltre ed identifica nella crescita del populismo e dell’estremismo sciovinista una delle cause dell’aumento della sfiducia verso la società civile, pretesto per attacchi allo spazio di agibilità civica.
E l’Italia? Secondo il rapporto di CIVICUS lo spazio di agibilità ed iniziativa “civica” in Italia si è “ristretto” e tende verso il livello di “ostruzione”, ben lontano dagli standard di “spazio civico aperto” di altri paesi membri della Unione Europea. Altri paesi dove si registra una “restrizione” dello spazio di agibilità sono gli Stati Uniti, il Canada, Cile, Argentina, Spagna, Francia, Corea del Sud, Giappone, Sudafrica, Australia, Zimbabwe oltre ad altri paesi africani. In realtà, la recente campagna di criminalizzazione delle organizzazioni non governative e della società civile che fanno soccorso in mare, o solidarietà con migranti e rifugiati sarebbe solo una manifestazione parossistica di un “trend” che si sta insinuando anche nel nostro paese. Dalla criminalizzazione delle proteste dei comitati per la protezione dell’ambiente, alle minacce a giornalisti o avvocati da parte della criminalità organizzata, anche nel nostro paese iniziano a palesarsi i sintomi di una dinamica preoccupante.
Sempre CIVICUS, che assieme a Civil Society Europe pubblicherà in autunno uno studio dettagliato paese per paese, Italia inclusa, nel nostro paese nella prima metà del 2016 le principali libertà civili di associazione, riunione ed espressioni sono generalmente rispettate, ma sussistono alcune problematiche. Dalla discrezionalità nelle operazioni di ordine pubblico, all’uso eccessivo della forza in occasione di proteste di piazza. Occasionalmente difensori e difensore dei diritti umani soffrono minacce e intimidazioni. Nella prima metà del 2016 inoltre sono state registrate ben 221 violazioni del diritto alla libertà di espressione, una situazione ulteriormente aggravata da casi di intimidazione verso giornalisti.
Per tutto questo oggi proteggere i difensori della terra, dell’ambiente, dei diritti umani è un compito urgente, una sfida essenziale anche per la politica e per il settore privato, oltre che per la società civile nel nostro paese, già impegnata nella rete In Difesa Di, per i diritti umani e chi li difende, e più di recente con la campagna “Coraggio” di Amnesty International. Il prossimo anno l’Italia presiederà l’OSCE (Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione Europea) che attribuisce grande rilevanza al tema dei difensori dei diritti umani nei suoi paesi membri, tra cui vanno annoverati seppur con modalità diverse, paesi come la Turchia, l’Egitto, la Polonia, o l’Ungheria. E non solo, il 2018 marcherà il 20esimo anniversario della Dichiarazione ONU sui Difensori dei Diritti Umani occasione imperdibile per rilanciare con forza il tema della difesa dei difensori dei diritti umani e della tutela degli spazi di agibilità “civica” chiedendo al governo, al Parlamento ed agli enti locali uno sforzo collettivo per questa importante campagna di civiltà politica e sociale.
Articolo pubblicato anche sull’huffingtonpost.it
 «Se certe Regioni rimangono inerti, lo Stato deve poter subentrare nei piani di prevenzione e intervento e nei piani paesaggistici. Dove sono quelli della Sardegna decisi da Soru?» La Nuova Sardegna, 19 luglio 2017
«Se certe Regioni rimangono inerti, lo Stato deve poter subentrare nei piani di prevenzione e intervento e nei piani paesaggistici. Dove sono quelli della Sardegna decisi da Soru?» La Nuova Sardegna, 19 luglio 2017
Il clima si surriscalda, la siccità e la desertificazione avanzano e il Belpaese abbassa le difese della prevenzione e dell'intervento immediato. Addirittura non mette in atto, a livello regionale, i piani di prevenzione per gli incendi. E' il capo della Protezione Civile che punta il dito su alcune Regioni inadempienti, a partire dalla Campania dove i roghi hanno assunto, sul Vesuvio ma non solo, dimensioni epocali, da tragedia di massa. La Regione ha pensato bene - in un anno che già dalla primavera si annunciava caldissimo - di non stipulare coi Vigili del Fuoco la convenzione per il 2017 per lo spegnimento dei roghi boschivi.
Per di più alla presidenza del Parco Nazionale del Vesuvio il più antropizzato, abusivamente, d'Italia (come altri 8 Parchi Nazionali esso è da tempo privo di un direttore), è stato posto, in luogo di un autentico esperto quale il professor Ugo Leone, Agostino Casillo, manager aziendale, giovane brillante nel suo campo e però digiuno di questioni ambientali e forestali. Tant'è che già nel 2016 il territorio del Parco vesuviano - seminato di migliaia di case abusive - ha subito un incendio disastroso. "Non si ripeterà", è stata la solenne promessa. Parole, soltanto parole.
Si dirà: la situazione vesuviana, campana è molto particolare, si sa. Particolare allora è anche la situazione siciliana, per esempio del Parco regionale dei Nebrodi, pure largamente a fuoco, il cui presidente è stato minacciato a fucilate dalla "mafia dei pascoli". In altre zone agiscono incendiari prezzolati - per lo più disperati, manovali della malavita - incaricati di incenerire aree a bosco sulle quali, senza fretta, i vari racket hanno puntato gli occhi per future lottizzazioni turistiche. Neppure sapendo in molti casi che su quei terreni "cotti" e quindi resi instabili non si potrà costruire nulla per decenni o che lo vieta una legge-quadro nazionale spesso, purtroppo, da applicare.
A livello nazionale poi si è aggiunto, da quest'anno, un altro clamoroso elemento di confusione e di disorganizzazione nella lotta a quanto minaccia la vita del grandioso manto boschivo nazionale e regionale e cioè la cancellazione del Corpo Forestale fuso, grazie alla criticatissima riforma Madia, coi Carabinieri dei Nuclei Ecologici. Pur con la massima stima verso questi ultimi, è stata dispersa una esperienza specifica di cento anni, è stata manomessa una secolare collaborazione coi Vigili del Fuoco attribuendo alla Protezione Civile una serie di funzioni o disfunzioni.
Le Regioni che non predispongono in modo cialtronesco i piani di prevenzione di legge vanno commissariate dal governo centrale. Analogamente i molti Comuni che non redigono l'indispensabile catasto dei terreni andati a fuoco preparando, anche senza volerlo, l'ingresso del racket su quelle stesse aree sulle quali la legge n. 353/2000 proibisce per almeno quindici anni ogni edificazione.
In Sardegna la Regione a statuto speciale ha potuto salvare l'autonomia storica e tecnica della Forestale e quindi preservarne il ruolo. Ma c'è altro da fare. Perché, ad esempio, la Regione non ha sviluppato quanto era già stato fatto, con qualità e incisività, dalla Giunta Soru col decreto salvacoste e coi piani paesaggistici validamente coordinati da Edoardo Salzano nel 2004? Perché, in tredici anni, non si è messo mano alla co-pianificazione prescritta dal Codice Rutelli/Settis in una regione che nella bellezza paesistica e nell'integrità ambientale ha la prima risorsa anche economica da tutelare? Inutile o ipocrita poi piangere sul verde incenerito.
La siccità e il surriscaldamento del clima non sono più una emergenza, sono la nuova "normalità" per la quale ci dobbiamo attrezzare, da subito. Tanto più che la manomissione speculativa sistematica, in varie forme, del paesaggio e dell'ambiente - oggi attraverso incendi mirati di vasta entità - fa ormai parte in Italia del "fatturato della criminalità organizzata" e anche di una diffusa illegalità. Se le Regioni rimangono inerti, lo Stato deve poterle sostituire. Non possiamo veder bruciare il Belpaese in una generale impotenza. Non possiamo vederlo, in autunno, sprofondare nelle alluvioni e nelle colate di fango rese più facili da questi roghi.
 L'ennesima invocazione alla saggezza nell'uso degli enormi spazi. Perché continuare a vedere separati gli immensi patrimoni di naturalità vuoti di attività. e le gigantesche risorse di forza lavoro inoccupata. Eppure le risorse finanziarie ci sarebbero. il manifesto, 18 luglio 2017, con postilla
L'ennesima invocazione alla saggezza nell'uso degli enormi spazi. Perché continuare a vedere separati gli immensi patrimoni di naturalità vuoti di attività. e le gigantesche risorse di forza lavoro inoccupata. Eppure le risorse finanziarie ci sarebbero. il manifesto, 18 luglio 2017, con postilla
Sono tornato in Sila, la Sila Piccola, nel Catanzarese, percorrendo in auto e a piedi i piccoli villaggi che si snodano lungo la statale, Racise, Villaggio Mancuso, Spineto, e ho fatto una passeggiata lungo il sentiero attrezzato di uno dei tanti immensi boschi.
Ancora una volta, ma in questo caso molto più accentuata che nelle escursioni degli anni precedenti, la stessa amara constatazione: una meraviglia della natura e del lavoro umano, uno tesoro di potenzialità economiche abbandonato a se stesso. In Sila, in pieno luglio, si possono percorrere chilometri di strada e non si incontra anima viva. In compenso, ai bordi della strada, tra le felci che tappezzano il sottobosco, è ancora possibile raccogliere le profumate fragoline, benché più piccole del solito per il gran secco di questa estate, o i lamponi selvatici.
Qui, queste piante sono endemiche. E da decenni mi sono sempre inutilmente chiesto come mai non fosse mai fiorita in queste terre la redditizia agricoltura dei piccoli frutti (fragole, mirtilli, lamponi, ribes, more), così come accade ad esempio in alcune campagne del Piemonte o della Valle d’Aosta. Ma a questa consueta domanda se ne aggiungevano altre: com’era possibile lasciare migliaia e migliaia di ettari di radure senza alcuna coltivazione, senza quasi l’accenno di una qualche forma di allevamento?
La risposta a queste domande si trova andando in giro nei villaggi prima nominati. Per le strade e le piccole piazze pochissimi villeggianti, in grandissima parte anziani, difficilissimo scorgere bambini. I negozi, che vantano prodotti tipici calabresi, hanno in vetrina qualche barattolo di salsa di peperoncino piccante, un po’ di funghi secchi, qualche marmellata e molte cianfrusaglie di quelle che si trovano in tutti i paesi d’Italia. Quasi niente di un territorio potenzialmente così ricco appare sotto forma di prodotto apprezzabile per la sua autenticità e specificità, per il suo legame con una tradizione di rilievo.
Il quadro si completa se ci si mette a girare nei villaggi, come ho fatto a Racisi, allontanandomi un po’ dalla nazionale. Allora si scorgono file di case abbandonate, alcune col tetto sfasciato, altre interamente crollate. Tutto intorno un’area di abbandono, l’ortica che cresce alta ai bordi della strada e qualche pianta di lampone che, a dispetto di tutto, continua a offrire i suoi frutti senza che nessuno li raccolga.
Dunque, se non c’è popolazione, non si produce nulla, le case vanno in rovina, la domanda esterna che potrebbe attivare il circolo non arriva. Così muoiono lentamente le cosiddette aree interne del nostro Paese. Solo che la Sila non è un territorio qualunque. Ed è anche un grande parco nazionale.
Tuttavia, anche qui non manca qualche presidio di resistenza. Ho cenato in quello che è forse rimasto l’unico ristorante di Racisi e ho assaggiato una fetta di lardo che non assaporavo dai tempi della mia infanzia. Un sapore così fine ed intenso – sia detto senza nessuna vanteria campanilistica – che fa impallidire al confronto qualunque Lardo di Colonnata. E che è il risultato semplice dell’allevamento domestico del maiale. Ma in sala c’erano solo 4 clienti ed era sabato.
Ebbene, come mi ha raccontato l’oste-resistente, quel po’ di attività e di economia che si svolge in quei luoghi, sono oggi resi possibili dagli immigrati, dai lavoratori che sono arrivati soprattutto dai Paesi dell’Est. Sono loro che fanno lavori in campagna, riparano case, accudiscono anziani.
E allora com’è possibile che un sindaco – a Castell’Umberto, in Sicilia, paese montano di 3 mila abitanti – faccia le barricate contro un albergo che ospita 50 immigrati, dove ancora non esiste una rete di corrente elettrica?
Come possiamo respingere i giovani che arrivano se le campagne si spopolano? Non costituirebbe oggi la più lungimirante forma di investimento, per l’Italia, attrezzare i comuni, fornirli di risorse finanziarie e di uomini, per metterli in condizione di accogliere e organizzare giovani, donne, bambini in grado di far rifiorire in pochi anni economie languenti, restaurare paesi in rovina, ridare vita a territori spesso dotati di spettacolare bellezza? E’ per questa strada che la sinistra può sconfiggere la propaganda fondata sulla paura, conquistare i ceti popolari a una visione solidale nei confronti dei migranti, senza dovere annacquare principi e valori nell’eterna campagna elettorale in cui si esaurisce la lotta politica.
Si assiste oggi impotenti e col solito chiacchiericcio agli incendi che devastano mezza Italia. Nessuno pensa che se queste aree perderanno ancora popolazione, gli incendi saranno ancora più devastanti e senza rimedio.
postilla
Qualche cifra che è bene ricordare. Le spese militari previste dal bilancio dello Stato per il 2017 ammontano a 23.400 milioni di euro, 64 milioni al giorno. Fonte, articolo de il Fatto Quotidiano del 23 novembre 2016. Proviamo un po' a fare il conto di che cosa ci si potrebbe fare, invece. Quante occasioni di lavoro utile si potrebbero formare, quali beni diversificati (dall'alimentazione, alla conoscenza alla ricreazione) si potrebbero produrre. E' un conto che una volta si dovrebbe cominciare a fare, area per area, a partire dalla ricostruzione del suolo dove è stato disgregato e dissolto, per proseguire con le città soffocate dalla mobilità individuale ecc..
 Le capitali Europee, alle prese con i radicali cambiamenti del clima, adottano sistemi sempre più innovativi. Naturalmente non si propongono di adottare provvrfimrmti che contrastino lo sviluèèismo, causa condistente del surriscaldamento, ma solo queli che incrementano il Pil. Regioneambiente, 15 luglio 2017 (c.m.c.)
Le capitali Europee, alle prese con i radicali cambiamenti del clima, adottano sistemi sempre più innovativi. Naturalmente non si propongono di adottare provvrfimrmti che contrastino lo sviluèèismo, causa condistente del surriscaldamento, ma solo queli che incrementano il Pil. Regioneambiente, 15 luglio 2017 (c.m.c.)
Le conseguenze derivate dai cambiamenti climatici stanno apportando modifiche sostanziali al modo in cui l'uomo si approccia alla natura. L'innalzamento del livello dei mari è una delle problematiche più attuali dato che già numerose città costiere del mondo devono fare i conti con la lenta scomparsa di alcune zone abitabili.
Per una nazione come i Paesi Bassi, la cui superficie è posizionata, per una buona parte, sotto il livello del mare, le problematiche sono all'ordine del giorno. E' per questo che la città di Rotterdam, uno dei capoluoghi principali del paese, sta adottando delle contromisure di ingegneria edile molto sofisticate e innovative, tali da attirare a sé l'interesse di numerose comunità scientifiche.
Come riportato nel dossier 2017 di Legambiente dal titolo "Le città alla sfida del clima", la città olandese è considerata come una delle più avanzate nel campo della trasformazione urbana. Tutti i progetti sviluppati, infatti, sono basati sul semplice quanto nobile concetto di resilienza urbana, ovvero l'adattamento ambientale delle strutture cittadine ai nuovi cambiamenti naturali. Non c'è dunque l'intenzione di forzare i percorsi e i comportamenti dell'acqua, bensì di convivere con questi nella maniera più intelligente e sostenibile possibile.
La superficie di Rotterdam è situata per l'80% al centro del delta del fiume Reno, il rapporto città-acqua è un fattore estremamente importante per la vita di tutti giorni. E grazie alle politiche urbanistiche attuate dalla municipalità nel corso degli ultimi 15 anni, tale rapporto è stato capovolto in maniera straordinaria, passando da minaccia ambientale a opportunità economica. Risale al 2001, infatti, il primo atto di un piano d'azione a lungo termine per contrastare gli effetti, anche devastanti, delle alluvioni e delle tempeste. Una programmazione che è stata poi aggiornata sia nel 2005 che nel 2007 e con una pianificazione fino al 2035, sintomo di come la città sia attiva su questo ambito.
Nel dettaglio, tra i provvedimenti presi, c'è l'istituzione dell'Eendragtspolder, una grande landa bonificata e ibrida, composta sia da campi che canali, utilizzata per moltissime attività acquatiche e sviluppata in maniera tale da poter accogliere le esondazioni del fiume Reno e l'eccesso di acqua dovuto alle alluvioni, senza causare nessun danno. Ci sono poi nuove modalità di architettura, che interessano soprattutto il centro di Rotterdam. Tra queste il retrofitting, ovvero la riutilizzazione di spazi sotterranei, come dei garage, convertiti in grandi serbatoi per lo stoccaggio dell'acqua piovana. Ma anche la costruzione di strutture abitative e quartieri galleggianti, soluzioni flessibili che si adattano alla fluttuazione dei livelli dell'acqua.
Il capoluogo olandese non è un unicum nel suo genere; altri centri metropolitani del centro e nord Europa stanno adottando strategie di adattamento innovative per contrastare i cambiamenti climatici. Alcuni esempi:
- La città di Brema, in Svizzera, ha avviato un programma di lavoro, il Sensible Water and Urban Development, con l'obiettivo di gestire in maniera ottimale le piogge intense. Questo consiste nell'uso multifunzionale del terreno, nella creazione di parchi acquatici, nell'utilizzo di strutture sotterranee e di raccolta dell'acqua e nella costruzione di strade di emergenza.
- Copenaghen, nel 2011 ha aggiornato il suo piano urbanistico, denominato "piano delle cinque dita" e risalente al 1949, per far fronte alle inondazioni. Nel dettaglio, si è deciso di allargare il sistema fognario, utilizzare nuove modalità di drenaggio urbano superficiali in grado di gestire localmente l'acqua piovana e di guidare il flusso in caso di alluvioni, dirottandolo verso luoghi non sensibili all'allagamento. Sempre nella capitale danese, alcuni quartieri hanno subito trasformazioni molto interessanti. In quello di St. Kjeld, a seguito del disastroso nubifragio del 2011, la municipalità di Copenaghen ha avviato un ambizioso progetto di ottimizzazione delle vie e delle piazze, con la creazione di zone piantumate, dune verdi, piste ciclabili, sostituzione di pavimentazioni impermeabili con prati e mini parchi urbani, oltre alla sopraelevazione dei marciapiedi per la raccolta e il deflusso delle acque in eccesso verso il porto. In quello di Nørrebro, oggetto tra i principali del Copenhagen Climate Plan, si è adottato un nuovo approccio al tema della presenza dell'acqua in ambito urbano. Essa non viene considerata più come un pericolo, bensì come una risorsa e un'occasione di creazione di nuovi spazi attrattivi che abbiano come scopo la diversità biologica, lo scambio culturale e l'interazione sociale di quartiere.
- Stoccarda, il capoluogo tedesco, rappresenta uno degli esempi più avanzati di integrazione delle misure di mitigazione del calore urbano all'interno di strumenti di pianificazione ordinaria. Nel 2008, nel Land Use Plan, piano di ampliamento della zona residenziale Schelmenäcker, realizzata a ridosso del bosco di Lemberg, è stato concepito un "corridoio verde" di attraversamento del nuovo nucleo abitato in grado di salvaguardare l'esistenza di un "passaggio di ventilazione" tra il centro cittadino e le aree rurali circostanti, migliorare le condizioni microclimatiche ed estetiche del nuovo quartiere, e garantire un nuovo spazio verde a scopi ricreativi e di mobilità, da e verso il centro urbano.
La strada per risolvere le problematiche del climate change è ancora molto lunga e impervia, specie se si valuta quanti pochi sforzi vengano fatti, allo stato attuale, dai governi della comunità mondiale. Ad ogni modo, l'attuazione di queste innovative strategie urbane, volte a salvaguardare la vita nei grandi centri urbani, sono il sintomo che una parte della popolazione si sta muovendo nella direzione giusta.
 «Lo Stato e per esso il governo, prima Renzi, poi Gentiloni, si è industriato in autentiche “controriforme” o in vere e proprie latitanze». Il FattoQuotidiano online, 14 luglio 2017 (c.m.c)
«Lo Stato e per esso il governo, prima Renzi, poi Gentiloni, si è industriato in autentiche “controriforme” o in vere e proprie latitanze». Il FattoQuotidiano online, 14 luglio 2017 (c.m.c)
Nello spettacolo drammatico del fuoco che divora migliaia di ettari di bosco nel cuore del Parco Nazionale del Vesuvio a vantaggio degli abusivi o del Parco regionale dei Nebrodi da tempo nel mirino della mafia si rispecchia un autentico “smontaggio” dello Stato, ad ogni livello.
Dopo mesi di primavera precoce, le Regioni per la loro parte e il Ministero dell’Ambiente hanno predisposto per tempo i piani di azione e di prevenzione anti-incendio previsti dalla legge e più che mai indispensabili con l’aumento delle temperature? Non sembra proprio. In regioni strategiche – dall’Abruzzo alla Sicilia – non c’erano mezzi aerei di contrasto.
Il cambiamento climatico è un fatto, la desertificazione in Italia avanza da Sud a Nord: a che punto è l’attuazione della legge del 2000 sui catasti comunali dei terreni bruciati dove non si può né si deve costruire? Molto indietro. In compenso in Sicilia si continua ad avere un mega-organico di forestali i quali “hanno bisogno” di incendi da spegnere. Ci siamo capiti.
Nell’“orribile” 2007 furono 308 le richieste di intervento anti-incendio fra aprile e luglio, quest’anno sono già 430 e il fuoco non dà tregua. Nel Lazio, regione fertile per abusi e speculazioni edilizie, i roghi sono aumentati del 400%. Ma il ministro dell’Ambiente Gianluca Galletti continua a parlare di “piromani” e ad “auspicare” più repressione. Già nel 2003 in Sicilia studi seri individuavano soltanto 4 cause naturali o accidentali di incendio, 101 “dubbie”, 25 colpose e ben 488 dolose (79%) su 618. Gli incendi estivi fanno parte del “fatturato” dell’economia criminale? Sì, dov’è lo Stato?
Lo Stato e per esso il governo, prima Renzi, poi Gentiloni, si è industriato in autentiche “controriforme” o in vere e proprie latitanze: 1) la situazione dei Vigili del Fuoco, uno dei corpi pubblici più efficienti, pronti al sacrificio, più vicini alle popolazioni colpite da ogni sorta di calamità, da ultimo il terremoto fra Lazio, Marche, Abruzzo sono da anni sotto organico di 3000 unità, con un’età media sui 50 anni, stipendi fra 1300 e 1500 euro appena e continui pensionamenti che le 2400 assunzioni del 2013 non compensano. Nell’era Berlusconi, loro come altri Corpi specializzati sono stati penalizzati e indeboliti rispetto alla Protezione Civile sacrificando grandi competenze.
2) La criticatissima “riforma Madia” della Pubblica Amministrazione, proprio mentre il cambiamento climatico ne esigeva il potenziamento specifico, ha cancellato dalla scena dei nostri monti la Guardia Forestale che tanti meriti si era conquistata in cento anni assecondando una importante ripresa della forestazione (spesso non pianificata purtroppo) su 3 milioni e mezzo di ettari aumentando notevolmente il miliardo e 24 milioni di tonnellate di carbonio organico sottratto all’atmosfera inquinata. Lo smembramento del Corpo Forestale assorbito nei Carabinieri dei Noe e il passaggio di competenze alla Protezione Civile “ha di fatto derubricato la questione incendi abbandonando le attività essenziali e strategiche di prevenzione”, si legge in una penetrante interrogazione dell’on. Serena Pellegrino (Si) e da altri.
Gli incendi stanno allontanando dalle montagne e persino dalle coste del Sud decine di migliaia di turisti. Un altro boomerang in piena fronte. Ma al Senato riemerge, pur modificata in qualche parte, la legge Caleo (Pd) che indebolisce il governo dei Parchi Nazionali nostra immensa ricchezza igienico-sanitaria, biologica, turistica, da tutelare metro per metro. E intanto bruciano boschi secolari, vengono carbonizzati nidi e covi di uccelli, di animali selvatici, rettili, insetti utili. E da questi terreni montani “cotti” a dovere aspettiamoci altri guasti con le piogge di novembre: frane, colate di fango, alluvioni. Altre tragedie da rincorrere.
L'inesorabile marcia dell'obsolescenza programmata, il potente strumento dell'ideologia e della prassi dello sviluppismo, la Peste dei nostri anni. comune-info.net, 14 luglio 2017, con riferimenti (p.d.)
«La costante sostituzione di merci utili per nessun altro motivo che la “modernità” è piuttosto evidente nell’industria dell’abbigliamento, nota come industria della “moda”. Ma l’obsolescenza programmata e sua sorella la pubblicità restano forze particolarmente potenti prima di tutto nell’alta tecnologia. Per questo dalla base non solo si moltiplicano ovunque le proposte per leggi sul diritto alla riparazione e campagne contro i Trattati di liberalizzazione del “libero scambio” (quelli che favoriscono le delocalizzazioni) ma si diffondono i “caffè di riparazione” non a fini di lucro. Queste iniziative locali rafforzano i valori della parsimonia e dell’autonomia erosi dal consumismo; collegano le persone con le loro comunità, ridimensionano l’uso di risorse e riducono la quantità di materiali gettati nelle discariche».
Un mio amico indiano racconta una storia riguardo all’aver guidato una vecchia Volkswagen Beetle dalla California alla Virginia durante il suo primo anno negli Stati Uniti. In una singolare tempesta di ghiaccio in Texas è finito fuori strada, lasciando l’auto col parabrezza rotto e portiere e parafanghi malamente ammaccati. Quando è arrivato in Virginia ha portato l’auto in una carrozzeria per una stima della riparazione. Il proprietario le ha dato un’occhiata è ha detto: “È irrecuperabile”. Il mio amico indiano è rimasto sconcertato: “Come può essere irrecuperabile? L’ho appena guidata fin qui dal Texas!”.
La confusione del mio amico era comprensibile. Anche se “irrecuperabile” suona come una specie di termine meccanico, è in realtà un termine economico: se il costo della riparazione è superiore a quanto varrà l’auto dopo, la sola scelta economica “razionale” è portarla dallo sfasciacarrozze e comprarne un’altra.
Nelle “società a perdere” del mondo industrializzato, questo è uno scenario sempre più comune: il costo di riparazione di stereo, elettrodomestici, utensili elettrici e apparecchi di alta tecnologia supera il prezzo di comprarne di nuovi. Tra i risultati di lungo termine ci sono crescenti pile di rifiuti elettronici, discariche che straripano e sprechi di risorse ed energia. È uno dei motivi per cui lo statunitense medio genera più del 70 per cento di rifiuti solidi in più rispetto al 1960. [1] E i rifiuti elettronici – i componenti più tossici degli scarti domestici – stanno aumentando quasi sette volte in più rispetto ad altre forme di rifiuti. Nonostante gli sforzi di riciclaggio, un numero di telefoni cellulari stimato in 140 milioni – contenenti metalli preziosi pari a 60 milioni di dollari in valore e una quantità di materiali tossici – sono gettati ogni anno nelle discariche statunitensi. [2]
Assieme a questi costi ambientali ci sono anche impatti economici. Non molto tempo fa la maggior parte delle cittadine statunitensi aveva calzolai, gioiellieri che aggiustavano orologi da polso e da tavolo, sarti che riparavano e modificavano vestiti e attività di riparazione che rimettevano a nuovo tostapane, televisioni, radio e dozzine di altri elettrodomestici casalinghi. Oggi la maggior parte di queste attività è scomparsa. “È un commercio moribondo”, ha detto il proprietario di un negozio di riparazione di elettrodomestici del New Hampshire. “Elettrodomestici di basso livello che si possono comprare per 200 o 300 dollari sono fondamentalmente apparecchi a perdere”. [3] La storia è simile per altre attività di riparazione: negli anni ’40, ad esempio, gli Stati Uniti ospitavano circa 60.000 calzolai, un numero ridottosi a meno di un decimo oggi. [4]
Un motivo di questa tendenza è la globalizzazione. Le imprese hanno delocalizzato le loro attività di fabbricazione a paesi a bassi salari, rendendo le merci artificialmente a basso prezzo quando vendute nei paesi a salari più elevati. Quando quelle merci devono essere riparate, non possono essere rispedite in Cina o in Bangladesh, devono essere riparate dove i salari sono più elevati e le riparazioni sono perciò più costose. Il mio amico è rimasto confuso riguardo alla condizione della sua auto perché in India c’è la situazione contraria: la manodopera è a basso costo mentre sono costose le merci importate e nessuno si sognerebbe di buttare un’auto che potrebbe essere riparata.
È allettante scartare il declino delle riparazioni in occidente come un danno collaterale – semplicemente un altro costo non intenzionale della globalizzazione – ma l’evidenza suggerisce che in realtà è una conseguenza intenzionale. Per comprendere il perché è utile guardare alle particolari necessità del capitale nell’economia della crescita globale, necessità che hanno determinato la creazione della cultura consumistica appena più di un secolo fa.
Quando la prima auto Modello T uscì dalla catena di montaggio di Henry Ford nel 1910, gli industriali compresero che la tecnica poteva essere applicata non solo alle auto ma a quasi ogni altro prodotto fabbricato, rendendo la produzione di massa possibile in dimensioni in precedenza inimmaginabili. Il potenziale di profitto era praticamente illimitato, ma c’era un inghippo: non aveva senso produrre milioni di articoli – non importa quanto a basso costo – se non c’erano abbastanza compratori per essi. E nella prima parte del ventesimo secolo la maggioranza della popolazione – classe lavoratrice, rurale e varia – aveva scarso reddito disponibile, una vasta gamma di imposte e valori che imponevano frugalità e autosufficienza. Il mercato di merci manifatturiere era largamente limitato alle classi media e alta, gruppi troppo piccoli per assorbire una produzione di massa a tutto gas.
La pubblicità fu il primo mezzo cui l’industria ricorse per aumentare i consumi affinché corrispondessero all’enorme balzo della produzione. Anche se le pubblicità semplici erano in circolazione da generazioni non erano certo sofisticate come gli annunci nascosti di oggi. Attingendo alle idee di Freud la nuova pubblicità si concentrò meno sul prodotto e più sulla vanità e le insicurezze dei potenziali consumatori. Come segnala lo storico Stuart Ewen, la pubblicità contribuì a sostituire i consolidati valori statunitensi che sottolineavano la parsimonia con nuove norme basate su consumi cospicui. La pubblicità, a quel punto di portata nazionale, ha anche contribuito a cancellare differenze regionali ed etniche tra le diverse popolazioni locali degli Stati Uniti, imponendo in tal modo gusti di massa adatti alla produzione di massa. Mediante tecniche di commercializzazione sempre più sofisticate ed efficaci, dice Ewen, “gli eccessi sostituirono la parsimonia come valore sociale” e intere popolazioni furono investite di “un desiderio psichico di consumare”. [5]
In altri termini, era nata la cultura consumistica moderna, non come risposta all’avidità umana innata o alla domanda dei clienti, bensì alle necessità del capitale industriale.
Nel corso della Grande Depressione i consumi non riuscirono a tenere il passo con la produzione. In un circolo vizioso, la sovrapproduzione portò a fabbriche chiuse, lavoratori persero il posto e la domanda di produzione industriale scese ulteriormente. In tale crisi del capitalismo, nemmeno la pubblicità più ingegnosa avrebbe potuto stimolare i consumi in misura sufficiente a rompere il circolo.
Nel 1932 una nuova soluzione fu proposta da un mediatore immobiliare di Bernard London. Il suo opuscolo “Por fine alla depressione mediante l’obsolescenza programmata” plaudiva agli atteggiamenti di consumatori che la pubblicità aveva creato durante gli anni ’20, un periodo nel quale “il popolo statunitense non aspettava fino a quando da qualsiasi bene fosse ricavata l’ultima briciola di utilità. Sostituiva gli articoli vecchi con nuovi per motivi di moda e di modernità. Rinunciava alle case e alle auto vecchie ben prima che fossero logore” [6]. Al fine di aggirare i valori di parsimonia e frugalità che si erano riaffacciati durante la Depressione, London sosteneva che il governo doveva “registrare l’obsolescenza dei beni capitali e di consumo all’epoca della loro produzione … Dopo che il tempo assegnato era scaduto, quelle cose sarebbero legalmente ‘morte’ e sarebbero controllate dall’agenzia debitamente nominata dal governo e distrutte” [7]. La necessità di sostituire tali prodotti ‘morti’ avrebbe assicurato che la domanda sarebbe rimasta per sempre alta e che il pubblico – indipendentemente da quanto parsimonioso o soddisfatto dai suoi beni materiali – avrebbe continuato a consumare.
L’idea di London non attecchì immediatamente e la Depressione alla fine terminò quando le fabbriche inattive furono convertite alla produzione di armi e munizioni per la seconda guerra mondiale. Ma il concetto di obsolescenza programmata non scomparve. Dopo la guerra il suo maggior promotore fu il progettista industriale Brooks Stevens, che la considerò non come un programma governativo bensì come una caratteristica integrale della progettazione e della commercializzazione. “Diversamente dall’approccio europeo del passato che cercava di produrre il bene assolutamente migliore e farlo durare per sempre”, disse, “l’approccio negli Stati Uniti consiste nel rendere il consumatore statunitense insoddisfatto del prodotto che gli è piaciuto usare e … [e fargli voler] ottenere il nuovissimo prodotto con l’aspetto più nuovo possibile” [8].
La strategia di Brooks fu abbracciata da tutto il mondo industriale ed è tuttora in vigore oggi. Accoppiata a una pubblicità mirata a rendere i consumatori inadeguati e insicuri se non hanno il prodotto più recente o gli abiti alla moda al momento, l’enigma del parallelismo dei consumi con una produzione sempre crescente è stato risolto.
La costante sostituzione di merci altrimenti utili per nessun altro motivo che la “modernità” è più chiara all’apice dell’industria dell’abbigliamento, significativamente nota come industria della “moda”. Grazie al costante fuoco di sbarramento di messaggi mediatici e pubblicitari, persino i ragazzi più giovani temono di subire l’ostracismo se indossano abiti che non sono “fighi” abbastanza. Le donne, in particolare, sono state indotte a sentire che saranno sottovalutare se i loro abiti non sono sufficientemente all’ultimo grido. Non è solo la pubblicità che trasmette questi messaggi. Una delle trame di un episodio della serie televisiva degli anni ’90 “Seinfeld” aveva per protagonista una donna che commette il passo falso di indossare in diverse occasioni lo stesso abito, resa oggetto di una quantità di risate preregistrate. [9]
L’obsolescenza è stata una forza particolarmente potente nel mondo dell’alta tecnologia, dove l’arco di vita limitato delle apparecchiature digitali è spesso la conseguenza più dell’”innovazione” che del malfunzionamento. Con la potenza di calcolo raddoppia ogni diciotto mesi per molti decenni (un fenomeno così affidabile da essere noto come legge di Moore) i prodotti digitale diventano rapidamente obsoleti: come ha scritto uno scrittore di tecnologia: “In due anni il vostro nuovo smartphone potrebbe essere poco più che un fermacarte” [10]. Con i pubblicitari che bombardano il pubblico di annunci che affermano che questa generazione di smartphone è la definitiva per velocità e funzionalità, il tipico utente di cellulari acquista un telefono nuovo ogni ventuno mesi [11]. Superfluo dirlo: questo è grandioso per l’ultima riga del bilancio delle imprese dell’alta tecnologia, ma tremendo per l’ambiente.
L’innovazione può essere il mezzo principale attraverso il quale i prodotti di alta tecnologia sono resi obsoleti, ma i produttori non disdegnano l’uso di altri metodi. La Apple, ad esempio, rende intenzionalmente i propri prodotti difficili da riparare, salvo per la stessa Apple, in parte rifiutando di fornire informazioni sulle riparazioni riguardo ai propri prodotti. Poiché il costo della riparazione in fabbrica spesso si avvicina al costo di un prodotto nuovo, la Apple si assicura un sano flusso di entrate indipendentemente da ciò che il cliente decide di fare.
La Apple si è spinta anche oltre. In una causa collettiva contro la società è stato rivelato che gli iPhone 6 della società sono programmati per smettere di funzionare – in gergo “murati” – quando gli utenti li fanno riparare in laboratori non autorizzati (e meno costosi). “Non hanno mai rivelato che il vostro telefono potrebbe essere murato dopo riparazioni semplici”, ha detto un avvocato dei querelanti. “La Apple aveva intenzione … di forzare tutti i suoi consumatori a comprare prodotti nuovi semplicemente perché si recavano in un laboratorio di riparazione” [12].
In reazione a questa furfanteria dell’industria un certo numero di stati ha cercato di approvare leggi sulla “riparazione equa” che aiuterebbero i laboratori indipendenti a ottenere le parti e gli strumenti diagnostici di cui hanno bisogno, nonché gli schemi di come i dispositivi sono assemblati. Una legge simile è già stata approvata dal Massachusetts per agevolare i riparatori di auto indipendenti e agricoltori del Nebraska stanno lavorando per far approvare una legge simile relativa alle macchine agricole. Ma, eccettuata la legge del Massachusetts, una pesante attività di pressione dei fabbricanti – dalla Apple all’IBM a gigante delle macchine agricole John Deere – ha sinora ostacolato l’approvazione di leggi sul diritto alla riparazione. [13]
Dalla base un’altra reazione è stata l’ascesa di “caffè di riparazione” non a fini di lucro. Il primo è stato organizzato ad Amsterdam nel 2009 e oggi ce ne sono più di 1.300 altri in tutto il mondo, ciascuno con strumenti e materiali per aiutare le persone ad aggiustare abiti, mobili, elettrodomestici, biciclette, vasellame e altro, assieme a volontari specializzati che possono offrire aiuto, se necessario [14]. Queste iniziative locali non solo rafforzano i valori della parsimonia e dell’autonomia intenzionalmente erosi dal consumismo; collegano le persone con le loro comunità, ridimensionano l’uso di risorse ed energia scarse e riducono la quantità di materiali tossici gettati nelle discariche.
A un livello più sistemico c’è un urgente bisogno di mettere le redini al potere dell’industria ridisciplinando il commercio e la finanza. Trattati di liberalizzazione del “libero scambio” hanno dato alle imprese la capacità di localizzare le loro attività dovunque nel mondo, contribuendo ai prezzi distorti che rendono più economico comprare prodotti nuovi piuttosto che riparare quelli vecchi. Questi trattati rendono anche più facile per le imprese penetrare non solo le economie del Sud globale, ma anche la psiche delle loro popolazioni, contribuendo a trasformare miliardi di altre persone autonome in consumatori insicuri avidi dei beni standardizzati, prodotti in massa dall’industria. La diffusione della cultura consumistica può aiutare il capitale globale a soddisfare la sua necessità di una crescita infinita, ma certamente distruggerà la biosfera; il nostro paese non è in grado di sostenere sette miliardi di persone che consumano al ritmo folle del nostro mondo “sviluppato”, e tuttavia tale obiettivo è implicito nella logica dell’economia globale.
Dobbiamo anche opporci – con le parole e gli atti – alle forze del consumismo nelle nostre stesse comunità. La cultura consumistica globale non è solo motore del cambiamento climatico, dell’estinzione di specie, di zone oceaniche morte e di molte altre aggressioni alla biosfera; alla fine non soddisfa reali bisogni umani. Il prezzo della cultura consumistica non si misura in beni a buon prezzo che riempiono le nostre case e poi, sin troppo presto, la discarica più vicina. Il suo costo reale è misurato in termini di patologie alimentari, epidemie di depressione, accresciuta conflittualità sociale e tassi crescenti di dipendenza, non solo dagli oppiacei, ma dagli ‘acquisti’, dai videogiochi e da Internet.
È ora di concepire – e compiere passi per creare – un’economia che non distrugga le persone e il pianeta solo per soddisfare gli imperativi di crescita del capitale globale.
NOTE
[1] EPA Report on the Environment, Municipal Solid Waste, https://cfpub.epa.gov/roe/indicator_pdf.cfm?i=53; Center for Sustainable Systems, “Municipal Solid Waste Factsheet,” http://css.snre.umich.edu/factsheets/municipal-solid-waste-factsheet
[2] National Public Radio, “The Continent that Contributes the Most to E-Waste is…”, January 26, 2017. http://www.npr.org/sections/goatsandsoda/2017/01/26/511612133/the-continent-that-contributes-the-most-to-e-waste-is
[3] “Irreparable Damage”, Washington Times, Jan 9, 2007. http://www.washingtontimes.com/news/2007/jan/9/20070109-121637-4917r/
[4] Morris, Natalie, “Fewer shoe repair shops mean business for those remaining”, Wall Street Journal, March 5, 2012. http://www.sj-r.com/x1644228326/; “Shoe Repair in the US: Market Research Report”, IBIS World, Apr 2017, https://www.ibisworld.com/industry-trends/market-research-reports/other-services-except-public-administration/repair-maintenance/shoe-repair.html
[5] Ewen, Stuart, Captains of Consciousness: Advertising and the Social Roots of the Consumer Culture(New York: McGraw-Hill, 1976).
[6] London, Bernard, 1932, “Ending the Depression Through Planned Obsolescence”. https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/27/London_(1932)_Ending_the_depression_through_planned_obsolescence.pdf
[7] Ibid.
[8] Pyramids of Waste: The Light Bulb Conspiracy, 2010, a documentary film by Cosima Dannoritzer. Viewed at FilmsforAction.org. http://www.filmsforaction.org/watch/pyramids-of-waste-2010/
[9] Seinfeld, “The Seven”, episode 13, season seven. Aired February 1, 1996.
[10] Walton, Andy, “Life Expectancy of a Smartphone”, Houston Chronicle, http://smallbusiness.chron.com/life-expectancy-smartphone-62979.html
[11] ibid.
[12] Beres, Damon, and Andy Campbell, “Apple is Fighting a Secret War to Keep You from Repairing Your Phone”, Huffington Post, June 9, 2016. http://www.huffingtonpost.com/entry/apple-right-to-repair_us_5755a6b4e4b0ed593f14fdea
[13] Solon, Olivia, “A Right to Repair: Why Nebraska Farmers are Taking on John Deere and Apple”, The Guardian, March 6, 2017, https://www.theguardian.com/environment/2017/mar/06/nebraska-farmers-right-to-repair-john-deere-apple. Beres, Damon, “Big Tech Squashes New York’s ‘Right to Repair’ Bill”, Huffington Post, June 17, 2016. http://www.huffingtonpost.com/entry/apple-right-to-repair_us_5755a6b4e4b0ed593f14fdea
[14] https://repaircafe.org/en/about/
Riferimenti
 «Vivere nell’emergenza significa inseguire gli eventi, farsi coinvolgere e trasportare come una canna al vento da ciò che accade ». il manifesto, 14 luglio 2017 (c.m.c.)
«Vivere nell’emergenza significa inseguire gli eventi, farsi coinvolgere e trasportare come una canna al vento da ciò che accade ». il manifesto, 14 luglio 2017 (c.m.c.)
Vorrei scrivere un articolo sugli incendi a gennaio, in mezzo alla neve, quando è il momento per pensarci seriamente ed attrezzarsi. Come fa l’industria della moda, che presenta i nuovi abiti una stagione prima, come succede in generale in un’ impresa di medie dimensioni che programma le innovazioni. E invece se ne parla d’estate, come è successo tante volte in passato: nel 2001, nel 2003, la peggiore stagione per gli incendi in Europa, nel 2007 e nel 2010.
Ogni estate gli incendi, un fenomeno sociale e non naturale (non esiste l’autocombustione se non in circostanze eccezionali), colpisce il nostro paese distruggendo foreste, macchia mediterranea e terreni coltivati, ma l’opinione pubblica se ne accorge solo quando viene superata una certa soglia e scatta la parola magica: emergenza.
Vivere nell’emergenza significa inseguire gli eventi, farsi coinvolgere e trasportare come una canna al vento da ciò che accade. Il termine “emergenza” evoca situazioni eccezionali, abnormi, destinate a suscitare paura e preoccupazione generale.
E serve, in primo luogo, a spostare l’attenzione dell’opinione pubblica, a bloccare o a rallentare quel processo di obsolescenza dell’informazione, a riportare verso l’alto la curva di Vernon applicata alla merce “informazione”.
E così si è parlato di “emergenza” per: il maltempo, il terrorismo, la disoccupazione giovanile, l’inflazione (anni ’70), la deflazione (in questo decennio), la radioattività, i terremoti, la siccità, le alluvioni, l’immigrazione (over all), e chi più ne ha più ne metta.
Emergenza e normalità si scambiano spesso le parti: ciò che sarebbe normale in quanto conseguenza di un certo modello di sviluppo diventa eccezionale, e viceversa ciò che è eccezionalmente grave e insostenibile (come la corsa agli armamenti o il salvataggio delle banche mentre una parte rilevante della popolazione vive sotto la soglia di povertà) diviene del tutto scontato e regolare. E’ normale che siano morti 6 milioni di congolesi per guerre intestine e fame nell’ultimo decennio, o centinaia di migliaia di yemeniti vittime di una guerra devastante quanto ignorata dai media, ed invece è «emergenza sempre più urlata ogni sbarco di migranti sulle nostre coste.
Scriveva profeticamente un noto politologo nordamericano : «L’esistenza di emergenze da fronteggiare è per la classe politica nel suo insieme condizione della sua stessa esistenza : l’unico mezzo per conquistare spazio e legittimità e contrastare il declino della partecipazione politica, la crisi delle ideologie, la tendenziale omogenizzazione dei partiti, la concorrenza rappresentata dalla molteplicità degli stimoli e delle informazioni» (A. Wolfe, 1981).
E così accade che ogni volta, all’arrivo di un’estate più calda del solito, all’estendersi delle terre bruciate dal fuoco, per qualche giorno tutti si occupano degli incendi per poi voltare pagina e dimenticarsene fino alla prossima, bollente estate.
Personalmente questo fatto mi è ancora più insopportabile per avere sperimentato con successo, nel Parco nazionale dell’Aspromonte, un metodo di lotta agli incendi che costa poco ed è efficace. In passato ne parlarono tutti i telegiornali nazionali ed i principali organi di stampa, ma senza che servisse a modificare l’approccio prevalente. Si tratta di un principio semplice: ricreare quel rapporto tra popolazione e territorio, che c’era in passato prima dello spopolamento delle campagne e montagne, attraverso i «contratti di responsabilità territoriale» che puntano ad uno spegnimento immediato dei fuochi. Recita un proverbio francese più o meno così : per spegnere un incendio dopo dieci secondi basta un bicchiere d’acqua, dopo un minuto ci vuole un secchio d‘acqua, dopo un’ora bisogna chiamare i pompieri.
Contratti di responsabilità territoriale che avevamo esteso anche alla raccolta rifiuti nei boschi, ma che dal 2005, quando il ministro Matteoli mandò un commissario, furono cancellati con la motivazione esilarante: di incendi e rifiuti se ne deve occupare la Regione Calabria. I risultati sono sotto gli occhi di tutti: le foreste aspromontane sono ridotte a pattumiera ed il controllo degli incendi con il metodo della responsabilità territoriale è ripreso solo negli ultimi anni, ma con un budget fortemente ridotto.
Dopo la tragedia del 2003 che causò oltre 25000 morti in Francia per l’anomala ondata di calore e provocò incendi spaventosi dal Portogallo fino all’Italia e Grecia, fui invitato a Bruxelles da una Commissione istituita ad hoc, che espresse grande interesse per il metodo Aspromonte, me lo rinnovò nel 2005 e poi non ne seppi più niente.
Non si tratta di un metodo perfetto, ma perfettibile, che nel tempo ha aggiunto al coinvolgimento delle associazioni ambientaliste e di protezione civile quello di un rapporto di responsabilità con contadini e pastori nella difesa territoriale.
E’ una sfida che ci riguarda tutti ma che richiede una uscita/liberazione dalla catena delle emergenze. Abbiamo bisogno di programmare la difesa territoriale in tutti i campi, tenendo conto che registreremo sempre più “eventi estremi” legati al mutamento climatico in corso con cui fare i conti. E’ un’altra politica unitamente ad un’altra informazione , che non stia solo sul pezzo, quella di cui abbiamo estrema necessità.

Un'altra prevaricazione dell'economia (capitalistica) sul diritto. L'erogazione dell'acqua è un servizio pubblico di "rilevanza economica" che deve assoggettarsi alle regole di mercato, non c'è diritto che tenga. economiaepolitica, 10 luglio 2017 (i.b)
Qualche settimana fa il Consiglio di Stato ha respinto, in via definitiva, i ricorsi presentati dal Codacons, da Federconsumatori e dall’Associazione Acqua Bene Comune Onlus contro il metodo tariffario approvato nel 2012 dall’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico (Aeegsi) per calcolare la tariffa che gli utenti devono pagare ai loro gestori per la fornitura e il trattamento delle acque.
Le associazioni dei consumatori e i proponenti dei referendum per l'acqua pubblica del 2011 lamentavano il fatto che l’Aeegsi non avesse rispettato, nell’elaborazione dei metodi di calcolo, gli esiti del secondo referendum che aveva abolito dal calcolo delle tariffe idriche l’«adeguatezza della remunerazione del capitale investito» con il voto di oltre 26 milioni di italiani.
Volendo riassumere brevemente le motivazioni del Consiglio di Stato, si potrebbe dire che, secondo il supremo giudice amministrativo, ai sensi della normativa italiana ed europea attualmente in vigore il servizio idrico è un servizio ‘a rilevanza economica’ e, dunque, anche per tale servizio vale la regola per cui tutti i costi devono essere coperti dalla tariffa secondo il principio del “full cost recovery”. In presenza di tale principio, il diritto deve fare un passo indietro e lasciare il campo alla scienza economica che è la sola legittimata a stabilire quali voci di spesa rientrino effettivamente tra le nozioni di costo e, di conseguenza, debbano essere coperte dalla tariffa e pagati dagli utenti finali.
Non è un caso, dunque, che per stabilire la correttezza del metodo di calcolo delle tariffe, il Consiglio di Stato abbia affidato a un collegio peritale composto da tre professori di economia industriale il compito di stabilire se le formule e i parametri adottati dall’ Aeegsi, per disciplinare la componente tariffaria relativa agli “Oneri finanziari del gestore del Servizio idrico integrato «rientrino, o meno, entro i limiti di attendibilità e di ragionevolezza del settore tecnico-scientifico che qui viene in rilievo, sotto il profilo della loro idoneità a riflettere la componente tariffaria strettamente limitata alla copertura dei costi di capitale proprio investito» [1]
Il collegio peritale – composto da tre professori uno della Sapienza Università di Roma, uno dell’Università di Roma Tor Vergata e uno dell’Università LUISS “Guido Carli”, designati dai rispettivi Rettori – ha stabilito che «le formule e i parametri diretti a calcolare il tasso di interesse di riferimento e la componente di copertura della rischiosità rientrano nei limiti di attendibilità e di ragionevolezza del settore tecnico-scientifico dell’economia industriale, sotto il profilo della loro idoneità a riflettere la componente tariffaria strettamente limitata alla copertura dei costi del capitale investito. Inoltre, sono in linea con le pratiche della regolamentazione in ambito nazionale ed internazionale» [2]
Insomma gli interessi sul capitale proprio investito si devono pagare in ogni caso perché rientrano nel principio di totale copertura dei costi come ci insegna la scienza ‘esatta’ dell’economia industriale.
Non vi può essere, dunque, alcuna attività a rilevanza economica che escluda dai propri conti il costo del capitale proprio investito e nessun referendum popolare potrebbe stabilire il contrario.
Del resto il quesito referendario del 2011, secondo l’interpretazione del Consiglio di Stato, è stato pienamente rispettato, dal momento che la remunerazione del capitale investito non deve essere più «adeguata» e, dunque, non assicura una posizione di ‘rendita’ prefissata una volta per tutte dal legislatore, ma è stabilita direttamente dai mercati finanziari e trasferita poi nella tariffa idrica attraverso la complicata formula matematica elaborata dall’Aeegsi che garantisce agli utenti finali l’assenza di aggravi o duplicazioni e cioè la piena economicità del servizio.
Insomma il secondo quesito referendario del 2011 è stato del tutto inutile: il servizio idrico è un servizio pubblico locale a rilevanza economica da gestire secondo le leggi del mercato. Non basta eliminare l’adeguatezza della remunerazione del capitale per rendere il governo e la gestione dell’acqua estranei alle logiche del profitto.
Ciò è il segnale di un processo molto preoccupante e ancora in corso: il progressivo appiattirsi del diritto sulla scienza economica. Tale processo avviene in due modi: da un lato attraverso un’interpretazione della normativa in vigore che privilegia le ragioni dell’efficienza economica su quelle della natura del servizio pubblico, dall’altro con l’ingresso diretto della scienza economica, attraverso lo strumento della consulenza tecnica, all’interno della decisione giudiziaria.
Il primo punto è stato messo in luce già qualche anno fa dal giurista francese Alain Supiot che ne aveva individuato le ragioni nel fatto che «La struttura linguistica e il mercato appaiono dunque oggi come i due punti di riferimento attorno ai quali le scienze sociali strutturano la loro ricerca delle leggi sotterranee che governano le questioni umane» [3]. La prova di ciò sta nel fatto che proprio la locuzione “rilevanza economica” applicata al servizio idrico integrato funge da paradigma linguistico attraverso cui il mercato entra prepotentemente nel settore dell’acqua. Tale locuzione dal punto di vista del diritto ha una duplice funzione, da un lato, serve a far rientrare anche i servizi idrici all’interno dei servizi pubblici locali in regime di libera concorrenza sia pure di concorrenza per il mercato e non di concorrenza nel mercato; dall’altro, serve a far rientrare la materia dell’affidamento dei servizi idrici all’interno della competenza esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza. Sono questi i motivi per i quali il legislatore italiano nel 2003 ha sostituito il concetto di «rilevanza industriale» con quello più ampio e indefinito di «rilevanza economica» per definire le caratteristiche di quei settori nell’ambito del servizio pubblico locale nei quali si doveva procedere con affidamenti mediante procedure ad evidenza pubblica [4].
Il secondo punto, cioè quello che si riferisce all’ingresso diretto della scienza economica nelle decisioni che riguardano la gestione del servizio idrico, trova la sua prova inconfutabile proprio nel fatto che i giudici del Consiglio di Stato si affidano alla consulenza tecnica di tre economisti per definire se le tariffe idriche vengono calcolate correttamente attraverso il metodo elaborato dall’Aeegsi. Solo la scienza economica può dire, infatti, al diritto come comportarsi per il calcolo delle tariffe determinando così una vera e propria identificazione della razionalità giuridica con quella economica.
La scelta politica viene così affidata esclusivamente al mercato senza lasciare alcuno spazio per una allocazione alternativa delle risorse affidata ad una diversa gerarchia di valori come quella che sta alla base della scienza giuridica.
Anche questo rischio era stato identificato qualche anno fa da un sociologo da poco scomparso, Ulrich Beck, il quale aveva sottolineato come le decisioni su come guidare i processi di investimento non sono tanto il risultato di una decisione diretta dei vertici imprenditoriali, quanto un effetto collaterale: «È importante sottolineare che il metapotere di indirizzare gli investimenti non dipende da vertici manageriali che perseguono attivamente un disegno politico. Piuttosto, accade loro di fare “politica” come effetto collaterale. Il loro coinvolgimento non è né politico né non-politico è una sorta di sub-politica globale» [5].
Resta il problema di capire fino in fondo quali siano i modi per evitare la concentrazione delle risorse finanziarie in un settore quale quello dell’acqua in cui la progressiva “depubblicizzazione” ha permesso l’ingresso di un numero rilevante di operatori privati. La strategia finora messa in campo dal Forum dei movimenti per l’acqua è stata quella di contrastare i processi di privatizzazione attraverso tutti gli strumenti giuridici a disposizione: prima con il ricorso a una legge di iniziativa popolare, che non è stata mai discussa dal Parlamento, poi promuovendo i referendum popolari del 2011, i cui esiti sono stati neutralizzati dal legislatore. Anche l’ultima forma di resistenza, quella di rivolgersi alla magistratura amministrativa contro le decisioni dell’Aeegsi ha portato a una sonora sconfitta.
Insomma si potrebbe dire che se gli italiani con il referendum del 2011 avevano provato a tirar fuori l’acqua dal sistema di mercato, ma l’intento non è stato raggiunto anche perché il collegio degli esperti di economia aziendale ha contribuito a far rientrare dalla finestra ciò che era uscito dalla porta: la teoria microeconomica dominante riconosce anche la remunerazione del capitale come esito spontaneo del mercato.
Si potrebbe dire, con Karl Polanyi, che una volta istituito il sistema di mercato «deve essere lasciato funzionare senza interferenze esterne. I profitti non sono più garantiti ed il commerciante deve realizzarli sul mercato. Si deve anche permettere che i prezzi si regolino da soli, ed un tale sistema autoregolato di mercati è ciò che intendiamo per economia di mercato» [6].
Tenendo conto del fatto che i referendum sull’acqua sono stati in grado di portare alle urne ventisei milioni di italiani in un periodo di elevata astensione politica, l’idea di una gestione pubblica dell’acqua potrebbe essere ancora in grado di smuovere una vasta partecipazione politica diretta a realizzare la redistribuzione dei benefici derivanti dall’utilizzo di una risorsa che va facendosi sempre più scarsa e, per questo, sempre più preziosa per l’intera comunità degli utenti, compresi quelli delle generazioni future.
Note
[1] Consiglio di Stato, sent. n. 2481 del 26 maggio 2017.
[2] Consiglio di Stato, sent. n. 2481 del 26 maggio 2017.
[3] A. Supiot, Homo juridicus. Saggio sulla funzione antropologica del diritto, Milano, 2006, p. 92.
[4] Mi si consenta di rinviare sul punto a S. Marotta, Le tariffe del servizio idrico integrato dopo il referendum, in «Munus», n. 3/2012, pp. 657-666.
[5] U. Beck, La società cosmopolita. Prospettive dell’epoca postnazionale, Bologna, Il Mulino, 2003, p. 233.
[6] K. Polanyi, La grande trasformazione, Einaudi, Torino, 1974, p. 56.
Riferimenti
Nelle cartelle di eddyburg
"Clima e risorse" e
"Clima e risorse*" si possono leggere gli articoli relativi sia alla campagna referendaria che alle conseguenze della privatizzazione dell'acqua pubblica.
«Nelle ultime settimane diversi impianti di trattamento sono andati a fuoco. Un caso o una strategia per fare affari?» il Fatto Quotidiano, 7 luglio 2017 (p.d.)
A chi giovano i roghi dei rifiuti?
6 aprile, La Loggia (To) La Cmt, piattaforma di trattamento e stoccaggio dei rifiuti appartenente al Gruppo San Germano al 100%, si incendia per la terza volta negli ultimi quattro anni. Il gruppo San Germano detiene Pluricart al 65% tramite CMT e la Tirreno ambiente Spa per una quota pari al 2%. La Tirreno ambiente Spa è detenuta per un 10% dalla Gesenu (incendiatasi nel 2015) appartenente alla galassia Cerroni e per un 3% dalla A2A. Il gruppo San Germano ha sede a Mazzarà Sant’Andrea (Messina) e il suo ex presidente Giambò è stato condannato per associazione mafiosa. Procedimenti penali per reati contro la Pubblica amministrazione sono in corso a carico di amministratori, presenti o passati, della Tirreno ambiente Spa.
12 aprile, Grosseto Incendio impianto trattamento rifiuti di Futura Spa alle Strillaie, tra Grosseto e Marina di Grosseto. A fuoco i rifiuti destinati a diventare combustibile da rifiuti.
16 aprile, Follo (Sp) Un vasto incendio scoppia all’interno dell’azienda Ferdeghini, l’impianto di trattamento rifiuti che si occupa della selezione, del recupero e dello stoccaggio di materiali pericolosi e non, situato a Cerri, nel Comune di Follo. Già il 5 luglio 2015 l’azienda aveva preso fuoco nonostante gli abitanti vicini avessero presentato una diffida per l’enorme accumulo di rifiuti nei giorni precedenti l’incendio.
5 maggio, Pomezia (Rm) Scoppia l’incendio della Eco X, presso cui risultavano stoccate ingenti quantità di rifiuti. Caso ampiamente trattato dalla stampa nazionale e su cui sono in corso indagini della Procura di Velletri.
24 maggio, Bedizzole (Bs) Incendio alla Faeco già interessata da simili episodi nel luglio 2013, e nel marzo 2017. L’incendio èavvenuto nell’area sottoposta a sequestro due mesi prima.
25 maggio, Malagrotta (Rm) Le fiamme hanno interessato un deposito di combustibile prodotto con i rifiuti che poi viene mandato nei termovalorizzatori.
5 giugno, Casale Bussi (Vt) Incendio nell’impianto di trattamento rifiuti di Casale Bussi, a Viterbo. La Procura della Repubblica di Viterbo ha aperto un fascicolo per incendio doloso.
7 giugno, Fusina (Tv) Incendio alla Eco Ricicli Veritas, il più grande centro comprensoriale del Conai Corepla in Italia con oltre 2500 tonnellate al mese di multimateriale che poi vengono aggiudicate mediante asta Corepla per divenire combustibile da rifiuti, conferito ad impianti nei 300 km di distanza. Eco ricicli Veritas conferisce rifiuti a Montello spa e a Idealservice. Quest’ultima azienda nel 2015 ha subito un incendio.
11 giugno, Battipaglia (Sa) A Battipaglia si sviluppa un incendio presso la Sele Ambiente, già precedentemente posta sotto sequestro dall’autorità giudiziaria, per il coinvolgimento in una inchiesta su un vasto giro di smaltimento illecito tra la Campania e la Puglia.
14 giugno, Villacidro (Ca) A fuoco la discarica Villaservice di Villacidro, discarica di servizio del Tecnocasic, altro impianto fuori uso per un incendio da fine aprile.
19 giugno, Angri (Sa) A fuoco l’impianto di trattamento dei rifiuti speciali non pericolosi di Sea Srl, con sede legale a Scafati.
Certo, tutto è possibile: incidenti, autocombustione, intimidazioni locali ecc. Ma, francamente, così tanti incendi, in tre mesi, in impianti di trattamento rifiuti sembrano un po’troppi. Tanto più che questa epidemia di incendi sembra ricorrente, e proprio quando la stagione calda e le alte temperature possono giustificare gli incendi con l’autocombustione.Sorge, quindi, spontaneo il sospetto che almeno alcuni di questi incendi servano a risolvere situazioni divenute ingombranti o pericolose per le stesse imprese andate a fuoco. Tanto più che, come abbiamo visto, spesso l’incendio è collegato ad altre attività del settore che hanno subito o un’ispezione o un sequestro o un altro incendio e fanno capo a persone già note per illegalità connesse al trattamento e alla raccolta dei rifiuti.
In questo quadro, le motivazioni più probabili sono quelle collegate al profitto derivante dal contributo economico erogato dai consorzi obbligatori di settore, per cui le imprese “riceventi” possono trovare più conveniente incamerare il contributo e disfarsi in qualche modo del materiale senza sostenere i costi che la sua lavorazione/smaltimento legale comporterebbero. Emblematico in tal senso è il caso del consorzio nazionale tedesco degli imballaggi, il DSD, il quale, nella seconda metà degli anni 90, inviava in tutta Europa rifiuti di plastica, spesso di scarsissima qualità e quindi difficilmente riciclabili, accompagnati da un sostanzioso contributo economico. Molti furono allora i casi, anche in Italia, di imprese che, incassati i contributi e riempiti capannoni spesso affittati ad hoc, trovarono più conveniente “chiudere la pratica”appiccando il fuoco piuttosto che affrontare i costi necessari per tentare ardue e in certe operazioni di riciclo o di smaltimento.
Un incendio, in particolare, può servire a evitare controlli su combustibile da rifiuti prodotto al di fuori delle specifiche di legge, per cui l’impresa ha, tuttavia, già percepito contributo all’ingresso del rifiuto. O a evitare che si scopra che l’impresa ha ricevuto contributi per rifiuti non idonei o non autorizzati fatti figurare in ingresso con falsi codici. Non a caso, la termovalorizzazione viene incentivata a 220 euro alla tonnellata mentre per il riciclo l’incentivo è di 170 euro.
E probabilmente questi incendi sono aumentati da quando la Cina ha stretto i freni sulla qualità dei rifiuti italiani che prima accettava senza problemi. Peraltro, incendiare un rifiuto significa trasformarlo in rifiuto pericoloso che deve essere smaltito in apposite discariche, spesso di proprietà delle stesse imprese da cui deriva. Ma la conseguenza più grave riguarda, ovviamente, la salute e l’ambiente, per la produzione di diossina e altri inquinanti altamente pericolosi. Proprio per scoraggiare questi eventi, nel 2013 un decreto legge ha stabilito finalmente che chi appicca il fuoco a rifiuti rischia la reclusione da 2 a 5 anni con aumento da 3 a 6 anni se i rifiuti sono pericolosi.
Tuttavia, questa pena si applica solo se si tratta di rifiuti “abbandonati, ovvero depositati in maniera incontrollata”. Trattasi di una specificazione veramente singolare e poco comprensibile, perché un incendio di rifiuti stoccati ordinatamente produce gli stessi effetti dannosi di un incendio di rifiuti abbandonati. E potrebbe portare addirittura alla conclusione che questo delitto non può applicarsi a chi appicca il fuoco, appunto, a rifiuti non abbandonati ma depositati non in modo incontrollato nel suo impianto.
Forse sarebbe il caso di intervenire al più presto per correggere questa evidente stortura legislativa invece di dedicarsi, coma fa il governo nel recente decreto legge sul Mezzogiorno, a “graziare” rifiuti fino a oggi ritenuti pericolosi, con palese violazione del principio di precauzione.
Un altra diga in Tanzania modificherà il sistema idrico privando le regioni delle inondazioni stagionali, vitali per le popolazioni. Ambientalisti, gestori di Safari e abitanti contro il progetto, greenMe.it, 28 giugno 2017, (i.b.) con postilla
Non si arresta la protesta delle popolazioni indigene contro la costruzione di un’enorme diga idroelettrica in uno dei più grandi polmoni verdi dell’Africa. Accanto a loro gli ambientalisti che temono che la costruzione causerà danni irreversibili alla riserva Selous in Tanzania. Sono sempre più minacciati gli indigeni, costretti a lottare contro multinazionali e governi compiacenti, pur di difendere le loro terre ancestrali, diventate ormai solo fazzoletti invivibili.
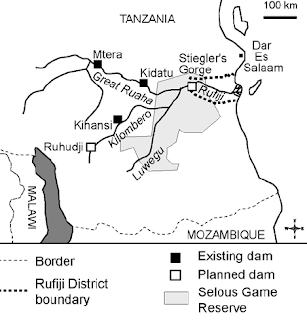 |
| Il fiume Rufiji con dighe esistenti e future. Estratto da un articolo di Duvail et at (2013) |
Non si arresta la protesta delle popolazioni indigene contro la costruzione di un’enorme diga idroelettrica in uno dei più grandi polmoni verdi dell’Africa. Accanto a loro gli ambientalisti che temono che la costruzione causerà danni irreversibili alla riserva Selous in Tanzania. Sono sempre più minacciati gli indigeni, costretti a lottare contro multinazionali e governi compiacenti, pur di difendere le loro terre ancestrali, diventate ormai solo fazzoletti invivibili. Dopo anni di ritardo e false partenza, in questi giorni il presidente della Tanzania John Magufuli ha annunciato che la diga Gola Stiegler sul fiume Rufiji, si farà.
E non c’è da stare tranquilli perché dalla sua elezione nel 2015, Magufuli soprannominato ‘il bulldozer’, è conosciuto soprattutto, per il suo record di infrastrutture costruite.Dopo anni di ritardo e false partenza, in questi giorni il presidente della Tanzania John Magufuli ha annunciato che la diga Gola Stiegler sul fiume Rufiji, si farà. E non c’è da stare tranquilli perché dalla sua elezione nel 2015, Magufuli soprannominato ‘il bulldozer’, è conosciuto soprattutto, per il suo record di infrastrutture costruite. Poca attenzione per l’ambiente, a fronte del profitto. La diga sorgerà, infatti, nel cuore del Selous, una riserva naturale che ha una superficie pari a quella della Svizzera. Un’oasi per elefanti, ghepardi, coccodrilli e giraffe che vivono a due passi dalle popolazione indigene.
Un luogo diventato Patrimonio Unesco, ma dichiarato anche in pericolo, a causa del bracconaggio. Adesso, arriva questa ennesima scure: la diga che fornirà 2100 MW di energia elettrica in un paese che sta soffocando. “Siamo molto preoccupati per la costruzione della diga che avrà un impatto negativo sul sito. Bisogna già lottare contro tutte le attività illegali che mettono in pericolo la vita degli animali, tra cui il rinoceronte nero e degli indigeni”, dice Remco van Merm dell'Unione Internazionale per la Conservazione della Natura.
“Questo tipo di progetti vengono giustificati dal fatto che forniranno energia elettrica e vengono inquadrati come misure poco impattanti. In realtà, che senso ha una costruzione che distrugge la riserva e limita la sopravvivenza dei popoli locali?”, dice Thabit Jacob, specialista in Energia e Ambiente.“Questo tipo di progetti vengono giustificati dal fatto che forniranno energia elettrica e vengono inquadrati come misure poco impattanti. In realtà, che senso ha una costruzione che distrugge la riserva e limita la sopravvivenza dei popoli locali?”, dice Thabit Jacob, specialista in Energia e Ambiente.
A luglio, il Comitato del Patrimonio mondiale si riunirà insieme al governo della Tanzania per trovare una soluzione e per chiedere ancora una volta che il progetto venga abbandonato perché non è compatibile con lo status di riserva protetta.
postilla
Con il nuovo boom delle dighe idroelettriche, anche i buoni propositi per una gestione integrata e sostenibile delle risorse idriche, che tanto consenso hanno avuto, vengono messi da parte. Questa gestione che dovrebbe promuovere lo sviluppo e la gestione coordinata dell'acqua, del suolo e delle risorse correlate, al fine di massimizzare un benessere sia economico che sociale senza compromettere la sostenibilità degli ecosistemi vitali e dell'ambiente, da grande importanza ai flussi e alle portate dei fiumi. Non solo riguardo al mantenimento dei flussi minimi, ma anche al mantenimento dei flussi di punta e a tutti quei ecosistemi legati alle inondazioni.
Sono proprio la diminuzione delle inondazioni che modificheranno profondamente il funzionamento dei laghi della regione, mettendo a rischio la sopravvivenza delle popolazioni circostanti.
Meno male che oltre agli interessi delle popolazioni povere circostanti sono a rischio anche il turismo legato ai Safari e un Patrimonio Unesco, altrimenti di questi “dannati dello sviluppo” non ne sapremmo mai l’esistenza. (i.b.)

Espropriazione dei beni comuni in Polonia, la destra populista autorizza il disboscamento dell’ultima foresta vergine Europea, il Manifesto, 4 Luglio, (i.b.)
Una parte della Polonia piange i suoi alberi e lancia un appello alla comunità internazionale. La speranza è quella che la Conferenza del Patrimonio mondiale, in programma a Cracovia fino al prossimo 12 luglio, possa sensibilizzare l’Unesco sul disboscamento di Bialowieza, l’unica foresta vergine rimasta sul continente europeo, vittima di un piccolo coleottero, il bostrico e del governo.
Negli ultimi mesi la mobilitazione ha portato diversi attivisti, alcuni dei quali giunti da Romania e Repubblica Ceca, a incatenarsi agli alberi, mentre altri hanno provato a ostacolare le cesoie forestali al lavoro. Adesso sono arrivati anche i primi fermi e multe. C’è ancora una parte del paese capace di indignarsi e che spera in un «Rospuda-bis», quando nel 2009 dopo otto anni di battaglie, il governo fu costretto a deviare il percorso di un’autostrada che sarebbe dovuta passare attraverso l’omonima valle. Le proteste cracoviane culmineranno in un happening previsto nella giornata di oggi. Una mobilitazione che porterà in strada numerose sigle e Ong: Greenpeace, Wwf, ma anche Fundacja Dzika Polska, Greenmind e Pracownia na rzecz Wszystkich Istot.
Il ministro dell’ambiente polacco Jan Szyszko ha dichiarato che l’argomento non è finito in agenda a Cracovia. Ma l’Unesco starebbe valutando proprio in questi giorni l’invio di un’altra missione di monitoraggio a Varsavia.
Quasi la metà della foresta, che si estende per oltre 3.000 km² tra Polonia e Bielorussia, è protetta come parco nazionale. La presenza di zone cuscinetto e di oasi protette all’interno di Bialowieza, contribuisce a disegnare una mappa amministrativa complessa del parco, dove lo sfruttamento per uso commerciale dei boschi, ai margini dell’aree strettamente protette, è comunque consentito. E lì che il governo della destra populista Diritto e giustizia (PiS) ha deciso l’anno scorso di triplicare il limite al volume di legno recuperabile da Bialowieza. Un’iniziativa, che con buona pace anche degli entomologi, mette a repentaglio tutta la biosfera della foresta. La decisione è stata giustificata dalla diffusione incontrollata del bostrico o tipografo dell’abete rosso, che continua a lasciare il segno in tutti i boschi europei. Abbattere gli alberi di Bialowieza «è il male minore», secondo il ministro Szyszko.
A fare il gioco del partito fondato dai fratelli Kaczynski, c’è anche l’allarmismo di una certa stampa locale che tende a presentare la diffusione del bostrico alla stregua di un’epidemia incontrollabile. Eppure, uno studio del 2008 sull’impatto del bostrico nel parco nazionale di Sumava in Repubblica ceca, ha mostrato un maggior impoverimento del sottobosco nelle aree sottoposte a un abbattimento preventivo. Più in generale, buona parte della comunità scientifica concorda sul fatto che gli alberi vittime del bostrico e il legno morto dovrebbero restare al proprio posto: i tronchi vecchi o caduti attaccati dal tipografo infatti trasformano il legno in humus. Ed è proprio questo a preoccupare maggiormente il governo che non intende rinunciare allo sfruttamento della legna. Che finisca nei camini o venga venduta ai mobilifici poco importa.
La strategia perseguita dal PiS a Bialowieza è solo uno dei tasselli nella disastrosa politica ambientale del governo. Un esempio, la cosiddetta lex Szyszko approvata in sordina dalla maggioranza a dicembre scorso. Il provvedimento in vigore nel 2017 ha autorizzato l’abbattimento degli alberi su un suolo privato senza il via libera della autorità locali. Mettendo insieme i dati raccolti sul territorio polacco si stima che le motoseghe abbiamo fatto fuori almeno 300.000 alberi dall’inizio di quest’anno. Una sorta di condono ecologico «a tempo» durato cinque mesi prima che il governo ponesse nuovamente alcune restrizioni in materia. Il maggior beneficiario delle politiche di Szysko è l’Azienda delle foreste statali polacche, Lasy Panstwowe, che gestisce per conto del governo una superficie pari quasi al 30% del paese. L’amministrazione forestale da lavoro a oltre 26.000 persone e garantisce salari di oltre 6.000 zlotych al mese (circa 1.500 euro) ai suoi dipendenti, oltre il doppio dello stipendio medio in Polonia. Compensi lauti paragonabili soltanto a quelli del settore minerario: legno e carbone, appunto. Da un punto di vista giuridico si tratta di un’azienda statale ibrida che autofinanzia le proprie attività, versa alcune tasse agli enti locali ma senza beneficiare del gettito fiscale dei contribuenti. Un giocattolo difficile da smontare, insomma, anche a medio termine. Il direttore dell’azienda, Konrad Tomaszewski, cugino del numero uno del PiS Lech Kaczynski, continua a paragonare in pubblico l’ecologia a una forma di «nazismo verde». Trasportare, piantare nuovi alberi e tagliare tronchi per conto degli enti locali: un circolo vizioso che permette all’autorità forestale di fare e disfare la tela a piacimento per generare profitti.
«Bialowieza è prima di tutto il risultato dell’intervento dell’uomo nel corso della storia», ha ripetuto come un mantra negli ultimi mesi Szyszko. La natura ridotta a merce è fatta per l’uomo e non il contrario: è questo il messaggio che vuole lanciare la Polonia «orbanizzata» ai tempi del PiS. Ma la foresta primaria di Bialowieza non è un hortus conclusus da potare con le cesoie. E con questi argomenti Szyszko non è riuscito a scongiurare l’intervento di Bruxelles visto che la foresta fa parte anche del programma Ue Rete Natura 2000. Intanto la battaglia per un’altra Rospuda è appena cominciata.
 «Secondo gli esperti, siamo sul punto di giungere ad un punto di svolta sociale, con la produzione di energia eolica e solare in grande espansione»
«Secondo gli esperti, siamo sul punto di giungere ad un punto di svolta sociale, con la produzione di energia eolica e solare in grande espansione». RegionieAmbiente,
4 luglio 2017 (c.m.c.)
Alla vigilia del G20 di Amburgo un gruppo di scienziati, imprenditori, dirigenti politici, economisti, analisti e opinionisti scrivono e sottoscrivono un articolo in cui affermano che solo un'azione immediata di riduzione nell'uso dei combustibili fossili potrà evitare le devastanti ondate di calore e l'ingestibile aumento del livello dei mari, proponendo delle misure in 6 tappe fondamentali da implementare entro il 2020.
Il mondo ha bisogno di un'azione climatica estremamente veloce per far scendere la curva delle emissioni globali di gas ad effetto serra, che comporta una drastica riduzione dell'utilizzo di combustibili fossili se si vuole evitare effetti non gestibili come ondate di calore devastanti e l'aumento del livello dei mari.
È quanto scrivono e sottoscrivono 60 scienziati, imprenditori, dirigenti politici, economisti, analisti e opinionisti (tra i più noti: Johan Rockström della Stockhom University; Jochim Schellnhuber e Stefan Rahmstorf del PIK; Anthony Hobley, Direttore esecutivo di Carbon Tracker; Jonathan Bamber, Presidente dell'Unione Europea delle Geoscienze) nell'articolo "Three years to safeguard our climate" pubblicato il 28 giugno 2017 su Nature.
«Noi siamo nella possibilità di piegare verso il basso la curva delle emissioni di gas serra entro il 2020, come richiede la scienza, a protezione degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell'ONU e, in particolare all'eradicazione della povertà estrema - ha affermatola co-autrice e prima firmataria Christiana Figueres, l'ex Segretaria esecutiva dell'UNFCCC e attuale coordinatrice di Mission 2020, una campagna di ampio respiro che richiede un'azione urgente per assicurare che le emissioni di carbonio inizino una caduta inesorabile entro il 2020 - Questa sfida monumentale coincide con l'apertura senza precedenti di autodisciplina da parte dei Governi subnazionali all'interno degli Stati Uniti, dei Governi a tutti i livelli al di fuori degli Stati Uniti, e del settore privato in generale. L'opportunità che ci viene data nei prossimi tre anni è unica nella storia».
Alla vigilia del G20 di Amburgo (6-7 luglio 2017), gli autori sono sicuri che sia il progresso tecnologico che lo slancio politico hanno raggiunto un punto che permette di avviare la "grande trasformazione della sostenibilità" e che il 2020 è una data fondamentale perché solo in quell'anno gli Stati Uniti potranno legalmente ritirarsi dall'Accordo di Parigi (vedi L'uscita dall'Accordo di Parigi conferma l'isolazionismo degli USA).
Ancora più convincenti sono le considerazioni basate sulla fisica: le recenti ricerche hanno dimostrato che il mantenimento del riscaldamento globale al di sotto dei +2 °C diventa quasi impossibile se si ritarda l'azione climatica oltre il 2020 e il superamento di quel limite sarebbe pericoloso E la violazione della linea a 2 ° C sarebbe pericolosa, poiché il numero dei fenomeni destabilizzanti del sistema Terra, come lo scioglimento delle grandi masse di ghiaccio, potrebbero risultare irreversibili.
«Finora siamo stati beneficati dalla notevole resilienza del Pianeta negli ultimi 100 anni, che ha assorbito la maggior parte dei nostri abusi sul clima - ha dichiarato a sua volta Rockström, riconosciuto a livello internazionale come uno dei massimi esperti sulle questioni legate alla sostenibilità globale per la teoria dei "Planetary boundaries" ovvero dei 9 confini planetari, oltrepassati i quali, gli effetti a cascata che ne derivano possono essere assolutamente fuori delle nostre capacità di controllo e devastanti per l'umanità - Ora abbiamo raggiunto la fine di questa epoca e abbiamo bisogno di piegare immediatamente la curva globale delle emissioni, per evitare risultati ingestibili per il nostro mondo moderno».
Secondo gli esperti, siamo sul punto di giungere ad un punto di svolta sociale, con la produzione di energia eolica e solare in grande espansione. In Europa, ad esempio, più di tre quarti delle nuove capacità energetiche installate si basano su tali fonti rinnovabili. La Cina sta rapidamente istituendo un sistema nazionale di scambio delle emissioni. Gli investitori finanziari negli Stati Uniti sono sempre più preoccupati per i rischi da carbonio.
Sono 6 le tappe che gli autori indicano accelerare la trasformazione in atto entro il 2020.
Energia. Le energie rinnovabili dovranno costituire almeno il 30% dell'approvvigionamento elettrico mondiale, dal 23,7% che era nel 2015. Non dovranno essere più approvate centrali elettriche a carbone dopo il 2020 e quelle in funzione dovranno essere progressivamente chiuse.
Infrastrutture. Le città e gli Stati avvieranno piani di azione per decarbonizzare completamente gli edifici e le infrastrutture entro il 2050, con un finanziamento di 300 miliardi di dollari l'anno, migliorando ogni anno di almeno il 3% il proprio parco immobiliare e infrastrutturale ad emissioni zero o quasi zero.
Trasporti. I veicoli elettrici dovranno rappresentare almeno il 15% delle vendite di auto nuove in tutto il mondo, un aumento significativo rispetto alla quota di mercato attuale di quasi l'1% che i veicoli ibridi a batteria e plug-in. Sono inoltre necessari impegni per un raddoppio l'utilizzo dei trasporti pubblici nelle città, un aumento del 20% , un aumento del 20% ddi efficienza dei carburanti per veicoli pesanti e una riduzione del 20% delle emissioni di gas serra dell'aviazione civile per ogni chilometro percorso.
Suoli. Dovranno essere adottate politiche di utilizzo dei suoli che riducano la distruzione delle foreste e indirizzino gli sforzi per il rimboschimento e l'afforestamento. Le emissioni nette attuali derivanti dalla deforestazione e dalle modifiche all'uso del suolo rappresentano circa il 12% del totale globale. Se fossero ridotti a zero nel prossimo decennio, rimboschimento e afforestamento potrebbero essere utilizzati, invece, per creare un dissipatore di carbonio entro il 2030, contribuendo a spingere le emissioni globali nette totali a zero, a sostenere l'approvvigionamento idrico e a produrre altri vantaggi. Le pratiche agricole sostenibili possono ridurre le emissioni e aumentare il sequestro del CO 2 nei suoli sani e ben gestiti.
Industrie. L'industria pesante adotterà e svilupperà piani per aumentare l'efficienza e ridurre le emissioni, con l'obiettivo di dimezzare le emissioni ben prima del 2050. Le industrie ad alto tenore di carbonio - quali quelle del ferro e dei metalli, del cemento, dei prodotti chimici, del petrolio e gas - attualmente costituiscono il 20% delle emissioni globali di escludendo le loro esigenze di elettricità e calore.
Finanza. Il settore finanziario dovrà ridefinire gli investimenti mobilitando almeno 1.000 miliardi di dollari l'anno per l'azione climatica. La maggior parte dei finanziamenti deriverà dal settore, ma Governi, Banche e Istituti di Credito come la Banca Mondiale dovranno emettere "obbligazioni verdi" per finanziare gli sforzi di mitigazione del clima. Ciò creerebbe un mercato annuale che, entro il 2020, gestirà obbligazioni 10 volte superiori agli 81 miliardi di dollari emesse nel 2016.
«La matematica del clima è brutalmente chiara: mentre il mondo non può essere guarito in pochi anni, può essere tuttavia ferito fa morte se la negligenza continua fino al 2020 - ha concluso Schellnhuber, Climatologo di fama mondiale e conosciuto per i suoi studi sui cosiddetti "tipping points" del sistema Terra ovvero il livello oltre il quale un cambiamento diviene inarrestabile - È necessario agire entro il 2020, ma non è chiaramente sufficiente: occorre impostare il percorso per dimezzare le emissioni di CO2 ad ogni decennio. Analogamente, alla leggendaria 'Legge di Moore' che afferma che i processori per computer raddoppiano di potenza ogni due anni, la 'Legge del Carbonio' può diventare una profezia che si autoadempie, mobilitando le innovazioni e le forze di mercato. Ciò diventerà inarrestabile, ma solo se spingiamo ora il mondo ad agire».
 «Si chiude la peggiore stagione degli incendi in Italia da 30 anni a questa parte. Le cause si possono riassumere in cinque punti. Tutti hanno a che fare con la scarsa attenzione al territorio e al bene comune». lavoce.info, 1° settembre 2017 (c.m.c)
«Si chiude la peggiore stagione degli incendi in Italia da 30 anni a questa parte. Le cause si possono riassumere in cinque punti. Tutti hanno a che fare con la scarsa attenzione al territorio e al bene comune». lavoce.info, 1° settembre 2017 (c.m.c)