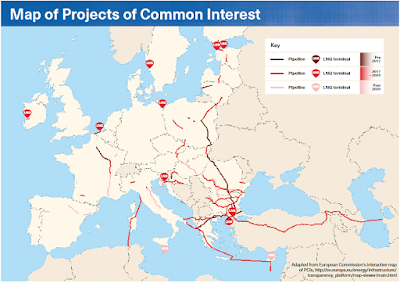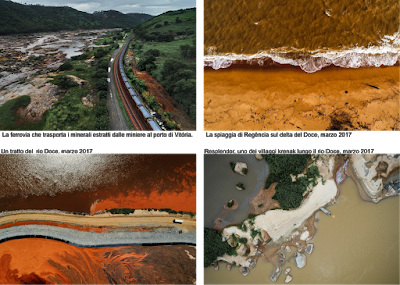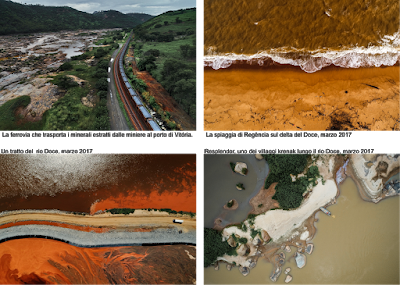Sbilanciamoci.info, newsletter 12 dicembre 2017. «Come il capitalismo, con le sue polarizzazioni tra oppressi e oppressori, colonizzati e colonizzatori, ha cambiato il rapporto uomo-natura: Antropocene, Capitalocene, Ecocapitalismo e Cthulhucene»
A 550 km dal circolo polare artico, sulle coste orientali della Groenlandia, si trova la Warming Island (‘l’isola del riscaldamento globale’), riconosciuta come tale nel 2005, quando il ghiacciaio che la univa alla terraferma, ritirandosi a causa dell’aumento della temperatura globale, ne provocò il definitivo distacco.
Quello del riscaldamento globale è uno dei fenomeni che appare oggi in cima alla lista delle principali emergenze ambientali del nostro pianeta. Il progressivo aumento della temperatura terrestre è dovuto all’emissione nell’atmosfera di crescenti quantità di gas serra, strettamente correlate ad attività umane industriali e a politiche economiche imperialiste. Tra gli altri fenomeni antropogenici di mutamento ambientale, la comunità scientifica annovera l’inquinamento (con l’immissione nell’atmosfera, nell’acqua e nel suolo di sostanze contaminanti), il buco dell’ozono, l’effetto serra, l’elettrosmog e l’estinzione di numerose specie naturali (con i suoi annessi fenomeni di deforestazione e desertificazione).
La portata di tali fenomeni ha convinto la maggioranza quasi assoluta della comunità scientifica (parliamo del 97%) a parlare di una nuova vera e propria era geologica, successiva all’Olocene, di cui attualmente le attività industriali dell’essere umano rappresenterebbero appunto i motori costitutivi delle modifiche territoriali, strutturali e climatiche del pianeta: questa nuova era è definita «Antropocene», termine coniato negli anni anni ’80 dal biologo Eugene F. Stoermer e diffuso nei 2000 dal Premio Nobel per la chimica Paul Crutzen, con la pubblicazione del suo saggio Benvenuti nell’Antropocene.
Tuttavia la riflessione sugli effetti geologici delle attività industriali sull’ambiente ha portato alcuni sociologi, filosofi e analisti politici a indagare le possibili cause storiche del fenomeno. La postulazione di una colpa universale dell’uomo (in quanto specie) non tiene conto infatti delle ragioni storiche e sociali sottese, incentivando di fatto un processo di deresponsabilizzazione collettiva e ignorando del tutto il discorso sui modelli culturali e sociali tramite cui l’essere umano si è sviluppato nelle diverse epoche.
Se infatti per alcune culture non occidentali il rapporto con la natura è paritario e di profonda comunione e alleanza, per quelle tecnicamente più avanzate la netta separazione tra natura e cultura è condizione necessaria a garantire la propria sopravvivenza e il proprio modello di sviluppo. A tal proposito il sociologo Jason W Moore suggerisce di sostituire il termine «Antropocene» con quello di «Capitalocene». Secondo Moore e i suoi sostenitori, la teoria antropocenica, infatti, assumendo l’umanità come totalità omogenea e indistinta, indurrebbe in una vera e propria mistificazione della storia, poiché tralascerebbe di fatto l’analisi della relazioni di potere e dei rapporti di capitale scaturiti da un preciso modello economico (appunto quello capitalistico, sorto nel XVI secolo in Occidente, che avrebbe radicalmente mutato il rapporto tra uomo e natura). Nell’ottica di Moore, capitale e natura si troverebbero pertanto in una relazione dialettica, mutando e influenzandosi a vicenda.
L’oggetto di critica della teoria capitalocenica non sarebbe dunque la storia dell’umanità (in quanto specie), ma quella del capitalismo, con le sue polarizzazioni tra oppressi e oppressori, colonizzati e colonizzatori, con l’obiettivo ultimo di individuare le ragioni storiche e politiche che hanno portato allo sviluppo dell’attuale crisi ambientale.
Tra i sostenitori della teoria capitalocenica figura uno dei più importanti filosofi marxisti tedeschi, c professore di Scienze Politiche presso l’Otto-Suhr-Institut dell’Università Libera di Berlino e co-direttore del Journal for critical sciences. Abbiamo deciso di fargli qualche domanda.
Domande e risposte
Dario Giovanni Alì: Attraverso la teoria dell’Antropocene, gli scienziati hanno segnato il momento di inizio di una nuova era geologica, ponendo particolare attenzione a tutti quei fenomeni geologici distintivi della nostra attuale crisi ambientale: gli inediti livelli di CO2 presenti nella nostra atmosfera e il conseguente fenomeno del riscaldamento globale, le estinzioni di massa di svariate specie, l’aumento del livello dei mari ecc. Nonostante ciò, il termine “Antropocene”, prendendo in considerazione solo le cause e gli effetti geologici di questa crisi, rischia di indurre in una vera e propria mistificazione storica: considera infatti l’umanità (intesa in quanto specie) responsabile dei mutamenti ambientali e globali. A tal proposito, invece, perché il termine “Capitalocene”, coniato da Jason W Moore, sembra più appropriato a descrivere proprio quei rapporti socioeconomici e quelle relazioni di potere che restano fuori dalla teoria antropocenica?
Elmar Altvater: Non c’è alcun dubbio sul fatto che nel corso degli ultimi secoli il genere umano abbia trasformato la Terra in qualcosa di profondamente diverso rispetto al passato. I mutamenti sono evidenti e incisi nelle sfere terrestri, nella biosfera per via dell’influenza degli esseri umani sull’evoluzione, nella litosfera a causa degli effetti delle attività umane sulla struttura sedimentaria della crosta terrestre ecc. Per questo motivo il 29 agosto 2016 l’International Geological Association ha proclamato la fine dell’Olocene e l’inizio di una nuova età della storia terrestre. A seguito di una proposta fatta all’inizio del nuovo millennio dal premio Nobel Paul Crutzen e da altri scienziati naturali, questa nuova età è stata definita come Antropocene. Non vi è alcuna teoria dietro a questa asserzione, e il nome riflette semplicemente l’empirico factum brutum di una profonda influenza del genere umano sulle sfere del pianeta Terra, nello specifico e in modo più sensibile sull’atmosfera, attraverso l’effetto serra. Non andrebbero dimenticati nemmeno gli effetti dell’azione umana sulla biosfera, l’idrosfera, la criosfera ecc., che si sommano al crescente impatto dell’uomo sulla Terra: l’estinzione delle specie, l’acidificazione degli oceani, lo scioglimento delle calotte artica e antartica ecc. Nel complesso significa che per la prima volta nella storia terrestre, cioè in più di 4 miliardi di anni di vita, l’essere umano ha dimostrato di essere in grado di mutare l’evoluzione naturale del pianeta Terra.
Tuttavia, l’umanità rappresenta davvero quell’attore collettivo responsabile del drammatico cambiamento globale? Ovviamente l’umanità non è un’unica entità che agisce collettivamente, ma è invece suddivisa in uomini e donne, in nazioni, tra cui molte sono povere e deboli e alcune ricche e molto potenti. Esistono classi sociali e differenze o divisioni etniche ecc. L’impatto di differenti classi sociali, nazioni e sessi sulla natura del pianeta Terra è diverso. È questa la ragione per cui vi sono delle perplessità sull’appropriatezza o meno del concetto di Antropocene. Alcune autrici femministe preferiscono l’etichetta “Fallocene”, per via della predominanza dell’influenza maschile sulla Terra. Altri parlano di “Necrocene” a causa della tragica accelerazione dell’estinzione delle specie sulla Terra. In modo ironico Donna Haraway ha proposto il termine “Chthulucene” poiché non solo gli esseri umani determinano la direzione dell’evoluzione planetaria ma anche altri importanti attori non umani. Inoltre secondo alcuni autori l’Antropocene tra i suoi effetti collaterali negativi avrebbe il Misantropocene.
La società internazionale geologica rinuncia a tali questioni. I suoi membri sono in cerca di “segni” geologici significativi all’interno dei depositi della crosta terrestre e nelle altre sfere del pianeta, per valutare lo stato in cui si trova la Terra e il nome da dare a questa nuova età. Il caso del concetto di “Capitalocene” è diverso. Non sono l’uomo e la donna, Adamo ed Eva, a rappresentare le dramatis personae, e nemmeno gli altri esseri viventi. Tuttavia, uomo e donna agiscono come esseri sociali all’interno di un dato sistema sociale, e la costruzione sociale dominante del XX secolo è il capitalismo. Quando si schiera a favore del termine “Capitalocene” al posto di quello di “Antropocene”, Jason W Moore ha in mente proprio questo. Forse è stato il primo a utilizzare questo termine all’interno di una pubblicazione scientifica. Tuttavia si sentiva “nell’aria” ed era già stato usato da altri. L’aspetto fondamentale è che il concetto di Capitalocene include la costruzione sociale del capitalismo, così come l’accumulazione capitalistica, all’interno della trasformazione geologica della Terra. In linea teorica ciò conduce in maniera diretta al concetto marxiano del “duplice carattere” di ogni azione economica, del lavoro e della produzione, dello scambio, della distribuzione o del consumo. Trasforma materia ed energia, come per esempio la natura, e in modo coincidente trasforma il valore producendo plusvalore.
G. A: La Rivoluzione Industriale del XVIII secolo è considerata da molti scienziati come il momento d’inizio dell’Antropocene. Tuttavia un primo momento chiave di svolta nel rapporto tra uomo e natura risale probabilmente alle origini del capitalismo, nel XVI secolo, quando si verificò una netta separazione tra l’uomo, da un lato, e una natura oggettivata, dall’altro. In che modo – se è possibile – le pratiche artistiche sono in grado di ricucire questo strappo tra uomo e natura e generare nuovi modelli di conoscenza e consapevolezza?
A.: Si tratta di una questione determinante. Il discorso sull’Antropocene deve essere inteso come una sfida per la comprensione di sé come individui, come esseri sociali e come parti umane del pianeta, estremamente distinte e per lo più natura non umana. Pertanto la relazione sociale tra uomo e natura è importante. Occorre interpretare tale relazione come il complesso metabolismo dell’uomo con la natura. È impossibile un’esistenza umana al di là del circuito metabolico di input e output, di nutrimento e scarto, di sostanze nutritive ed emissioni ecc. Tuttavia dobbiamo ricordarci il significato cruciale della categoria marxiana di “duplice carattere” del lavoro, e in ultima istanza di tutti i processi economici all’interno di una costruzione sociale capitalista. Tutte le azioni umane al medesimo tempo trasformano materia ed energia, per esempio nella produzione agricola o nell’estrazione di carbone o di petrolio, o nella produzione industriale, e si tratta di trasformazioni di valore, come per esempio la produzione di valore e plusvalore. Pertanto il metabolismo dell’uomo con la natura è guidato dal meccanismo capitalista di plusvalore e dalla sua accumulazione. È questo il motivo principale per cui lo sviluppo economico emerge come una potente norma della società in grado di penetrare tutti i sottosistemi della vita sociale.
Dovremmo tenere presente che questa, all’interno della storia umana, è pur sempre una novità. Uno sguardo alle statistiche a lungo termine del millennio, realizzato dall’OECD nel suo Millennium Report del 2001, compilato dallo studioso di statistica Angus Maddison, mostra che nel corso dei secoli il tasso di crescita economico nella storia dell’uomo è sempre stato vicino allo zero. La stagnazione era un fenomeno normale, e i tassi di crescita inferiori non rappresentavano il segno di una crisi, di un cattivo risultato economico o di un fallimento delle politiche economiche. Soltanto a partire dalla rivoluzione industriale della seconda metà del XVIII secolo i tassi di crescita aumentarono di una media globale del 2% annuo. Le conseguenze di ciò furono rivoluzionarie. Tra una generazione e l’altra, il reddito pro capite medio raddoppiò. L’impatto sulle condizioni di vita, sull’esperienza quotidiana del tempo e dello spazio, e quello sulle ideologie furono enormi, molto più incisivi di quelli della rivoluzione francese o di quella russa.
A causa dell’influenza crescente di coloro che guidavano il capitalismo anche il metabolismo dell’uomo con la natura si espanse. Di conseguenza ricollegare l’inizio dell’Antropocene a un evento in particolare, a un “segno” storico, non ha alcun senso. Esso emerge infatti da un lungo processo storico che si svolge nel corso di millenni e che diventa maturo nell’Olocene. Nicholas Georgescu-Roegen, uno dei pochi economisti moderni che assume le fondamenta bio-fisiche dei processi economici, parla di due «Rivoluzioni prometeiche» nella storia dell’uomo. La prima avviene all’inizio dell’Olocene. Si tratta della rivoluzione neolitica dell’agricoltura stanziale che sostituisce la lunga era di caccia e raccolta. La seconda si verifica invece nel XVIII secolo, quando il genere umano comincia a dipendere energeticamente quasi al 90% dai combustibili fossili. Le fonti esterne di energia, come ad esempio le radiazioni solari, sono state sostituite da una fonte interna, le riserve fossili situate nella crosta terrestre, dapprima il carbone, in seguito petrolio e gas. Sfortunatamente le emissioni di combustibili fossili e della loro combustione rimangono nelle sfere terrestri, soprattutto nell’atmosfera. Le conseguenze sono funeste: la possibilità di un collasso climatico.
È ragionevole distinguere alcune fasi nel passaggio dall’Olocene all’Antropocene. La storia moderna antropocenica dell’umanità ha inizio con la rivoluzione neolitica e con i suoi effetti sulla cultura e le grandi civiltà moderne, soprattutto in Asia e Medio Oriente. La fase successiva è costituita dalla nascita delle grandi religioni monoteiste, il giudaismo, il cristianesimo e l’islam. Esse danno forma alla particolare logica dell’accelerazione nel tempo e dell’espansione nello spazio. Il risultato è lo sviluppo della scienza, di una specifica razionalità di conquista della Terra (anche fisica) e di cattura degli esseri umani e delle risorse a partire dal «lungo XVI secolo», com’è stato definito da Fernand Braudel. Vi sono buone ragioni per affermare che l’Antropocene abbia inizio con l’emergere della modernità e del capitalismo, all’epoca del Rinascimento.
Infatti, la fase successiva è quella della rivoluzione industriale, cioè il momento in cui la produzione capitalista di plusvalore assoluto e la sussunzione formale del lavoro (e della natura) sotto il dominio capitalista sono state trasformate in produzione di plusvalore relativo e sussunzione reale del lavoro (e della natura) sotto il Capitale, per usare le parole di Karl Marx.
Quella successiva è la fase della cosiddetta Grande Accelerazione, che si verifica dopo la seconda guerra mondiale. Le emissioni presenti in tutte le sfere del pianeta aumentano fino a un carico eccessivo ben oltre “i confini dello sviluppo”. Non c’è da stupirsi che lo studio del 1972 del Club di Roma sia stato così affascinante. Ancora più importante, comunque, è la capacità umana di distruggere il pianeta utilizzando l’arsenale di bombe atomiche e a idrogeno prodotte dalle superpotenze del pianeta. Il vero dominio del pianeta oggi permette anche la sua distruzione fisica e l’autodistruzione del genere umano. Di certo ciò segna una nuova era della storia umana e planetaria.
G. A.: Uno dei modi tramite cui il capitalismo sembra interessarsi alle questioni ecologiche è il cosiddetto «ecocapitalismo» (o “capitalismo verde”), una visione politica ed economica che estende il concetto di “capitale” all’intero ambiente naturale, con l’obiettivo di indicare le risorse naturali come uno strumento da usare in modo sostenibile e all’interno di un’economia di libero mercato. Possono capitalismo ed ecologia coesistere ed essere compatibili? O piuttosto l’ecocapitalismo rappresenta solo un ulteriore tentativo di sussumere la grande questione ecologica nel capitale?
A.: Visto dalla logica del capitalismo, il pianeta appare come un deposito di risorse e una miniera di inutili emissioni solide, liquide o gassose. Ma non tutto il mondo fa parte di questo deposito, sulla Terra ci sono molte erbacce inutili. Le risorse utili costituiscono l’obiettivo per le strategie del capitalismo di trasformare la natura per quanto redditizia in valore, di creare capitale naturale al di fuori della natura. Vi sono ancora economisti e politici ‘verdi’ che interpretano la trasformazione della natura in capitale come un positivo atto ecologico di difesa ambientale. Il concetto di green economy, di un capitalismo ‘verde’, non è altro che un tentativo ecologico di riconciliare economia ed ecologia, per giustificare la «liberazione del carbonio» come la definisce McKenzie Wark in Molecular Red. Dobbiamo considerare che di un milione d’anni di presenza umana sulla Terra solamente cinquecento anni hanno visto una coesistenza tra uomo e carbonio. Oggi si presenta come necessaria la cattura dell’anidride carbonica per arrestare l’impatto negativo che ha sul clima. La questione decisiva è se la cattura dell’anidride carbonica debba avvenire prima della combustione o, dopo, in forma di CO2. Si tratta solo in parte di una questione di natura tecnica. In fondo, pone i modelli di produzione e consumo in cima all’agenda politica: «Ende Gelände».
G. A.: In Anthropocene or Capitalocene? Donna Haraway presenta una teoria chiamata Cthulhucene. Secondo Haraway «gli esseri umani non sono gli unici attori importanti» coinvolti nei processi di trasformazione, «accanto a tutti gli altri esseri in grado solo di reagire», ma «sono le altre forze biotiche e abiotiche di questa Terra a essere la main story». Tale teoria sembra prendere in prestito alcuni elementi di certa letteratura visionaria e fantascientifica, e presenta una realtà ipercomplessa in cui vi sono interazioni (o intra-actions per usare le parole di Karen Barad) co-costitutive tra ogni cosa e ciascuna creatura. Come analista politico ed economista che cosa ne pensa di questa teoria?
A.: Prima le cose importanti, e ciò significa tradurre il linguaggio di Haraway, Barad e altri in un discorso che possa essere riconnesso ad altri discorsi comuni alle scienze e alle arti. Fatto questo, il concetto di «intra-action» è molto simile a quello hegeliano (ed engeliano) di Gesamtzusammenhang, o al concetto di totalità negli scritti di Marx. Tali concetti sono totalmente anti-individualistici e persino anti-neoliberali. Tuttavia le conseguenze politiche dipendono dalla visione del sistema sociale, del mondo contemporaneo e futuro. Pertanto include necessariamente elementi utopici (o distopici).
G. A.: A giugno 2017, il 45° presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha annunciato la decisione di ritirarsi dagli Accordi di Parigi siglati da 195 paesi a dicembre 2015 con l’obiettivo di ridurre le emissioni annuali di CO2 e arrestare il fenomeno del riscaldamento globale. Questa notizia, che potrebbe causare disastrose conseguenze sul clima, è rimbalzata sulle prime pagine di tutti i giornali dando inizio a una serie di proteste in Europa e in USA. Tuttavia, generalmente i mass media, soprattutto in Italia – un paese poco attento alle questioni ambientali –, affrontano gli argomenti che riguardano l’ambiente con superficialità o con eccessivo sensazionalismo. Pensare alla crisi ecologica e a quella finanziaria come strettamente connesse l’una all’altra può costituire un modo per stimolare l’interesse pubblico nei confronti delle tematiche ambientali (ma a questo punto diremmo anche politiche e sociali)? Il sistema capitalistico può davvero essere rimesso in discussione e sconfitto? Una volta individuate le cause di questa crisi, che cosa possiamo fare per contrastare i suoi effetti?
A.: Hai ragione nel menzionare la comune origine delle crisi finanziaria e climatica. Si tratta di una delle ripercussioni del “duplice carattere”, che Marx delinea come punto cruciale («der Springpunkt») nell’analisi del lavoro del sistema capitalista. A causa del duplice carattere è impossibile concepire la merce o il denaro e il credito come fenomeni virtuali. Si tratta invece di fenomeni realmente esistenti (e in modo coincidente nella loro struttura sociale con tutte le conseguenze, incluso il feticismo della merce e del denaro). Ciò significa che una merce esiste come cosa materiale e fisica e come relazione sociale immateriale. Tuttavia entrambe le facce della merce sono reali. La crisi finanziaria irrompe per via dello sviluppo contrastante di benessere e debito, di capitale reale e capitale monetario, del mondo del lavoro e di quello della speculazione. I crediti monetari oltrepassano il reale benessere monetario prodotto, di modo che i crediti monetari o finanziari vengono cancellati. Quando le perdite diventano un fenomeno di massa, scoppia la crisi. Aumenta la disoccupazione, così come il numero di bancarotte, il capitale perso diventa visibile e quantificabile, come ad esempio la gradita riduzione delle emissioni di CO2.
Il benessere monetario può essere prodotto solo trasformando materia ed energia e perciò producendo CO2 e altre emissioni. Dato che la vera accumulazione non può essere fermata a causa dei fautori del capitalismo che applicano il sistema per produrre surplus, persino le emissioni di CO2 tecnicamente possono essere ridotte. Tuttavia, come già sappiamo, i margini tecnici della manovra sono limitati. Il duplice carattere è importante anche nei riguardi della soluzione alla crisi. Vi è l’alternativa tecnica di intervenire sul metabolismo grazie alla geoingegneria, mettendo in pratica modelli di gestione delle radiazioni o di cattura e deposito di anidride carbonica. Paul Crutzen, che ha coniato il termine Antropocene, è un fervido sostenitore della geoingegneria. Non a caso. Tecnicamente il genere umano ha trasformato il mondo nel pianeta antropocenico. Il genere umano è inoltre responsabile dei cambiamenti, e l’uomo è in grado di riparare il danno commesso. Tuttavia vi sono seri dubbi che gli interventi o le «intra-azioni» umane riescano ad avere successo su scala planetaria. Qui, come in molte altre aree dell’azione sociale, la portata conta. Con l’incremento di scala, gli investimenti negli impianti di geoingegneria aumentano, così come, secondo la logica dei profitti, la forza del capitale. La geoingegneria non è pertanto sostenibile né socialmente né ecologicamente.
Tuttavia, a causa del duplice carattere vi è un’altra via d’uscita dallo stallo della crisi antropocenica e geopolitica. La vediamo all’orizzonte quando interpretiamo l’Antropocene come Capitalocene. Questo perché la crisi climatica, l’estinzione delle specie, le minacciose catastrofi atomiche e le guerre non possono essere intese come un risultato dell’azione umana in quanto tale. La crisi del nostro mondo contemporaneo e antropocenico va intesa come la crisi della forma sociale, dell’insieme di forme sociali (come ad esempio della costruzione sociale) e dei suoi modelli di produzione. Pertanto la costruzione sociale e ogni sua emanazione possono e devono essere cambiate per superare le molteplici crisi capitaloceniche del sistema sociale e della natura del pianeta Terra, come ad esempio la crisi economica, finanziaria e sociale dell’accumulo di capitale e la propensione alla crisi del clima, dell’evoluzione, delle acque globali e della cultura umana. I primi passi per mettere in salvo il pianeta dal disastro dell’Antropocene vengono fatti all’alba di una rivoluzione.
Questo articolo, ripubblicato da Sbilanciamoci.info, è raggiungibile nella pagina di Kabulmagazine.com, dalla quale lo abbiamo ripreso

Nigrizia
, 1 dicembre 2017 «Un progetto di sviluppo fallimentare e distruttivo sta portando alla progressiva scomparsa di un ecosistema millenario e delle antiche popolazioni che lo abitano». Colpevole impunito: Impregilo, Italia
 |
| Ragazzini Hamar con il corpo dipinto di cenere bianca. (Magda Rakita/Survival) |
La valle del fiume Omo, in Etiopia, e in particolare la sua parte finale, conosciuta come bassa valle, è una delle pochissime parti dell’Africa, e del mondo, in cui si trovano ancora popoli nativi che vivono seguendo costumi e tradizioni ancestrali. E’ stata abitata fin dagli albori dell’umanità. Vi sono stati trovati resti di un australopiteco, uno dei nostri lontani antenati, risalenti a 2 milioni e mezzo di anni fa. La valle è stata una culla dell’evoluzione umana. Vi sono stati scoperti anche resti di altri ominidi e segni della permanenza dell’homo sapiens, cioè il nostro diretto progenitore, quali quarzi scheggiati, risalenti a circa 190.000 anni fa.
La valle, dicono gli studiosi del settore, è stata sempre un crocevia di popoli migranti portatori di diverse culture, provenienti da diverse zone del continente. Questa è la ragione della diversità dei popoli nativi che vi sono ancora oggi stanziati: circa 200.000 persone appartenenti ai gruppi Mursi, Suri, Karo e numerosi altri. La valle è anche l’habitat di flora e fauna indigene, talvolta in via di estinzione in altre aree della regione. Per questo è il paradiso di archeologi, antropologi, botanici e altri scienziati, ed è stata dichiarata patrimonio dell’umanità dall’Unesco. E’ un territorio dal delicato equilibrio ecologico che si estende per centinaia di chilometri nel sud dell’Etiopia. Le acque, raccolte dal fiume Omo, finiscono nel lago Turkana, un grande bacino - 6.405 Kmq, profondità media 30 metri - che si estende per la maggior parte oltre il confine etiopico, in Kenya, nella Rift Valley. Delle sue risorse vivono centinaia di migliaia di persone.
Dighe e land grabbing
In molti ormai si chiedono fino a quando questo patrimonio di tutti potrà sopravvivere. E’ infatti gravemente minacciato dai progetti del governo di Addis Abeba per produrre energia e prodotti agricoli per l’esportazione. Il basso corso dell’Omo e il lago Turkana sono infatti il teatro di trasformazioni rapidissime provocate dalla costruzione di una cascata di dighe sul maggior affluente dell’Omo, il fiume Gibe, che ha cambiato in modo radicale e permanente il regime delle acque, mettendo a serio rischio l’intero ecosistema e la vita stessa della popolazione e della fauna che vive delle sue risorse.
La situazione è aggravata dai progetti di sfruttamento dell’acqua, raccolta nei vasti bacini formati dalle dighe, per l’irrigazione di smisurati territori dati in concessione, per cifre risibili, a compagnie straniere dell’agribusiness per la coltivazione di prodotti come il cotone o la canna da zucchero. Sono prodotti destinati all’esportazione e dunque al sostegno del bilancio statale da impegnare in un programma di sviluppo economico rampante, secondo un modello industriale che ha già rivelato enormi limiti nei nostri paesi. Non sono certo intesi al rafforzamento della sicurezza alimentare del paese, che annualmente dichiara crisi che colpiscono milioni di persone nelle aree rurali più isolate, appellandosi ogni volta alla solidarietà internazionale per evitare vere e proprie carestie.
L’acqua e la terra che sono la base dell’economia, e della stessa sopravvivenza, dei popoli nativi e rivieraschi in genere, sono insomma oggetto di accaparramento - water and land grabbing - per uno sviluppo che non li prevede. La più grande delle dighe in programma - la Gilgel Gibe III, la più imponente dell’Africa fino alla costruzione della Gerd (Grand Ethiopian Renaissance Dam) in via di costruzione sul Nilo Blu, entrambe ad opera della ditta italiana Salini Impregilo - è entrata in funzione nel 2015, e ha già cambiato in modo radicale e permanente il regime delle acque del fiume Omo, determinando la riduzione drastica delle alluvioni stagionali che permettevano la coltivazione dei terreni lungo le rive per la produzione di ortaggi, cereali e legumi, base alimentare della popolazione della bassa valle.
Quasi desertificati anche i pascoli che non riescono più a sostenere l’allevamento del bestiame, altra risorsa della popolazione locale. Per non parlare del pesce, che costituiva un’importante fonte di cibo per le popolazioni della valle dell’Omo e di risorse anche monetarie per quelle che vivono attorno al lago Turkana, di cui si osserva già una notevole diminuzione del livello. Inoltre, organizzazioni internazionali come Survival International - ascolta, a destra della pagina, la nostra intervista alla direttrice, Francesca Casella - denunciano frequentemente abusi e violazioni gravissimi dei diritti delle popolazioni locali, allo scopo di cacciarli dalle proprie terre ancestrali per far posto ad attività di agricoltura meccanizzata.
Un disastro annunciato
Per dire la verità, tutto era stato ampiamente previsto fin dall’inizio del progetto. Ma non sono bastate combattive e documentate campagne internazionali, con forti radici in loco e attività competenti e continuative in molti paesi europei - e in particolare in Italia per via della ditta costruttrice - a fermare il programma. I timori espressi dalla società civile, basati su studi di esperti riconosciuti a livello internazionale, non sono stati presi in considerazione. Ma, a soli due anni dall’inaugurazione della diga, i risultati già possono essere visti chiaramente. Il cambiamento drammatico dell’ambiente e l’assottigliarsi delle possibilità di sopravvivenza delle popolazioni interessate sono stati descritti nelle ultime settimane in ricerche sul campo, in numerosi reportage (Rai, New York Times, The East African) e in articoli di riviste autorevoli come il National Geographic.
La valle dell’Omo è ormai una regione sul precipizio, si legge nell’articolo del New York Times, mentre il lago Turkana sembra destinato a fare la fine del lago Ciad, di fatto quasi scomparso. Un impatto funesto sull’ambiente, sulle comunità locali e sul nostro patrimonio comune in nome di un modello di sviluppo economico già fallito nel nord del mondo e perfino in Etiopia. Il governo, infatti, dimostra di non essere in grado di assicurare condizioni minime di sopravvivenza a milioni di cittadini e a centinaia di comunità, nonostante la crescita vertiginosa del Pil, o più probabilmente proprio a causa del modo nel quale questa crescita è originata.
L'originale dell'articolo è reperibile a questo indirizzo, corrispondente a una pagina del sito web della rivista Nigrizia
dal quale lo abbiamo tratto. Raggiunto il sito indicato è possibile ascoltare la conversazione con la direttrice di Survival International Italia, Francesca Casella. Ringraziamo Nigrizia per la concessione

il Salvagente, online, 28 novembre 2017. L'accorato appello della comunità degli scienziati consapevoli per tentar di scongiurare la morte del nostro pianeta. Le 13 cose da fare subito
La scienza unanime continua predicare, inascoltata, che il tempo rimasto per salvare il pianeta su cui abitiamo è poco. Secondo le informazioni e testimonianza raccolte da il sito “il salvagente”«se continuiamo così, finiremo per uccidere il nostro sistema». Già nel 1992, del resto, la Union of Concerned Scientists (una (Ong che raccoglie più di 1700 scienziati) sosteneva che l’impatto delle attività umane sulla natura avrebbe presto distrutto il pianeta irrimediabilmente.
Un quarto di secolo dopo, purtroppo, le cose non sono cambiate. Anzi sono peggiorate. Disponibilità di acqua potabile, deforestazione, diminuzione dei mammiferi, emissioni di gas serra: questi indicatori sono in rosso dal 1992 e le risposte sono ad oggi deludenti.Da qui la necessità di un secondo avvertimento lanciato dai 15mila scienziati. Essi non si limitano a denunciare il rischio, ormai immanente. indicano 13 azioni virtuose che potrebbero, se non annullare la tendenza, almeno rallentarla dicono e nel manifesto indicano 13 azioni da mettere in atto subito. Eccole come le riporta il quotidiano Le Monde:
1. creare riserve interconnesse ben collegate e correttamente gestite per proteggere una proporzione significativa dei vari habitat terrestri, aerei e acquatici; 2. preservare i servizi della natura attraverso gli ecosistemi fermando la conversione delle foreste naturali, delle praterie e di altri habitat;3. ripristinare le comunità vegetali endemiche su larga scala, compresi i paesaggi forestali; 4.riqualificare aree con specie endemiche, in particolare super-predatori, per ripristinare le dinamiche e i processi ecologici; 5. sviluppare e adottare adeguati strumenti politici per combattere la sconfitta, il salvataggio, lo sfruttamento e il traffico di specie minacciate; 6. ridurre i rifiuti alimentari attraverso l’istruzione e migliorare le infrastrutture; 7. promuovere una riorientazione della dieta verso prodotti alimentari di origine vegetale;
8.ridurre ulteriormente il tasso di fertilità assicurando che gli uomini e le donne abbiano accesso ai servizi di istruzione e di pianificazione familiare, in particolare nei settori in cui questi servizi mancano ancora; 9. moltiplicare le escursioni per i bambini per sviluppare la loro sensibilità alla natura e generalmente migliorare l’apprezzamento della natura in tutta la società; 10. incoraggiare un cambiamento ambientale positivo; 11. progettare e promuove nuove tecnologie verdi e rivolgersi in maniera massiccia verso fonti energetiche verdi, progressivamente riducendo il sostegno alla produzione di energia con combustibili fossili; 12.e soprattutto rivedere la nostra economia per ridurre le iniquità della ricchezza e garantire che i prezzi, le tasse e gli incentivi tengono conto del vero costo dei nostri modelli di consumo per il nostro ambiente;13. determinare a lungo termine una dimensione umana sostenibile e scientificamente difendibile, assicurando il sostegno dei paesi e dei leader mondiali a raggiungere questo obiettivo vitale.
il manifesto, 23 novembre 2017. Un nuovo supplemento de il manifesto, interamente dedicato a un ambientalismo nuovo, anticapitalista. Inizia con l'inizio della storia dell'uomo: la storia del grano. Articoli di Piero Bevilacqua, Luca Fazio, Monica di Sisto, Saverio De Bonis
UN AMBIENTALISMO
NUOVO, ANTICAPITALISTA
di Piero Bevilacqua
In principio era il grano, un seme coriaceo che piantato nella terra generava una spiga con sei o sette chicchi, buoni per essere macinati e fare farina e a loro volta capaci di tornare a germinare, di avviare un ciclo produttivo che si rinnovava ogni anno. Grazie a questo cereale, negli altipiani della Mezzaluna Fertile, intorno a 10 mila anni fa, i primi gruppi umani cessavano di migrare e cominciavano la vita stanziale in attesa del raccolto, costruivano dimore stabili, adunavano villaggi, edificavano città, inventavano la scrittura. Dal seme del grano sorgevano le civiltà umane, aveva inizio quel che noi chiamiamo storia. E in questa storia, per millenni, un ruolo preminente, non solo alimentare, ma anche religioso e simbolico ha giocato il suo prodotto fondamentale: il pane. L’alimento che si spartiva con solidarietà tra gli uomini e che si spezzava nei riti delle religioni rivelate.
Che cosa di più storicamente e simbolicamente significativo del grano per iniziare un inserto dedicato specificamente all’ambiente? Forse nessun altro elemento – simbolo di rigenerazione della fertilità, di pace, di fratellanza – può sintetizzare le ragioni e le intenzioni di fondo del nostro progetto.
La nostra ambizione, infatti, non si limita a rinverdire i temi consueti dell’ambientalismo per offrirli con più frequenza ai lettori del manifesto. Non intendiamo coltivare un settore di studi e di problemi fin troppo trascurato dalla cultura nazionale. Vogliamo andare oltre, forti di acquisizioni ormai consolidate, che hanno tratto l’ambientalismo fuori dal recinto di una tematica elitaria, da paesi ricchi, dalla sua pur nobile e importante difesa dell’esistente.
Inserire la natura nella storia, quel mondo vivente che il pensiero economico ha cancellato con i suoi astratti edifici teorici, che ha occultato per volontà di dominio, comporta un sovvertimento radicale del nostro modo di pensare le società contemporanee. Per noi la natura non è fuori, ma dentro la società, non è solo l’aiuola fiorita, il parco, il fiume. È anche e forse prima di tutto la fabbrica, costruita con il ferro sottratto alle viscere della terra tramite scavi minerari devastanti, che produce merci utilizzando minerali, acqua, petrolio, un gran numero di risorse non rigenerabili.
È ancora natura la fabbrica che sfrutta l’energia del lavoro umano, che rovescia rifiuti, che inquina cielo, suolo ed acqua perché anche noi siamo natura e quegli scarichi ci coinvolgono nel generale metabolismo che si svolge sulla superfice del pianeta. Non dimentichiamolo: la nostra salute, il lavoro, la fecondità delle donne, il nostro tempo di vita sono fra le risorse naturali più sfruttate.
Dunque non vogliamo rinverdire una tradizione riparatoria e rivendicazionistica: l’ambientalismo che denuncia il danno esterno e che chiede rimedi ex post. La nostra vuole essere una nuova modalità di critica radicale del capitalismo, un nuovo sguardo sul più distruttivo modo di produzione della storia dal punto di vista degli equilibri naturali. Il mondo fisico è messo in pericolo non dall’uomo in astratto, ma da modelli di dominio storicamente determinati.
È questo punto di vista, tuttavia, questa nuova visione radicale e olistica, che consente di fornire una nuova universalità alla politica e al tempo stesso di scorgere i processi che già oggi prefigurano nuovi modi di produrre e di fare economia, pratiche alternative nell’utilizzare le risorse naturali, forme cooperative del lavoro che anticipano assetti nuovi della vita sociale.
LA PASTA È «MADE IN ITALY»,
IL GRANO NO
di Luca Fazio
«Il fatto della settimana. Un pacco su tre è prodotto con grano importato. Ma anche quello italiano non è garanzia di qualità. E ora ci si prepara allo sbarco dei canadesi»
«Maccarone, m’hai provocato e io te distruggo, maccarone! Io me te magno», e questa è storia. La nostra. Eppure anche l’Albertone nazionale oggi si farebbe qualche domanda prima di affondare la forchetta in una montagna di maccheroni.
La pasta italiana è mediamente buona ed ha già vinto la sfida globale essendo uno dei cibi più ricercati e consumati al mondo, ma è inutile nascondere che nel piatto c’è qualcosa che non funziona.E che in futuro potrebbe restarci sullo stomaco. I numeri per ora sono l’unica certezza e forniscono il quadro di un mercato mondiale che è teatro di interessi non sempre confessabili, soprattutto al consumatore.
Nel 2015 nel mondo sono state prodotte 14,3 milioni di tonnellate di pasta. Sono 48 i paesi che ne producono più di 1.000 tonnellate all’anno (e 52 i paesi che consumano almeno 1 chilo pro capite di pasta all’anno). L’Italia è paese leader tra i produttori con circa 4 milioni di tonnellate all’anno (seguono Usa con 2 milioni, Turchia con 1,3, Brasile con 1,2 e Russia con 1,1).
L’Italia è anche il paese con il più alto consumo pro capite del mondo: gli italiani mangiano più di 25 chili di pasta all’anno (16 i tunisini, 12 i venezuelani, 11 i greci e 9 gli svizzeri). Con questi numeri è anche leader del mercato: nel 2016, per il dodicesimo anno consecutivo, l’export della pasta ha avuto il segno più (6%). L’Associazione delle industrie e della pasta italiane (Aidepi) certifica che nel 2016 l’Italia ha esportato 2 milioni di tonnellate di pasta per un valore che supera i 3 miliardi di euro.
Tutto bene? Non proprio.
C’è un problema che ne richiama altri e che fa della pasta uno degli alimenti più significativi per comprendere le insidie di un mercato agroalimentare globale che per sua natura non può convergere con la sostenibilità ecologica del sistema produttivo: all’Italia manca circa il 40% di grano duro per soddisfare la produzione di pasta necessaria al mercato interno (e all’export).
Negli ultimi 15 anni le coltivazioni di grano duro si sono ridotte di 500 mila ettari. Per questo, spiega Coldiretti nel suo atto d’accusa contro il grano straniero, l’Italia nel 2015 ha importato dall’estero circa 4,3 milioni di tonnellate di frumento tenero e 2,3 milioni di tonnellate di grano duro (utilizzato per la pasta).
Il risultato, denuncia l’associazione, è che un pacco di pasta su tre è fatto con grano che arriva dall’estero, senza obbligo di indicare la provenienza sull’etichetta (alcune tra le marche più famose miscelano grano italiano e straniero). Non è solo una questione di sovranismo cerealicolo per tutelare gli agricoltori nostrani strozzati dai prezzi imposti dal mercato globale, è anche un problema di salute e di politica internazionale.
I principali paesi che forniscono grano all’Italia sono europei. La Francia, con 350 mila tonnellate nel 2015, poi l’Austria con 176 mila tonnellate nel 2015 e l’Ungheria che nel primo semestre del 2016 ce ne ha vendute 165 mila tonnellate. Seguono Romania, Polonia, Ucraina, Turchia, Cipro. Complessivamente dal resto del mondo (dati 2015) l’Italia ha importato 2,3 milioni di tonnellate di grano duro e ne ha esportate più di 181mila, soprattutto verso il Maghreb (per il cous cous).
L’Italia, dunque, anche se non produce abbastanza grano duro per soddisfare il suo mercato, è un paese che comunque ne esporta. Un paradosso facile da spiegare: il frumento nostrano è molto richiesto e viene venduto a prezzi più alti, mentre il grano importato costa meno ed è qualitativamente meno pregiato. E in qualche caso anche dannoso per la salute, come denunciano numerose associazioni ambientaliste che puntano il dito contro il grano canadese.
La questione canadese introduce scenari preoccupanti anche in virtù del fatto che il paese di Justin Trudeau si sta imponendo tra i primi fornitori di grano all’Italia: dal Canada abbiamo importato 329 mila tonnellate nel 2015 e 383 mila tonnellate nel primo trimestre del 2016.
Problema numero uno.
In Canada, per accelerare la maturazione della spiga, prima della raccolta viene utilizzato il glifosato come disseccante, una pratica vietata in Europa (il glifosato è l’ingrediente principale dell’erbicida Roundup della Monsanto che secondo l’Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro è potenzialmente cancerogeno e che è al centro di una controversia internazionale: entro la fine di quest’anno l’Unione europea dovrà decidere se vietarlo o meno).
Tracce di erbicida, questa la preoccupazione, potrebbe essere presente nei prodotti alimentari derivati dal grano – pasta “made in Italy” compresa. In più, il grano canadese per via dell’umidità del clima viene aggredito dalle micotossine, un fungo patogeno contaminante che ad alti livelli di concentrazione può agire a livello gastrointestinale.
La presenza, pur nella norma, di questi contaminanti – glifosato, micotossine e cadmio – è stata riscontrata in un test effettuato su alcuni campioni di pasta italiana dall’associazione GranoSalus.
Il problema numero due, oltre a complicare la faccenda sul piano della sicurezza alimentare, introduce una questione di politica internazionale. Con l’entrata in vigore del Ceta (l’accordo commerciale tra Unione europea e Canada che non è ancora stato ratificato dal parlamento italiano) le grandi aziende nord americane dell’agro-business avranno a disposizione nuovi strumenti per attaccare i rigorosi standard europei a tutela della qualità del cibo.
È evidente, come spiega l’Associazione italiana agricoltura biologica (Aiab), che una futura armonizzazione delle norme canadesi ed europee potrebbe rimettere tutto in discussione. Le criticità da affrontare a livello parlamentare non riguardano solo il grano duro al glifosato: «L’armonizzazione delle norme verso un minimo comune denominatore, previsto nell’accordo, accetta di fatto lo spostamento verso il basso delle regole di produzione e degli standard di sicurezza alimentare. In particolare ci verrebbero imposti gli ormoni della crescita nelle carni, l’uso di antimicrobici nel lavaggio, una liberalizzazione degli Ogm e un’etichettatura ancora meno trasparente».
Gli stessi industriali canadesi del resto non ne fanno mistero. Cam Dahl, presidente di Cereals Canada, ha minacciato ritorsioni (un’azione legale al Wto) qualora l’Italia dovesse imporre l’etichettatura d’origine sui pacchi di pasta.
Di fatto il contenzioso è già aperto perché in Italia l’obbligo di etichettare la provenienza del grano dovrà, o dovrebbe, scattare il 17 febbraio.
Il decreto però è stato impugnato dall’Aidepi con un ricorso al Tar del Lazio che somiglia a un’arrampicata sugli specchi. L’associazione delle industrie dei pastai ritiene che «l’obbligo dell’indicazione di origine del grano nella pasta sia sbagliato: promette trasparenza ma disorienta il consumatore e invece di sostenere una filiera di grande valore per la nostra economia, come quella della pasta, rischia di affossarla».
Nel frattempo Barilla (azienda leader in Italia con ricavi consolidati per 3,4 miliardi di euro e nel 2016 e utile netto in salita a 371 milini di euro) si è affidata a Bebe Vio per riorientare il consumatore con uno spot che ammette il ricorso al grano straniero, che però è buono e di qualita: “Ottimo, grande, mi hai convinto, dammi cinque…”. Paolo Barilla, vice presidente dell’omonimo gruppo, su Rai1 è stato meno simpatico: «Per l’industria tutto dipende da che tipo di prodotto produrre e a quali costi, perché se noi dovessimo fare un prototipo di pasta perfetta, in una zona del mondo non contaminata, senza bisogno di chimica, probabilmente quel piatto di pasta invece di 20 centesimi costerebbe 2 euro. Una pasta a glifosato zero è possibile ma solo alzando i costi di produzione».
Più chiaro di un’etichetta.
«IL GLIFOSATO C’È,
BASTA CONTROLLARE»
intervista a Saverio De Bonis
Critiche a 360 gradi: «Gli agricoltori italiani accettano la filiera capestro imposta dalle multinazionali, che dettano il prezzo del grano».
Saverio De Bonis, 52 anni, lucano, è un produttore di grano duro e presidente dell’associazione GranoSalus. I suoi attacchi alle industrie – supportati da analisi di laboratorio – continuano a scatenare polemiche furibonde tra i pastai più noti. La controversia non è ancora risolta.
Lo scorso ottobre il tribunale di Roma ha dato ragione a GranoSalus che ha riportato articoli secondo cui la pasta di alcuni marchi contiene sostanze contaminanti e quindi, per deduzione, sarebbe lavorata anche con grano importato dal Canada. Perché avete commissionato quei test che hanno scovato glifosato, micotossine e cadmio?
Sette anni fa un microbiologo che partecipava alle attività dei nostri circoli ha lanciato l’allarme sulla presenza di micotossine. È un fungo patogeno che si sviluppa sul grano a causa dell’umidità. Le istituzioni non ci hanno ascoltato e così abbiamo deciso di cambiare strategia per parlare anche ai consumatori. GranoSalus nasce così: piccoli produttori locali si associano per tutelare il diritto alla salute e alla produzione di qualità. Lo scorso febbraio abbiamo effettuato i primi test prendendo la pasta sugli scaffali e abbiamo trovato tracce di glifosato e cadmio in otto campioni esaminati, sono perturbatori endocrini e quindi dannosi a prescindere dalla quantità rilevata. Le analisi sono state condotte da un laboratorio di Cuneo certificato e utilizzato anche dall’Unione europea.
Quali paste avete fatto analizzare?
Barilla, La Molisana, De Cecco, Divella, Garofalo, Granoro, Voiello e Coop. Le industrie che hanno presentato ricorso (Coop non lo ha fatto ma ha precisato con una nota) sono state condannate a risarcire le spese processuali perché negli articoli non c’era diffamazione.
Avete fatto controlli sulle navi.
Due a Manfredonia e due a Bari, dove arriva il 60 per cento del grano duro importato. Anche in quel caso i test hanno confermato la presenza degli stessi contaminanti sulla materia prima: micotossine, cadmio e glifosato.
I vostri test però sono stati duramente criticati dalle industrie della pasta. Vi hanno accusato di allarmismo ingiustificato.
Gli articoli in questione, come scrive la prima sezione civile del Tribunale di Roma, costituiscono legittima espressione del diritto di critica e manifestazione del pensiero, trattandosi di temi di tale delicatezza e rilevanza per la salute pubblica. Le industrie dicono di avere accusato il colpo con un calo delle vendite, ma hanno solo cercato di riposizionare la propria immagine vantando la bontà degli approvvigionamenti dall’estero, come fa Barilla: hanno imposto agli agricoltori italiani un disciplinare su cui scrivere che il grano venduto non contiene glifosato, ma è del tutto superfluo poiché in Italia nessuno spruzza diserbante sulle spighe.
Le sostanze rilevate però sono presenti in quantità che rispettano i limiti previsti dalla legislazione europea, dunque qual è il problema?
Sono nei limiti, però non ci sono prove scientifiche che dimostrino che tutti questi contaminanti, assunti insieme, non provochino danni alla salute. Sui limiti ci sarebbe da discutere. La Fao fissa la presenza della micotossina DON (deossinivalenolo) a 1.000 ppb (parti per miliardo), solo che in Europa a partire dal 2006 questa soglia è stata portata a 1.750. In Canada il grano che supera la soglia di 1.000 ppb non viene dato nemmeno agli animali: è questa la roba che finisce in Europa. Quanto al glifosato, nel 2016 l’Europa, essendo impossibile stabilire una soglia di pericolosità, si è messa al riparo vietandolo del tutto. Quindi, teoricamente, le paste con tracce di glifosato dovrebbero essere fuorilegge. Abbiamo rivolto la questione al ministero della Salute, ma non ci hanno saputo rispondere.
Se il grano che già oggi importiamo dal Canada è inquinato, cosa cambierebbe qualora venisse approvato il Ceta?
Con il mutuo riconoscimento della legislazione, l’Europa sarebbe costretta ad accettare l’impalcatura giuridica canadese. Il legislatore italiano, per fare solo un esempio, non potrebbe più rifiutare la pasta contaminata al glifosato, quindi verrebbe neutralizzato il principio di precauzione.
Chi utilizza solo grano italiano produce pasta non contaminata?
Il grano italiano non garantisce nulla. La vera garanzia sarebbe scrivere su un’etichetta che nella pasta non ci sono sostanze contaminanti. Anche nel grano prodotto in Italia possono trovarsi elementi di tossicità, nelle zone più umide del paese per esempio è più facile che si sviluppi la micotossina. Comunque va detto che in Italia si producono ottime paste a 0 ppb fatte con grano secco dove il fungo non si sviluppa. Che prendano il grano dove vogliono, ma le industrie devono dire al consumatore cosa contiene a livello di residui tossici. Del buon grano turco, o spagnolo, può avere le stesse caratteristiche qualitative di quello italiano.
Il grano duro italiano di alta qualità viene anche esportato. Eppure la produzione totale non soddisfa il fabbisogno interno.
Il nostro grano è prezioso e viene venduto all’estero a prezzi più alti. Noi abbiamo l’oro e lo esportiamo, poi per soddisfare il mercato interno a volte lo tagliamo con un po’ di argento. Sta succedendo questo. Nel Maghreb vogliono il nostro grano, non quello canadese: oggi è più tutelato un marocchino che mangia cous-cous di un italiano che mangia la pasta.
Cosa potrebbe fare il governo per tutelare produttori e consumatori?
Dotarsi di una politica di settore che non ha mai avuto. Il cibo, invece, continua ad essere utilizzato come merce di scambio per trattati internazionali e per incrementare l’export. Il governo dovrebbe decidere cosa è strategico per il paese e poi potenziare i controlli. Un esempio: il ministero ha un elenco di sostanze da cercare negli alimenti stoccati nei porti italiani e tra queste non figura il glifosato. Come mai? Servono controlli seri su tutti i derivati dai cereali: pasta, pane, pizze, dolci.
Tutti gli agricoltori italiani sono impegnati in questa campagna?
Non tutti nello stesso modo. Il sistema agricolo italiano accetta supinamente la filiera capestro imposta dalle multinazionali dei pastai che fissano i prezzi minimi e massimi. Con la complicità del governo.
«NOI, PADRI DEL BIO ITIANO,
CONTRO IL CETA»
di Monica di Sisto
«Reportage. Per Girolomoni la pasta è un progetto politico. Il fondatore portò il biologico in Italia. Ora spiegano come si può produrre senza glifosato»
Naturalmente No Ceta: «Perché produciamo anche per il mercato estero e sappiamo che, adeguandoci ad esso, potremmo farlo a costi decisamente inferiori. Ci rimetterebbero la qualità, i consumatori, il territorio, l’ambiente, noi stessi. Dovremmo rinunciare a principi e valori, e non valgono così poco».
Giovanni Battista Girolomoni, poco più che trentenne, ha gli occhi accesi da un sogno e una grande eredità sulle spalle. Con suo fratello Samuele e sua sorella Maria sono le gambe sulle quali cammina ancora, tra i campi di Isola del Piano di cui è stato sindaco per dieci anni, Gino Girolomoni, il padre del biologico italiano, spentosi all’improvviso nel 2012. Gino nel 2006 aveva lanciato un appello agli abitanti della provincia di Urbino perché sostenessero alle elezioni politiche «quei candidati che si adopereranno affinché in un territorio non si compia alcuna scelta senza il consenso della maggioranza dei suoi abitanti».
Per questo avrebbe apprezzato la scelta dei suoi figli di ospitare nel loro festival Ville e castella una delle tappe del No Ceta tour, sostenuto dalla Campagna Stop Ttip Italia in piazze e città italiane per fermare la ratifica del trattato di liberalizzazione commerciale tra Europa e Canada da parte del Parlamento italiano.
Per i Girolomoni la pasta, prodotto di punta dell’azienda che porta il nome di Gino e viene gestita in forma cooperativa nel cuore delle Marche, non è solo cibo e denaro ma un progetto politico: «Nel 1980 un’ispezione dei Nas gliene sequestrò 400 quintali per frode commerciale, perché la definiva biologica quando in Italia non c’era ancora una legge che riconoscesse questa produzione», racconta Giovanni. «Mio padre vedeva un futuro che le normative hanno faticato a definire, ma che noi vogliamo continuare a scrivere» sostiene, camminando tra le macchine a trafila di bronzo e le celle statiche dove la pasta lentamente essicca, preservando qualità e profumo speciali.
Ma se il trattato di liberalizzazione tra Europa e Canada dovesse passare la ratifica, il Ceta porterebbe a contraddire e a concorrere slealmente con quella filosofia di vita e produzione. Per il trattato tra Europa e Canada,1057 pagine dove si affronta un po’ di tutto – dagli investimenti alla finanza, dalle professioni ai brevetti, fino al cibo – l’unico criterio che conta è che il commercio tra le due sponde dell’Atlantico sia il più facile possibile.
Già al momento, soprattutto per il grano, è decisamente fluido: l’Italia è il principale produttore europeo di grano duro, destinato alla pasta, con 4,9 milioni di tonnellate su una superficie coltivata pari a circa 1,3 milioni di ettari.
Nonostante ciò sono ben 2,3 milioni le tonnellate di grano duro che arrivano dall’estero in un anno (dal Canada 1,2 milioni di tonnellate) senza che questo venga reso noto ai consumatori in etichetta. Per Girolomoni, invece, nonostante venda anche in Nuova Zelanda e Giappone, «sono un centinaio le aziende agricole coinvolte direttamente e il grano è comunque tutto italiano, principalmente di filiera marchigiana», elenca Giovanni Battista.
Chi sale attraverso i colli di solchi e viti verso la collina di Montebello, 150 ettari a pochi chilometri da Urbino, incontra un mondo contromano rispetto alle regole che il Ceta vorrebbe imporre, ma economicamente vincente.
La Gino Girolomoni Cooperativa Agricola è una realtà che va dal campo alla pasta ma resta ben integrata nelle colline circostanti. A una passeggiata di distanza si staglia l’ex monastero di Montebello, strappato alla rovina da Girolomoni padre, che ha ospitato negli anni incontri con intellettuali e artisti come Sergio Quinzio, Ivan Illich, Guido Ceronetti, Paolo Volponi, e dove ogni anno passano centinaia di ospiti appassionati da accoglienza, cucina e un intenso calendario di eventi.
Con i suoi 200 agricoltori, 37 dipendenti e con i suoi oltre 11,5 milioni di fatturato, l’azienda cooperativa Gino Girolomoni, «che è voluta rimanere tale perché così si è tutti responsabili e partecipi», spiega ancora Giovanni Battista, ha contribuito in modo sostanziale allo sviluppo del biologico in Italia.
Nei pressi del monastero, circondato da circa duemila ettari di foresta demaniale, ha sede l’attività della Cooperativa con i suoi magazzini, la stalla, il pastificio. Oggi, dopo oltre trent’anni, buona parte della superficie agricola del comune di Isola del Piano è coltivata con il metodo dell’agricoltura biologica.
«Facciamo in casa anche l’energia – spiega ancora Girolomoni jr – Quella che usiamo è tutta da fonti rinnovabili: in parte acquistata certificata e per circa un terzo ricavata da un sistema composto da un parco di pale eoliche e da un tetto fotovoltaico».
È anche in corso uno studio di fattibilità per la produzione di energia termica da biomasse. Il Canada del giovane premier Justin Trudeau invece ha sbloccato, con l’aiuto del presidente americano Donald Trump, la costruzione dell’oleodotto transfrontaliero Keystone XXL che gli consentirà di immettere sul mercato internazionale 173 miliardi di barili di petrolio da sabbie bituminose canadesi che, se bruciati, secondo i conti di Oil change international, genererebbero quel trenta per cento di anidride carbonica che ci porterebbe oltre l’obiettivo di 1,5 gradi centigradi di incremento di temperatura atmosferica stabilita come soglia massima di aumento con l’accordo di Parigi contro i cambiamenti climatici.
Il Ceta introduce anche l’applicazione del principio di equivalenza delle regole sanitarie e fitosanitarie tra il Canada e l’Europa, che consentirà ai prodotti canadesi di non sottostare a nuovi controlli una volta arrivati alle nostre frontiere.
Un rischio annunciato visto che in Canada sono impiegate nell’agroalimentare 99 sostanze vietate in Unione europea tra cui il glifosato, attualmente sotto processo in Europa, e il mortale Paraquat, illegale da noi da oltre vent’anni.
Nel Canada del Ceta il grano, ad esempio, non solo è trattato con il glifosato, l’erbicida di casa Monsanto sospettato di essere cancerogeno e oggi vietato in Italia, ma arriva nel nostro Paese già vecchio di un anno, visto che la raccolta avviene in settembre. Perché si irrora il grano con il glifosato? Per seccare le piante in un Paese in cui abbastanza sole non c’è, abbattere le tossine e garantire artificialmente un livello proteico elevato nelle spighe, concentrando più nutrienti ma anche tutti i residui chimici.
Nel mondo di Girolomoni, invece, la semina del grano avviene verso i primi di novembre. Raggiunta un’altezza di circa dieci centimetri, il germoglio si ferma per tutto l’inverno. La pianta di grano, infatti, torna a crescere velocemente dopo la pausa invernale.
A luglio, essendo ormai il grano secco e maturo, si procede con la trebbiatura, che separa i chicchi della spiga dalla paglia e dalla pula. Il grano raccolto viene controllato e, una volta accertata la qualità, la pulizia e un’umidità non superiore all’undici per cento, collocato nei silos di stoccaggio.
Prima del riempimento i silos vengono puliti con cura e trattati con polvere di diatomee che uccide gli insetti per disidratazione. Successivamente si deve muovere e arieggiare costantemente il prodotto fin verso la fine di settembre: questo, infatti, è il periodo in cui calore e umidità in eccesso possono creare muffe, germinazioni e infestazioni di insetti e le si combatte con lavoro e natura.
«Gli investimenti futuri e le idee vanno nel costruire una filiera della pasta sempre più sicura per qualità e sostenibilità ambientale», è il programma di Giovanni, il cui ultimo passo è stato un centro di stoccaggio da 10 mila quintali a Isola del Piano per la raccolta del grano locale, e il prossimo, «se le cose vanno come sembra – suggerisce – sarà un mulino, che ci permetterebbe controllo della qualità e autosufficienza totali. Senza contare che potremmo aumentare la produzione locale strappando ancora più territorio all’abbandono».
«Il Ceta ci offre l’occasione di sorpassare tutti i nostri concorrenti. Il governo deve lavorare nella sua applicazione per superare gli ostacoli rimanenti, legati alle condizioni poste in Europa ai trattamenti su produzioni e colture e alle biotecnologie; questioni importanti che devono essere affrontate perché l’accordo possa offrire il proprio potenziale», è invece l’agenda d’azione dei suoi colleghi d’oltreoceano, rappresentati dalla potente Canadian Agri-Food Trade Alliance (Cafta).
Visioni da avere ben presenti per decidere da che parte di futuro stare.
Uno degli argomenti più caldi in discussione alla Conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (COP23), tenutasi a Bonn tra il 6 e il 17 novembre, sono stati gli aiuti finanziari per coprire i danni e le perdite (loss & damage) legati alle conseguenze dei cambiamenti climatici. Questione urgente e troppo a lungo rimandata, divide i Paesi sviluppati e in via di sviluppo in una lotta che resta irrisolta. C’erano molte aspettative per quest’anno in cui le Fiji avevano la presidenza della conferenza, dato che le isole del Pacifico sono una tra le aree del mondo più colpite dal riscaldamento globale e a rischio di scomparsa per l’innalzamento del livello dei mari. Nonostante ciò, la questione è rimasta irrisolta, rimandata al 2018.
Cos’è il loss & damage
Non esiste una definizione condivisa per i danni e le perdite legati alle conseguenze dei cambiamenti climatici. Quella più citata risale al 2012, di Warner et al.: “Per danni e perdite si intendono gli impatti negativi della variabilità del clima e dei cambiamenti climatici che le popolazioni non sono state in grado di gestire o a cui non sono riuscite ad adattarsi”. Mentre il concetto di danno implica la possibilità di riparazione, rientra tra le perdite ciò che non può essere recuperato o ricostruito, ma solo eventualmente compensato. Ci sono due tipi di perdite: quelle economiche, ovvero di risorse, beni e servizi di mercato, che hanno quindi un valore monetario facilmente definibile, e quelle non economiche, il cui valore economico è difficile da stabilire ma che hanno nondimeno un impatto sugli individui e sulla società. Un documento tecnico redatto nel 2013 dal gruppo di esperti delle Nazioni Unite sulle perdite non economiche include tra queste la vita, la salute, gli sfollamenti e la mobilità, il territorio, l’eredità culturale, le conoscenze indigene e locali, la biodiversità e i servizi ecosistemici.
Le conseguenze dei cambiamenti climatici causati dall’uomo si diversificano a seconda delle aree del mondo e possono essere divise in due categorie. La prima sono gli impatti immediati, ovvero quelli causati da eventi estremi come inondazioni, ondate di calore, siccità, precipitazioni intense, tornado e uragani: nel periodo tra 1995 e 2014, gli eventi climatici estremi hanno causato danni per 2.97 miliardi di dollari e più di 525.000 morti. La seconda sono gli impatti di lungo termine, come la perdita di biodiversità e degli ecosistemi, la degradazione della terra e la desertificazione, il cambiamento della circolazione oceanica e atmosferica, l’innalzamento del livello dei mari e l’erosione costiera, che si traducono in riduzione della sicurezza idrica e alimentare, sfollamenti forzati, diffusione di malattie tropicali, e così via.
Azioni di mitigazione e adattamento possono contribuire a ridurre questi impatti, ma è inevitabile che, soprattutto nella seconda metà del secolo, comporteranno dei danni e delle perdite. È perciò cruciale parlare di questo problema, in special modo dal momento che colpisce in particolare i Paesi meno sviluppati, che hanno contribuito meno ai cambiamenti climatici e sono meno preparati a farvi fronte.
Il concetto di loss & damage nel dibattito internazionale sui cambiamenti climatici
Dalla prima proposta effettuata dall’Alleanza dei piccoli Stati insulari (AOSIS) per l’istituzione di un meccanismo internazionale che fornisse un’assicurazione finanziaria contro le conseguenze dell’innalzamento del livello dei mari, lanciata nel 1991 durante le negoziazioni della Convenzione Quadro delle Nazioni Unite sui Cambiamenti Climatici (UNFCCC), il dibattito sulle perdite e i danni è progredito notevolmente. Se infatti nei primi anni gli aiuti finanziari per il clima erano previsti soprattutto per azioni di mitigazione, successivamente si è fatto spazio il concetto di supporto per l’adattamento alle conseguenze inevitabili dei cambiamenti climatici. La progressiva realizzazione che, nonostante gli sforzi, è impossibile evitare tutti gli impatti negativi sulla società e sugli individui del cambio del clima ha portato all’emergere nel dibattito internazionale del concetto di compensazione dei danni e delle perdite.
Nel 2013 è stato istituito nell’ambito dell’UNFCCC il Meccanismo Internazionale di Varsavia per i danni e le perdite associate agli impatti dei cambiamenti climatici (WIM), con il compito di approfondire le conoscenze sul tema, creare contatti tra gli attori rilevanti e rafforzare le azioni e il supporto per gestire le perdite e i danni. Il meccanismo è stato successivamente posto sotto l’egida della Conferenza delle Parti dell’Accordo di Parigi, che all’articolo 8.1 riconosce l’importanza di prevenire, minimizzare e gestire le perdite e i danni legati agli impatti dei cambiamenti climatici.
Tuttavia, anche se il problema è da molto tempo conosciuto e discusso, non sono state ancora adottate misure pratiche per aiutare chi subisce questi impatti. Il meccanismo di Varsavia, a quattro anni dalla sua istituzione, non è ancora completamente operativo, specialmente per quanto riguarda l’aspetto del rafforzamento delle azioni e del supporto nel campo. Le motivazioni dietro questo ritardo sono complicate, ma possono essere ricondotte in ultima analisi alla riluttanza dei Paesi sviluppati di ammettere la propria responsabilità per gli impatti che le popolazioni del Sud del mondo stanno subendo, per timore di doverle ripagare.
Cosa è successo durante la COP23?
Durante la conferenza sul clima di Bonn, invece di progredire il dibattito è rimasto fermo. I Paesi sviluppati si sono opposti alla richiesta dei rappresentanti delle popolazioni più vulnerabili di coprire con la finanza climatica i costi dei danni e delle perdite associati agli impatti dei cambiamenti climatici. L’Unione Europea e l’Australia si sono giustificate dicendo che non ogni disastro è causato dai cambiamenti climatici.
Ciò è successo a pochi giorni dalla pubblicazione di un rapporto della rivista indipendente The Lancet, che registra per il 2016 797 eventi climatici estremi che hanno causato 129 miliardi di dollari in perdite economiche. Rispetto a ciò, un progetto di Carbon Brief lanciato nel 2012 sta studiando singoli casi di eventi estremi per collegarli alle attività antropiche. Dei 144 casi studiati finora, per il 63% l’influenza umana ha aumentato la probabilità o la gravità dell’evento, per il 14% non ha causato cambiamenti rilevabili e per il 18% non ci sono abbastanza dati per trarre conclusioni definitive. La scienza che collega attività umane, cambiamenti climatici e aumento dei fenomeni estremi sta quindi progredendo e potrebbe essere una base per la relativa compensazione finanziaria. Inoltre, come spiegato sopra, i danni e le perdite non si esauriscono a fenomeni immediati, ma riguardano anche e soprattutto processi lenti già in corso, la cui relazione di causa-effetto con l’influenza umana è innegabile.
Hasan Mahmud, ex Ministro dell’Ambiente del Bangladesh, che attualmente presiede la commissione parlamentare permanente per il Ministero delle Foreste e dell’Ambiente, ha espresso durante una conferenza stampa la sua preoccupazione per il rifiuto dei Paesi sviluppati di riconoscere il bisogno di fondi pubblici e aiuti per l’adattamento. La critica era soprattutto collegata all’iniziativa della Presidenza Fiji, che ha promosso lo strumento assicurativo come una soluzione alla questione del loss&damage, lanciando il secondo giorno dei negoziati la InsuResilience Global Partnership, un’iniziativa finanziata dal settore privato che mira a estendere l’assicurazione climatica a 400 milioni di persone povere entro il 2020. In parallelo, il Comitato Esecutivo dell’UNFCCC per il meccanismo di Varsavia ha lanciato un database online che mira a mettere in contatto gli assicuratori con potenziali clienti nei Paesi vulnerabili. Entrambe le iniziative lasciano al settore privato e a logiche di mercato il compito di compensare le perdite e i danni, senza affrontare il problema di chi pagherà i premi assicurativi.
In breve, i Paesi ricchi hanno trovato un modo per evitare di riconoscere le proprie responsabilità per le conseguenze dei cambiamenti climatici e quindi ripagare i Paesi meno sviluppati e più vulnerabili per gli impatti negativi che stanno subendo. Sembra così che il principio delle responsabilità comuni ma differenziate e delle diverse capacità, riconosciuto nell’articolo 2 dell’Accordo di Parigi, sia condiviso solamente quando non si tratta di soldi.
Azioni di persuasione non sempre lecite per convincere, con successo, i nostri governanti e la Commissione Europea a continuare una politica energetica basata sul gas, che è tutt'altro che un' energia pulita.
In questi giorni è uscito il rapporto dell’Corporate Europe Observatory (
qui il link al documento) sull’industria e la lobby del gas. Secondo il registro volontario di trasparenza, l’industria del gas ha speso circa 100 milioni di euro nel 2016 per azioni di lobby dirette a influenzare le scelte dei governi nazionali e della Commissione Europea in material energetica e a tenere a bada le proteste. Oltre 1.000 lobbisti più un esercito di agenzie di consulenza e pubbliche relazioni hanno aiutato, e continuano a farlo, ad organizzare eventi e incontri ad alto livello con tutti gli attori che contano nel campo dell’energia e del clima. L’obiettivo era, e rimane, di far passare il messaggio che il gas è un combustibile "pulito" e un partner nelle risorse rinnovabili e che l’Europa continui a basare la propria politica energetica sul gas.
 |
Da quando hanno assunto i loro ruoli, nel novembre 2014, il commissario dell'Azione per il clima e l'energia, Miguel Arias Cañete, e il vicepresidente dell l'Unione dell'energia, Maroš Šefčovič, hanno avuto un ruolo determinate nell'approvazione del gas come fonte energetica, con la loro politica di porte aperte ai lobbisti dell'industria.
Fonte: Balanyá, B. e Pascoe Sabido, P. (2017) The Great Lock-in, Corporate Europe Observatory |
L’articolo ripreso su eddyburg dall’open democracy riporta alcune delle tante azioni di “lobby”, ampiamente descritte nel rapporto, messe in campo dall’industria del gas. Queste comprendono tangenti per ingraziarsi i politici europei, elargite con soldi riciclati attraverso il paradiso fiscale azerbaigiano nonchè azioni apparentemente più morbide, come le pressioni fatte a istituzioni accademiche in cambio di collaborazioni varie, la sponsorizzazione di eventi culturali e sportive. L’Azerbaijan è noto per le violazioni dei diritti umani, la repressione dell’opposizione, e la sua “diplomazia del caviale" che con abbondanti doni, da tappeti di seta a oro, argento e chili di caviale, si compra sia il silenzio sull’infrangimento dei diritti umani che l’appoggio alla costruzione del Trans Adriatic Pipeline (TAP), uno dei mega progetti in previsione (vedi la mappa qui sotto) per allargare l’approvvigionamento e consumo di gas.
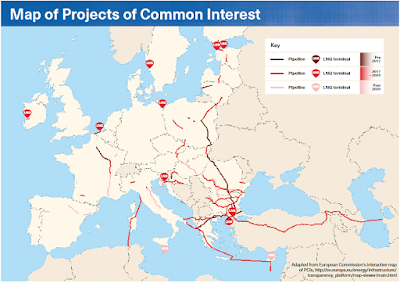 |
| Fonte: Balanyá, B. e Pascoe Sabido, P. (2017) The Great Lock-in, Corporate Europe Observatory
|
Una lobby che ha dato i suoi frutti! Infatti la Commisssione Europea e i governi nazionali, anziché trasformare il sistema energetico in direzione del vento, del sole e soprattutto della riduzione del consumo di energia, hanno sostenuto, approvato e finanziato l’espansione della fornitura di gas.
Il TAP è un progetto iniziato a metà 2016 per la costruzione di un gasdotto che trasporterà il gas dall'Azerbaijan all’Europa, attraversando la Turchia - dove si collegherà al Trans Anatolian Pipeline - la Grecia settentrionale, l’Albania e l’Adriatico per poi approdare in Puglia, collegandosi alla rete nazionale. I lavori sono gestiti da un consorzio di aziende, tutti colossi dell’energia: Bp, Socar, Snam, Fluxys, Enags e Axpo.
«Una volta realizzato, costituirà il collegamento più diretto ed economicamente vantaggioso alle nuove risorse di gas dell’area del Mar Caspio, aprendo il Corridoio Meridionale del Gas, una catena del valore del gas lunga 4.000 chilometri, che si snoderà dal Mar Caspio all’Europa.» (dal sito della TAP: www.tap-ag.it/).
Ma vantaggioso per chi? Non certo per i cittadini.
Ad aprile un’ inchiesta dell’ Espresso, che aveva potuto esaminare i documenti riservati della Commissione Europea, aveva già rivelato come il progetto celava il riciclaggio di denaro mafioso con la compiacenza dei governanti e ovviamente di tutte le ditte coinvolte. Qui il link all’articolo, già ripreso da eddyburg.
La questione più spaventosa di questo intrigo tra affari, mafia e potere politico è che questa scelta costringerà l’intera Europa a protrarre per oltre 40-50 anni la sua dipendenza dai combustibili fossili, con conseguenze disastrose per il clima, le comunità locali e per i territori lungo tutta la tratta del gas, infrangendo gli impegni presi in materia di cambiamenti climatici ed energia pulita.
Il gas – nella sua forma convenzionale o quella ora più gettomata derivante da giacimenti non convenzionali in argille (fracked gas) - sebbene sia una fonte energetica più pulita del petrolio appartiene alla lista dei combustibili fossili e responsabile dell’incremento del cosiddetto effetto serra.
Il processo di estrazione dei fracked gas richiede alti volumi di acqua e prodotti chimici inquinanti, ha impatti particolarmente negativi sui territori e comunità locali. Ma anche l’estrazione del gas convenzionale provoca seri problemi in quanto favorisce la formazione di dissesti geologici. Per esempio nei Paesi Bassi il governo è stato messo sotto pressione per ridurre l’estrazione di gas dal campo di Groningen dopo ripetuti terremoti che hanno danneggiato migliaia di case.
Anche l'impatto sul clima è enorme. Nonostante il gas viene spacciato dalla lobby, dalla Commissione Europea e dai governi nazionali come “energia pulita” e “un ponte verso l’energia rinnovabile” esso rimane un dannosissimo combustibile fossile. È vero che quando brucia emette meno anidride carbonica rispetto al carbone, ma essendo il gas naturale composto in gran parte da metano, si verifica che il suo impatto, in arco di tempo di 10 anni sia 100 volte di più dannoso della CO2. Inoltre c’è una grande perdita nel trasporto e tariffe più alte di quanto stimate in precedenza. Lo scienziato Americano Robert Howarth ha affermato che "il gas naturale è un ponte verso il nulla".
Infine i danni causate dalle infrastrutture stesse. Le campagne “Platform” e “Re:Common” hanno documentato numerose violazioni lungo la rotta dal Mar Caspio all’Europa. Ma in Azerbaijan, dove inizia il gasdotto, quelli che tentano di denunciare il progetto sono finiti in carcere o assoggettati a dura repressione.
Non mancano le proteste in Italia, il Comitato No Tap cerca da tempo di fermare il progetto. Anche se la Commissione europea, il governo italiano e la società Tap dicono che i cittadini e le autorità locali, si sono mosse troppo tardi, le opposizioni si sono fatte sentire sin dal 2011. Su eddyburg abbiamo pubblicato un articolo a questo proposito: “No Tap, la lunga storia dell'opposizione al gasdotto pugliese”.
Proprio di recente, anche il ricorso della Regione Puglia non è stato ascoltato. La Corte costituzionale ha ritenuto inammissibile il conflitto sollevato dalla Regione Puglia contro lo Stato, quindi la costruzione proseguirà. Il governatore della Puglia accusa il governo di avere agito senza l’intesa della regione e dei suoi abitanti in un progetto in cui "La prepotenza di questa scelta è sotto gli occhi di tutti", ed è calpestata "la volontà delle popolazioni che non accettano, giustamente, l'approdo del gasdotto" vicino a una delle spiagge più belle del Salento (Repubblica.it, 10 ottobre 2017). La Puglia accusa il governo – nella fattispecie il ministero dello Sviluppo economico (Mise) che ha autorizzato la costruzione dell'opera - di non avere intrapreso nessuna trattativa per trovare una soluzione condivisa, in particolare sul punto di approdo del gasdotto, ma la Consulta ha ritenuto non ammissibili i motivi del ricorso.

In un formato abbastanza sintetico un programma di lavoro per rendere il mondo più vicino a quanto ci piacerebbe che fosse. A Tomaso non è dispiaciuto

Premessa
Maria Pia Guermandi ha invitato alcuni amici, estimatori di Tomaso Montanari e conquistati dalla piattaforma politica lanciata al Teatro Brancaccio di Roma nel luglio 2017, di specificare, in un numero limitato di schede, le proposte che vedrebbero utilmente contenute in un programma elettorale coerente con quella piattaforma politica. Abbiamo riflettuto, ragionato, discusso, scritto e corretto. Qui il nostro prodotto. Lo abbiamo inviato a Tom, perché ne faccia ciò che crede meglio.
1. Definizioni
Città, territorio, urbanizzazione, territorio urbanizzato, habitat dell’uomo. La città è la forma che ha assunto, in una determinata fase della storia dell’umanità, l’insediamento della società (delle società) sul territorio: una forma caratterizzata dalla spiccata densità della popolazione, dalla forte intensità delle relazioni tra i suoi abitanti, e dalla parallela consistenza delle trasformazioni fisiche e antropiche del suolo (al limite “la repellente crosta di cemento e asfalto” A. Cederna).
Nel tempo, la contrapposizione tra città e territorio rurale, dove dominava ancora la natura e le trasformazioni erano lente, si è affievolita. IL processo di espansione della civiltà urbana si è esteso molto al di là dei confini delle città, investendo parti via via più ampie del territorio del pianeta Terra. In gran parte del mondo, la condizione urbana, un’espressione di Manuel Castell per indicare una situazione socio-economica, politica e culturale, oltre che fisica, investe e comprende il territorio. Il termine “territorio urbanizzato” può volta per volta essere adoperato sia per indicare questa condizione, che travalica i confini della città tradizionale, che per identificare l’area interessata dal processo di urbanizzazione e trasformazione fisica del suolo.
Gli esseri viventi continuano a insediarsi in modi diversi e non sempre secondo quella densità di relazioni che contraddistinguono la città. Ma gli insediamenti sono sempre il risultato di un rapporto particolare tra essere umano e la natura circostante, con tutte le implicazioni che questo comporta. Per enfatizzare l’importanza di questo rapporto, nel parlare della città, del territorio e degli insediamenti umani in generale, si può usare l’espressione “habitat dell’uomo” di Piero Bevilacqua.
2. Il blocco edilizio: l’appropriazione privata della rendita urbana
“Il blocco edilizio” è il titolo di un geniale saggio di Valentino Parlato (il Manifesto, 1970, oggi su eddyburg), e di una realtà sociale, tutta italiana, che ha ostacolato, e continua a ostacolare, i tentativi di governare efficacemente il territorio e la società che lo abita. Questa analisi della produzione edilizia e delle stratificazioni che ne fanno parte o ad esso subordinate, mette in luce la saldatura tra interessi privati, (grandi e piccoli, industriali e commerciali), poteri pubblici e rendita immobiliare che caratterizzano l’affare casa in Italia e detta legge nelle scelte urbanistiche e di pianificazione del territorio.
Allo stesso livello di analisi, si pone la successiva analisi di Walter Tocci sul trionfo della rendita, nell’età del finanzcapitalismo (L’insostenibile ascesa della rendita urbana, 2008, oggi su eddyburg. Questo saggio mette in luce le ulteriori trasformazioni avvenute nella città neoliberista con finanziarizzazione dell’economia, che ha rafforzato l’intreccio tra rendite finanziarie e rendite immobiliare, a scapito del salario e del profitti.
L’esistenza della rendita immobiliare e della sua continua crescita in relazione alle trasformazioni quantitative e qualitative delle diverse porzioni della città esprime una caratteristica peculiare e un’anomalia di fondo. La rendita, quando gli interessi ad essa legati sono dominanti, fa si che il perimetro della città si allarghi indipendentemente dalle reali necessità delle comunità che ci vivono e che i suoli edificabili a fini privati prevalgano su quelli destinati ad usi collettivi. L’anomalia sta nel fatto che gli attori che provocano gli aumenti di rendita, in virtù delle trasformazioni apportate nell’area, sono generalmente collettivi e spesso pubblici, mentre l’appropriazione del suo effetto (l’incremento della rendita) è individuale e generalmente privato.
3. il conflitto di fondo: città della rendita o città dei cittadini
Dalla definizione della città come habitat dell’uomo, e peso che ha nelle sue trasformazioni l’appropriazione privata della rendita, nasce il conflitto di fondo che caratterizza la città. Occorre domandarsi se le sue trasformazioni (fisiche, funzionali, proprietarie, fruitive) devono essere dominate dalla logica dell’accrescimento dei benefici economici ottenibili attraverso la loro privatizzazione, oppure da quella del suo miglioramento qualitativo in relazione ai bisogni della società che la abita?
Questo conflitto è tradizionale per la città, ma ha visto mutare le sue forme in relazione alle gigantesche trasformazioni avvenute nell’attuale epoca (o fase) della globalizzazione capitalista:
- l’assorbimento della rendita urbana nel più vasto e potente complesso del potere finanziario, attraverso il quale un gruppo di poche decine di persone detta le regole dei processi economico-sociali mondiali;
- l’accrescimento dalla differenza di potere e di reddito tra un’area sempre più limitata di attori e il resto della popolazione mondiale;
- l’accentuazione delle differenze interne tra gruppi sociali caratterizzati da diversi modi di appropriarsi del territorio, di organizzarlo e di viverlo (un mosaico di recinti, e al tempo stesso un recinto nei confronti del mondo esterno all’area del benessere.
4. Che cosa deve essere la “città dei cittadini?
Se vogliamo combattere davvero la città della rendita non possiamo fermarci agli slogan: dobbiamo raccontare che cosa vogliamo nel concreto. Dobbiamo esprimere un’ immagine chiara di ciò che vogliamo. Proviamo subito a farlo, ma rendiamoci subito conto che il nostro racconto sarà parziale: sappiamo quello che vorrebbero le persone che hanno avuto modo di esprimere le loro esigenze, non sappiamo che cosa vogliono i giovani di oggi, e gli abitanti di domani e come dobbiamo comporre queste esigenze con quelle già note. Proviamo a elencare alcuni requisiti, già emersi nelle esperienze degli adulti e degli anziani, delle donne e dei bambini, degli operai e degli impiegati.
Una città bella perché equa: una città in cui siano presenti tutti i luoghi e i servizi necessari al di là dell’uscio della propria abitazione, distribuiti sul territorio in modo che siano raggiungibili da tutti quale che sia il loro reddito. Una città nella quale , accanto alle aree trasformate e rese artificiali c’è la maggiore quantità possibile di suolo naturale per mantenere l’adeguato approvvigionamento di acqua, cibo, e contatto con la natura. Una città senza barriere né recinti, fisici o sociali che siano: che faciliti le relazioni tra le persone e i gruppi sociali diversi, in cui l’identità delle singole parti non cancelli né impedisca il colloquio tra le diversità, e anzi lo stimoli. una città che consenta agli esseri umani di mantenersi in salute, facendo fronte all’inquinamento sempre più grave e a una produzione di cibo, la cui qualità oggidipende dal quanto ciascunopuò spendere. Una città che consenta agli altri essere viventi, animali e piante, di vivere in armonia con gli umani. Una città capace di razionalizzare la propria produzione di merci per tornare a dare alle merci un valore d’uso più che di scambio e consentire una riduzione degli sprechi e dei rifiuti. Una città capace di decidere del proprio futuro attraverso la pace e il dialogo, seppure lungo e strenuante, e aperta alla collaborazione e cooperazione con i territori vicini e non in competizione con essi.
5. Le regole necessarie per trasformare il territorio
La città e le sue trasformazioni possono essere il risultato di una somma di eventi individuali oppure possono essere guidate da una o più politiche pubbliche. La prima soluzione, almeno a partire dall’epoca dell’affermazione del capitalismo si è rivelata fallimentare.
D’altra parte si è rapidamente compreso che la vita urbana richiedeva una forte integrazione tra la collocazione sul territorio delle diverse sedi per la vita e le attività degli uomini e gli strumenti della connessione fisica.
È nata così l’esigenza di far precedere le singole trasformazioni del territorio (insediamenti residenziali, industriali, commerciali, strutture per i servizi collettivi, infrastrutture per il trasporti delle persone, delle merci ecc.) da un inquadramento complessivo generalmente costituito da una rappresentazione fisica del territorio e delle trasformazioni desiderate) e da un testo normativo, capaci nel loro insieme di trasmettere ordini o divieti ai singoli utilizzatori/trasformatori del territorio.
La prima legge urbanistica italiana degna di questo nome è quella dell’ agosto 1942.
Essa statuiva, o confermava da leggi precedenti, alcuni principi di notevole rilievo, che si sono in gran parte smarriti nel tempo: il primato del pubblico sul privato nelle decisioni sulle trasformazioni del territorio, la multiscalarità, la facoltà del pubblico di espropriare le aree necessarie all’espansione senza riconoscere ai proprietari l’aumento di valore dei loro beni.
Negli anni successivi alla Seconda guerra mondiale, quando l’esigenza di ricostruire ciò che la guerra aveva distrutto e governare la trasformazione della struttura economica da prevalentemente agricola a prevalentemente industriale, avrebbero richiesto il massimo impiego della pianificazione urbanistica e territoriale, queste invece furono totalmente abbandonate.
La struttura generale della legge è rimasta pressoché immutata, salvo le importanti modifiche intervenute dopo l’istituzione della Repubblica e nella metà degli anni Sessanta del secolo scorso. Gli standard urbanistici
Un progresso decisivo nella legislazione urbanistica italiana (purtroppo molto meno nella prassi) è stata l’introduzione degli standard urbanistici: cioè della regola che ad ogni abitante spettasse il diritto di godere dell’uso di una determinata porzione di spazi pubblici e di uso pubblico (6 agosto 1965). Questo evento va segnalato con una forte sottolineatura per molte ragioni:
1. perché è la prima affermazione, nel sistema legislativo italiano, del “diritto alla città” (Henri Lefebvre, 1967), bandiera per i movimenti che a partire da quegli anni hanno operato per il miglioramento della condizione urbana, attraverso la richiesta di servizi e spazi ad uso collettivo ed accessibili a tutti da sottrarre alla logica della rendita;
2. perché è un risultato raggiunto grazie all’incontro fecondo tra forze sociali -esprimenti esigenze diverse (donne, studenti, classe operaia, intellettuali), ma confluenti - di radicali mutamenti nell’organizzazione dell’habitat dell’uomo;
3. perché costituivano un primo passo verso l’affermazione che la città e un “bene” e non una ”merce”, caratterizzata da una logica “comune” e non “individuale;
3. perché poneva alcune basi essenziali per il miglioramento concreto delle condizioni di vita di tutti gli abitanti della città.
6. La città e la società del benessere
Quella che abbiamo sommariamente decritta –e si è affermata in Italia dal dopoguerra in avanti raggiungendo il suo più elevato grado, negli anni Settanta e Ottanta - può essere definita la “città del benessere”. Essa è uno degli elementi di una società che gode anch’essa dello stesso attributo.
Città del benessere e società del benessere sono il frutto della medesima politica, della quale abbiamo a lungo goduto i frutti senza renderci conto che, se ci sono dei frutti, devono esserci delle radici e chi le annaffia e le nutre, a che se in una parte del mondo ci sono dei guadagni in un’altra parte ci sono delle perdite.
Vivevamo nel mondo del capitalismo (quello privato in una parte del mondo e quello di Stato in un’altra: in modo differenziato sotto molti profili al di qua e al di là della “cortina di ferro” e a seconda del differente grado di maturazione del capitalismo e dei suoi conflitti, ma sostanzialmente in modo migliore che nel resto dl mondo.
Là dove si era consolidata la città del benessere, e si abitava meglio, quelle stesse lotte che avevano contribuito a raggiungere questo risultato avevano condotto a ottenere risultati importanti e positivi (per chi poteva goderne) anche su altri terreni: il lavoro, la condizione delle donne, la tutela della salute e della vecchiaia e quella dell’ambiente.
Si trattava della città e della società nelle quali il compromesso tra i diversi gruppi sociali antagonisti (a partire dalle classi) segnava la conclusione di ogni conflitto.
Ma la storia insegna che il sistema capitalistico non è regolato da una logica dialettica perfetta. Il conflitto tra “tesi” e “antitesi” non si risolve in una “sintesi”, che assorbe e compensa gli interessi dell’una e dell’altra: essa si è di fatto risolta non “risolvendo” le contraddizioni, ma “esportandole”.
Ecco allora che, quando il bilanciamento tra la forza contrattuale della classe sfruttatrice nei confronti della classe sfruttata diminuiva, ecco allora che la prima allargava i confini dell’area dello sfruttamento. Ecco allora manifestarsi le varie fasi dello sfruttamento ad altri paesi, altre regioni, e altri settori, prima di allora esclusi, o solo relativamente coinvolti, nell’area del sistema capitalistico.
7. A Lampedusa
Una mattina ci siamo svegliati, e le contraddizioni del nostro modello di sviluppo sono diventate palesi, anche se moltissimi tentano ancora di evitare il confronto con la realtà. Centinaia di persone sono morte, affogate nel Mediterraneo, perché il nostro benessere era stato pagato da un meccanismo che, attraverso le varie fasi dello sfruttamento delle risorse altrui, aveva trasformato le loro regioni in inferni, dai quali tentavano di scappare.
La morte nei nostri mari, a pochi passi da noi, di quelle persone ha posto la domanda del perché fuggivano sapendo dei grandissimi rischi da affrontare. La risposta ha fatto comprendere, a coloro che se la sono posta, che il prezzo del nostro benessere era stato pagato con l’impoverimento dei popoli di cui avevamo rubato le risorse: a cominciare dagli uomini resi schiavi agli albori del colonialismo, per proseguire con l’estrazione dal suolo dei loro minerali e del loro petrolio, per proseguire ancora con la sostituzione delle nostre colture industriali ai loro regimi alimentari, con la distruzione delle loro culture e delle loro lingue, con la sostituzione del nostro imperialismo ai loro poteri, delle nostre lingue alle loro. E’ la truffa della parola “sviluppo” utilizzata per giustificare lo sfruttamento di popoli e risorse situati su territori lontani, in nome di una cultura superiore, più “sviluppata”.
Sviluppo non significava aumento della nostra capacità di ascoltare e comprendere gli altri, qualunque lingua essi adoperassero, utilizzando insieme cervello e cuore: significava solo aumento della produzione e consumo di merci, aumento della ricchezza di chi produceva e induceva a consumare merci sempre più inutili , sacrificando per una merce inutile ma fonte di maggior ricchezza il produttore a un bene che veniva distrutto (un bosco antico per qualche tonnellata di legname, una città storica per una marea di turisti, un paesaggio di struggente bellezza in una selva di palazzoni o una marea di villette).
Questo sviluppo, da un obiettivo è diventata una religione, una credenza cui tutti si inchinano obbedienti. In nome di questo sviluppo abbiamo invaso, saccheggiato, distrutto altre regioni e altri popoli, abbiamo trasformato paradisi in inferni da cui fuggire. E alla fine del ciclo abbiamo trasformato i fuggitivi da nostri simili in cerca di salvezza in nemici da abbattere.
8. I nostri doveri nei confronti del mondo
Il primo passo che dobbiamo compiere è diventare consapevoli del fatto che la miseria e la disperazione degli inferni del mondo sono fortemente dipendenti dalle decisioni prese nel nostro mondo – e dalla credenza dello “sviluppo” che abbiamo accettato e praticato. I passi successivi si chiamano accoglienza, cittadinanza e una politica estera profondamente diversa.
Accoglienza: i migranti vanno accolti e aiutati a mettersi in salvo, costruendo canali protetti per chi vuole fuggire, sconfiggendo le azioni malavitose che si generano attorno alla domanda di fuga. E non solo tragitti organizzati fisicamente con vettori adeguati, ma politiche di assistenza sanitaria e sociale, alle quali l’Europa deve contribuire a dare il suo sostegno.
Cittadinanza: non assimilazione e omogeneizzazione ma riconoscimento agli stranieri degli stessi diritti e doveri degli italiani, nel rispetto delle differenze culturali e religiose. Significa predisporci noi stessi a diventare diversi da quello che siamo: di diventare noi stessi meticci (se già non lo siamo).
Politica estera: una politica indipendente e incerniera sulla pace e su aiuti umanitari genuini, non legati a meccanismi di sfruttamento di risorse locali, favoreggiamento di interessi economici nazionali, o ricatti politici.
9. Un nuovo modello di sviluppo
Esiste una stretta correlazione tra il modello di sviluppo dominante, l’impoverimento economico e sociale della nostra società, le devastazioni ambientali entro e fuori i nostri confini, e i flussi migratori indotti provenienti dai paesi del Sud del mondo verso il Nord. E chi maggiormente subisce gli effetti negativi di questo sviluppo sono le persone più povere, fragili e molto spesso coloro che meno hanno contribuito a provocarli.
La parola sviluppo è quella che forse più di ogni altra è stata capace di plasmare un’epoca. Per oltre settant’anni, il concetto di sviluppo come sinonimo di progresso, civilizzazione, e positività a priori (senza il bisogno di qualificare lo sviluppo con un attributo) ha orientato le politiche di tutti i paesi del mondo e colonizzato le menti, impedendo ad altre concezioni di essere approfondite e altre pratiche di essere attuate.
Nei decenni successivi c’è stata una progressiva sovrapposizione tra sviluppo e “sviluppo economico” compiendo una forte riduzione dei significati complessi e che il termine comprende. Così come ci sono stati tentativi di riabilitare la parola stessa nei suoi momenti di crisi, per esempio durante il momento di presa di coscienza ambientale, di preoccupazione per la scarsità di risorse e lo sfruttamento sfrenato della natura.
Se questa coscienza ha introdotto l’importante concetto di “limite alla crescita”, la nozione di sostenibilità - che invece ha vinto - ha matrici diverse. Infatti, quest’ultimo concetto è avvolto da una “modernizzazione ecologica”, dove l’innovazione tecnologica riveste un ruolo centrale. Si riconosce una crisi ecologica, ma a differenza del movimento radicale sul limite della crescita si crede fermamente di poter interiorizzare la cura per l’ambiente.
10. Lo sviluppo: una credenza
La caratteristica peculiare dello sviluppo, e dell’immaginario che lo accompagna, è che la crescita e il progresso possano svilupparsi all’infinito, anche grazie all’aumento costante delle merci prodotte. Ma, come scrive Gilbert Rist, l’egemonia dello sviluppo si è potuta affermare solo grazie ad un’illusione semantica, attraverso la creazione del sottosviluppo, cioè creando uno “pseudo contrario” che ha trasformato una credenza in senso comune, e facendo credere nella possibilità di trasformare l’intero mondo ad immagine e somiglianza.
Invece, a distanza di 70 anni ci ritroviamo un pianeta caratterizzato da profonde diseguaglianze socio-economiche, in cui lo sfruttamento delle risorse naturali e la protezione dei capitali e dei profitti dei grandi investitori sta provocando espulsioni di lavoratori, agricoltori e residenti non abbienti da un numero sempre più consistente di aree e progressivamente deteriorando l’ambiente fisico, sociale e culturale in cui viviamo. Queste contraddizioni non sono esportabili all’esterno del suo core (la società nord-atlantica), ma colpiscono il suo stesso bacino sociale e le misure adottate dai governanti sono tali da aggravare la crisi anziché mitigarne gli effetti.
Occorre superare il paradigma dello sviluppo e dell’infinita e indefinita produzione di merci, poiché è una produzione indipendente da ogni valutazione delle loro qualità intrinseche in funzione del miglioramento dell’uomo e della società. L’economia “data”, (vogliamo alludere con questo termine al fatto che questa non è né l’unica economia storicamente esistita né l’unica possibile), va radicalmente trasformata. Due paradigmi a cui appellarci, per esplorare, indagare, studiare e sperimentare un nuovo sistema socio-economico, sono quello dei “beni comuni” e della “città come bene comune”.
Per cominciare, una nuova visione del mondo e dell’economia, radicalmente diversa da quella nel cui ambito viviamo da troppi secoli. Non è uno sforzo né semplice né breve, ma se la distanza tra il mondo attuale e quello che vogliamo costruire è grande, grande, determinato e costante dovrà essere il nostro impegno.
Occorre anche essere pronti a superare l’eurocentrismo, che ha prodotto una sorta di inamidatura dei modi di vivere, produrre, consumare, rapportarsi agli altri. In questo senso, l’ondata immigratoria può costituire una risorsa e un’opportunità di rinnovamento della civiltà europea, nord-atlantica e globale. La globalizzazione, se intesa in questo senso di commistione, condivisione, confronto, dialogo e sintesi (al plurale) di modi di vivere e concepire diversi, diventa un’occasione di innovazione ed emancipazione.
11. Una nuova visione del lavoro
Un nuovo modello di sviluppo richiede una revisione del concetto e visione del lavoro.
Nell’economia capitalistica, esiste una immensa quantità di lavori necessari per la sopravvivenza e il miglioramento delle condizioni di vita che non vengono effettuati, perché il Mercato non li considera utili (non producono né profitto né rendita). Esiste insomma una enorme domanda insoddisfatta di lavoro. Pensiamo alla ricostituzione dell’integrità fisica dei terreni non urbanizzati, alla ricostituzione del reticolo idrologico, ai rimboschimenti, allo sviluppo di un’agricoltura articolata secondo le diverse potenzialità e le diverse domande alimentari. Pensiamo alla ristrutturazione edilizia e urbanistica delle lande urbane devastate dalla speculazione. Pensiamo a una ricostruzione dei sistemi per la mobilità non più basati su modalità energivore e inquinanti. Pensiamo alle dotazioni di spazi pubblici articolati in relazione delle esigenze, delle loro caratteristiche.
Il lavoro è qui inteso come l'insieme delle attitudini fisiche e intellettuali che esistono nella corporeità, ossia nella personalità vivente d'un uomo, e che egli mette in movimento ogni volta che produce valori d'uso di qualsiasi genere (K. Marx). Il lavoro, quindi, deve essere utilizzato dall’uomo non solo in relazione soltanto alla sua propria sussistenza e riproduzione, ma a qualsiasi fine socialmente utile e produttore di valor d’uso a cui egli ritenga utile applicarlo, comprendendo tra tali attività tutte quelle finalizzate alla ricerca della verità, della bellezza, della comunicazione di se stesso e alla comprensione degli altri, mediante l’impiego di tutti gli strumenti espressivi impiegabili.
Naturalmente, ciascuno di tali impieghi del lavoro dovrebbe essere retribuito nella misura necessaria per continuare a svolgerlo. È l’economia, in altri termini, che deve essere subordinata al lavoro, non il lavoro all’economia. Il contrario di ciò che avviene nel sistema capitalistico.
12. E nell’immediato che fare?
In una simile nuova economia la distribuzione delle risorse tra le possibili opzioni alternative avverrebbe (e noi speriamo, avverrà) in modo del tutto diverso che nell’attuale Mercato (l’oligopolio costituito da un gruppo di poche decine di padroni del mondo delle finanze). Ma nel frattempo occorre porsi due domande:
1. come reperire le risorse finanziarie necessarie per soddisfare l’enorme domanda insoddisfatta di lavoro di cui abbiamo detto, retribuendo adeguatamente la forza lavoro che dovrà esservi impiegata?
2. come difendere quello che di positivo è rimasto?
13. La spesa militare come risorsa finanziaria
La risposta alla prima domanda è facile. Basta pensare alla gigantesca mole di risorse impegnata per realizzare opere inutili e spessissimo anche dannose, la cui realizzazione è motivata solo, o prevalentemente, da interessi economici dei promotori e realizzatori. E basta pensare alla quantità di risorse, non solo finanziarie, dissipate per convincere il consumatore che questo prodotto è utile ed è diverso da quest’altro Basta infine alla dimensione degli sprechi causata dalla “obsolescenza programmata” degli oggetti d’uso corrente.
Ma vogliamo porre l’accento su un’altra spesa gigantesca, e per di più terribilmente nociva per l’umanità: le spese militari.
L’Italia nel 2017 spenderà per le forze armate almeno 23,4 miliardi di euro (64 milioni al giorno), più di quanto previsto. Quasi un quarto della spesa, 5,6 miliardi (+10 per cento rispetto al 2016) andrà in nuovi armamenti (altri sette F-35, una seconda portaerei, nuovi carri armati ed elicotteri da attacco) pagati in maggioranza dal ministero dello Sviluppo economico, che il prossimo anno destinerà al comparto difesa l’86 per cento dei suoi investimenti a sostegno dell’industria italiana. La sovrapposizione delle competenze di due ministri (Difesa e Sviluppo economico) aiuta a comprendere le ragioni dell’opacità delle informazioni provenienti dalle fonti ufficiali italiane (I dati che qui riportiamo provengono dall’istituto di ricerca svedese SIRTI).
Le spese militari italiane sino in aumento costante dal 2.000. Nell’ultimo decennio italiane sono cresciute del 21 per cento – del 4,3 per cento in valori reali – salendo dall’1,2 all’1,4 per cento del Pil.
Il 70 % della spesa è costituita dalle spese per il personale, in massima parte costituito da graduati. Ciò aiuta a comprendere l’ampiezza del blocco sociale favorevole al mantenimento della spesa militare ai suoi attuali livelli. C’è infine da osservare che gran parte della spesa per armamenti l’Italia è tributaria di fornitori stranieri.
Questi dati (cui bisognerebbe aggiungere quelli sui numerosi coinvolgimenti di contingenti militari italiani in guerre in altri paesi) rendono stupefacente il fatto che il tema della lotta per la pace sia scomparso dall’attenzione della sinistra.
14. La pianificazione come tutela della città dei cittadini
In attesa di elaborare e rivoluzionare il sistema economico-sociale in cui viviamo (ciò che significa anche sconfiggere alla radice “la città della rendita”) occorre orientare e plasmare il più possibile il sistema in cui viviamo. Lo scopo è chiaro: una tensione verso la “città dei cittadini” attraverso la difesa delle conquiste sociali già ottenute (ma sempre a rischio), della salvaguardia delle risorse ambientali in cui viviamo sfruttando le conoscenze già in possesso, e una promozione dei valori della pace, partecipazione, e diversità culturale.
Alcune questioni che la pianificazione si deve fare immediatamente carico, sapendo che ciascuna di esse richiede una lotta contro la rendita e i poteri che la difendono:
1. sovranità e qualità alimentare. I cambiamenti climatici in corso e il deterioramento dell’ambiente naturale pone l’alimentazione come una sfida non solo per i paesi poveri, ma anche per quelli ricchi. L’Italia deve difendere la propria relativa autonomia alimentare non come “marchio Italia” ma come pratica per sostenere una popolazione in salute. L’accesso a tutti a una alimentazione sana e di qualità deve diventare una priorità non solo per le politiche sociali, ma anche per le politiche economiche e territoriali. Il “ritorno alle terra” sentito da molte nuove famiglie e individui dovrebbe essere incoraggiato e sostenuto.
2. la salute ambientale, dalla tutela della qualità dell’aria e dell’acqua, alla difesa da erosioni, alluvioni e terremoti attraverso una politica di vera prevenzione e non di emergenza, come quella che ha caratterizzato l’Italia negli ultimi decenni.
3. Una nuova stagione di politiche pubbliche urbane e territoriali nelle quali siano posti al centro il valore d’uso e un’idea ampia di cittadinanza ponendo l’attenzione sugli standard (aggiornati e ampliati per rispondere ai nuovi bisogni) e al connesso sistema degli spazi e servizi pubblici, nonché sulle “piccole opere” di manutenzione, ri-uso e cura dell’esistente.
IB, ES, 10 novembre 2017

La città invisibile, 30 ottobre. L'incendio ha messo in luce quanto già da tempo si sapeva: gli scavi per la costruzione della Tav hanno progressivamente disseccato le sorgenti d'acqua privando il territorio di una risorsa importante.
Ottava giornata di fuoco e fumo, altri ettari di boschi resi estremamente infiammabili da oltre novanta giorni di siccità stanno bruciando inesorabilmente nonostante la lotta commovente che sfinisce Pompieri, Aib e volontari che non contano le ore, i pasti saltati e i veleni respirati. Loris Mazzetti – scrittore, giornalista e dirigente Rai che era venuto a trovarci giovedì per presentare il suo ultimo lavoro, “la profezia del Don” dedicato a un prete che non prometteva miracoli, (li faceva) – ha voluto trattenersi per altri due giorni per vedere di persona quel che stava succedendo nella Valle dei No Tav.
Ecco cosa ha scritto sulla piazza virtuale Facebook, la più frequentata al mondo: “Sono stato in Valsusa a presentare il libro La Profezia del Don. La valle è devastata da incendi dolosi, non si vede il sole per colpa del fumo, si respira a fatica, la solidarietà non basta, occorre la presenza dell’esercito, ci vogliono leggi adeguate contro chi provoca gli incendi. L’informazione nazionale deve fare di più non è un problema che riguarda solo il Piemonte è l’Italia che è stata colpita. In alcune zone le fiamme sono a ridosso delle case, un giovane di venti…sei anni mentre tentava di spegnere le fiamme è morto d’infarto, vigili del fuoco salvati per miracolo, animali morti. No, no la solidarietà non basta. Basta con i soldi sperperati dalla politica per inutili referendum, basta con treni che vanno su e giù per il Paese per campagne elettorali che durano mesi e mesi. I cittadini della Valsusa hanno bisogno di risposte immediate. Portiamo le telecamere nella valle.”
Di telecamere siamo invasi ma per inquadrare noi, la nostra ribellione contro chi – prima che qualcuno desse fuoco ai boschi ha bucato per decenni le nostre montagne, i recipienti millenari di acqua potabile e di quella – comunque di buona qualità – di fossi e torrenti che oggi sarebbe stata preziosa per difendere le case, oltre le piante. Milioni di metri cubi persi per sempre con la realizzazione – oltre mezzo secolo fa – della prima centrale in caverna a Venaus da parte dell’Enel e dei francesi di Edf che non appena appropriatisi del Moncenisio nel 1947 – come ritorsione per la guerra persa dall’Italia del duce – vi hanno costruito una della più imponenti dighe d’alta quota d’Europa, decapitando – allo scopo – una montagna trasformata in cava di inerti: la Carrier du Paradis che forse dovrebbe essere rinominata “dell’inferno”. Fino alla grande centrale in Caverna – questa Iren, ma sempre a Venaus – che dopo il versante Cenischia ha mezzo disseccato il versante Dora prelevando l’acqua fin da Pont-Ventoux per far girare le turbine dell’ingegner Garbati (anno 2006) . Versante che era già stato impoverito negli anni ‘70/’80 con lo scavo delle gallerie di raddoppio della ferrovia esistente (altro che storica) e successivamente, negli anni ‘80/’90, dallo scavo delle innumerevoli gallerie dell’Autostrada A32 del Frejus. Per finire – per adesso – con lo scavo del cunicolo della Maddalena di Chiomonte che appena terminato ci si è accorti di dover prolungare di mezzo chilometro e che – nonostante i soli 7 km di lunghezza e il piccolo diametro – di acqua ne ha dispersa e avvelenata in modo sproporzionato.
Mentre non si ricorda mai abbastanza che un expertise internazionale commissionato dagli stessi proponenti la galleria Tav Torino-Lione aveva quantificato nel fabbisogno di una città di un milione di abitanti l’acqua potabile che sarebbe sparita con lo scavo di 57 km di doppia galleria. Paolo Ferrero – naturalista e guardaparco – ha realizzato qualche anno fa un censimento delle sorgenti disseccate che mostra, attraverso delle slide comprensibili persino da un politico di professione, la evidente interrelazione tra il loro disseccamento e il progredire dello scavi di grandi opere.
Mentre scrivo sento l’ormai familiare rumore dei Canadair che fanno la spola ancora tra il lago di Viverone e le Pendici del Rocciamelone dove sta notte sono state evacuate altre borgate di Monpantero e alcune cascine, anche nel territorio della stessa Susa.
Ora quel che sto facendo – scrivere – so che è una attività che – per inutilità conclamata – è seconda solo alle visite pastorali dei politici di palazzo, come quella di ieri di Sergio Chiamparino che di ognuna di queste grandi opere è stato ed è un fan scatenato. La drammatica notte di Monpantero e Susa appena trascorsa speriamo lo inducano almeno a restarsene nel suo polveroso e fuligginoso ufficio di Piazza Castello e ad uscirne solo per andare a ricevere – a Portauova – il suo amico Matteo Renzi di ritorno dal comizio-omelia nella chiesa di Capaccio (Paestum) col collega De Luca per chierichetto.
Claudio Giorno, residente in Val Susa e fondatore del "Comitato Habitat" è tra gli animatori della campagna No Tav.
il Fatto Quotidiano, 31 ottobre 2017. Ferruccio Sansa intervista il meteorologo Luca Mercalli sui cieli colorati e gli inquinamenti dell'aria che respiriamo. (p.d.)
Giù le mani dai tramonti. Almeno con quelli l’uomo non c’entra nulla. Gli splendidi cieli di questi giorni non sono provocati dall’inquinamento, dagli incendi. Sono ‘soltanto’ delle meravigliose nuvole rosse e viola. Ci siamo abituati a non guardarli più e adesso ce ne accorgiamo perché abbiamo paura…
Luca Mercalli lei vive studiando le nuvole, i ghiacciai e il clima. Da Roma a Milano tutti puntano il dito verso il cielo indicando tramonti stupendi. È così ‘normale’?
Sono tramonti fatti con gli ingredienti della natura. Certo, ci vuole un po’ di fortuna.
Quali sono gli ingredienti per un buon tramonto?
Tanto per cominciare ci vuole la stagione giusta. Perché in ogni periodo dell’anno i raggi del sole colpiscono con un’angolazione diversa l’atmosfera. Poi mettete delle belle nuvole, quelle di questi giorni sono nubi d’onda che si chiamano altocumuli lenticolari.
Lenticolari, perché?
Hanno la forma di una lente vista di taglio. Poi ci vuole un bel vento, come il phon che ha investito le Alpi e che spalma le nuvole per centinaia di chilometri. E infine… serve un po’ di polvere.
Ecco, l’inquinamento…
Macché, è tutto naturale. Parlo della polvere alta dell’atmosfera, che si trova a 30 chilometri di quota. A volte è provocata dalle grandi eruzioni vulcaniche – come il Sant’Elena e il Pinatubo – che lasciano per anni polvere nell’atmosfera. Ma non è il caso dei tramonti di oggi.
Non c’entrano nemmeno gli incendi nella sua Valsusa?
Sono giorni che non vediamo il sole. Abbiamo la casa coperta di cenere e lapilli. Centocinquanta roghi in dieci giorni… e poi parlano di caso e piromani. Bisognerebbe vedere chi ci guadagna da questo disastro… No, comunque neanche questo c’entra.
Ma se i tramonti ci sono sempre, perché ce ne accorgiamo soltanto adesso?
Perché siamo in allarme. E non osserviamo più la natura in cui viviamo.
Non ci accorgiamo dei tramonti. E nemmeno dell’inquinamento. Ieri l’Onu ha lanciato un allarme…
È come un bollettino medico di un paziente che da anni è steso sul letto. Ci ricordano le emissioni di anidride carbonica nell’atmosfera. Per un paio di giorni ci preoccuperemo, vedremo i tramonti rossi… poi sarà come prima.
E cosa potremmo fare?
A livello mondiale dovremmo almeno rispettare gli accordi di Parigi. Finora non si sta facendo nulla. Non sono sufficienti, non servono per guarire il paziente. Ma se fossero raggiunti gli obiettivi, nel 2100 l’incremento delle temperature sarebbe di due gradi. Invece che di cinque. Serviva una compattezza a livello mondiale, come per il piano Marshall. Emmanuel Macron e Angela Merkel si sono mossi. Però se il presidente della prima potenza mondiale dice di non volerli rispettare, si butta tutto in burletta.
L’Italia che cosa può fare?
Noi teniamo il piede in troppe scarpe. Abbiamo industrie di eccellenza nei materiali per l’edilizia e nella domotica, cioè l’applicazione di informatica ed elettronica alla gestione della casa. Ma la politica non sembra convinta. Servono regole semplici, chiare e applicate da tutti. Invece un comune ti dice sì e l’altro no. Cambia il sindaco e cambia la politica ambientale. Dovremmo fare come i tedeschi…
Sempre questi tedeschi!
Loro quando decidono qualcosa la fanno fino in fondo. La chiamano energiewende, la transizione energetica dopo il carbone. L’opinione pubblica è compatta. Se lo facessimo in Italia, avremmo forse un milione di posti di lavoro.
Non c’è riuscito Silvio Berlusconi, ci riusciremmo con l’ambiente?
Siamo il terzo Paese al mondo per impianti fotovoltaici. Abbiamo eccellenze industriali. E ci sono anche degli ecobonus importanti, anche se sono stati ridotti da 65 al 50%. Ma se lasciamo che sia facoltativo, nessuno investirà nella casa ecologica.
Noi cittadini cosa possiamo fare?
Trasformare la nostra casa. Utilizzare gli ecobonus che, soprattutto per i condomini, sono consistenti. Poi cambiare le finestre e il cappotto…
Il cappotto?
Sì, l’isolamento delle pareti. Adesso si mette uno strato di dieci centimetri per esempio di polistirolo. Poi si mettono una caldaia efficiente e i pannelli solari. Non vedo perché a Bolzano si riesca e in tante altre regioni no. E con l’energia prodotta ci ricarichi l’auto elettrica. Aiuta a risparmiare, è un investimento che si recupera presto. Poi c’è la soddisfazione di non inquinare. La politica dovrebbe dare un valore a quello che non si brucia nell’atmosfera. E premiare chi pensa al mondo in cui viviamo.
il manifesto, 29 ottobre 2017. Due incontri paralleli a Milano che esprimono un grande conflitto della globalizzazione capitalista: quello tra gli sfruttatori dell'acqua, che vogliono diventare più potenti, e quello degli assetati o sfrattati, che vogliono sopravvivere.
Il 5 e il 6 novembre si svolgerà a Milano l’incontro dei ministri della salute del G7.
Gli argomenti in agenda sono: le conseguenze sulla salute dei cambiamenti climatici, al quale verranno dedicate 3,5 ore di discussione; la salute della donna e degli adolescenti 1,5 ore, e la resistenza antimicrobica 1 ora. Tempi sufficienti, secondo i ministri, per arrivare ad una solenne dichiarazione finale su questioni la cui rilevanza è fondamentale per il futuro dell’umanità. Considerato che a quei tavoli siederanno i massimi responsabili dell’attuale modello di sviluppo è fin troppo facile immaginare che, al di là delle parole, vi sarà il vuoto.
Decine di associazioni impegnate in difesa della salute a livello locale, nazionale e internazionale hanno costituito il comitato «Salute senza padroni e senza confini» e, insieme al Gue, gruppo parlamentare «Sinistra Unitaria Europea/Sinistra Verde Nordica» e al gruppo consiliare «Milano in Comune», hanno organizzato a Milano due iniziative.
Sabato 4 novembre un «Forum internazionale per il diritto alla salute e l’accesso alle cure»
nel quale si confronteranno ricercatori, scienziati, medici, biologi di altissima professionalità con attivisti di tutto il mondo per individuare obiettivi condivisi sia dai movimenti sociali che da chi agisce in campo scientifico. Proprio da quest’ambito abbiamo ricevuto un’enorme disponibilità, come testimonia il programma, segno che la scienza, quando non è asservita al potere, giunge a conclusioni molto simili a quelle del movimento antiliberista.
Domenica 5 novembre si svolgerà un incontro tra i movimenti italiani attivi nella difesa della salute per organizzare insieme delle campagne nazionali. I temi del Forum sono: «la disuguaglianza sociale come determinante di malattie», nel 2012 l’effetto Glasgow aveva dimostrato come il tasso di mortalità fosse strettamente correlato alle condizioni sociali della popolazione, l’Istituto Mario Negri ha documentato lo stesso fenomeno a Milano.
«L’accesso alle cure», il 50 % delle persone colpite dal virus Hiv nel mondo ne sono prive e l’accesso ai farmaci salvavita non è più garantito nemmeno nel mondo occidentale come testimonia la vicenda del Sofosbuvir per l’epatite C.
«La privatizzazione dei servizi sanitari» vera preda del mercato globale ma anche locale come dimostra, ad esempio, il tentativo della Regione Lombardia di sostituire, nell’assistenza a 3.350.000 cittadini con patologie croniche, il medico di famiglia con un gestore, società per lo più private finalizzate al profitto.
E infine «Le conseguenze sulla salute dei cambiamenti climatici». Amitav Gosh, noto romanziere bengalese, ha recentemente pubblicato un saggio: «La Grande Cecità», quella dei cambiamenti climatici. L’accusa è, alla letteratura mondiale, di essere centrata su l’umano e i suoi diritti, e di aver ignorato il «non umano», indifferente ai destini della terra, dell’acqua e dell’aria, relegati tutti nella letteratura di serie B: la fantascienza. Eppure di cambiamenti climatici ci si ammala e si muore; per l’Oms potrebbero provocare 12,6 milioni di decessi tra il 2030 e il 2050. 250.000 morti in più ogni anno: per malnutrizione, malaria, diarrea. 20.000 morti per colpi di calore nella sola Europa. A questi numeri andrebbero aggiunti i morti per la maggior concentrazione di inquinanti nell’atmosfera dovuti all’assenza di piogge: 500.000 deceduti in Europa, 90.000 in Italia e 9 milioni nel mondo.
Ma la vera tragedia del cambio climatico è l’acqua. Siccità e alluvioni agiscono pesantemente nel ridurne la sua disponibilità. Nel 2050 verrà a mancare il 50% del necessario e a farne le spese saranno i poveri della Terra, i 900 milioni di persone prive di acqua potabile. La corsa all’accaparramento delle terre fertili e degli invasi da parte delle multinazionali e dalla Cina e dall’Arabia saudita è da tempo iniziata e i mutamenti climatici l’accentueranno sempre più. Le grandi dighe prolificano in Asia e in Africa con il loro seguito di profughi e di guerre e le multinazionali degli acquedotti Suez – Veolia – Thams Water – Rwe ecc.. premono con maggior forza per la privatizzazione dei rubinetti di tutto il mondo.
Le stime dell’alto commissario delle Nazioni Unite parlano di 79 guerre in corso per cause ambientali e appropriazione di risorse. Nella guerra del Kashmir (100.000 morti) ci sono le dighe sul fiume Indo e la concorrenza tra India, Pakista, Cina. L’Egitto è una polveriera di 90 milioni di persone che vivono attorno al Nilo aggredito dalle dighe dell’Etiopia. La guerra in Siria avviene dopo 5 anni di siccità e di dighe turche sul Tigri. Le guerre ai kurdi hanno acqua e petrolio sullo sfondo.Nella contabilità mondiale 3 miliardi di persone sono considerati da «qualcuno»: insostenibili esuberi.
Beni comuni salute del pianeta e salute pubblica vanno insieme e vanno collocate in cima alle nostre priorità.
Vittorio Agnoletto comitato «Salute senza padroni e senza confini». Emilio Molinari contratto mondiale dell’acqua

Internazionale, 27 ottobre. A due anni dal crollo della diga Da Taille di Fundao, costruita per contenere gli scarti della miniera di ferro Sanmarco sul Rio Doce, una documentazione della trasformazione devastante dell'ambiente e delle comunità lungo il bacino del fiume. (i.b)
Il 5 novembre 2015 una diga è crollata nel villaggio di Bento Rodrigues, vicino a Mariana, nel Brasile sudorientale. Era stata costruita per contenere gli scarti di lavorazione di una miniera di ferro di proprietà della Samarco, una joint venture tra l’azienda brasiliana Vale e l’australiana Bhp Billiton.
 |
I villaggi e le comunità danneggiate dall'ondata dei detriti ferrosi
Fonte: www.telesurtv.net |
Sessanta milioni di metri cubi di riiuti tossici si sono riversati nel rio Doce prima di sfociare nell’oceano Atlantico, percorrendo più di 850 chilometri negli stati di Minas Gerais ed Espírito Santo. In quello che è stato definito il peggiore disastro ambientale nella storia del Brasile sono rimaste uccise 19 persone. La valanga di fango ha sommerso interi paesi tra cui Bento Rodrigues e Paracatu de Baixo, ha distrutto impianti elettrici e infrastrutture, e ha inquinato fonti di acqua potabile. A due anni dal disastro, le comunità che vivevano nella zona e usavano il fiume per irrigare i terreni agricoli e per pescare, hanno perso la loro fonte di sopravvivenza.
Dal 1986 nello stato di Minas Gerais sono crollate almeno sei dighe, causando la morte di 33 persone. L’incidente del 2015 è stato attribuito al modello di costruzione scelto per la diga, che è stato vietato in alcuni paesi perché ritenuto non affidabile, e alla mancanza di controlli da parte delle autorità.
Le attività della Samarco sono state bloccate subito dopo il disastro. Nell’ottobre del 2016 un tribunale brasiliano ha accusato di omicidio 22 persone, tra cui alcuni dirigenti dell’azienda, ma a luglio del 2017 il processo è stato sospeso per accertamenti sullo svolgimento delle indagini.
Nicoló Lanfranchi ha realizzato questo progetto nel corso di due viaggi. Il primo nel 2015, un mese dopo il crollo della diga, e il secondo nel 2017 grazie a una borsa di studio della fondazione Bild Kunst.
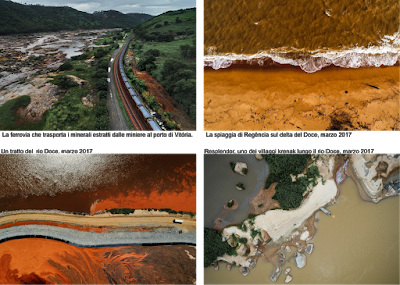 |
| Fonte: http://www.nicolanfranchi.com/watu-death-of-a-river/ |
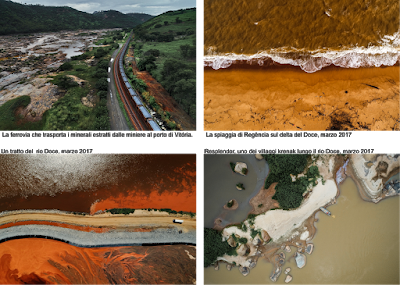 |
| Fonte: http://www.nicolanfranchi.com/watu-death-of-a-river/ |
il Fatto Quotidiano, 23 ottobre 2017. «Duecento km di costa gravemente inquinati dagli scarichi dell’acciaieria Formosa, colosso di Taiwan costretto a scuse pubbliche. Puniti anche 8 leader politici». (p.d.)
In Vietnam non era mai accaduto che un ministro, due vice ministri, un leader provinciale nonché membro del parlamento più altri otto amministratori locali fossero sbattuti sulla prima pagina del sito web del governo e indicati come i responsabili politici e amministrativi della più grande tragedia ambientale che il paese abbia vissuto: l’inquinamento di 200 chilometri di coste con l’immediata e visibile distruzione di oltre cento tonnellate di pesce, la morte di tutti gli allevamenti ittici, la scomparsa delle saline, oltre allo stop per mesi e mesi del turismo e di tutte le attività collegate al mare. Gli incolpati sono stati tutti “irresponsabili nel loro ruolo di dirigenti, non sono stati buoni amministratori, hanno omesso controlli e ispezioni”. Per questo l’ex ministro delle Risorse Naturali e dell’Ambiente Nguyen Minh Quang è stato ufficialmente ammonito, i due ex vice ministri Nguyen Thai Lai e Bui Cach Tuyen non potranno mai più fregiarsi del titolo governativo, e il leader della provincia di Han Tin e deputato nazionale Vo Kim Cu è stato sospeso dal Parlamento e destituito da tutti gli incarichi periferici. Gli altri 8 sono stati tutti trasferiti ad altri uffici, in modo da tenerli ben lontani da qualsiasi pratica che riguardi un impianto di produzione di acciaio della società taiwanese Formosa, un investimento da 20 miliardi di dollari.
Furono proprio i rifiuti della lavorazione, un micidiale miscuglio di acque ad alta concentrazione di cianuro, fenolo e idrossido di ferro, a causare il disastro ambientale che ha colpito direttamente le attività di 260 mila vietnamiti. Era il 6 aprile 2016, quando sulle spiagge della provincia di Ha Tin, dove ha sede la Formosa, cominciarono ad arrivare le carcasse di decine di migliaia di pesci e di crostacei. Nei giorni successivi il fenomeno si allargò a sud fino a interessare altre 3 provincie per 200 chilometri di costa. Fu la paralisi, nessuno andò più in mare e la pressione per sapere le cause del disastro fu giorno dopo giorno sempre più forte, con i timidi e controllati media vietnamiti scatenati a inseguire le ipotesi più diverse e a indagare sul campo con i cronisti che si fecero subacquei per trovare una risposta e il governo che prometteva di far luce rapidamente e rinviava ogni dichiarazione ufficiale.
Fino a quando, il 30 giugno 2016 e senza che la tensione fosse diminuita intorno al caso, fu proprio l’ex ministro dell’Ambiente Ha, con accanto l’ex premier Nguyen Xuan Phuc, il coordinatore del governo Mai Tien Dung, ad essere il protagonista di un colpo di scena accuratamente preparato. In apertura di conferenza stampa, fu proiettato un video in cui il presidente del consiglio di amministrazione della Formosa, Tran Nguyen Thanh, circondato da tutti i dirigenti dell’azienda, si inchinava davanti alla telecamera e ammetteva: “Ci assumiamo ogni responsabilità e chiediamo scusa al Vietnam”. A seguire, l’impegno di pagare un indennizzo di 500 milioni di dollari per i danni.
Si chiesero in molti se la punizione fosse troppo lieve e il ministro dell’ambiente rispose con queste parole: “Mai colpire un uomo quando è già a terra”. Tanta magnanimità si fonda sul potere che il governo vietnamita ha di agire ancora in qualsiasi momento contro Formosa: può cominciare un processo criminale (non ci sono stati solo i pesci morti, ma anche decine di casi di avvelenamento di uomini donne e bambini che hanno mangiato pesce prima che scattasse il divieto totale), così come, di fronte alla violazione dell’obbligo di non scaricare più in mare veleni industriali, può scattare la requisizione dell’intero impianto industriale.
Con l’annuncio che le responsabilità del disastro ambientale erano dell’azienda taiwanese, il governo di Hanoi ha ottenuto una serie di risultati politici. Il primo, di natura esclusivamente interna, mostra ai vietnamiti che nonostante la lentezza con cui si è mosso chi guida il Paese, si è arrivati alla verità e le migliaia di persone che sono rimaste senza lavoro nel settore della pesca, del commercio ittico, della produzione del sale marino e del turismo hanno ricevuto un indennizzo che in media vale 2 mila dollari a persona. Il governo e il partito comunista hanno oggi chiarissimo che la questione ambientale può mettere in discussione la stabilità dell’assetto istituzionale: nei giorni successivi all’avvelenamento furono molte le manifestazioni di protesta seguite da incidenti tra manifestanti e polizia.
Altri risultati riguardano la politica degli investimenti stranieri e le relazioni internazionali. In futuro, chi vorrà investire in Vietnam, nazione che ha attirato nel 2016 quasi 22 miliardi di dollari in investimenti dall’estero, non lo potrà fare a scapito dell’ambiente o pensando che autorità locali e nazionali possano chiudere un occhio di fronte all’uso sconsiderato se non criminale dell’ambiente. E i funzionari e amministratori vietnamiti che dovessero facilitare azioni illegali delle compagnie straniere sono avvertiti che rischiano grosso.
Infine, il messaggio ai Paesi vicini è che il governo di Hanoi controlla tutto quello che succede nelle acque territoriali e nessuno può violarle. Destinatario numero uno di questo messaggio è il governo di Pechino che da anni persegue una politica di espansione nel Mar della Cina meridionale molto al di fuori delle sue acque territoriali.
La vicenda della Formosa ha avuto un riflesso anche nel mondo dell’informazione vietnamita, controllata interamente dal Partito comunista e dal governo, ma dove esiste comunque un dibattito cauto ma serrato sul rapporto tra informazione, potere e cittadini. A rivelare come quelli ambientali siano sicuramente temi sensibili delle scelte politiche ed economiche, è stata un’analisi apparsa su Vietnam News, il quotidiano in lingua inglese. A fine aprile, in un’analisi a firma Thu Van, sono stati evidenziati i problemi di un evento del genere. Chi deve cercare la verità? Possono farlo i giornalisti che si sono trasformati in investigatori invece che essere solo il passaggio finale dei messaggi del partito? Ed è possibile che in un paese che corre velocemente verso lo sviluppo non ci sia un’agenzia indipendente che si occupi dell’ambiente e che possa intervenire immediatamente senza aspettare il via governativo? Sono domande che dimostrano la voglia di discutere su tutto quello che accade senza attendere alcun permesso.
Ad innescare tute quelle domande fu sicuramente la sortita di un dirigente della Formosa che lavorava negli uffici di Hanoi. Alle prime domande dei giornalisti, che avevano individuato uno dei possibili responsabili nell’impianto industriale, Chou Chun- fan se ne uscì con questa affermazione al microfono della stazione televisiva statale VTC14: “Voi vietnamiti non potete avere tutto, dovete scegliere se pescare pesci e gamberi o possedere una fabbrica di acciaio super moderna”. Nel giro di poche ore arrivarono le scuse e il licenziamento di Chou Chun-fan, mentre il governo gettò acqua sul fuoco dicendo che sì, forse l’avvelenamento poteva essere causato dagli scarichi industriali, ma quella era solo una ipotesi. Invece era assolutamente vero.

il manifesto, 22 ottobre 2017. «Siamo di fronte alla combinazione di un fenomeno anomalo, sicuramente. La seconda estate più calda della storia si è saldata con una siccità prolungata che riguarda le regioni del nord ovest». Ha ragione, ma c'è ben di più, vedi postilla
Luca Mercalli è un climatologo e un divulgatore scientifico. Sostiene uno stile di vita più sobrio e attento, servendosi delle esperienze fatte in prima persona nella sua abitazione in Val Susa. È stato tra i primi personaggi pubblici ad impegnarsi nella lotta contro il progetto della Torino – Lione.
Cosa sta succedendo nella Pianura Padana?
«Siamo di fronte alla combinazione di un fenomeno anomalo, sicuramente. La seconda estate più calda della storia si è saldata con una siccità prolungata che riguarda le regioni del nord ovest in particolare. Una situazione che si è già verificata un paio di volte, ad esempio nell’Ottocento, ma in un contesto storico dove faceva molto meno caldo. Anche ottobre, sebbene le misurazioni non siano complete, con ogni probabilità risulterà statisticamente anomalo».
Questo è il riscaldamento globale?
«Il riscaldamento globale, lo sappiamo benissimo, è una presenza da oltre trenta anni. Purtroppo sta rappresentando una costante, non si tratta di una novità di un mese o di una stagione che presentano, talvolta, delle condizioni anomale. Il freddo è ormai una componente episodica, mentre quelle di caldo diventano inedite: alcune giornate della scorsa estate hanno battuto ogni record di caldo registrato negli ultimi duecento anni, come i 43 gradi a Forlì il 4 agost»o.
Trump ha scelto di uscire dall’accordo di Parigi
«Si scende uno scalino molto importante perché purtroppo gli Stati Uniti sono il secondo emettitore mondiale di anidride carbonica. Non è solo un atto simbolico, si tratta proprio di quantità fisiche. Ovviamente pesa anche sul piano psicologico, perché la più grande potenza economica mondiale si sfila e indebolisce la percezione comune della sua importanza. È vero che uno può sperare che vadano avanti gli altri, ma non si tratta di un piccolo Stato: pur con molte differenze all’interno, sappiamo che nel paese che oggi cancella un accordo globale sul clima vi sono molti soggetti attivi nella lotta al riscaldamento globale. Si pensi a interi stati come la California, o di città come Portland, Seattle, New York, che hanno già intrapreso una strada di sostenibilità di New York e sono contrarie alle scelte del presidente Trump.
Lei vive in montagna: quale è il futuro dell’economia alpina?
«Il futuro della montagna è scritto da quasi trenta anni. E’ un argomento di cui discute da sempre, di cui si sa tutto, ogni scenario: eppure l’economia alpina continua a pensare di poter continuare a crescere grazie al turismo della neve. Sappiamo che quel modello non ha futuro, e si devono abbracciare nuove forme di turismo, legate alla cultura del territorio, alle bellezze naturalistiche, ad uno stile di vita più rilassato».
Cosa pensa delle restrizioni che città come Torino e Milano hanno imposto al traffico veicolare privato?
«Sono cose già viste, non c’è nulla di nuovo. Queste situazioni sono sempre le stesse, accadono sempre nello stesso periodo per altro. Purtroppo non si sceglie di affrontarle con decisioni strutturali, ma solo con misure d’emergenza. Si spera nel vento e nella pioggia e i problemi rimangono insoluti. Questa intervista potrebbe essere stata fatta dieci anni fa.
Cosa propone lei?
«In primis la diffusione dell’auto elettrica nella pianura padana e in particolare nelle città dove c’è il massimo problema sanitario. Guido l’auto elettrica da sei anni: è una guida più riflessiva, che ti impone un consumo minore in ogni ambito, perfino dei freni e dei pneumatici. Per sviluppare questa buona pratica ci vuole ovviamente una normativa, ad esempio simile a quella francese che prevede forti incentivi. Qui noi pensiamo all’auto elettrica come a qualcosa di decorativo, stravagante. Se restringessero l’area C di Milano – ma è solo un piccolo esempio – alle auto elettriche vi sarebbe una forte pressione sulla domanda, che porterebbe all’abbassamento del prezzo di queste automobili, oggi ancora elevato. Il secondo strumento è il telelavoro. È necessaria una normativa che agevoli questo modo di lavorare che toglie le auto dalle strade: basta avere un computer, e si può lavorare da casa senza intasare le metropoli. Magari non tutti i giorni: ma rendiamolo un argomento di discussione politica».
postilla
Il modo nel quale sono collocati i nuovi oggetti che l'uomo pone o trasforma sul territorio (le case, i paesi, le città le fabbriche, i servizi commerciali, quelli sanitari, gli stadi e gli aeroporti, la strade e le ferrovie, i tram e le metropolitane) non è affatto indifferente all'intensità dell'inquinamento. Nemmeno la scelta di privilegiare, per la mobilità, le soluzioni individuali (l'automobile) o quelle collettive (treni, tram). Altrettanto pesantemente incide il reciproco rapporto tra punti di origine/destinazione dei flussi e vettori che li convogliano.
Tutto questo per ricordare allo stimatissimo Luca Mercalli che in luogo dello spontaneismo e dell'individualismo (e della speculazione) che oggi governano in Italia le trasformazioni del territorio occorrerebbe ripristinare la pianificazione urbanistica e territoriale, che una volta era il vanto di molte città, province e regioni della Padania oggi divorata dai fumi dello sviluppo sregolato.
 il manifesto, 22 ottobre 2017 « In Abruzzo c'è un rischio Vajont. La diga contiene 70 milioni di metri cubi d'acqua. Sorge in una zona sismica e franosa, soggetta a subsidenza. Se si trivella può succedere l’imprevedibile»(c.m.c.)
il manifesto, 22 ottobre 2017 « In Abruzzo c'è un rischio Vajont. La diga contiene 70 milioni di metri cubi d'acqua. Sorge in una zona sismica e franosa, soggetta a subsidenza. Se si trivella può succedere l’imprevedibile»(c.m.c.)
Era il 18 maggio 2015 e a Bomba, un pugno di case tra le colline della Val di Sangro, in provincia di Chieti, pensavano di avercela fatta. Di essere riusciti, loro, appena 790 abitanti, a «cacciare» dal paese gli americani, i petrolieri di Denver, Colorado, che dal 2004 «insidiavano» il borgo. Quel giorno, il 18 maggio, campane di giubilo. Perché il Consiglio di Stato, dopo più di 5 anni anni di lotte, aveva decretato, in maniera definitiva, che quei luoghi, un paradiso incastonato tra i boschi, non possono essere trivellati: è pericoloso, perché è zona altamente franosa e sismica.
Bomba, che ha dato i natali ai fratelli Spaventa, si slarga su un cocuzzolo che quasi si specchia nell’omonimo lago sottostante: bacino artificiale, con diga, costruito a cavallo tra il 1957 e il 1960 lungo il corso del fiume Sangro, le cui acque alimentano una centrale sfruttata, tutt’oggi, dalla società Acea, che ne ricava elettricità per illuminare buona parte di Roma. Lo sbarramento – come spiega un film documento dell’epoca – è stato realizzato «in terra compattata» per assicurarne la stabilità. Nel 2004 la statunitense Forest Oil Corporation, attraverso la sua controllata italiana Forest Cmi Spa, ha esplorato l’area attorno al lago e ha trovato, anzi ritrovato, il giacimento di gas naturale denominato “Colle Santo”. E, il 20 febbraio 2009, ha chiesto, all’Ufficio nazionale minerario, la concessione per procedere allo sfruttamento.
Perforazioni a mille metri di profondità, per tirar fuori 238 milioni di metri cubi di metano: circa 650 mila metri cubi al giorno per 12 anni. E poi una raffineria, con impianto di desolforazione, ad un palmo dal centro abitato. Ma – salta subito fuori – la messa in produzione di quel giacimento non è possibile per problemi geomorfologici, legati alla storica instabilità dei posti e al minaccioso fenomeno della subsidenza, cioè il suolo che cede e sprofonda. Nel 1992, Agip, gruppo Eni, la prima aver effettuato sondaggi e ad aver creato pozzi per l’estrazione, aveva rinunciato. Forest, però, intravede montagne di bigliettoni e non demorde. Ma non lo fa neppure il territorio, con i suoi cittadini, i comitati, le associazioni.
«Bisogna resistere». Così è stato. Tutti i balconi di Bomba si vestono di lenzuoli: «No raffineria». Cortei, manifestazioni, ricorsi, dossier, carte bollate, le osservazioni di contrarietà, la «rivolta» di decine e decine di Comuni e della Provincia. Compatti e cocciuti. Arrivano i primi dinieghi, del comitato Via (Valutazione impatto ambientale) della Regione: parere sfavorevole del 10 aprile 2012 e del 20 novembre 2013. Le ragioni? La raffineria prevista, con emissioni di idrogeno solforato, potente veleno, contrasta «con il piano regionale di qualità dell’aria» e poi nel caso si innestassero fenomeni di subsidenza questi sarebbero irreversibili, con «conseguenti danni insostenibili per la popolazione» e quindi va applicato «il principio di precauzione». Principio che, a seguire, è anche il cardine della sentenza numero 02495/2015 della quinta sezione del Consiglio di Stato, che, due anni or sono, boccia irrevocabilmente il progetto: alla magistratura hanno fatto ricorso Wwf e il comitato «Gestione partecipata del territorio» di Bomba.
«Il principio di precauzione – scrive il Consiglio di Stato – fa obbligo alle autorità competenti di adottare provvedimenti appropriati al fine di prevenire i rischi potenziali per la sanità pubblica, per la sicurezza e per l’ambiente, ponendo una tutela anticipata… L’applicazione del principio di precauzione comporta dunque che, ogni qual volta non siano conosciuti con certezza i rischi indotti da un’attività potenzialmente pericolosa, l’azione dei pubblici poteri debba tradursi in una prevenzione anticipata…». Stop, dunque, alle ambizioni a stelle e strisce.
Una batosta per la multinazionale statunitense, che opera nel settore degli idrocarburi dal 1916, e che ai propri investitori, sulle pagine del Wall Street Journal, è costretta ad annunciare la perdita di 35 milioni di dollari. È tracollo finanziario e il motivo è… Bomba. Il colosso Forest, malamente inciampato in questo lembo d’Abruzzo, fallisce. «The end», così dovrebbe concludersi la storia, con i festeggiamenti, che pure ci sono stati, degli irriducibili di Bomba che cantano vittoria. In Italia però, patria del nulla è certo e/o definitivo, accade che, pochi mesi dopo, con istanza pervenuta al ministero dello Sviluppo economico il 20 maggio 2016, protocollo 11210, la Cmi Energia Spa ripropone lo stesso progetto, più impattante e con delle varianti. Cmi (Compagnia meridionale idrocarburi), con sede legale a Roma, ma con governance canadese, è nata per mano di manager della Forest Cmi Spa. Modifica parziale della denominazione, passaggio del titolo minerario da una società all’altra et voilà, si riparte.
La procedura riparte, daccapo. «Possibile – domanda Alessandro Lanci, del movimento Nuovo Senso Civico – che non si tenga conto neppure di quanto deciso dal Consiglio di Stato?». Cmi chiede la messa in produzione dei pozzi esistenti a Bomba, con possibilità di realizzarne ulteriori 2-3. E di costruire, su tre ettari, «una centrale di trattamento (raffineria, ndr) che, invece che a Bomba, viene ora posizionata nella zona industriale di Paglieta (Chieti) e che verrebbe collegata ai pozzi tramite un gasdotto di circa 21 chilometri, che andrebbe a tagliare diversi centri della Val di Sangro quali Archi, Roccascalegna, Torricella Peligna, Pennadomo, Villa Santa Maria, Atessa, Colledimezzo, Altino e Perano. Progetto ritenuto «strategico» dal governo e attualmente all’esame del comitato Via (Valutazione impatto ambientale) nazionale che ha avocato a sé la questione, rifiutando il confronto con il territorio, che è di nuovo mobilitato.
E in allerta, perché si teme uno scellerato nulla osta. «In questi giorni – spiega Massimo Colonna, chimico, di “Gestione partecipata del territorio”, in prima linea nella battaglia – , insieme a Wwf e a Legambiente, abbiamo predisposto una diffida da inviare al ministero dell’Ambiente, affinché la commissione Via esprima la propria contrarietà, e una richiesta al ministero dello Sviluppo economico per far dichiarare definitivamente non sfruttabile il giacimento». Negli atti si evidenzia che la nuova istanza «è illegittima, in quanto chiede di sottoporre a giudizio di compatibilità ambientale un progetto identico a quello bocciato dal Consiglio di Stato appena poco più di un anno prima. Tutto ciò – viene aggiunto – è offensivo nei confronti degli enti che già si sono espressi in merito in passato. La situazione idrogeologica dei luoghi, del resto, è la stessa».
Terreni friabili, sfaldabili, soggetti a continui smottamenti e che cingono un bacino idrico che racchiude 70 milioni di metri cubi d’acqua. «Le sponde del lago sono tutte franose; in particolare quella sinistra, sotto Montebello sul Sangro. E quella zona rassomiglia tanto al Monte Toc del Vajont, che produsse l’immane sciagura nel 1963»: è l’avvertimento che il 6 maggio 2010 lanciò, con raccomandata alla Regione e al Mise, Nicola Berghella, che aveva 86 anni, che era stato dirigente Acea e che dagli anni Cinquanta aveva seguito, passo passo, la realizzazione della diga, dagli espropri al taglio del nastro.
Berghella, morto nel 2015, si era preoccupato di mettere in guardia le istituzioni. «Estrarre gas nelle vicinanze della diga, se non addirittura sotto il lago – scrisse – è a dir poco azzardato, assolutamente da evitare, considerando l’assoluta instabilità dei terreni. I pericoli sono potenziali e latenti e bisogna tenere conto del fenomeno della subsidenza, con le sue imprevedibili effetti. Ed in caso di possibili crepe alla diga o di franamenti delle sponde del lago e conseguente tracimazione, c’è soltanto il disastro inimmaginabile per tutta la Valle del Sangro, per le abitazioni e gli insediamenti industriali. Occorre pertanto evitare di andare a stuzzicare la zona».
La prima concessione per l’estrazione di gas a Bomba fu rilasciata il 2 agosto del 1967 alla Società Meridionale Idrocarburi; il 30 gennaio 1969 fu trasferita ad Agip che avrebbe dovuto iniziare la produzione nel 1971 e che, dopo quasi 25 anni di proroghe, tentativi, di rilevamenti e perizie, di studi morfologici, idrodinamici e sismotettonici dovette abbandonare, per i rischi connessi. C’è una nota, del primo febbraio 1993, dell’allora ministero dell’Industria e dell’Artigianato che riassume le traversie vissute da Agip e pone l’accento sulla «presenza di vaste aree franose attive ed importanti dislocazioni tettoniche», sulla «sismicità medio-elevata, dovuta a movimenti di origine profonda del fronte appenninico della Majella e alla presenza di faglie…». «Pur trattandosi – conclude il ministero – di un adunamento di idrocarburi di ragguardevoli dimensioni, le numerose problematiche ambientali che si frappongono appaiono insanabili… Solo svuotando il lago si potrebbe procedere…».
il manifesto, 21 0tt0bre 2017La nostra società ha ammalato prima il suo spirito, teorizzando e praticando un'idea distorta di "sviluppo", dominata dalla miopia e dall'individualismo.. Ora tutti gli uomini ne pagano il prezzo
«Le malattie dovute all’inquinamento nel 2015 hanno causato il 16% dei decessi nel mondo. La perdita di benessere derivante dall’inquinamento è stimata sui 4600 miliardi di dollari all’anno: 6,2% della produzione economica mondiale»
«L’inquinamento è la più grande causa ambientale della malattia e della morte prematura nel mondo di oggi. Le malattie causate dall’inquinamento sono state responsabili di circa 9 milioni di morti premature nel 2015 – il 16% di tutti i decessi nel mondo – pari a tre volte il numero di morti dovute all’Aids, alla tubercolosi e alla malaria messe insieme, e a 15 volte quelle provocate da tutte le guerre e altre forme di violenza. Nei Paesi più gravemente colpiti – quelli a basso e medio reddito, dove si colloca il 92% di questi eventi fatali – le malattie correlate all’inquinamento sono responsabili di più di una morte su quattro».
Non è il solito allarmismo sociale molto in voga di questi tempi, ma quanto riportato dalla rivista scientifica Lancet nell’introduzione della lunga e accurata ricerca condotta dalla «Lancet Commission on pollution and health» composta da 47 scienziati di tutto il mondo.
La natura dell’inquinamento, spiegano gli esperti, «sta cambiando e, in molti luoghi del mondo, sta peggiorando», soprattutto nei Paesi in rapida industrializzazione come India, Pakistan, Cina, Bangladesh, Madagascar e Kenya.
Le cause si possono rintracciare nell’aumento del consumo energetico di fonti fossili e dell’uso di veicoli alimentati a petrolio, nella crescita delle estrazioni, dell’utilizzo di nuovi materiali e tecnologie, nell’abuso di erbicidi e pesticidi, e a causa del movimento globale delle popolazioni dalle aree rurali alle città, che si espandono incontrollatamente.
È l’inquinamento dell’aria quello che provoca la maggior parte di morti (nel 2015, 6,5 milioni in tutto il mondo), seguito da quello dell’acqua (1,8 milioni), nei posti di lavoro (800 mila) e dovuto al piombo (500 mila).
Naturalmente, la contaminazione di aria, acqua e suolo ha dei costi enormi, non sono in termini di vite umane: il Pil dei Paesi a basso e medio reddito si riduce del 2% l’anno a causa della perdita di produttività, mentre aumentano fino al 7% i costi sanitari (1,7% nei Paesi ad alto reddito). «La perdita di benessere derivante dall’inquinamento è stimata sui 4600 miliardi di dollari all’anno: 6,2% della produzione economica mondiale», scrive Lancet, sottolineando che i costi tendono ad aumentare man mano che si scoprono ulteriori correlazioni tra patologie e smog.
Viceversa, i «notevoli benefici economici», oltre che sociali, dell’abbattimento degli inquinanti sono evidenti per esempio negli Stati Uniti, dove – prima di Trump – «per ogni dollaro investito nel controllo dell’inquinamento atmosferico dal 1970, se ne sono guadagnati circa 30, con un vantaggio complessivo di 1500 miliardi di dollari contro un investimento di 65 miliardi di dollari».
Allo stesso modo, si legge ancora nel report, «la rimozione del piombo dalla benzina ha restituito alle economie americane circa 200 miliardi di dollari (da 110 a 300 miliardi) ogni anno a partire dal 1980, con un vantaggio complessivo di oltre 6 mila miliardi di dollari attraverso l’aumento della funzione cognitiva e una maggiore produttività di generazioni di bambini esposti fin dalla nascita solo a basse quantità di piombo».
Ecco perché nelle sei raccomandazioni finali della Lancet Commission al primo posto c’è il monito rivolto ai governi di tutto il mondo e alle amministrazioni di ogni livello di mettere in cima ai propri programmi il controllo dell’inquinamento. Che, appunto, deve essere affrontato a livello globale. Motivo per il quale sia i finanziamenti che il «supporto tecnico internazionale» vanno «mobilitati, aumentati e concentrati», così come vanno costruiti «partenariati tra diverse agenzie governative, e tra governi e settore privato».
Gli scienziati invitano poi a fare ricorso alle tecnologie più innovative per raccogliere dati sull’inquinamento, ad «integrare la riduzione dello smog nel piano d’azione globale per la prevenzione e il controllo delle malattie non trasmissibili», e infine a finanziare e promuovere la ricerca nel campo degli agenti inquinanti e della correlazione con le malattie.
La rotta è tracciata, non è una via semplice ma non si può far altro che iniziare a percorrerla.
Enea, una banca dati sui danni alla salute in Italia
L’inquinamento atmosferico accorcia la vita di ciascun italiano in media di 10 mesi: 14 per chi vive al nord; 6,6 per chi vive al centro e 5,7 per i cittadini del sud e delle isole. «Ma i valori di mortalità più elevati al settentrione vanno letti alla luce della maggiore disponibilità di dati rispetto al resto d’Italia».
Lo dice Carmela Marino, responsabile della divisione Enea Tecnologie e metodologie per la salvaguardia della salute dell’uomo. I dati sono il risultato degli studi condotti dall’Agenzia che ha realizzato una mappa degli effetti dell’inquinamento atmosferico sulla salute: la prima banca dati italiana in grado di fornire informazioni sulla mortalità per età, sesso e patologia anche a livello di singolo comune.
 Altreconomia, 13 ottobre 2017«Non possiamo fare finta di non vedere le contraddizioni di chi parla di produzioni sostenibili e allo stesso tempo costruisce gasdotti, Tav, e altre opere che cementificano la terra»(c.m.c)
Altreconomia, 13 ottobre 2017«Non possiamo fare finta di non vedere le contraddizioni di chi parla di produzioni sostenibili e allo stesso tempo costruisce gasdotti, Tav, e altre opere che cementificano la terra»(c.m.c)
Il G7 Agricoltura, sotto gli auspici della presidenza italiana, apre le porte sabato 14 ottobre a Bergamo. Una due giorni per avviare «un confronto internazionale di grande rilievo sulle azioni e sulle responsabilità da esercitare in campo agricolo e alimentare, per produrre meglio sprecando meno e garantire livelli di sostenibilità sempre maggiori al futuro dell’agricoltura globale», come scrive il ministro Maurizio Martina sul sito http://agriculturabg.it/. Un vertice che ha avuto un lungo prologo la settimana passata, con convegni, incontri e laboratori, mercati e degustazioni in città che -sulla spinta dell’Expo di Milano- parlano di “diritto al cibo”, “sostenibilità e giustizia”, “cibo più giusto e sicuro”.
Un vocabolario che sembra incompatibile con altre scelte portate avanti dal Governo, come spiega Roberta Maltempi, coordinatrice della “Rete bergamasca per l’alternativa al G7”. «Non possiamo fare finta di non vedere le contraddizioni di chi parla di produzioni sostenibili e allo stesso tempo costruisce gasdotti, Tav, autostrade come la Brebemi e altre opere che cementificano la terra, mettono a rischio la sicurezza idrogeologica del Paese e la salute dei cittadini. O ancora, un Governo che non mette in discussione le multinazionali dell’agrobusiness, responsabili dell’insicurezza alimentare, della desertificazione e della deforestazione e perdita di biodiversità».
Per la Rete alternativa -nata la scorsa primavera quando si è saputo che il ministro Martina, originario di Calcinate (Bg), avrebbe portato il G7 nella sua città -, «l’agrobusiness e l’agroecologia non sono compatibili. Fin dall’inizio abbiamo capito che il G7 di Bergamo avrebbe fatto leva sui percorsi ecosostenibili già attivi in città, come il distretto di economia solidale, ma proponendo questi come complementari a un sistema industriale distruttivo, anziché come reale alternativa -spiega Roberta-. Noi crediamo che si debba invece guardare alla sovranità alimentare e all’autodeterminazione dei popoli come modello alternativo all’intero sistema economico».
La caratteristica della Rete alternativa è quella di essere una comunità trasversale, che in questi mesi è stata capace di tenere insieme «il mondo -molto vivace nella nostra Provincia- dell’agricoltura biologica, dei piccoli produttori, dei gruppi d’acquisto solidale, che difendono un’agricoltura sana e naturale, con altre realtà che stanno praticando il mutualismo per affrontare la crisi e si pongono il problema di poter garantire a tutti l’accesso al cibo -spiega Roberta-. C’è il mondo cattolico, i sindacati di base, le associazioni locali e le reti di economia solidale», per 93 adesioni alla Rete da tutta Italia.
Insieme, hanno costruito un programma di tavole rotonde e momenti trasversali di confronto che si svolgeranno nel fine settimana per “svelare i lati oscuri del sistema agro industriale e proporre un’alternativa”. Le giornate del G7, infatti, vogliono essere solo “un pretesto per rafforzare una rete che costruisca sui territori pratiche di agricoltura sostenibile e mutualismo”.
Il forum alternativo si svolgerà all’Edoné Bergamo di Redona; si aprirà con una plenaria sabato 14 ottobre alle 9.00 sul tema “agrobusiness vs agroecologia” e si chiuderà con una manifestazione a Bergamo, domenica con concentramento alle 14.00 nel piazzale della stazione.
Agricoltura, mutualismo, lavoro e montagna saranno le quattro parole chiave del meeting all’Edoné, uno spazio che in questi giorni sarà animato anche da musica e convivialità attorno al cibo, con il mercato delle aziende bio e i banchetti delle associazioni locali.
In contemporanea, i “grandi 7” discuteranno “due grandi temi in agenda: la tutela degli agricoltori dalle crisi, dovute anche alle calamità naturali e ai cambiamenti climatici e le migrazioni e la sicurezza del cibo per una popolazione mondiale in crescita”. Una realtà fotografata anche dal report Fao 2017 “The state of food security and nutrition in the world” -in uscita in occasione del “World food day” del 16 ottobre-, nel quale si sottolinea il grave aumento della fame nel mondo: oggi colpisce l’11% della popolazione.
«Oltre ad aumentare la percentuale della popolazione mondiale che soffre di fame cronica a causa della malnutrizione - si legge nel report -, il numero di persone che soffre la fame è aumentato da 777 nel 2015 a 815 milioni». Tra le cause, le carestie in Sud Sudan, i conflitti in Nigeria, Somalia e Yemen, siccità e inondazioni legate al cambiamento climatico. «Negli ultimi 10 anni il numero di conflitti violenti è aumentato significativamente in tutto il mondo - scrive la Fao -, in particolare in paesi già toccati da una insicurezza alimentare, colpendo duramente le comunità rurali con un impatto negativo sulla produzione e la disponibilità di cibo».

Reset.it, 6 ottobre 2017. Il rapporto fra cambiamenti climatici, accesso alle risorse, giustizia globale, accentramento del potere e corsa agli armamenti analizzato da Amitav Ghosh. (p.d.)
Conosciamo Amitav Ghosh come un romanziere, probabilmente uno dei più grandi scrittori indiani contemporanei. Ghosh però è anche uno studioso, e la sua formazione di antropologo è visibile nel rigore della documentazione in ogni suo romanzo. Ghosh è anche un giornalista, autore di alcuni bellissimi reportage e di numerosi saggi.
È un lungo saggio anche il suo ultimo libro, La grande cecità. Il cambiamento climatico e l’impensabile, che tratta di come la cultura, e in particolare la letteratura, reagisce alla drastica trasformazione dell’ambiente in cui viviamo. Un cambiamento globale e profondo, che ormai è sotto i nostri occhi. Basti pensare agli eventi degli ultimi mesi: la siccità in Italia, l’ondata di caldo battezzata Lucifero, le disastrose alluvioni in Asia Meridionale, una serie di uragani nel golfo del Messico (eventi che hanno ricevuto attenzione diseguale: alla fine di agosto, proprio mentre i media mondiali seguivano la marcia del ciclone Harvey verso il Texas, in Bangladesh e India le alluvioni hanno ucciso 1.500 persone: senza quasi lasciare traccia sui media italiani). Insomma: per dirla con Amitav Ghosh, le forze naturali che plasmano il nostro ambiente ci lanciano segnali che però stentiamo a riconoscere. Ho incontrato Amitav Ghosh durante il recente festival Internazionale a Ferrara.
Lei sostiene che il cambiamento del clima sta sconvolgendo il nostro ambiente fisico ma noi, gli umani, non vogliamo vederlo. È questa “la Grande Cecità”?
È vero, assistiamo a fenomeni meteorologici estremi un po’ ovunque. Quello che più mi ha impressionato è la recentissima inondazione a Livorno: una famiglia va a dormire tranquilla, senza segni di avvertimento, e si sveglia mentre sta annegando. Non solo non vogliamo riconoscere le forze naturali intorno a noi, non vogliamo neppure prendere atto dei pericoli che corriamo a causa del cambiamento climatico.
Ma perché lei chiama in causa gli scrittori? Un argomento centrale del suo libro è che la letteratura non riesce a riflettere sulla trasformazione del clima, benché sia di gran lunga la crisi più drastica del nostro tempo: dice che gli intellettuali, e più precisamente i letterati, rischiano di essere complici della “Grande cecità”.
Parlo degli scrittori in primo luogo perché è ciò io faccio proprio questo, scrivere. Ma è un atto di auto-critica, non sto additando gli altri. Mi interessa analizzare questo fallimento collettivo: noi, intellettuali, scrittori, artisti, ci stiamo dimostrando incapaci di riflettere sul cambiamento del clima. L’ironia è che questa è un’epoca di intellettuali e scrittori impegnati, engagés su ogni tipo di questione e in particolare questioni di identità, genere, razza, nazionalità, o delle diseguaglianze. Eppure la crisi ambientale, benché sia di gran lunga il pericolo più grande per l’umanità, resta al margine. È bizzarro che il grande cambiamento intorno a noi non entri a far parte della nostra consapevolezza.
Il ruolo del narrare, lei ha scritto, è “affrontare il mondo al congiuntivo“, cioè “immaginare altre possibilità”. La crisi del clima ci impone di immaginare altre forme di esistenza umana sul pianeta, e lei dice che la fiction è l’espressione culturale più adatta a farlo. Dunque oggi cosa si aspetterebbe da uno scrittore?
Se guardiamo il romanzo del Diciannovesimo secolo credo che Moby Dick sia uno dei romanzi più intensi mai scritti. Riesce a esprimere un profondo legame con il mondo non-umano: in Moby Dick la balena è un essere pensante, dotato di un’energia quasi diabolica. Herman Melville è consapevole del danno ambientale provocato dalla caccia alla balena, spinta quasi all’estinzione, e attraverso il linguaggio riesce a mostrarci le contraddizioni della storia umana in relazione al mondo naturale. Mi viene da pensare anche a Zola, e a come ha esplorato le prime fasi dell’economia basata sui combustibili fossili: il carbone è un tema ricorrente nel suo lavoro. Nel romanzo del Ventesimo secolo, prendiamo Furore di John Steinbeck: per me è un romanzo sul cambiamento climatico ante litteram. Steinbeck descrive la risposta umana a un catastrofico evento climatico, la grande siccità, e le prime quattro pagine del romanzo sono forse la più potente narrazione del clima mai scritta. Insomma: voglio dire che gli umani hanno avuto gli strumenti per parlare di tutto ciò. Ma questo si è perso negli ultimi cinquant’anni. Per ironia proprio i processi che hanno portato in campo i gas di serra, responsabili del riscaldamento globale, sono gli stessi processi che stimolano il consumismo e ci portano a dimenticare il mondo fisico intorno a noi.
In effetti l’ambiente naturale è molto presente nei suoi romanzi – penso a Il paese delle Maree, dove la foresta del Sundarban, in Bengala, è protagonista della narrazione. In La grande cecità troviamo numerose digressioni narrative, che ne fanno una lettura affascinante. Ad esempio racconta come la Birmania aveva sviluppato una primitiva industria petrolifera, poi assorbita dalle compagnie britanniche. In effetti un grande merito di questo libro è che sposta lo sguardo: dal nostro punto di vista Euro-centrico, ci porta a spostare l’attenzione sull’Asia. Dice che l’Asia è cruciale nella crisi del clima. In che senso?
L’Asia è al centro di tutta la faccenda del clima perché è stato il rapido sviluppo economico di alcuni paesi asiatici negli ultimi vent’anni a far precipitare la crisi climatica. La crescita in Cina, India, Indonesia, per citare i tre paesi più popolosi, ha accelerato le emissioni globali dei gas di serra, quindi il riscaldamento dell’atmosfera. Ma così l’Asia ha dimostrato che un modello di economia ad alta intensità di risorse e di capitali può funzionare solo se praticato da una piccola minoranza della popolazione mondiale. In effetti, nell’Ottocento e fino agli anni ’70 del Novecento era così, solo il mondo Occidentale poteva praticare un’economia basata sui combustibili fossili. Ma poi quando Cina, India e Indonesia sono entrati in gioco – sia pure in piccolo, perché l’impronta ecologica di questi paesi resta molto piccola se paragonata all’Europa – questa sia pur modesta espansione ha accelerato il collasso del clima. L’Asia ha dimostrato che l’economia basata sui combustibili fossili non può essere estesa a tutto il mondo. E questa è un’altra straordinaria ironia: negli anni seguiti al 1789 la Rivoluzione francese ha affermato le idee di libertà, eguaglianza e fraternità, ma allo stesso tempo abbiamo enormi diseguaglianze, il lavoro forzato, la corsa delle potenze coloniali ad arraffare le risorse nel Sud del mondo. Per tutto il Ventesimo secolo abbiamo inseguito idee di progresso per combattere le diseguaglianze. Ma ora dobbiamo scoprire che era solo un’illusione: non possiamo perseguire in modo paritario il consumo di combustibili fossili.
Quindi il cambiamento del clima mette sul tavolo la questione dell’accesso alle risorse e della giustizia globale.
Certo. Il mondo in cui viviamo oggi è più diseguale di quello del Diciottesimo secolo. Le disparità di ricchezza e di potere non sono mai state così forti, sia tra nazioni – ad esempio l’Asia rispetto all’Occidente – sia all’interno delle singole nazioni, ad esempio in Cina o in India. E questo è un effetto del neoliberalismo. Nel dibattito sul clima parliamo spesso di “scettici”,“negazionisti”, ma lei argomenta che i veri detentori del potere sono ben consapevoli della sfida del clima: semplicemente non hanno alcuna intenzione di modificare il modello di economia su cui è fondato lo stile di vita Occidentale. Questo è un punto importante. È un errore pensare che quanti avversano le politiche sul clima siano inconsapevoli. L’amministrazione Trump, lo stesso presidente Donald Trump, il segretario di stato Rex Tillerson, perfino Steve Bannon, sono ben informati. Sanno. E sarebbe un errore anche pensare che non abbiano un piano: il loro piano è questo. Il piano è lo status quo. Contano su un’apocalisse climatica che ucciderà un gran numero di esseri umani. E questo perché sanno benissimo che l’economia estrattiva su cui si fonda lo stile di vita occidentale può funzionare solo per numeri piccoli. In un certo senso sono catastrofisti malthusiani. Pensano che una catastrofe malthusiana si avvicina, e si stanno preparando.
È quella che lei chiama “politica della scialuppa armata”?
Esatto. La “politica della scialuppa armata” significa tenere fuori gli immigranti a tutti i costi, militarizzare le frontiere, armarsi fino ai denti, difendere il proprio accesso alle risorse, e fare di tutto ciò una questione di sicurezza.
In effetti negli ultimi dieci o quindici anno diverse istituti di studi strategici hanno cominciato a ragionare sull’impatto del cambiamento climatico come una questione di sicurezza. Non ultimo il Pentagono, cioè il ministero della difesa della prima potenza mondiale…
Sì, ed è interessante. Oggi il più grande singolo consumatore di combustibili fossili al mondo è proprio il Pentagono. Un anno di operazioni militari brucia una quantità di energia fantasmagorica. E tutti gli eserciti sono in espansione: Russia, Cina, India, tutti paesi che hanno firmato gli Accordi di Parigi sul clima, eppure stanno rapidamente rafforzando la propria difesa: e questo perché dall’inizio della Rivoluzione industriale i combustibili fossili e il potere sono inestricabilmente legati. Il carbone ha permesso alla Gran Bretagna di innescare la rivoluzione industriale e allo stesso tempo creare un’industria delle armi: è così che ha sconfitto l’intera flotta cinese con una sola nave da guerra a vapore, la Nemesis. Da allora ogni paese sa che i combustibili fossili hanno una relazione diretta con il potere, e ogni paese sta surrettiziamente allargando l’uso di combustibili fossili per la difesa. Solo che nessuno dirà al Pentagono “ora dovete tagliare”. E questo anche perché via via che il cambiamento del clima accelera, e cresce il suo impatto, vedremo più insicurezza. Conflitti per l’acqua e per le risorse sono già una realtà in diverse parti del mondo. Un circolo vizioso: aumentano i conflitti per le risorse e aumenta il consumo di combustibili fossili, cosa che a sua volta accelera il cambiamento del clima.
Vuol dire che andiamo verso una situazione in cui una piccola élite mondiale vorrà monopolizzare le risorse naturali, l’acqua l’energia?
Appunto. Il cambiamento del clima è in sostanza una questione di potere: non ci sarà un approccio realistico se non metteremo in discussione la distribuzione globale del potere.
Tra gli effetti del cambiamento del clima si parla spesso di masse di persone costrette a sfollare da eventi estremi come alluvioni o siccità, quindi nuove ondate di migranti. Nei suoi romanzi l’esperienza del migrare è molto presente – contadini egiziani che si spostano in Medio oriente, migranti bengalesi nella penisola Arabica, commercianti indiani nella Cina del secolo scorso… Lei sembra suggerire che attraversare frontiere, sia geografiche che culturali, è parte dell’esperienza umana, e di sicuro parte della modernità. In Europa però l’arrivo di alcune centinaia di migliaia di persone suscita paure e reazioni ostili…
La crisi dei migranti mi interessa molto. Sarà per la mia storia familiare: io sono bengalese; i miei avi venivano da quello che ora è Bangladesh ma dovettero emigrare, intorno al 1850, perché un fiume aveva cambiato il suo corso e sommerso il nostro villaggio. Forse è per questo che mi sono sempre interessate le storie di sfollati e migranti. Negli ultimi mesi ho visitato diversi centri per migranti in Italia – in Sicilia, vicino a Milano, a Venezia. Io parlo bengalese, hindi, urdu, arabo, e queste oggi sono le lingue dei poveri globali: posso avere una comunicazione diretta con le persone che ho incontrato. Cosa ho ricavato da queste visite? Primo, che in effetti è vero, la gran parte di questi migranti sono spinti da effetti del cambiamento climatico: è vero per il Sahel e l’Africa sub sahariana, ma anche per il Bangladesh, che oggi è il secondo paese di provenienza di immigrati in Italia. Ma è complicato. Prendiamo una famiglia rurale in Bangladesh. Un anno la terra viene allagata: è cosa che succede, e loro riescono a farvi fronte. Ma l’anno dopo l’alluvione si ripete, e anche quello dopo ancora, e le risorse per fare fronte non ci sono più. Di solito, la prima risposta sarà mandare il figlio, un ragazzo di 16 o 17 anni, a cercare lavoro in città, magari a Dhaka. Se non lo trova, il ragazzo finirà su una delle barche che attraversano il Mediterraneo. Ma se gli chiedete ‘sei un migrante climatico’ lui negherà. Un elemento che spesso sfugge agli europei è che nessuno dei migranti che sbarca in Europa si percepisce come vittima. Loro sono protagonisti. Hanno iniziativa. E in effetti per intraprendere un viaggio così pericoloso devi avere iniziativa, e coraggio.
Un altro aspetto spesso tralasciato è l’impatto delle nuove tecnologie delle comunicazioni. I telefoni cellulari e l’internet sono fondamentali per i migranti. Il telefonino ti permette di vedere foto, sapere cosa succede in Europa, essere aggiornato sui percorsi, trasferire soldi. Forse il servizio più importante che le Ong possono offrire ai migranti sono i punti di ricarica. In questo vedo un’altra delle ironie del cambiamento del clima: proprio il tipo di consumismo che porta alla crisi del clima porta anche a una sempre maggior dipendenza da questi strumenti che stanno tagliando la nostra connessione storica alla terra. In un villaggio del Bangladesh vedi telefilm magari girati a Calcutta, che mostrano una vita piena di automobili e frigoriferi e cose simili: e sono gli oggetti che tutti vorranno. Voglio dire che siamo di fronte a una crisi su parecchi livelli. È una questione di cambiamento del clima e anche una questione di desideri, solo che questo aspetto non è spesso considerato. Forse il solo che abbia compreso la natura ambigua della questione è Papa Francesco nella sua enciclica Laudato Sì. Il capo della chiesa cattolica, con la sua rete di istituzioni a diretto contatto con i poveri, deve avere percepito che il desiderio di migrare non riguarda solo la povertà.
Amitav Ghosh è nato a Calcutta nel 1956. Ha studiato a Oxford, dove ha conseguito un dottorato in antropologia sociale. Vive tra New York e l’India. È autore dei romanzi Il cerchio della ragione; Le linee d’ombra; Il cromosoma Calcutta; Il palazzo degli specchi; Il paese delle maree; e la “trilogia dell’Ibis” (Mare di papaveri, Il fiume dell’oppio e Diluvio di fuoco). La grande cecità è il suo secondo lavoro di non-fiction dopo Lo schiavo del manoscritto. Tra i reportage vanno segnalati Conto alla rovescia (sui test nucleari dell’India nel 1998), e Danzando in Cambogia. Articoli e saggi di Ghosh sono stati pubblicati da The New Yorker, The New Republic e The New York Times; una raccolta di saggi brevi è pubblicata nel volume Circostanze incendiarie.

il Fatto Quotidiano online, 6 ottobre 2017. «Roma non ha fornito a Bruxelles informazioni relative a oltre 3.000 stabilimenti. Lo si legge sul sito dell’E-Prtr, il Registro europeo del rilascio e trasferimento degli inquinanti: "Non sono state comunicate entro la data richiesta", marzo 2017». (p.d.)
L’Italia è l’unico Paese a non aver fornito alla Commissione europea i dati relativi al 2015 sulle emissioni inquinanti di oltre 3.000 stabilimenti nei tempi stabiliti dal Regolamento comunitario. Così, ora che il registro è pubblico, nella mappa delle circa 30mila industrie dei Paesi membri e di Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Serbia e Svizzera, la Penisola è un buco nero senza alcuna informazione. E la situazione non cambierà almeno fino a novembre.
Lo si legge chiaramente sul sito dell’E-Prtr, il Registro europeo del rilascio e trasferimento degli inquinanti: “Attenzione: non sono disponibili dati relativi all’Italia per il 2015. I dati non sono stati comunicati entro la data richiesta”, scrive l’E-Prtr, gestito dalla Commissione europea che si avvale dell’Agenzia europea per l’ambiente per il controllo delle certificazioni inviate dai 28 Stati membri.
Istituito da un Regolamento europeo nel 2006 e poi potenziato, il Registro europeo fornisce dati ambientali chiave facilmente accessibili relativi a 91 sostanze inquinanti rilasciate da circa 30mila aziende europee di nove settori industriali, tra figurano quali centrali elettriche, stabilimenti siderurgici e industrie chimiche. I dati riguardano le emissioni al suolo e da fonti diffuse, oltre che il trasferimento dei rifiuti fuori dal sito industriale. La Commissione aveva deciso di istituire la banca dati per “fornire al pubblico informazioni attendibili”, “permettere decisioni consapevoli” e “contribuire alla prevenzione e alla riduzione dell’inquinamento ambientale”. Dal 2007, quindi, gli Stati membri hanno l’obbligo di inviare i dati “entro 15 mesi dalla fine dell’anno di riferimento”.
Le schede delle industrie riferite al 2015 sarebbero quindi dovute arrivare alla Commissione entro marzo 2017. Un compito assolto da tutti gli Stati, tranne che dall’Italia. IlFattoQuotidiano.it ha chiesto al ministero dell’Ambiente, responsabile del procedimento, per quali motivi ciò non è avvenuto. Ma non ha ottenuto risposte ufficiali. È stato tuttavia possibile ricostruire quanto sarebbe accaduto grazie ad alcune fonti. L’Italia ha fornito i dati alla Commissione solo a giugno, con tre mesi di ritardo, e ora l’Agenzia europea per l’ambiente sta effettuando uno screening delle schede ‘validandole’.
Il problema – secondo quanto apprende Il Fatto – non è imputabile agli oltre tremila stabilimenti coinvolti, ognuno dei quali deve fornire una rigorosa autocertificazione all’ente governativo responsabile del procedimento, ma a un “problema tecnico” interno al ministero dell’Ambiente che ha “ritardato tutto”. Di più, non è dato sapere, se non che l’Italia ha provveduto a settembre a integrare i dati inviati a inizio estate, che questi sarebbero già disponibili in una piattaforma interna ma comunque non nel Registro europeo, dove dovrebbero essere pubblicati “entro novembre”.
Il ritardo non provocherà l’apertura di una procedura d’infrazione perché le schede sono comunque state inviate e inoltre non era mai accaduto dall’istituzione dell’E-Prtr che l’Italia infrangesse l’obbligo di inviare i report entro 15 mesi dopo la fine dell’anno di riferimento delle emissioni inquinanti. Ma la figuraccia è tutta lì, in quell’avviso che campeggia sul sito: “I dati non sono stati comunicati entro la data richiesta”.
Comune Info, 25 settembre 2017. «Fra l’estinzione e la fuga vedo una terza possibilità: rimanere, curare, difendere la nostra casa. Rimanere a casa, proteggere e rigenerare i sistemi viventi e i processi vitali della Terra, è un dovere etico ed ecologico». (m.p.r.)
Per riparare il ciclo del carbonio che abbiamo spezzato dobbiamo smettere di estrarre carbonfossile, che va lasciato sotto terra, e rigenerare piante e suoli Disastri climatici, resilienza climatica. Fra l’estinzione e la fuga su altri pianeti abbiamo una terza via: sopravvivere prendendoci cura di Madre Terra. Negli Stati indiani di Assam, Bihar e Uttar Pradesh le inondazioni hanno provocato 41 milioni di sfollati e ucciso circa cinquecento persone; a Houston e Mumbai hanno paralizzato ogni attività. È sempre più evidente che non stiamo vivendo all’interno dei limiti ecologici del nostro pianeta, e che per le nostre continue violazioni delle leggi della Terra, essere vivente, subiamo pesanti conseguenze.
Quest’anno si susseguono immagini di inondazioni estreme; l’anno scorso è stata la siccità a essere estrema ed estesa. Quando distruggiamo i sistemi climatici della Terra, che si autoregolano, arriviamo al caos, all’incertezza climatica, a cambiamenti imprevedibili ai quali pensiamo di sfuggire con la geo-ingegneria e l’ingegneria genetica.
I sistemi viventi evolvono, si adattano, si rigenerano. Non sono ingegnerizzati. Il dominio del paradigma ingegneristico inizia con l’era dei combustibili fossili, l’era dell’industrialismo e del meccanicismo. E la dottrina secondo la quale ogni fenomeno naturale, compresi la vita e il pensiero, possono essere spiegati sulla base di processi meccanici e chimici.Negli ultimi duecento anni una piccola parte dell’umanità ha inquinato il pianeta, a causa di un’economia alimentata da carbone, petrolio e gas, e di un sistema di conoscenza fondato su un paradigma meccanicistico, riduzionista e materialistico.
L’inquinamento dell’atmosfera ha sconvolto i sistemi e l’equilibrio climatico. La distruzione degli habitat e la diffusione delle monocolture hanno contribuito a quello che gli scienziati chiamano la Sesta estinzione, la sparizione della biodiversità a un ritmo che è mille volte quello naturale. Mangiamo, beviamo, respiriamo petrolio. L’estrazione di combustibili fossili (carbonio morto) dal suolo, la loro combustione e le emissioni incontrollabili in atmosfera portano alla rottura del ciclo del carbonio e in questo modo alla destabilizzazione dei sistemi climatici.
Come sottolineano Steve McKevitt e Tony Ryan (in Project Sunshine), tutto il carbone, il petrolio e il gas naturale che estraiamo e bruciamo si sono formati oltre seicento milioni di anni fa. Bruciamo ogni anno venti milioni di anni di natura. Il ciclo del carbonio è spezzato. Noi lo abbiamo spezzato. La dipendenza dal carbonio fossile, morto, induce anche scarsità di carbonio vivo, con la conseguente diminuzione della disponibilità di cibo per gli umani e per gli organismi del suolo. Una scarsità che si traduce in malnutrizione e fame da una parte e desertificazione del suolo dall’altra. L’agricoltura chimica intensifica gli input di sintesi e il capitale, riducendo la biodiversità, la biomassa e il nutrimento che i semi, il suolo e il sole possono produrre.
Per fissare più carbonio vitale, abbiamo bisogno di intensificare biologicamente le nostre fattorie e le nostre foreste, in termini di biodiversità e biomassa. La biodiversità e la densità di biomassa producono più nutrimento e più cibo per ettaro (come abbiamo mostrato nel rapporto di Navdanya intitolato Health per Acre – Salute per ettaro), affrontando così il problema della fame e della malnutrizione. Ma aumentano anche (e non solo) il carbonio vitale nel suolo, e tutti gli altri nutrienti, insieme alla densità degli organismi benefici.
Più facciamo crescere la diversità e la biomassa, più le piante fissano il carbonio e l’azoto atmosferici, e riducono sia le emissioni che la quantità di sostanze inquinanti in atmosfera. Il carbonio viene restituito al suolo attraverso le piante. Ecco perché è davvero stretto il legame fra biodiversità e cambiamenti climatici. Più si intensificano la biodiversità e la biomassa delle foreste e delle fattorie, più materia organica è in grado di ritornare al suolo, invertendo il trend verso la desertificazione che è la prima causa degli spostamenti di popolazione e dello sradicamento delle persone, con la creazione di ondate di rifugiati (si veda il manifesto di Navdanya Terra viva: Our Soils, Our Commons, Our Future).
Per riparare il ciclo del carbonio che abbiamo spezzato dobbiamo tornare ai semi, al suolo, al sole, aumentare il carbonio vivo nelle piante e nei suoli. Dobbiamo ricordare che il carbonio vivo dà vita, mentre il carbonio morto distrugge i processi della vita. Così, con le nostre cure e la nostra consapevolezza, possiamo accrescere il carbonio vivo sul pianeta e il benessere di tutti. Invece, più sfruttiamo e usiamo carbonio morto, più inquinamento produciamo e meno avremo per il futuro. Il carbonio morto deve essere lasciato sottoterra. È un obbligo etico e un imperativo ecologico. Ecco perché il termine «decarbonizzazione» – senza distinzione fra il carbonio vivo e quello morto – è scientificamente ed ecologicamente inappropriato. Se decarbonizziamo l’economia, non avremo piante, che sono carbonio vivo, non avremo vita sulla Terra. Vita che crea carbonio vivo e ne è alimentata. Un pianeta decarbonizzato sarebbe un pianeta morto.
Dobbiamo ricarbonizzare il mondo con carbonio vivo. Dobbiamo decarbonizzare il mondo relativamente al carbonio morto. Quando creiamo più carbonio vivo attraverso l’agroecologia e l’agricoltura organica, abbiamo più suoli fertili che producono più cibo e trattengono più acqua, aumentando dunque la resilienza di fronte a siccità e inondazioni. L’agricoltura biologica ad alta intensità di biodiversità produce più cibo e più nutrienti per ettaro.Garantendo servizi ecologici e il controllo degli agenti infestanti, permette di fare a meno degli input di sintesi, dei veleni, evitando anche i debiti contratti per acquistarli, la principale causa di suicidio fra gli agricoltori. I redditi agricoli possono aumentare di dieci volte se si abbandona la dipendenza da input chimici costosi e dalla coltivazione di derrate i cui prezzi continuano a scendere.
Far crescere cibo vero a zero costi è la strada verso il secondo degli Obiettivi per lo sviluppo sostenibile (Sdg) dell’Onu: fame zero. I combustibili fossili, la strada verso la conquista, ci hanno portati alla crisi che l’umanità è ora costretta ad affrontare. Crediamo di essere al di fuori e al di sopra della Terra, crediamo di controllarla, di esserne i padroni. Lo crediamo. I combustibili fossili ci hanno consentito l’illusione di non dover vivere entro i limiti, le frontiere e i processi ecologici del nostro pianeta. Ma ecco che i cambiamenti climatici, gli eventi estremi, i disastri ci ricordano con sempre maggiore frequenza che siamo parte della Terra. Ogni atto di violenza che distrugge i sistemi ecologici minaccia anche le nostre vite.

Ormai la minaccia alla stessa sopravvivenza umana è riconosciuta, ma continua a non essere messa in relazione con la violenza contro la Terra, e non giunge alla conclusione che dobbiamo trasformarci da specie predatrice e incurante a specie che si prende cura, che lavora in co-creazione e co-evoluzione con la Terra.
Stephen Hawking ha lanciato l’allarme: entro cento anni, per sopravvivere dovremo lasciare la Terra e trovare altri pianeti. Non ci sarebbero che due opzioni: l’estinzione o la fuga. Questo escapismo è al tempo stesso una dichiarazione di irresponsabilità (rispetto al prendersi cura della Terra) e di tracotanza tecnologica. È un’arroganza cieca rispetto al fatto che alcuni umani hanno spezzato i fragili processi ecologici che mantengono e riproducono la vita sulla Terra. È il rifiuto di riconoscere il dovere ecologico di chiedere scusa alla nostra Madre, smettere di danneggiarla, dedicare il nostro amore e la nostra intelligenza a lenirne le ferite, un seme alla volta, un giardino alla volta. Se abbandoniamo l’arroganza tecnologica antropocentrica, di Padroni e Conquistatori, riconoscendo con umiltà che siamo membri della famiglia della Terra, possiamo, con i semi, il suolo, il sole, rigenerare il pianeta e il nostro futuro.
A differenza di Hawking, fra l’estinzione e la fuga vedo una terza possibilità: rimanere, curare, difendere la nostra casa. Rimanere a casa, proteggere e rigenerare i sistemi viventi e i processi vitali della Terra, è un dovere etico ed ecologico.
il Fatto Quotidiano, 23 settembre 2017. «Quanto vale un bosco, un ruscello, l’aria pulita? “Il nostro benessere: lo insegna la contabilità ambientale”». (p.d.)
“Quanto conta, anzi quanto vale un bosco? E un costone di montagna, un prato, un ruscello d’acqua pulita, una spiaggia senza schifezze, una veduta? Il capitale naturale è l’unico tesoro che possediamo e al quale però togliamo il suo giusto prezzo, neghiamo il valore che possiede, evitiamo di pensare al suo costo economico se lo mandiamo in fumo”. Davide Marino insegna all’Università del Molise Contabilità ambientale ed Estimo rurale. Da più tempo degli altri, con più caparbietà degli altri (e passione, e vigore) tiene il registro del capitale naturale. “Non è una sommatoria di risorse ma un combinato di fattori. Sono fattori di produzione e di benessere, indicatori di vitalità economica e civiltà, ma l’approccio collettivo è deludente, anzi disarmante”.
Un bosco quanto vale?
Vale naturalmente la sua legna. Ma nel capitale naturale gli addendi sono diversi: alla legna aggiunga il beneficio che ne trae l’aria, il valore anche economico della regolazione bioclimatica. Aggiunga il servizio essenziale di filtraggio dell’acqua piovana, e poi le ricadute sull’economia del turismo. E infine: quanto vale l’ispirazione che quella risorsa dà all’arte, alla filosofia, alle religioni. Ricorda il bosco di San Francesco? Ecco: un bosco è una ricchezza complessa e dal valore piuttosto alto.
Vale tanto, eppure per noi non conta nulla.
Il prezzo è il segnale della qualità di risorsa. Se è limitata esso sale.
Dovrebbe costare una fortuna allora.
Invece zero. Lei paga per passeggiare in montagna? Di certo però compra il biglietto per andare al cinema e vedere un film.
Non la stimiamo come indispensabile quella montagna e forse nemmeno quella passeggiata.
Facciamo di peggio. Se un bosco va a fuoco, e se vanno a fuoco decine di boschi, di costoni di montagne, lo Stato impiegherà mezzi e persone per spegnerli. L’attività antincendio ha sicuramente un costo e quel costo finisce alla voce attiva, è spesa pubblica. Aumentando gli incendi aumenta la spesa pubblica e dunque aumenta il Pil. E il Pil (prodotto interno lordo) è un indicatore di ricchezza.
Benvenuti nel mondo alla rovescia.
Più incendi, più allagamenti, più ricostruzioni, più emergenze fanno salire il Pil. Dunque inducono noi a ritenerci non solo più ricchi, ma anche più fortunati.
Com’è possibile che siamo giunti a questa primitiva condizione di obsolescenza mentale, questa forma di inettitudine logica?
Perché rispetto a trent’anni fa l’ambiente, il valore delle risorse naturali, ha perso centralità nelle coscienze individuali e nel dibattito pubblico. Trent’anni fa si costruì sotto la spinta di una pressione di massa una rete enorme di parchi e aree protette. Oggi quella consapevolezza diffusa si è rarefatta, è divenuta patrimonio di pochi.
Nei talk show la politica è declinata secondo le formule di rito.
Un filino di attenzione appena il disastro si compie. Poi il nulla, o forse l’attesa del successivo. Parola d’ordine emergenza non prevenzione.
Altro che passi in avanti, stiamo felicemente tornando indietro.
Bisogna dire che si sono elaborati schemi di contabilità omogenei che definiscono meglio questa ricchezza naturale. Ora si tratta di obbligare gli Stati a utilizzare quel tipo di conto economico.
Ce la faremo a fare entrare un bosco o un fiume nel quadrante della ricchezza o della povertà di un popolo?
Non lo so. Sono aumentate le forme di egoismo, abbiamo una cura di noi stessi a volte parossistica, ma non riusciamo a cogliere l’opportunità che il capitale naturale mette a nostra disposizione. Noi italiani – che ne possediamo tanto – dovremmo essere felicissimi di rivalutarlo. E invece lo facciamo scorrere e defluire nell’enorme voragine della nostra disattenzione. Non solo non ci applichiamo ma troviamo il modo per arretrare.
Per esempio?
La mia università ha dovuto chiudere il corso di studi in Scienze ambientali. Gli iscritti si sono ridotti fino a scomparire. Come se della natura non debba fregare più niente a nessuno.
È la rete che ci rende liberi e felici, no?
Sconforto.
 la Repubblica, 14 settembre 2017. «Per stoppare l’avanzata del cambiamento climatico e del riscaldamento globale è necessario fermare la crescita economica. Questa è la realtà». Intervista ad Amitav Gosh, autore di La grande cecità
la Repubblica, 14 settembre 2017. «Per stoppare l’avanzata del cambiamento climatico e del riscaldamento globale è necessario fermare la crescita economica. Questa è la realtà». Intervista ad Amitav Gosh, autore di La grande cecità
Siamo tutti vittime e colpevoli, dice Amitav Ghosh. Pare di riascoltare le parole dell’ultima intervista di Pier Paolo Pasolini. Altra epoca, altro «gioco al massacro ». Ma il finale è lo stesso. Siamo tutti «deboli e vittime» del cambiamento climatico, perché ne subiamo le spietate conseguenze. Ma siamo anche tutti colpevoli perché, dice lo scrittore indiano, «il silenzio e l’indifferenza verso la più grande e imminente catastrofe del presente umano è di tutti. Non solo dei politici, ma anche di scrittori e intellettuali, che si occupano raramente di questo problema, e dei cittadini, che oramai dimenticano le sempre più frequenti catastrofi naturali, da Livorno ai Caraibi, dall’India a Houston».
Benvenuti dunque nell’epoca della “Grande cecità”, dove un cavalluccio marino nuota con un cotton fioc e dove neanche l’occhio di Irma, il più terribile uragano della storia recente degli Stati Uniti, ci illumina la vista, né «smuove le coscienze. O meglio, la nostra incoscienza», racconta affranto Ghosh, autore, tra le altre cose, de Il paese delle maree e della Trilogia dell’Ibis. La Grande Cecità
che ha annebbiato il nostro immaginario e l’istinto ecologico, è anche il nome dell’ultimo saggio di Ghosh, edito da Neri Pozza (pagg. 284, euro 18). Sottotitolo «il cambiamento climatico e l’impensabile». Impensabile, spiega lo scrittore, «è l’autocensura del termine climate change, che compare raramente in libri e media, nonostante la gravità del problema. È una questione di narrativa, di immaginazione».
E perché capita questo, Ghosh?
«Alla base c’è sicuramente una colpa dei politici e della inerme comunità mondiale. È una cosa scandalosa, ma in fondo la capisco. Oggi i politici hanno mandati di 4-5 anni in media ed è impossibile limitare una piaga così ampia e a lungo termine come il cambiamento climatico in tempi così brevi. Gli accordi di Parigi, già rinnegati da Trump, sono stati importanti ma si tratta di un passo minuscolo verso una soluzione del problema».
Come mai?
«Innanzitutto perché ne affrontavano una parte piccolissima, concentrandosi solo sulle emissioni e non su agricoltura, acqua e altri aspetti cruciali. Più in generale, per stoppare l’avanzata del cambiamento climatico e del riscaldamento globale è necessario fermare la crescita economica. Questa è la realtà. I politici lo sanno ma non lo ammetteranno mai, altrimenti si brucerebbero la carriera. Invece continueranno a ripetere “crescita, crescita, crescita”. Così i disastri e il calore cresceranno sempre di più, oramai l’aria condizionata la usano anche a Seattle, saranno necessari energia e fondi sempre maggiori, e continueremo a morderci la coda fino al prossimo disastro».
Cosa bisogna fare secondo lei?
«Limitare l’uso di energia, e ricalibrare quest’ultima sul consumo pulito. Ridefinire il modello economico e la globalizzazione. Così non si può andare avanti. Il Pakistan per sopravvivere deve esportare sempre più cotone, ma per farlo crescere ci vuole tanta acqua, e così prosciuga le sue riserve. Lo stesso accade in India per la canna da zucchero. Ma la crisi idrica è una delle tante conseguenze di questo sistema insostenibile. E nessuno ne parla seriamente ».
Nella “Grande Cecità” lei affronta proprio questo problema. Quali sono le cause?
«La cultura è connessa al mondo della produzione di merci e ne induce i desideri. Inoltre, non c’è istruzione né educazione su ambiente e cambiamento climatico, né da piccoli, né da grandi. Perciò, al cinema o nei romanzi, un tema del genere non viene ancora considerato realistico, ma surreale, o “fantascienza”. Eppure il disastro è qui, imminente, intorno a noi. La cosa più deprimente è la glaciale insensibilità che persino i cittadini, ormai, mostrano senza ritegno».
Ma perché abbiamo smarrito quest’anima ambientalista? Del resto, anche in Europa, per esempio, i partiti verdi ed ecologisti hanno perso moltissimo consenso.
«È vero ed è sconfortante. La nostra assuefazione emotiva nei confronti dei disastri naturali e del cambiamento climatico si è fortificata parecchio negli ultimi decenni. Quasi non ci spaventano più, ma soprattutto non ci fanno più pensare alle loro conseguenze e, quindi, al nostro futuro. L’attuale modello di vita estremamente materiale, individuale e schiacciato su una singola esistenza influisce profondamente su qualsiasi domanda sul nostro destino e sul futuro del mondo. Non che avessero fondamento scientifico, ma almeno in passato, quando le religioni avevano molto più seguito, le catastrofi naturali ci inducevano a riflettere sulle loro cause, sul perché di quella “punizione divina”. Era un ragionamento errato, ma almeno si rifletteva. Oggi abbiamo rinunciato anche a questo. Paradossalmente, nell’era della globalizzazione, non abbiamo più quello spirito globale nell’avversità. Per questo si tratta di un problema soprattutto culturale».
E, conseguentemente, molto spesso non si fa nulla neanche per la prevenzione dei disastri.
«Difatti sono rimasto sconvolto da quello che è successo a Livorno qualche giorno fa. È incredibile che in un paese come l’Italia possano accadere drammi simili senza alcuna protezione pregressa, date anche le condizioni particolarmente ostiche del territorio italiano. Persino le Mauritius hanno un ottimo sistema di allerta anti cicloni, per esempio. Anche la vituperata Cina sta facendo molto rispetto al passato. Ma nemmeno questo oramai mi stupisce più. Le grandi nazioni occidentali, nonostante la facciata, sono paradossalmente quelle che fanno meno per risolvere il problema. Non solo Trump, ma anche uno come il premier canadese Justin Trudeau, icona dei liberal e della sinistra nel mondo, sta facendo poco per l’ambiente. L’influenza della cultura economica, estrattiva e coloniale del mondo anglosassone non si è indebolita nei decenni. Eppure affrontare il cambiamento climatico risolverebbe tanti problemi dell’Occidente, anche quelli migratori. E invece... Con questo assordante silenzio intorno, è impossibile essere ottimisti».
 Un editoriale pessimista sul negazionismo del governo Trump in merito al cambiamento climatico. Neanche i recenti disastri in Texas e in Florida fermano la macchina da guerra, dei conservatori. The new York Times, 11 settembre 2017, con postilla (m.c.g.)
Un editoriale pessimista sul negazionismo del governo Trump in merito al cambiamento climatico. Neanche i recenti disastri in Texas e in Florida fermano la macchina da guerra, dei conservatori. The new York Times, 11 settembre 2017, con postilla (m.c.g.)
Dopo la devastazione provocata da Harvey a Houston - una devastazione perfettamente in linea con le previsioni dei meteorologi – ci si sarebbe aspettati una maggiore attenzione quando gli stessi esperti mettevano in guardia contro i rischi rappresentati dall’uragano Irma. Ma vi sareste sbagliati. Martedì scorso Rush Limbaugh (un noto conduttore radiofonico) ha accusato gli scienziati del clima di inventarsi i pericoli di Irma per motivi politici e finanziari: “Si vuole mettere in agenda il cambiamento climatico, e gli uragani rappresentano l’occasione migliore per farlo” ha dichiarato, aggiungendo che “la paura e il panico” aiutano a vendere batterie, bottiglie d’acqua e pubblicità televisiva. Subito dopo è stato costretto ad abbandonare la sua villa a Palm Beach.
In un certo senso, dovremmo essere grati a Limbaugh per aver quanto meno sollevato il tema del cambiamento climatico e della sua relazione con gli uragani, se non altro perché si tratta di un tema che l’amministrazione Trump sta disperatamente cercando di evitare. Ad esempio, Scott Pruit, il capo dell’Agenzia della Protezione dell’Ambiente federale, un amico dell’inquinamento e degli inquinatori, ha dichiarato che non è questo il momento di sollevare il problema – che questo comportamento mostra una insensibilità nei confronti del popolo della Florida. Inutile sottolinearlo, per persone come Pruitt non vi sarà mai un momento giusto per discutere sul clima.
Cosa possiamo imparare dallo sfogo di Limbaugh? Certamente, che è una persona terribile – ma già lo sapevamo. Il punto importante è che non è uno che evita di esporsi. Di sicuro, non ci sono stati altri personaggi influenti che si sono espressi così negativamente in merito agli avvertimenti su Irma, anche se negare i risultati scientifici attaccando a un tempo gli scienziati in quanto politicamente motivati e venali è una procedura standard della destra americana.
Quando Donald Trump ha definito il cambiamento climatico una truffa, stava semplicemente comportandosi come un normale Repubblicano. E grazie alla vittoria elettorale di Trump, sono dei conservatori ignoranti e contrari alla scienza che oggi governano negli Stati Uniti.
Quando si leggono analisi recenti affermare che la gestione del potere nei confronti dei Democratici in qualche misura ha trasformato Trump in pochi mesi in un moderato indipendente, ricordatevi che non si tratta solo di Pruitt. Tutti i politici di lungo corso dell’amministrazione Trump che hanno a che fare con l’ambiente o l’energia sono Repubblicani e tutti concordano nel negare il cambiamento climatico e l’evidenza scientifica. E la maggior parte di costoro sono d’accordo con la teoria della cospirazione alla Limbaugh.
In realtà, vi è un consenso scientifico travolgente sul fatto che le attività umane stanno riscaldando il pianeta. Quando i politici conservatori e i loro esperti contestano questo consenso, non lo fanno sulla base di una attenta considerazione delle evidenze – dai, non scherziamo – ma impugnando le motivazioni di migliaia di scienziati in tutto il mondo. Tutti questi scienziati sarebbero motivati da pressioni politiche e remunerazioni finanziarie, falsificando dati e nascondendo le opinioni contrarie.
Sembrano chiacchiere folli. Ma sono profondamente radicate nella destra moderna, nei suoi esperti e nei suoi politici. Perché i conservatori americani sono così determinati nel delegittimare la scienza e nel dar credito alla teoria della cospirazione degli scienziati? Parte della risposta sta nel fatto che sono impegnati a difendere il loro potere. Così funzionano le cose nel loro mondo.
Qualche repubblicano disilluso ama parlare di un’età dell’oro del pensiero conservatore, in qualche luogo nel passato. Ma questa età dell’oro non è mai esistita, anche se, in altri tempi, qualche intellettuale conservatore ha espresso delle idee interessanti e indipendenti. Ma molto tempo fa. Oggi l’universo intero degli intellettuali di destra è dominato da propagandisti piuttosto che da studiosi.
E i politici di destra molestano e perseguitano i ricercatori le cui conclusioni non sono gradite – un comportamento che è stato ampiamente legittimato ora che Trump è al potere. L’amministrazione Trump è disorganizzata su vari fronti, ma sta sistematicamente epurando le scienze sul clima e gli scienziati del clima ovunque le sia possibile.
Così, la gente a cui piace ascoltare le trasmissioni di Limbaugh immagina che i liberal siano impegnati in una cospirazione per promuovere idee false sul clima e sopprimere la verità. E questo ha per loro un senso, poiché i conservatori sono sempre più ostili alla scienza in generale. I sondaggi mostrano infatti un considerevole declino della fiducia nella scienza dagli anni ’70 in poi, determinato da un’evidente motivazione politica – non certo dal fatto che la scienza ha smesso di produrre conoscenza.
È vero che gli scienziati hanno restituito il favore, perdendo fiducia nei conservatori: più dell’80% propende per il partito Democratico. Ma come potremmo immaginare che gli scienziati supportino un partito i cui candidati alla presidenza non possono neppure accettare la teoria dell’evoluzione?
La questione di fondo è che oggi siamo governati da gente completamente lontana non solo dalla comunità scientifica, ma dall’idea di scienza – dalla nozione che la valutazione oggettiva dell’evidenza è l’unico modo per conoscere il mondo. E questa ignoranza caparbia è terribilmente spaventosa. Infatti, può finire per distruggere la civiltà.
postilla
Mentre dopo l’inondazione in Texas provocata da Harvey, anche la Florida si prepara a valutare i danni, ambientali e umani, dell’uragano Irma - l’evento che ha provocato la più grande evacuazione di popolazione dalle città dopo quella di Londra durante la seconda guerra mondiale - Scott Pruit, il neodirettore dell’EPA, l’agenzia federale per la protezione dell’ambiente, ha immediatamente dichiarato che discutere di cambiamento climatico nel bel mezzo di una tempesta mortale era una stupidaggine. Ma il personaggio, voluto da Trump a quella carica, considera il riscaldamento globale come una “truffa” (in piena sintonia con il suo Presidente): le emissioni di CO2 da fonti mobili e stazionarie non costituiscono un problema per l’ambiente. Il fronte dei Repubblicani a livello locale sembra un po' meno compatto. Mentre il governatore della Florida Rick Scott, in piena tempesta distruttiva, ribadisce le tesi dei negazionisti, il sindaco di Miami, Tomas Regalado, anch’egli Repubblicano, ha rilasciato un’intervista nella quale ha dichiarato:“If this isn’t climate change, I don’t know what is”. Ma si tratta di un caso isolato. Il pessimismo, quando si tratta di questa leadership, dei suoi giornalisti accreditati, dei suoi esperti e dei suoi amministratori non è mai eccessivo, come sottolinea Paul Krugman nell’editoriale desolato pubblicato sul New York Times che eddyburg ha tradotto per i suoi lettori (m.c.g.).

Il clima sta cambiando, i suoi effetti sono evidenti e le responsabilità delle attività umane sono innegabili. Internazionale online, 11 settembre 2017 (p.d.)
A Fiorenzuola d’Arda, un piccolo comune a sudest di Piacenza, Franco Varani si china per vedere come stanno le piante di pomodoro che occupano la maggior parte degli 80 ettari dell’azienda agricola di famiglia. Dopo aver staccato un frutto, me lo mostra indicandomi la parte inferiore, annerita e secca. “Succede quando la pianta non riceve acqua a sufficienza”, mi spiega. È una mattinata afosa di metà luglio, ci sono già più di 30 gradi e l’aria è appiccicosa. Una strada taglia in due i campi di Varani. Le piante di pomodori formano lunghe file simmetriche e non sembrano passarsela bene: nonostante manchino ancora due settimane alla raccolta, molte stanno già appassendo e gran parte del raccolto andrà perduto. Le terre di Varani confinano con quelle di altri coltivatori. E anche nelle loro, sotto il sole cocente, molte piante stanno morendo. La causa è una delle peggiori siccità degli ultimi decenni, che nei mesi scorsi ha investito l’Italia e che secondo Coldiretti ha fatto perdere più di due miliardi al settore agricolo nazionale.
Anche se ha riguardato l’intero paese, costringendo sindaci e governatori a dichiarare lo stato d’emergenza, alcune zone ne hanno risentito di più. La pianura padana, dove si concentra il 35 per cento della produzione agricola nazionale e dove si produce circa il 40 per cento del pil italiano, è una di queste: la sua principale riserva d’acqua, il bacino idrico del Po, si è ridotta drasticamente proprio nei mesi in cui c’era più bisogno di irrigare i campi. “L’acqua da queste parti non è mai stata un problema, ora invece dobbiamo scegliere quali coltivazioni innaffiare e quali lasciare al loro destino,” dice Varani. Come molte altre aziende della zona tra Piacenza e Parma, anche la sua ha dovuto fare i conti con disponibilità di acqua inferiori rispetto al passato. “Su circa 60 ettari coltivati a pomodoro, siamo riusciti a irrigarne 13. Poi l’acqua è finita”, dice.
La struttura che fornisce a Varani l’acqua per i suoi campi, ovvero la diga di Mignano – una piccola chiusa costruita su un affluente del Po – a giugno è stata chiusa, mettendo in difficoltà molti agricoltori. È la prima volta che accade in ottant’anni. “Non avevo mai visto niente di simile in tutta la mia vita e nemmeno credevo fosse possibile”, aggiunge Varani. “Abbiamo vissuto momenti di crisi anche in passato, ma siamo sempre riusciti a cavarcela. Questa volta però è diverso, non so proprio come faremo ad andare avanti”, conclude.
Campane a morto
Il Po è il più lungo dei fiumi italiani, a volerlo seguire per intero si percorrerebbero 652 chilometri. Alimentato da 141 affluenti, il suo bacino idrico attraversa sette regioni, tocca più di 3.200 comuni e copre un’area di circa 71mila chilometri quadrati. Le sue acque sono un elemento centrale della pianura padana e hanno dato vita a storie e leggende in cui non a caso viene chiamato Grande fiume. Osservarlo da vicino, vedere l’acqua fluire normalmente in alcuni punti e abbassarsi in altri, quasi a diventare un ricordo di giorni più fortunati, aiuta a capire gli effetti della siccità su un pezzo consistente del nostro paese.
Per ragioni geografiche e climatiche, i periodi di secca sono ricorrenti nell’area. Negli ultimi vent’anni, episodi di siccità ci sono stati nel 2003, nel 2007 e nel 2012. Ma l’estate del 2017 sarà ricordata come una delle più calde e meno piovose della storia recente in Italia. Me lo conferma il Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr), secondo cui durante i mesi estivi sono state registrate temperature al di sopra della media rispetto al trentennio di riferimento 1970-2000.
I periodi di siccità sono diventati sempre più numerosi, così come le piogge torrenziali che colpiscono il nostro paese. “Il clima sta già cambiando e aumentano i fenomeni meteorologici estremi”, denuncia Legambiente. “Dal 2013 al 2016 ben 18 regioni sono state colpite da 102 eventi estremi che hanno provocato alluvioni o fenomeni franosi”, si legge nel rapporto Le città alla sfida del clima. Per quanto possano sembrare distanti, per quanto possa sembrare che si neghino a vicenda, questi eventi sono collegati all’irruzione sulla scena di un unico fattore, e cioè il cambiamento climatico. Tuttavia, ogni volta che si pronunciano queste due parole, si alzano i sopraccigli degli scettici. A molte persone sembra di muoversi in un terreno sconosciuto, lontano, quasi fantascientifico. Ma per vederne gli effetti, basta spostarsi da Fiorenzuola d’Arda a Volpedo, in provincia di Alessandria.
Nel cuore della val Curone, a circa 200 chilometri dalla sorgente del Po, alberi da frutto si inerpicano sulle colline che circondano il paese. Gianpiero Chiapparoli, responsabile della cooperativa Volpedo, mi spiega che qui questo tipo di coltivazioni si è diffuso tra le due guerre mondiali proprio grazie al fatto che fosse un territorio ricco d’acqua. Molte famiglie vivono ancora di questo, ma tante cose sono cambiate rispetto al passato e la situazione per alcuni è drammatica. Gran parte delle mele, delle ciliegie, delle albicocche e delle susine hanno subìto danni ingenti, così come il 70 per cento delle pesche di Volpedo, uno dei frutti più pregiati della zona. L’emergenza ha spinto l’amministrazione comunale ad annullare la festa tradizionale di fine luglio e a far suonare le campane a morto in segno di protesta. “Per quel che riguarda le pesche, parliamo di 800mila euro di fatturato in meno rispetto all’anno scorso”, dice Chiapparoli. “Nel complesso, il fatturato della cooperativa Volpedo passa da tre milioni di euro nel 2016 a 1,3 nel 2017”.
E la situazione non è migliore nella zona del delta del Po. Nell’area del Polesine i raccolti di mais e soia si sono dimezzati, impedendo anche la produzione di foraggio per il bestiame. Mentre nella provincia di Venezia il basso livello delle falde ha favorito l’infiltrazione dell’Adriatico lungo le foci dei fiumi in secca. Il fenomeno prende il nome di cuneo salino ed è uno dei problemi che fa più paura agli studiosi. “Nel delta del Po si verificava già negli anni cinquanta, ma la risalita non andava oltre tre chilometri dalla foce”, spiega Alessio Picarelli, dirigente dell’autorità di bacino del fiume Po. “Mentre oggi è stata rilevata a più di 20 chilometri dal mare. I motivi sono tanti, dall’abbassamento del canale di scorrimento del fiume per il continuo prelievo di sabbia e pietrisco agli stati di magra del Po, un fenomeno in netto aumento a causa del cambiamento climatico”, aggiunge Picarelli. Nelle campagne del litorale veneto il cuneo salino ha reso inutilizzabile l’acqua per irrigare e ha così causato danni ingenti agli agricoltori, facendo registrare quasi il 30 per cento di raccolto in meno rispetto al 2016.
L’influenza umana
I numeri delle aziende e i racconti degli agricoltori fanno pensare che il cambiamento climatico ci riguardi molto più di quanto crediamo e che la situazione sia più grave di quanto si immagini. L’aumento della temperatura media globale nel 2012 è stato di 0,85 gradi rispetto al livello preindustriale, spiega un rapporto delle Nazione Unite. L’Italia non fa eccezione, anzi. Nel 2015 la temperatura è aumentata di 1,58 gradi rispetto alla media annuale. “Il valore più elevato dal 1961”, si legge nello studio dell’Istituto superiore per la protezione ambientale (Ispra).
Nel caso della pianura padana, l’analisi dell’agenzia regionale per la protezione ambientale dell’Emilia-Romagna (Arpae) conferma i dati delle Nazioni Unite e dell’Ispra: “Dal 1960 a oggi sul bacino del Po si osserva un aumento delle temperature medie annue di circa due gradi, che potrebbero arrivare a tre o quattro alla fine del secolo”. Al tempo stesso, rispetto a trent’anni fa le precipitazioni medie annue sono diminuite del 20 per cento. Secondo uno studio del Centro euro-mediterraneo sui cambiamenti climatici(Cmcc), il cambiamento climatico ha giocato un ruolo determinante nel ridurre le riserve idriche del bacino. La situazione è evidente grazie ai dati raccolti dalla stazione di Pontelagoscuro, in provincia di Ferrara.
“I numeri ci dicono che più ci si avvicina al presente, più le temperature aumentano e più le precipitazioni diminuiscono”, dice Paola Mercogliano, una delle autrici dello studio del Cmcc. “La combinazione tra questi due fattori influisce sulla disponibilità idrica in diversi modi. Il ciclo idrologico alterato provoca uno scioglimento anticipato dei nevai e le stagioni di coltivazione diventano più lunghe, facendo così crescere la domanda d’acqua e i prelievi: è un circolo vizioso”, spiega Mercogliano.
A Pontelagoscuro i rilevamenti sono effettuati in corrispondenza di un ponte ferroviario dei primi del novecento, una struttura che collega le due sponde del fiume lungo la linea Bologna-Ferrara. Nella banchina sono ormeggiate alcune chiatte per la ghiaia e un rimorchiatore. Lungo il bacino del Po c’è una rete navigabile di oltre 900 chilometri, che serve una manciata di porti commerciali e alcuni attracchi industriali privati. Ogni giorno gli operatori ricevono un’email dall’agenzia interregionale per il fiume Po (Aipo) con gli aggiornamenti sui livelli del fiume. “Lo scorso marzo, qui il livello segnava -4,9 metri, lo stesso che di norma si registra ad agosto e due metri in meno rispetto allo stesso periodo del 2016”, mi dice Dario Barborini, che da più di vent’anni lavora come manovratore sulle chiatte. “Io qui ci sono nato e non ricordo nulla del genere”. Secondo lo studio del Cmcc, la situazione è destinata ad aggravarsi. “Abbiamo simulato lo scenario nel periodo tra il 2021 e il 2050. Nella valle del Po le temperature continueranno ad aumentare e le piogge saranno sempre meno, la portata del fiume si ridurrà in estate e gli eventi di magra saranno più frequenti e severi”, dice Mercogliano.
Verso nord
Carlo Cacciamani, responsabile del servizio idrometeorologico dell’Arpae, mi spiega a cosa ci dovremmo abituare nei prossimi anni: “È probabile che l’aumento delle temperature comprometterà i raccolti sia in termini di quantità sia di qualità, mentre la richiesta d’acqua sarà sempre maggiore. Inoltre, il clima dell’Europa meridionale diventerà sempre più tropicale, e animali e coltivazioni saranno costretti a spostarsi verso nord e verso altitudini più elevate. Quelle di ulivo sono arrivate a ridosso delle Alpi, per dire”.
Il cambiamento riguarderà anche i cicli stagionali, che saranno meno definiti di un tempo. “Le coltivazioni potranno essere esposte a rischi che prima non correvano, come quello di gelate tardive”, conclude Cacciamani. Gli esperti temono inoltre che non sarà possibile garantire le stesse quantità d’acqua usate oggi per irrigare i campi. Ogni anno vengono estratti dal bacino del Po circa 20,5 miliardi di metri cubi d’acqua. Gran parte – 16,5 miliardi di metri cubi – è destinata al settore agricolo. “Il cambiamento climatico ridurrà la disponibilità di acque superficiali, la ricarica delle falde sarà inferiore rispetto a oggi e i livelli si abbasseranno, causando una riduzione delle risorse idriche”, dice Alessio Picarelli dell’autorità di bacino del fiume Po.
Adattamento e pianificazione
Viene da chiedersi cosa si possa fare di fronte a queste previsioni. Quali provvedimenti si debbano prendere per salvare il paesaggio stupefacente che rapisce chi si addentra nell’area del delta. Qui, sotto il sole impietoso di questa estate caldissima, le ramificazioni del fiume sembrano infinite, qua e là si intravedono golene secche e polverose, mentre sullo sfondo antichi casolari si fanno spazio tra dune fossili e pioppi bianchi. Navigando tra il verde e il blu delle lagune non è raro imbattersi in gabbiani reali e aironi rossi, così come negli operai delle aziende specializzate nell’acquacoltura, anch’esse in difficoltà. Cosa ne sarà di tutto questo?
Le strade per affrontare la situazione sono due: quella della mitigazione e quella dell’adattamento. La prima riguarda l’adozione di politiche per ridurre le emissioni di gas serra ed è fondamentale nel caso della pianura padana, visto che nella valle del Po si respira l’aria peggiore di tutta l’Europa occidentale, dice l’Organizzazione mondiale della sanità. “Intanto, si potrebbe applicare una rotazione delle colture, così da aumentare o almeno mantenere la fertilità dei terreni”, dice Silvano Pecora, responsabile del servizio idrologia dell’Arpa dell´Emilia-Romagna e vicepresidente dell’Organizzazione mondiale per la meteorologia. Per quanto riguarda l’adattamento alle mutazioni del clima, Pecora è convinto che “bisognerà produrre alimenti in modo più efficiente, adottare nuovi combustibili biologici, usare tecniche di irrigazione che consentano un maggiore risparmio idrico, scegliere materiale genetico più adatto alle nuove condizioni climatiche e colture che abbiano bisogno di meno acqua”.
I costi per tradurre tutto questo in realtà sono trascurabili rispetto a quelli da sostenere se non si fa niente, ma gli ostacoli per farlo sono molti. Il primo è di ordine burocratico. Il Po è stretto tra un’intricata rete di norme e un numero indefinito di consorzi, agenzie, autorità e commissioni. Un sistema così complesso che “diventa quasi impossibile applicare certe misure di adattamento”, dice Pecora.
Un problema di comunicazione
Il secondo ostacolo riguarda la comunicazione. “Comunicare i cambiamenti climatici non è facile. Sono argomenti complessi, basati su dati scientifici non sempre di immediata comprensione, descritti il più delle volte con grafici e tabelle”, mi dice Luca Mercalli, presidente della società di meteorologia italiana. “Non c’è preoccupazione o negazionismo, c’è piuttosto un clima di indifferenza”, spiega. “L’informazione non manca. Quello che manca è invece una discussione costante che aiuti a comprendere quali saranno le conseguenze nel breve e nel lungo periodo”. I problemi, secondo Mercalli, sono due. “Da una parte, gli intellettuali che hanno deciso di spendersi per la causa sono pochi; dall’altra, manca una visione politica autorevole in grado di trasformare iniziative singole in azioni collettive”. La conclusione è amara: “Allo stato attuale, diventa difficile far passare il concetto che l’impatto del cambiamento climatico è una questione ineludibile”.
Il romanziere Guido Conti ha scritto che il fiume che “passa per Torino e accarezza il parco del Valentino è diverso da quello dell’Oltrepò pavese e da quello che comincia a Piacenza, e non è lo stesso che solca la pianura fino a Mantova; da Ferrara al delta, il fiume cambia di nuovo aprendosi come un fiore di canali verso il mare”. Ha ragione a dire che il Po ha mille facce, mille colori, mille forme. Purtroppo, ad accomunarle oggi è l’ombra del cambiamento climatico sulle sue acque, la minaccia che venga recisa una delle arterie principali di questo paese.
Da sapere
L’accordo di Parigi. Il testo è stato
approvato il 12 dicembre 2015. Alla conferenza che si era tenuta a Copenaghen nel 2009, l’obiettivo era di limitare l’aumento della temperatura globale rispetto ai valori dell’era preindustriale. L’accordo di Parigi stabilisce che questo rialzo va contenuto “ben al di sotto dei 2 gradi”, sforzandosi di fermarsi a 1,5 gradi.
Ecosistemi a rischio. Uno
studio pubblicato su Nature ha analizzato gli effetti della siccità e i tempi di recupero degli ecosistemi. Nelle aree più vulnerabili la vegetazione può impiegare anni per riprendersi e diventa più esposta a malattie e incendi. L’aumento della frequenza dei periodi secchi previsto per i prossimi anni potrebbe portare molti ecosistemi al collasso.
Le ricadute sulla salute. Secondo
un rapporto del Medical society consortium bambini, anziani, persone con malattie croniche, quelle con un reddito basso e le donne in gravidanza risentiranno del cambiamento climatico più di altre.
«Viviamo in un mondo in cui i poteri al governo si sono mostrati ben disposti a sfruttare le crisi per portare avanti le proprie politiche più regressive, che ci spingono lungo la strada di un “apartheid climatico”». comune-info.net, 10 settembre 2017 (p.d.)
È giunto il momento di parlare del cambiamento climatico che rende disastri come Harvey catastrofi umane. In tv dicono che questo tipo di precipitazioni non ha precedenti. Che nessuno l’avesse previsto, e come quindi nessuno potesse prepararsi adeguatamente. Quel che non sentirete è il motivo per cui eventi climatici del genere stiano avvenendo con tale regolarità. Ci è stato detto che non si vuole “politicizzare” una tragedia umana, il che è comprensibile. Ma ogni volta che fingono che un disastro meteo sia una punizione divina, i giornalisti prendono una decisione altamente politica. Si vuole evitare controversie e non dire una scomoda verità. Perché la verità è che questi eventi sono stati previsti da tempo dagli scienziati del clima. Oceani più caldi provocano tempeste più forti. Livelli del mare più alti significa che le tempeste si riversano in luoghi mai raggiunti prima. Temperature più alte portano a precipitazioni estreme: lunghi periodi secchi interrotti da precipitazioni di neve o pioggia. Il tempo non si comporta più come una volta.
I record che vengono rotti anno dopo anno – per siccità, ondate di tempesta, incendi o caldo – stanno accadendo perché il pianeta è notevolmente più caldo di quanto non lo fosse all’inizio delle registrazioni. Coprire eventi come Harvey ignorando questi fatti, senza dare spazio agli scienziati del clima che li rendono chiari e non citando mai la decisione di Trump di ritirarsi dagli accordi climatici di Parigi, fallisce nel dovere fondamentale del giornalismo: fornire dati contestualizzati. Lascia al pubblico la falsa idea che questi disastri non abbiano cause e che non si possa far nulla per prevenirli. Vale anche la pena notare che la copertura su Harvey è stata altamente politicizzata fin da molto tempo prima che la tempesta toccasse terra. Ci sono state discussioni infinite su se Trump la stesse prendendo seriamente e su se questo uragano sarà il suo “momento Katrina”. Ovviamente si ignora convenientemente che mettere gli interessi delle società di combustibili fossili davanti alla necessità di un controllo dell’inquinamento sia una cosa decisamente bipartisan.
In un mondo ideale, tutti saremmo in grado di mettere in pausa le discussioni politiche fino a fine emergenza. Poi, quando tutti fossero al sicuro, avremmo un lungo dibattito sulle implicazioni. Cosa significa per il tipo di infrastrutture che costruiamo? Cosa significa per il tipo di energia su cui ci basiamo? (una domanda con nocive implicazioni per l’industria dominante nella regione colpita, quella di petrolio e gas). E l’iper-vulnerabilità alla tempesta di malati, poveri ed anziani cosa ci dice del tipo di reti di sicurezza che dobbiamo tessere, dato il sentiero traballante che abbiamo già intrapreso? Con migliaia di sfollati, potremmo anche discutere dei legami tra disgrazie climatiche e migrazione – dal Sahel al Messico – premettendo che gli Usa ne sono una delle cause. Ma non viviamo in un mondo che permette un dibattito del genere. Viviamo in un mondo in cui i poteri al governo si sono mostrati ben disposti a sfruttare le crisi per portare avanti le proprie politiche più regressive, che ci spingono lungo la strada di un “apartheid climatico”. L’abbiamo visto dopo l’uragano Katrina, quando i repubblicani non persero tempo per privatizzare il sistema scolastico, indebolire le leggi su lavoro e fiscalità, aumentare la perforazione e la raffinazione di petrolio e gas, e lasciare la porta aperta a società mercenarie come Blackwater. Mike Pence fu un architetto chiave di quel cinico progetto, e non dovremmo aspettarci niente di diverso nel dopo Harvey, ora che lui e Trump sono al comando.
Il presidente sta già usando la distrazione dell’uragano per perdonare Joe Arpaio e per militarizzare ulteriormente le forze di polizia. Sono movimenti particolarmente minacciosi, dato che controlli dell’immigrazione continuano ad operare ovunque le autostrade non siano inondate (grosso disincentivo all’evacuazione dei migranti) e che i funzionari municipali parlano di sanzioni massime per i “saccheggiatori” (vale la pena ricordare che dopo Katrina, diversi residenti afroamericani di New Orleans vennero sparati dalla polizia in mezzo a questo tipo di retorica). In breve, la destra non sprecherà tempo per sfruttare Harvey e qualsiasi altro disastro simile, per spacciare false soluzioni, come militarizzare la polizia, creare più infrastrutture di petrolio e gas e privatizzare i servizi. Le persone informate devono citare le reali cause di questa crisi – collegando i punti tra inquinamento climatico, razzismo sistemico, insuccesso dei servizi sociali ed eccesso di fondi per la polizia. Dobbiamo anche cogliere il momento per mettere a punto soluzioni su più livelli, che riducano notevolmente le emissioni nonché tutte le forme di disuguaglianza ed ingiustizia (qualcosa che abbiamo cercato di mettere nel Leap Manifesto e che gruppi come il Climate Justice Alliance propongono da tempo). E deve accadere proprio ora, proprio quando gli enormi costi umani ed economici dell’inazione sono evidenti a tutti. Se non ci riusciamo o se esitiamo, lasciamo la porta aperta ad attori spietati che sfrutteranno questo disastro per scopi personali.
La finestra per avere questi dibattiti è estremamente piccola. Non ci sarà alcun tipo di dibattito dopo che questa emergenza sarà cessata; i media torneranno a coprire ossessivamente i
tweet di Trump ed altri intrighi di palazzo. Perciò, anche se potrebbe sembrare inutile parlare di cause mentre la gente è ancora intrappolata nelle proprie case, questo è realisticamente l’unico momento in cui i media hanno interesse a parlare di cambiamento climatico. Vale la pena ricordare che la decisione di Trump di ritirarsi dall’accordo sul clima di Parigi – un evento che avrà effetti a livello mondiale per i decenni a venire – ha ricevuto due giorni circa di copertura dignitosa. Poi si è tornati a parlare di Russia tutto il giorno. Poco più di un anno fa, Fort McMurray, la città nel cuore del boom di Alberta per le sabbie bituminose, è quasi bruciata totalmente (leggi
L’inferno di Fort Mc Murray). Per un certo tempo, il mondo è stato inondato dalle immagini dei veicoli allineati su un’unica autostrada, circondati dalle fiamme su ambo i lati. Al tempo, ci venne detto che era insensibile parlare di come il cambiamento climatico stesse aggravando incendi come quello. Era tabù connettere il riscaldamento globale all’attività economica che tiene in piedi Fort McMurray e che impiegava la maggioranza degli sfollati, cioè una forma particolarmente carbonica di petrolio. Il tempo non era quello adatto; era un momento di compassione, aiuto e zero domande.
Ma, naturalmente, nel momento in cui veniva ritenuto opportuno sollevare tali questioni, i riflettori dei media erano da tempo passati ad altro. Oggi, mentre Alberta spinge per almeno tre nuovi oleodotti per aumentare notevolmente la produzione di sabbie bituminose, non si è imparato nulla da quella storia. C’è una lezione invece per Houston. La finestra per avere una discussione importante è piccola. Non possiamo permetterci di gettarla al vento. Parlare onestamente di ciò che sta alimentando questa epoca di disastri non è una mancanza di rispetto per le vittime. Anzi, è l’unico modo per onorare veramente le loro perdite, e la nostra ultima speranza per impedire un futuro pieno di innumerevoli altri morti.