


Il significato profondo del lavoro risiede nella volontà di conservare e riprodurre dei valori, che non sono solo rapporti e relazioni spaziali, né sono solo rapporti o relazioni sociali, ma sono invece relazioni spaziali-temporali che mettono in rapporto natura storia e società.
L'invariante strutturale è in primo luogo il rapporto fra gruppi sociali e territori, nella sua articolazione storica. La tesi è che non ci si possa limitare agli oggetti situati nello spazio e alle relazioni spaziali ma si debbano indagare anche le relazioni ed i processi sociali che formano quelle strutture spaziali.
Non si tratta di privilegiare le relazioni sociali rispetto alla materialità del territorio ma di considerarle entrambe e quindi allargare l’orizzonte dell’analisi su due fronti: considerare accanto allo spazio assoluto quello relativo e relazionale, e assumere nell’analisi la contemporanea presenza di relazioni sociali e strutture spaziali.
Per capire le strutture spaziali è necessario conoscere il processo di urbanizzazione e quindi le relazioni sociali spaziali e temporali che lo producono. Contemporaneamente indicare come invariante strutturale un elemento sociale o culturale o economico avulso dalle sue caratteristiche spaziali cioè senza capirne e mostrane gli effetti spaziali è altrettanto problematico. L’aggancio spaziale è necessario, si tratta di due elementi, spazio e relazioni sociali, che è necessario trattare insieme, se si vuole governare il territorio.
Se dobbiamo governare il territorio dobbiamo agire sui meccanismi e sui processi che lo producono: quelli locali e quelli sovra locali, quelli materiali e quelli immateriali. Infatti la produzione del territorio non deriva solo dagli aspetti materiali, ma anche da quelli immateriali. E al centro spicca il valore delle aree, immateriale ma oggettivo, che è determinante per la sua influenza sul processo di urbanizzazione.
Gli elementi immateriali come la memoria o i valori d’uso e di scambio, non possono certo essere localizzati sul territorio al pari di una funzione, eppure giocano un ruolo fondamentale nella trasformazione territoriale e nel processo di urbanizzazione.
Le invarianti strutturali sono le strutture, contemporaneamente sociali e spaziotemporali, costitutive e relazionali che danno forma ad un territorio e ne segnano identità, qualità e riconoscibilità. Ogni invariante strutturale è caratterizzata da una propria struttura, organizzazione e funzionamento ed è prodotta dalle interazioni fra natura / storia / società. È definita dalle relazioni interne e dalle relazioni con l’esterno.
Si possono individuare tre componenti dell’invariante strutturale. La prima è la componente materiale. Comprende le conformazioni e le configurazioni territoriali; le caratteristiche fisiche ed ecologiche, i caratteri lito-idro-geo-morfologici, ecosistemici, le strutture insediative e infrastrutturali, i sistemi agroforestali, la presenza di beni comuni; le caratteristiche qualitative e gli elementi fondanti. Sono alcuni degli aspetti studiati dalla geografia, geologia, fisiografia. Concettualmente è lo spazio assoluto (Harvey 2006), in cui si situano gli oggetti materiali, gli eventi e le pratiche. È quello dove si trovano muri, ponti, porte, scale, strade, edifici, città, montagne, bacini idrografici, confini fisici e barriere ma anche le attività lavorative e di trasformazione.
La seconda componente riguarda i processi sociali, economici e naturali nel loro specifico intreccio: essi conformano i funzionamenti e l’organizzazione dell’invariante strutturale, le relazioni interne e con l’esterno; esprimono e pongono le condizioni (regole) generative e di riproduzione; sono retti dagli attori sociali attivi nella loro produzione. In base a queste modalità di funzionamento (spazio-temporale e sociale) dovranno essere definite le regole di manutenzione, d’uso e di trasformazione che ne consentono la riproduzione. Concettualmente è lo spazio relativo, quello della frizione della distanza, della circolazione e del flusso dell’energia, dell’acqua, dell’aria, delle merci, delle persone, dell’informazione, dei soldi, del capitale.
Una terza riguarda le componenti immateriali: è lo spazio relazionale, quello della memoria, della cultura e dei valori attribuiti dalla popolazione colta nelle sue differenti espressioni.Concettualmente è lo spazio relazionale, quello delle relazioni sociali, in cui le persone sono presenti nella loro pienezza, è lo spazio vissuto, ma è anche lo spazio del valore, immateriale ma oggettivo, e quindi dei differenziali di valore immobiliare che generano processi di valorizzazione e tanto peso hanno sulle trasformazioni territoriali.
Queste tre componenti rimandano ai tre concetti di spazio: assoluto, relativo e relazionale (Harvey 2006). Si tratta di strutture della spazialità che sono sempre presenti anche se pratiche sociali differenti assegnano un peso differenziato ad ognuna di esse. La semplificazione più deleteria nell’interpretare il territorio e nell’identificare le invarianti strutturali è dare preminenza ad una sola delle componenti invece che alla loro strutturante compresenza.
Ne consegue che le regole di insediamento e di trasformazione del territorio per le invarianti strutturali dovranno contemporaneamente: garantire la riproduzione degli aspetti materiali a cui si è riconosciuto carattere strutturale; preservare l’organizzazione e il funzionamento; infine dovranno gestire e governare i valori in gioco, sia quelli sociali che quelli economici. In altri termini le regole di utilizzazione e di trasformazione dovranno governare la trasformazione territoriale che riguarda questi valori.
E proprio dai valori immateriali è necessario prendere le mosse: i valori immobiliari e i valori attribuiti dalla popolazione compresa la questione della memoria, dell’attribuzione di senso e dell’identità. È essenziale la conoscenza del mercato immobiliare e di come i suoi valori si sono costituiti nel rapporto fra mercato e governo pubblico del territorio.
Un secondo passo è conoscere come questi valori e queste memorie si esprimono nel processo di urbanizzazione e trasformazione territoriale in corso, in modo tale da sapere su quali processi bisogna agire per permettere ai valori individuati come invarianti di riprodursi e quali regole di funzionamento socio-spaziali devono essere attivate.
Infine bisogna guardare alle strutture spazio-temporali che si sedimentano sul territorioindicando quali di loro devono essere preservate perché racchiudono il senso e il valore di quel territorio e perché possono essere considerate perni su cui ruota il funzionamento di quel territorio.
Le regole di trasformazione e di funzionamento debbono vertere su tutti e tre gli aspetti dell’invariante strutturale. Il maggior limite nella definizione delle invarianti strutturali nei piani ai vari livelli è stato di relegarle nel materiale, dimenticando l’immateriale, come se tutto fosse forma ed immagine e non anche contenuto.
Harvey D. (2006), Spaces of global capitalism, Verso, London - New York.
Il libro Invarianti strutturali nel governo del territorio è scaricabile gratuitamente dal sito dell'editore Firenze University Press:
«
Il progetto costituzionale dell’uguaglianza, un libro a cura di Chiara Giorgi, per Ediesse. Come la crisi ha eroso la democrazia e i diritti sociali». Il manifesto, 9 aprile 2015
Nell’età del capitalismo trionfante, segnata dalla retorica del merito e dalle virtù della competizione, le ragioni dell’eguaglianza sembrano non avere più ragione di esistere. Eppure tutti noi sappiamo che una democrazia non può vivere senza eguaglianza e che lo stesso costituzionalismo rischierebbe fatalmente di deperire semmai dovesse rinunciare ad affermare le ragioni dell’égaliberté, come definita da Etiénne Balibar in un suo recente volume. Di qui, il bisogno di rilanciare nell’immediato «il progetto costituzionale dell’uguaglianza».
È questo l’appassionato appello contenuto nel volume collettaneo, curato da Chiara Giorgi, docente di Storia delle Istituzioni politiche all’Università di Genova (Il progetto costituzionale dell’uguaglianza, prefazione di Stefano Rodotà, Ediesse, euro 13). Un appello divenuto tanto più urgente quanto più la crisi economica tende drammaticamente ad abbattersi su vaste aree della società cancellando, giorno dopo giorno, diritti, garanzie sociali, lavoro.
Siamo in presenza di una drammatica e irrisolta estensione delle aree del disagio sociale che ha, in questi anni, determinato un’inedita e dilaniante «esplosione delle diseguaglianze» (così come definita da Laura Pennacchi). Eppure la povertà — avverte Enrico Pugliese – continua ad essere la grande «questione rimossa». Né vi è da sorprendersi: ci troviamo a vivere una fase storica che ha fatto della competizione il motore dell’organizzazione sociale e del mercato il modello etico sul quale costruire le relazioni umane.
Una vera e propria offensiva politica e culturale che ha le sue origini agli inizi degli anni Ottanta quando, in nome del dogma liberista, si diede vita (con gli esecutivi Thatcher e Reagan) a una nuova fase del governo dell’Occidente. È da questa svolta neoconservatrice, teorizzata sin dagli anni Settanta dalla Trilateral, che trarrà forza quel lento (ma pervasivo) processo di dissoluzione del costituzionalismo democratico che rischia di oggi di consumarsi sotto nostri occhi. Bersaglio privilegiato di questa offensiva sarà, non a caso, l’idea costituzionale di eguaglianza e la convinzione, ad essa sottesa, che «senza eguaglianza la libertà si chiama privilegio».
Di qui l’esigenza — espressa con toni marxiani da Gaetano Azzariti — di riprendere «la lotta rivoluzionaria per l’uguaglianza di ognuno come condizione necessaria per il libero sviluppo di tutti», coinvolgendo in questo movimento storico non solo i cittadini, ma anche i migranti. Per il costituzionalista Azzariti, l’eguaglianza — per inverarsi nuovamente nella storia — ha pertanto bisogno di tornare ad essere il terreno prioritario di azione di tutti gli esclusi, gli stranieri, i discriminati per sesso, razza, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni personali e sociali. Sono questi, d’altronde, i soggetti a cui si rivolge l’art. 3 della Costituzione repubblicana: il «capolavoro istituzionale» di Lelio Basso.
Ed è proprio all’impegno costituente di Basso e al suo «capolavoro» che Chiara Giorgi dedica il suo saggio, disvelandone accuratamente, pagina dopo pagina, genesi e sviluppi di questa norma-principio. Norma dalla quale trarranno consistenza, a partire dalla fine degli anni sessanta, non solo i diritti sociali, ma più in generale, i processi di costruzione dello Stato democratico-sociale (sulla «portata rivoluzionaria del principio dello Stato sociale», con particolare riferimento alla Legge fondamentale tedesca, il volume contiene un interessante contributo di Erhard Denninger).
Ma il tentativo di coniugare libertà ed eguaglianza, diritti e democrazia è espressione di un’asfittica (in quanto di matrice esclusivamente occidentale) e oramai decadente pretesa del costituzionalismo o può tornare, anche nel mondo globalizzato, ad assumere pregnanza politica e legittimità culturale? Quale è la forza propulsiva di cui dispone oggi il «progetto costituzionale dell’uguaglianza» in Europa e nel resto del mondo?
A queste tematiche il libro dedica la sua parte centrale, ospitando un «confronto tra le esperienze costituzionali dell’Unione europea e dell’America Latina»: dalla vicenda costituzionale brasiliana, ricostruita da Marcelo Cattoni a partire dall’art. 3 della Carta che affida alla Repubblica federale il compito di «sradicare la povertà e l’emarginazione e ridurre le diseguaglianze sociali e regionali», al caso argentino alle prese con la «mutazione antiegualitaria» e la «secessione degli ultraricchi» (ricostruito da Isidoro Cheresky).
Il volume contiene, altresì, due pregevoli saggi di Pietro Costa e di Luigi Ferrajoli. Costa, dopo aver ricostruito i traguardi storici del principio di eguaglianza, si confronta con le drammatiche conseguenze prodotte dalla crisi economica sui diritti sociali, sulla crescita delle diseguaglianze e, più in generale, sulla tenuta degli assetti costituzionali. Sulla stessa scia, si colloca anche il contributo di Luigi Ferrajoli che vede nel principio di eguaglianza sociale il connotato fondamentale del costituzionalismo, l’asse di contatto che ha sempre legato e «lega le tre classiche parole della Rivoluzione francese: liberté, égalité, fraternité, rivelandosi così, allo stesso tempo, presupposto dei diritti di libertà e fondamento del principio di fratellanza (inteso soprattutto come solidarietà sociale).
Il significato rivoluzionario del motto dell’89 francese è però progressivamente deperito nel corso degli anni. Anche perché queste parole sono state, nel tempo recente, surrettiziamente utilizzate l’una contro l’altra dalle politiche liberiste e dalla travolgente avanzata della cultura delle destre. Gli esiti sono sotto i nostri occhi: compressione degli spazi democratici di libertà, esplosione delle disuguaglianze e delle aree di povertà, rigurgiti antisolidaristici con forti connotati razzisti e neofascisti.
A fronte di tale contesto, spetta pertanto alla sinistra tentare di stabilire un nuovo terreno di connessione tra questi principi, rifondandone coerentemente le istanze, salvaguardandone i valori, modulandone gli obiettivi. Dal perseguimento del «progetto costituzionale dell’uguaglianza» dipende anche il suo futuro.
Da giovedì 9 a domenica 12 aprile, torna a Pistoia la rassegna Leggere la Città, organizzata dal Comune di Pistoia. Quest’anno ha per tema lo spazio pubblico. Interverranno, tra gli altri, Edoardo Salzano, Vezio De Lucia, Ilaria Boniburini, Paolo Maddalena, Antonietta Mazzette (segue qui)
Da giovedì 9 a domenica 12 aprile, torna aPistoia la rassegna Leggere la Citta’, promossa e organizzata dal Comune diPistoia. Quest’anno ha per tema Lo spazio pubblico.

E' uscita l'edizione cartacea di
Rottama Italia,
Edizioni Altreconomia, 44 pagine €12,00
Rottama Italia
Perché lo Sblocca-Italia è una minaccia per la democrazia e per il nostro futuro.
Testi di: Tomaso Montanari, Paolo Maddalena, Giovanni Losavio, Massimo Bray, Edoardo Salzano, Paolo Berdini, Vezio De Lucia, Salvatore Settis, Anna Donati, Maria Pia Guermandi, Pietro Dommarco, Domenico Finiguerra, Anna Maria Bianchi, Antonello Caporale, Carlo Petrini, Wu Ming, Luca Martinelli, Pietro Raitano
La Repubblica, 10 marzo 2015
«SONO arrivati. Sono sanguinari, sono selvaggi… Uccidere e massacrare è il loro divertimento». Tagliano teste, arrostiscono, cavano occhi, amputano mani, piedi, nasi. Sono d’oltremare. Ma non vengono dall’altra sponda del Mediterraneo. Vengono dal Nord. Non sono islamici. Anzi, sono il terrore dei musulmani. La ferocia è il loro biglietto da visita, ne fanno un deliberato uso mediatico.
Un loro capo militare, Ruggero (non l’assai più tardo Ruggero di Sicilia ma
Sono i normanni. Inutilmente Carlo Magno aveva proibito i commerci di armi con loro. Si erano specializzati nel ruolo di strumenti e cani dei potenti in lotta tra di loro. Si erano resi indispensabili. Un ramo si sarebbe impadronito della parte della Francia che si affaccia sulla Manica, poi di tutta l’Inghilterra, restando vassalli del Re di Francia. Un altro ramo era approdato da tempo in Sicilia. Poi, passando per la Puglia, erano arrivati in Campania, chiamati dai signori longobardi di Salerno e Capua, infine si erano insediati in un loro castello a Canossa. Controllavano le vie di comunicazione, non un territorio preciso e delimitato. Un po’ come l’Is a cavallo di Iraq, Siria e Libia. Si facevano chiamare marchesi ma non avevano nemmeno una marca. Eppure nel giro di pochi decenni avrebbero finito col dare origine dal nulla all’invenzione statuale di più lungo periodo della storia italiana sin dalla Repubblica romana, il regno dell’Italia meridionale.
È uno dei quadri, anzi delle “cerniere”, su cui fa perno l’ultimo lavoro di Glauco Maria Cantarella, il Manuale della fine del mondo, sottotitolo Il travaglio dell’Europa medievale , pubblicato da Einaudi. La “fine del mondo” temuta al volgere del primo millennio, a dire il vero non c’entra. Se ne discettava da molti secoli e ne riparlavano ogni volta che le cose sembravano andar peggio. Ma allora non esisteva nemmeno il concetto di secolo, che sarebbe stato inventato molto più tardi. Anche il “Medioevo” sarebbe stato inventato più tardi, solo nel ‘500. Oggi gli storici concordano nel considerarla «un’età né più buia né più luminosa di altre ». Semmai, leggendo questo libro, che segue gli innumerevoli altri che questo studioso gli ha dedicato, si potrebbe parlare di “Medioevo continuo”. Che ci evoca qualcosa del nostro presente. O forse addirittura del nostro futuro.
Non bisogna fraintendere. Cantarella, colonna degli studi di storia dell’Europa medievale e delle Istituzioni politiche medievali all’Università di Bologna, è uno storico serissimo, non gli si possono imputare “attualizzazioni” ad effetto, trasposizioni tirate, analogie superficiali. Semmai pignoleria quasi maniacale sulle “fonti” e sugli aggiornamenti continui nel campo di cui si occupa da moltissimi anni. In quell’epoca lui è di casa. Frequenta i protagonisti e ne conosce a menadito le complicate vicende, il modo di far politica, di ragionare, di giustificare, di far propaganda. Sbircia persino nelle loro camere da letto. Il suo “manuale” è una summa da grande specialista. Che però evoca anche nel lettore non specialista o per mestiere schiavo dell’attualità una gragnuola di suggestioni.
Il secolo di cui parla questo libro non è quello della fine del mondo, ma degli stratagemmi per non farlo finire. Dai Papi che si facevano notare solo per la “cieca cupidigia” (fagiano, oppure gallo veniva soprannominato Giovanni XVIII, boccadiporco Sergio IV) si passa a quelli che invece fanno politica per venire ad un nuovo modus vivendi con l’Imperatore e i nuovi regni in formazione e a nuovi ingegnosi compromessi sulle investiture, cioè le nomine dei vescovi, insomma a chi dovesse far capo chi incassava i tributi ed esercitava poteri di polizia, oggi diremmo le nomine tout court . Fu una riforma istituzionale infinitamente più complessa di quelle su cui si discute e si litiga oggi, che impegnò i migliori specialisti e per la quale, tra alti e bassi, rotture e ricomposizioni, colpi di scena e ripensamenti ci volle più di un secolo.
Era anche l’epoca in cui si affacciavano in scena veri e propri “professionisti del governo”. «Oggi forse li chiameremmo tecnici», nota Cantarella. Solo molto, ma molto più tardi sarebbero arrivati quelli che chiamiamo “politici”. Molti di questi “tecnici” erano di grande levatura. I Normanni, che pure avevano esordito come feroci mercenari e briganti, in Sicilia avevano messo in piedi una cancelleria coi fiocchi, in cui si governava in tre lingue, arabo, greco e latino, e si impiegavano non solo musulmani ma anche “tecnici” di valore internazionale importati dall’Inghilterra come Thomas Brown (o Le Brun). Erano stati loro a inventare lo “Scacchiere”, la tavola su cui si computavano, con procedimenti matematici d’avanguardia, rendite e cespiti delle baronie, e che ancora oggi dà il nome al ministero dell’economia britannico. Palermo quasi come Bruxelles. Ma forse non funzionava così bene, se poi il Mezzogiorno arrivò tanto disastrato all’Unità, come un agglomerato di feudi inespugnabili, impervio al senso dello Stato. Colpa degli Angioini, degli Aragonesi, degli Spagnoli e dei Borboni (e magari degli intoccabili Svevi)? O di troppa tecnica e poca politica?
Quanto alle città, apprendiamo che prosperano grazie alle loro turbolenze. «Comune, nome nuovo e pessimo», lamentano i cronisti dell’epoca. I cives hanno la mala consuetudo di ribellarsi ai loro vescovi (e quindi alla potestas imperiale, quindi alle prerogative del governo) negandogli le imposte, «l’affitto dei mulini e il censo solito delle navi e la rendita delle case», e tagliano i boschi e demoliscono «la città vecchia per costruirne una più grande». Pretendono persino che i contadini paghino i tributi a loro… Succede in Lombardia, ma anche in Francia, in Castiglia, in Renania… il disordine investe tutta l’Europa. Finché zona per zona, caso per caso, per fronteggiare l’emergenza, dovranno inventarsi nuovi compromessi istituzionali differenziati…
PIl manifesto, 25 febbrai 2015
Scisso tra le imposizioni europee e la dura concretezza dei fatti, il ministro dell’Economia Piercarlo Padoan proprio qualche giorno fa ha ammesso, in un’intervista all’Espresso, che ciò che finora non ha funzionato nel governo Renzi sono state le privatizzazioni. Difficile, nonostante l’ideologia dominante cerchi di far pensare il contrario, non rendersi conto che, nella situazione economica attuale, disfarsi di pezzi dello Stato voglia dire svenderli al miglior offerente. Lo stesso discorso vale per la Grecia di Tsipras, dove le pressioni più forti sono per proseguire il processo di alleggerimento del patrimonio pubblico, anche se per fortuna più nessuno propone di mettere all’asta il Partenone.
Ben vengano, allora, messe a punto giuridiche, innanzitutto, di una materia che attiene al diritto pubblico. Alberto Lucarelli, professore all’Università Federico II di Napoli, è uno studioso di quei beni, pubblici per appartenenza ma da non lasciare alla gestione statale, che vengono definiti “comuni”. Accorto a non sganciare mai la teoria dalla tecnica giuridica, di fronte all’esondare di definizioni che rischiano di annacquare definitivamente il potenziale antiprivatizzatore, e dunque antiliberista, dei beni comuni, lo studioso partenopeo ha sentito l’esigenza di perimetrare il campo d’azione, partendo dalla commissione Rodotà dalla quale tutto era cominciato, qualche anno fa. Lo ha fatto con un lungo articolo pubblicato sulla rivista on line Costituzionalismo (si può leggere integralmente su www.costi tuzionalismo.it), nel quale, affrontando la questione del demanio pubblico, ne fa un terreno d’azione della dottrina dei beni comuni.
Ferma restando la proprietà pubblica, dunque, cos’è che distingue un bene comune dagli altri? Lucarelli respinge la dottrina della “terza via”, né statale né privata, della proprietà di suddetti beni, ma è convinto che, piuttosto che la questione proprietaria, debba porsi quella della funzione: i beni comuni non sono gestiti dallo Stato ma neppure possono scadere nella logica della concessione, che sostanzialmente privatizza il bene. Ciò che è fondamentale è la loro funzione sociale, a beneficio di una comunità che non è quella delle «piccole patrie» ma è interpretata, con il filosofo Roberto Esposito, come «composta da soggetti attraversati da una differenza e legati dalla medesima urgenza di fruire del bene». Un legame funzionale, dunque, non escludente e neppure legato a un territorio, non proprietario ma inteso come «un dono nei confronti degli altri». È quest’ultimo aspetto, per Lucarelli, che apre le porte a una nuova funzione del diritto pubblico ed è il modo per superare una concezione dello Stato che, oggi che ci troviamo in pieno «ciclo del privato», per dirla con lo storico Paul Ginsborg, segna il passo.
Un lavoro prezioso, dunque, che definisce gli strumenti, teorici e concreti, per un’alternativa reale e li mette a disposizione delle Syriza e dei Podemos di casa nostra che intendano servirsene/l2:r
 "Questione abitativa e trasformazioni urbane": questo il sottotitolo del libro di Gaetano Lamanna, di cui pubblichiamo la prefazione: un libro che ragiona «sulla difficoltà di vivere e di abitare oggi, sviluppando con padronanza e con chiarezza (e con lingua asciutta, frasi brevi ed essenziali) i temi generali e quelli specifici».
"Questione abitativa e trasformazioni urbane": questo il sottotitolo del libro di Gaetano Lamanna, di cui pubblichiamo la prefazione: un libro che ragiona «sulla difficoltà di vivere e di abitare oggi, sviluppando con padronanza e con chiarezza (e con lingua asciutta, frasi brevi ed essenziali) i temi generali e quelli specifici».
L’area sempre più vasta del disagio abitativo in Italia è il tema che Gaetano Lamanna affronta con passione e competenza. La passione del sindacalista militante, la competenza di chi ha studiato e frequentato la materia. Non posso non ricordare che proprio sul tema della casa, e più in generale sulla condizione urbana, il sindacato diventò protagonista della vita pubblica alla fine degli anni Sessanta, contribuendo ad avviare «la più grande stagione di azione collettiva nella storia della Repubblica» (Paul Ginsborg). Tutto cominciò con lo sciopero generale del 3 luglio 1969, a Torino, dove il problema delle abitazioni era stato esasperato dalla decisione della Fiat di assumere quindicimila nuovi addetti da reclutare nel Mezzogiorno, il che avrebbe determinato un pesante aggravamento delle condizioni di vita. La Fiat propose addirittura di costruire baracche nei comuni di cintura e nelle fabbriche dismesse (tolto il letto e le suppellettili, restava uno spazio libero di un metro e sessantacinque centimetri quadrati per persona).
A mano a mano, il movimento si estese da Torino a tutta l’Italia. Per la prima volta, non solo le condizioni di lavoro, ma anche quelle di vita nella città, divennero il terreno di un forte scontro sociale che investì l’intero paese e culminò con il grande sciopero generale del 19 novembre 1969, per la casa e l’urbanistica. Nonostante la violenta reazione degli interessi colpiti (le bombe del 12 dicembre a Milano, le stragi e la strategia della tensione) si raggiunsero risultati importanti, a cominciare dalla nuova legge per la casa del 1971 che riorganizzò le forme, gli strumenti e le modalità dell’intervento pubblico in edilizia. A essa seguirono nel 1977 la legge sul regime dei suoli, l’anno successivo l’equo canone e il piano decennale per l’edilizia.
Parafrasando Giorgio Ruffolo, fu l’età dell’oro del compromesso socialdemocratico. Ma durò poco. Con gli anni Ottanta è cominciata la controriforma, e nel giro di pochi anni sono state cancellate una dopo l’altra le conquiste del ventennio precedente. Sono cadute la legge Bucalossi, le norme sugli espropri e quelle per il contenimento degli affitti, fino alla sostanziale dissoluzione dell’edilizia pubblica.
Ancora peggio con la crisi che dal 2008 continua a tormentare in primo luogo le classi sociali più sfavorite. Di questo soprattutto tratta il libro, della difficoltà di vivere e di abitare oggi, sviluppando con padronanza e con chiarezza (e con lingua asciutta, frasi brevi ed essenziali) i temi generali e quelli specifici, la fiscalità, la tassazione immobiliare, la sempre più pressante domanda inevasa, l’esclusione abitativa, il nodo mai risolto del contenimento della rendita. Lamanna ci spiega come nella politica della casa il valore d’uso (l’abitazione come tetto, spazio domestico) ha finito con l’essere sostituito dal valore di scambio (la casa come funzione finanziaria, come veicolo di risparmio). Non cade nella trappola del social housing all’italiana, “un bluff, o meglio un imbroglio”, business allo stato puro, i cui unici beneficiari sono i costruttori. E al riguardo non salva nessuno, denunciando «il ruolo primario, ma inefficace, delle Regioni».
Approfondisce in particolare l’analisi di una della più drammatiche condizioni abitative, quella degli anziani. Gli anziani soli, anzi le anziane, le vedove, più numerose per il minor tasso di mortalità delle donne. Analizza lucidamente le alternative di cui si discute: il ricovero, la soluzione residenziale, quella domiciliare, il cohousing (già oggetto di interesse di fondi immobiliari e di manovratori della rendita). Ma scrive che se togli un anziano dal suo spazio «lo vedrai deperire in pochi mesi, perdere la voglia di vivere». Sradicarli dal loro ambiente è una violenza. La via maestra è mantenere gli anziani nelle proprie case, senza cedere al fascino o al ricatto del nuovo che avanza.
Alla completezza dell’analisi settoriale fa da contrappeso l’attenzione con la quale Lamanna inquadra la politica della casa negli scenari più complessi ma non meno deprimenti delle politiche finanziarie e territoriali. “Rendita crescente, reddito calante” è il titolo di un capitolo che racconta della stretta correlazione fra declino dell’industria e sviluppo immobiliare. Una delle conseguenze del perverso intreccio fra mattone e finanza è stata l’immane valorizzazione delle aree urbane centrali, con l’espulsione dei residenti costretti a trasferirsi in periferie sempre più lontane, stressati dal traffico e dall’alienazione. Alla fine, l’urbanistica è stata obliterata, e anche da questo punto di vista destra e sinistra non sono riconoscibili. «Le amministrazioni locali – scrive Lamanna – hanno dovuto rincorrere i processi anziché programmarli. E i condoni edilizi a livello nazionale, le continue sanatorie a livello locale, tramite varianti, deroghe, cambi di destinazione d’uso degli immobili, sono stati rimedi peggiori del male». Ma di che meravigliarsi, nel 2005 non fu Piero Fassino, allora segretario dei democratici di sinistra, in un’intervista al Sole 24 ore, a riconoscere agli speculatori immobiliari il rango e la dignità di imprenditori?
Nel libro comanda il pessimismo, non si colgono orizzonti di cambiamento a portata di mano. Inutile illudersi e illudere che si possano facilmente riprendere linee di riforma, svolte e ripensamenti rispetto ai disastri dell’ultimo trentennio. Lamanna fa capire che per ricominciare la strada sarà lunga, faticosa, disseminata di insidie. Ma non viene meno al dovere di proporre istruzioni per il futuro. E ho specialmente apprezzato il suo schierarsi a favore di impostazioni alternative in materia di urbanistica, per il recupero e la fine delle espansioni, consapevole che il buongoverno urbanistico è la prima condizione per ridurre il disagio abitativo.
La Federal Reserve e la crisi finanziaria", il libro di Ben S. Bernanke, che ne è stato governatore in America negli anni caldi. Le iniezioni di liquidità non sono tutto e non abbattono l'instabilità del mercato». Il manifesto, 13 gennaio 2015
 «L'autore dialoga con l'ultimo libro di Stefano Rodotà, edito da Laterza,
«L'autore dialoga con l'ultimo libro di Stefano Rodotà, edito da Laterza,
Solidarietà, un'utopia necessaria. L'analisi di una parola apparentata a molte altre (naturalità, moralità, carità, assistenza, beneficenza, fraternità, doverosità, diritto, eguaglianza e gratuità, che la lambiscono, investono, assumono e la interpretano curvandola al loro spirito ed essenza. Il manifesto, 8 gennaio 2015
Col suo ultimo libro (Solidarietà, un’utopia necessaria, Laterza, pp.141, euro 14) Stefano Rodotà allarga il campo dell’impegno scientifico e politico nella lotta per i diritti che, da decenni, ha ingaggiato con tenacia ininterrotta e con successo non solo dottrinale. Lo amplia alle precondizioni, ai connettivi dei diritti e che ne sono forse anche i nuclei primigeni. A denominarli è un nome: principi. E, mai come a questo proposito, il nome è la cosa.
Di questi connettivi Rodotà sceglie la solidarietà, il più complesso (a questo proposito il rinvio è all’intervista rilasciata a Roberto Ciccarelli sulle pagine di questo giornale il 4 dicembre). Complesso perché ha una storia particolarmente intrecciata con quella di altri connettivi. Complessa perché matrici diverse la hanno motivata come propria derivazione, connotandola con le relative impronte, intanto che altri connettivi provavano ad assorbirla. Naturalità, moralità, carità, assistenza, beneficenza, fraternità, doverosità, diritto, eguaglianza e gratuità lambiscono, investono, assumono la solidarietà e la interpretano curvandola al loro spirito ed essenza. Ognuna di esse, in verità, ha svolto un ruolo che va riconosciuto almeno come rivelazione della possibilità e della pratica di un’esigenza umana mai del tutto sradicata.
Rodotà ne fa la storia degli ultimi secoli e ne descrive le movenze e i ruoli collaterali che ha svolto e anche le valenze strumentali che ha saputo esprimere. Ma sa distinguere, separare, sa individuare le impronte che possono come assorbirla ed esaurirne — e anche degradarne — l’essenza. Sa, soprattutto, scegliere il fondamento sicuro su cui costruire la solidarietà come principio. È quello del diritto, della norma giuridica. Prosegue così l’alto e nobile insegnamento di quel padre del costituzionalismo che formulava la prima enunciazione dei diritti sociali attribuendo allo stato gli obblighi di offrire a «tutti i cittadini la sussistenza assicurata, il nutrimento, un abbigliamento decente, e un genere di vita che non sia dannoso alla salute», Montesquieu.
La solidarietà è così che si concretizza. Per poter essere principio giuridico, deve poi dispiegarsi in diritti. È il modo in cui si libera dalle tante impronte che la hanno segnata. Da quelle impresse da una incerta naturalità, dalla inerme moralità, dalla doverosità a irritante garanzia della proprietà, dalla evanescente fraternità, a quelle, inesorabilmente mortificanti, della carità, della assistenza e della beneficenza. È il modo in cui si eleva a fonte rivendicativa della dignità umana.
Ma ha di fronte il mondo della globalizzazione. Che è quello del mercato capitalistico, perciò della proprietà privata e del profitto, del trionfo dell’una e dell’altra da trent’anni celebrato senza pause e senza limiti alla devastazione delle conquiste di civiltà che l’idea e le forze della solidarietà avevano raggiunto. È il mondo della barbarie postmoderna.
Rodotà non lo accetta, invita a riflettere sulla tortuosa storia della solidarietà, sulle politiche sociali che furono imposte dalle forze che ne avevano necessità e che ebbero ascolto nelle dottrine giuridiche e politiche che ne reclamarono forme di riconoscimento. Forme diversificate che andavano dal corporativo, al caritatevole, al compassionevole, al mutualismo contadino ed operaio. E che, pur nei limiti e con le torsioni che le caratterizzavano, testimoniano tuttavia una possibilità di affermazione pluralistica del principio. Consentendo in tal modo che per «l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica economica e sociale» dell’articolo 2 della Costituzione, all’insostituibile e prevalente azione istituzionale possano aggiungersi iniziative sociali (volontariato, terzo settore) alla base della forma-stato. A questo proposito, va riconosciuto a Rodotà il merito di proporre un’interpretazione di quest’articolo della Costituzione che, nell’affermare che la Repubblica «richiede» l’adempimento dei doveri della solidarietà, estende al massimo i destinatari della norma, universalizza la sua efficacia.
Affronta la questione del Welfare State, della sua origine e crisi. Ne ricostruisce la molteplicità dei significati, mostra come e perché il Welfare denomina una specifica forma di stato costruendola proprio intorno alla solidarietà. Una forma di stato che, a partire dai principi fondamentali che furono enunciati nei primi articoli della nostra Costituzione e proseguendone il disegno normativo per la forma-stato della contemporaneità, ridefinisce la persona umana come centro di riferimento della solidarietà, sia come titolare del diritto sia come destinatario del dovere di solidarietà. La ridefinisce in termini di cittadinanza tanto comprensiva di diritti integrati l’un l’altro da assicurare il ben-essere, l’autodeterminazione, cioè il potere di crearsi un’esistenza dignitosa, a progettarla come credibile prospettiva, a viverla come effettiva condizione umana.
Ma quando, dove, come? Di cos’altro è indice, in quale contesto la si può concretizzare, con quale altro prodotto storico, per essere stata storicamente determinata, la solidarietà può e deve convivere? Chi può assicurarla nella materialità dei rapporti umani esistenti, chi la può sostenere alla base degli ordinamenti giuridici vigenti, insomma, di quale e quanta forza sociale dispone la solidarietà oggi?
Rodotà non nasconde affatto che il produttore storico della solidarietà, degli istituti che la hanno concretizzata, dei diritti che ha generato, il movimento operaio, insomma, è stato frantumato e che non c’ è più nessuno in grado di contenere e respingere le pretese e l’arbitrio dei costruttori del «nuovo ordinamento normativo governato da un potere sovrano, quello delle grandi società transnazionali che davvero si pongono come il soggetto storico della fase presente». La fase cioè dell’avvento e del consolidamento del dominio globale del capitalismo neoliberista, il nemico storico e strutturale della solidarietà.
Cosa opporgli che sia credibile e perciò consentaneo, collegabile, corrispondente anche nella prospettiva dell’esigenza sempre più pressante dell’universalizzazione della solidarietà? Rodotà non deflette dalla più rigorosa coerenza con le premesse, e le scommesse, da cui parte. Non credendo alla emersione di soggetti storici che possano, nel breve periodo, riprendere con successo la lotta del movimento operaio per la solidarietà, intravede però focolai di resistenza e di contrasto al potere sovrano delle centrali transnazionali del capitalismo neoliberista.
Al sociale frantumato, al politico servente l’economico per aver abdicato a suo favore, il giuridico gli sembra confermarsi come credibile potenziale di produzione della solidarietà. In una sentenza recentissima della Corte di giustizia dell’Ue scorge una sorta di rivendicazione della prevalenza dei diritti fondamentali riconosciuti dalla Carta di Nizza sull’interesse economico di una corporation transnazionale della forza di Google. Attribuisce a questa sentenza l’efficacia costitutiva di «una nuova gerarchia fondata sui principi… espressi dai diritti fondamentali». Come se, per incanto, rovesciando la sua giurisprudenza di favore al principio della concorrenza e a danno dei diritti del lavoro, la Corte di Lussemburgo avesse abrogato quella che Rodotà chiama la «contro costituzione» dell’Ue, fondata sul Fiscal Compact e che, invece, io credo che sia la vera «costituzione» europea. Come se, la stessa Corte, avesse anche espunto dal Trattato sul funzionamento dell’Ue le norme che impongono come vincolo assoluto della dinamica e come fine dell’Unione «l’economia di mercato aperta ed in libera concorrenza». Qui l’amore paterno dell’eccellente ma non solitario legislatore della Carta di Nizza ha fatto aggio sull’acutissimo spirito critico del giurista.
Ma, a riflettere, chissà: questa interpretazione-ricostruzione operata da Rodotà potrebbe anche assumere valore preconizzante di un processo che l’astuzia della storia del diritto futuro, grazie ad una raffinatissima ermeneutica, con tacite abrogazioni e provvide addizioni, consenta che i principi che Rodotà ha ridefinito acquistino effettività giuridica. Sicché da «utopia necessaria» diventi esperienza vivente quella solidarietà che il movimento operaio si inventò e che Rodotà ricorda come rapporto tra eguali e perciò autentica. Affiora così il tema dell’eguaglianza. Quello sul quale chi scrive sta aspettando il maggior defensor dei diritti del nostro tempo.
 «Le idee del rapporto di S
«Le idee del rapporto di S
bilanciamoci! sono il frutto dei calcoli di esperti ed economisti incrociati con le idee delle associazioni che lavorano su alcune grandi questioni aperte sulle quali la politica potrebbe intervenire più e meglio, dall'ambiente, al disagio sociale, all'immigrazione, passando per la cultura». Pagina99.it, 27 novembre 2014
Conti pubblici
La rete di 64 associazioni presenta il suo rapporto 2015. Mantenendo il parametro del pareggio di bilancio e lavorando su fiscalità e tagli alla spesa pubblica sbagliata si troverebbero le risorse per un reddito minimo, la tutela del territorio e risorse per il welfare
Ci risiamo: la discussione sulla legge di stabilità si avvicina – un tempo la chiamavano Finanziaria – e puntuale, come dal 2000 in poi, arriva il rapporto di Sbilanciamoci!, la rete di associazioni, Ong e altre organizzazioni della società civile che ogni anno guarda ai conti dello Stato e cerca di farsi un'idea su come e dove trovare soldi per dare risposte a bisogni diversi dal pareggio di bilancio. Come ogni anno il rapporto è dettagliato, ricco di numeri e attento a individuare la copertura necessaria alle misure proposte.
Le idee del rapporto sono il frutto dei calcoli di esperti ed economisti incrociati con le idee delle associazioni che lavorano su alcune grandi questioni aperte sulle quali la politica potrebbe intervenire più e meglio, dall'ambiente, al disagio sociale, all'immigrazione, passando per la cultura. Il rapporto 2015 contiene 84 proposte e rispetta l'idea del pareggio di bilancio “dimostrando che la quantità delle risorse pubbliche disponibili non è l’unica variabile che condiziona l’impianto della legge di stabilità. Il punto dirimente resta quale modello di economia, di società e di democrazia si ha in mente”, si legge nell'introduzione al rapporto.
Il quadro sociale ed ambientale dell'Italia è quel che è, sostengono le decine di realtà della società civile che danno vita alla campagna e per cercare di invertire la rotta occorre affrontare “i buchi neri del declino del nostro paese: l’economia in declino, un’occupazione in calo e sempre più precaria, un sistema di istruzione e di ricerca pubblico indebolito dai progressivi tagli, un disagio sociale crescente che consegna alla povertà assoluta sei milioni di persone, politiche sociali fragili e sempre più delegate alla famiglia, un patrimonio naturale e culturale in abbandono”. Le associazioni criticano l'austerità imposta dall'Europa alla quale, sostengono, i governi che si sono succeduti negli ultimi anni non hanno saputo opporre nessuna alternativa.
La contromanovra di Sbilanciamoci prevede due assi portanti sul piano delle entrate: una redistribuzione del prelievo fiscale che sposti risorse disponibili dalla ricchezza alla povertà e dai grandi patrimoni e rendite al reddito da lavoro e di impresa; tagli alla spesa pubblica che la campagna chiama “tossica”: meno soldi per Difesa e grandi opere, a sanità e istruzione private per reperire risoprse da impegnare in recupero del territorio, ricerca, istruzione, servizi di welfare.
Di seguito una sintesi delle proposte delle 46 organizzazioni
Riduzione di un punto delle aliquote sui primi due scaglioni, l’aumento di tre punti delle aliquote sul IV e sul V scaglione e la creazione di un VI scaglione, oltre 100mila euro, con aliquota al 50%. Si propone l’aumento di 100 euro delle detrazioni Irpef su redditi da lavoro e pensioni, l’abolizione del regime di tassazione separata per le rendite finanziarie (attualmente al 26%) e della cedolare secca sugli affitti a canone libero (oggi al 21%), con assoggettamento di questi redditi all’Irpef.
Iva: si inverte la tendenza all’aumento, riportando l’aliquota base dal 22% al 21%.
Tassazione del patrimonio: si prevede l’introduzione di un’imposta patrimoniale con aliquote progressive, che nella componente immobiliare operi una redistribuzione a parità di gettito (sostanzialmente esentando i ceti bassi), mentre nella componente finanziaria generi entrate aggiuntive per 4 miliardi (2 dalle famiglie e 2 dalle imprese). La franchigia sulla tassa di successione verrebbe ridotta a 100mila euro con, anche in questo caso, aliquote di tassazione crescenti con la ricchezza. Gli interventi su Irpef e Iva proposti costerebbero rispettivamente 0,9 e 4 miliardi, mentre la tassazione di patrimoni e successioni genererebbe equivalenti entrate aggiuntive.
Altre specifiche misure settoriali genererebbero risorse aggiuntive da impiegare per finanziare la spesa pubblica utile. Tra queste: la tassazione aggiuntiva sui capitali già scudati (5 miliardi), la revoca del condono sui concessionari di videogiochi (2,1 miliardi), il rafforzamento della tassa sulle transazioni finanziarie (0,8 miliardi), la tassazione degli immobili tenuti vuoti (400 milioni), misure di contrasto al canone nero e irregolare (250 milioni), la tassazione dei profitti del settore del lusso (200 milioni) e nocivi, come l’emissione di Co2 delle auto (500 milioni), l’adeguamento dei canoni di concessione per le attività estrattive (205 milioni) e delle acque minerali (250 milioni), le misure fiscali penalizzanti per il rilascio del porto di armi (170 milioni).
Tagli alla spesa
Cancellare gli stanziamenti previsti dalla legge di stabilità 2015 per le scuole private (471,9 milioni) e di sostituire con insegnamenti alternativi l’ora di religione nelle scuole il cui costo è stimato in 1,5 miliardi di euro. La revisione dei criteri di valutazione dei falsi invalidi potrebbe generare un risparmio di 250 milioni.
Si chiedono una riduzione degli stanziamenti per le Grandi infrastrutture strategiche dannose per l’ambiente (1,5 miliardi), l’istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta che esamini lo stato delle convenzioni con le strutture sanitarie private, che generano molti sprechi e abusi (1 miliardo) e l’eliminazione del bonus bebè (202 milioni) a vantaggio della riduzione delle rette per gli asili pubblici.
Si propongono la chiusura dei Cie e dei CARA (191,9 milioni) e la riduzione delle spese militari portando entro il 2016 il livello degli effettivi delle Forze armate a 150.000 unità (400 milioni), eliminando l’ausiliaria per una fascia di ufficiali superiori (440 milioni), azzerando la parte di fondi iscritti al bilancio del ministero per lo Sviluppo Economico a disposizione del Ministero della Difesa per sostenere le industrie a produzione militare per specifici programmi d’armamento (2,2 miliardi). Restano naturalmente le richieste storiche di Sbilanciamoci!: la rinuncia al programma di acquisto degli F-35 (500 milioni) e della seconda serie di sommergibili U-212 (210 milioni) e il ritiro da tutte le missioni a chiara valenza aggressiva (600 milioni).
4 miliardi sono destinati ad un Piano di investimenti pubblici per creare occupazione nel settore dei trasporti ferroviari locali, stabilizzare il personale paramedico precario, assumere figure professionali stabili per combattere gli abbandoni scolastici e mettere in sicurezza il nostro territorio. 900 milioni sono invece destinati a finanziare la ricerca di base e applicata con l’istituzione di un Fondo venture capital “Industrial Compact 2020: industrializzazione della R&S”. Si propone inoltre di attribuire le risorse messe a bilancio per il credito di imposta a favore delle imprese che investono in ricerca ai bilanci degli enti di ricerca pubblici nazionali (costo zero).
Sperimentazione di una misura di reddito minimo garantito
Con 4 miliardi sarebbe possibile garantire 500 euro al mese individuali a circa 764 mila persone che si trovano in condizioni di povertà assoluta, ovvero con una capacità di spesa mensile inferiore a un paniere di beni di “sussistenza” e che sono in cerca di occupazione. Siamo consapevoli che il finanziamento di un vero e proprio reddito di cittadinanza richiederebbe la rivisitazione dell’intero sistema delle politiche del lavoro, sociali e fiscali e un investimento ingente, improbabile nell’attuale contesto economico e politico, ma riteniamo fondamentale l'inizio di una sperimentazione di questo tipo, mancante in Europa, soltanto in Italia e Grecia.
Cultura e conoscenza
Cultura, scuola e università sono state duramente colpite dalla miopia dei tagli lineari degli ultimi anni. Per rafforzare le politiche culturali Sbilanciamoci! propone la costituzione di un fondo rotativo per la ristrutturazione degli spazi di proprietà pubblica da destinare allo svolgimento di attività culturali (20 milioni), misure di sostegno all’accesso alla cultura per studentesse e studenti (20 milioni), l’introduzione di un credito di imposta per le produzioni musicali di artisti emergenti (10 milioni), un’integrazione del Fondo Unico per lo Spettacolo (95 milioni) e del Fondo per le associazioni di promozione cinematografica (300mila euro).
Per migliorare il sistema di istruzione pubblico si propone di varare una piano ventennale per l’edilizia scolastica (1 miliardo per il 2015), di finanziare la legge 440/97 (300 milioni) e garantire il diritto allo studio (300 milioni), di promuovere progetti che favoriscano l’alternanza scuola-lavoro (200 milioni), di costituire un fondo per l’innalzamento dell’obbligo scolastico e per l’integrazione (200 milioni), di finanziare la promozione di progetti studenteschi (10 milioni) e la formazione di docenti curricolari per l’inclusione degli alunni con disabilità (20 milioni). 800 milioni sono destinati a incrementare il Fondo di finanziamento ordinario dell’università e 400 milioni a garantire la copertura totale delle borse di studio.
Case senza persone e persone senza case
Nella legge di stabilità non ci sono risorse per la politica sociale sulla casa. Ma sono circa 700.000 le domande di alloggi popolari non soddisfatte e 70.000 le sentenze di sfratto ogni anno, aumentate a seguito degli effetti della crisi. 30 mila sono gli alloggi di edilizia residenziale pubblica non assegnati perché bisognosi di ristrutturazione. Si propone di investire di più nel recupero di immobili di proprietà pubblica per uso abitativo (1 miliardo) e nel sostegno sociale all'affitto (300 milioni) e di integrare il Fondo per la morosità incolpevole (300 milioni).
Lo sviluppo è verde
Non c’è futuro senza salvaguardia dell’ambiente. Per attuare una strategia per l’adattamento ai cambiamenti climatici e alla manutenzione del territorio servirebbero investimenti per 2 miliardi di euro per i prossimi 20 anni. Recuperando le risorse dal taglio delle grandi opere e dalla tassazione delle attività che danneggiano l’ambiente, Sbilanciamoci! chiede che nella Legge di Stabilità 2015 siano stanziati a questo scopo almeno 500 milioni di euro. Si propone inoltre di integrare il Bilancio del Ministero per l’ambiente di 100 milioni, di costituire un fondo di rotazione per le demolizioni delle opere abusive (150 milioni), di varare un piano nazionale per la mobilità sostenibile (1 miliardo), di promuovere l’installazione di impianti fotovoltaici con accumulo (200 milioni), di tutelare le aree protette (30 milioni).
Spendere di più e meglio per proteggere le persone
I diritti sociali non sono un lusso né una merce. Per contrastare le scelte di privatizzazione in corso da tempo, Sbilanciamoci! propone di integrare il Fondo Nazionale Politiche Sociali (1,164 miliardi) per riportarlo ai livelli del 2008, impiegare le risorse stanziate per il bonus bebè per ridurre le rette degli asili nido pubblici (costo zero), integrare il Fondo per la non autosufficienza (350 milioni) e quello per l’infanzia (15,2 milioni), varare misure per l’invecchiamento attivo (1 milione) e per l’inclusione attiva delle persone con disabilità (50 milioni). L’inserimento sociale dei detenuti potrebbe avvenire a costo zero.
Ridurre i ticket sanitari e rafforzare la medicina territoriale servirebbe 1 miliardo recuperabile rivedendo le convenzioni con le strutture sanitarie private. Per promuovere le politiche di genere sono fondamentali provvedimenti come l’assegno di maternità universale (900 milioni), incentivi nei settori della formazione tecnico-scientifica delle donne (275,1 milioni) e, visto il pericoloso aumento della violenza sulle donne, un finanziamento per nuovi centri anti-violenza (50 milioni).
L’ampliamento degli interventi di inclusione sociale e lavorativa dei cittadini stranieri (60,9 milioni), l’abolizione della tassa di soggiorno (26 milioni), il rafforzamento del sistema nazionale di lotta contro le discriminazioni e il razzismo (30 milioni) e il varo di un piano nazionale di smantellamento dei “campi nomadi” potrebbero arginare, se accompagnati da un rafforzamento delle politiche di welfare generali, l’ondata di razzismo che sta travolgendo di nuovo il nostro paese.
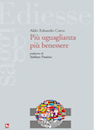 «Per quanto sia importante avere un’occupazione, essa non è tuttavia sufficiente per la realizzazione delle persone; il loro benessere non è favorito se le esigenze produttive impongono condizioni squilibrate di sovraoccupazione che costringono a una «rincorsa permanente» a maggiori consumi o a condizioni di sottoccupazione che deprimono la qualità della vita».
«Per quanto sia importante avere un’occupazione, essa non è tuttavia sufficiente per la realizzazione delle persone; il loro benessere non è favorito se le esigenze produttive impongono condizioni squilibrate di sovraoccupazione che costringono a una «rincorsa permanente» a maggiori consumi o a condizioni di sottoccupazione che deprimono la qualità della vita».
Il manifesto, 28 novembre 2014 (m.p.r.)
Il rapporto tra opportunità di vita e qualità della stessa si presenta contraddittorio fin dagli anni Settanta quando, come ricostruisce Stefano Fassina nella prefazione al libro di Aldo Carra Più uguaglianza, più benessere. Percorsi possibili in tempi di crisi (Ediesse, pp. 156, euro 12), emergono i limiti di uno sviluppo che, pur in forte crescita produttiva, è incapace a rispondere alla domanda di maggiore qualità del lavoro e di estensione del welfare. Il volume sarà presentato oggi a Roma da chi scrive, Stefano Fassina e Norma Rangeri in un incontro con l’autore (appuntamento alle ore 18 alla chiesa valdese, Via Marianna Dionigi 59). Il «ben-essere» (well-being) al quale si riferisce Carra non è la soddisfazione dei soli bisogni personali con beni di mercato, e servizi pubblici, ma anche delle esigenze che attengono alla realizzazione personale e sociale degli individui e, in questo senso, si contrappone al Pil quale misura dei risultati economici di un paese.
Il well-being incontra un limite nel modello produttivo esistente per la subordinazione che impone al lavoro e per le disuguaglianze che genera nella società. Keynes aveva visto giusto nel prevedere l’enorme crescita della produttività del XX secolo, ma non aveva visto giusto nel ritenere che, appagati i bisogni primari, ci sarebbe stato tutto lo spazio per soddisfare le necessità di più alto livello. Le cose non sono andate così; il sistema capitalistico, per non intaccare il suo assetto sociale, ha accompagnato la sua crescita con la trasformazione dei modelli di consumo inducendo i bisogni necessari all’assorbimento dei «suoi» prodotti in un circuito «infernale tra sviluppo che genera bisogni e ricerca di soddisfazione dei bisogni che genera sviluppo».
Una realtà di «minori occupati che lavorano di più» genera una sistematica disuguaglianza che, come esplicita il titolo (Più uguaglianza, più benessere), costituisce un vincolo all’opportunità di scelta della propria vita. Carra parla giustamente, a questo proposito, di «grande inganno» perpetrato da quegli economisti che teorizzano che la disuguaglianza faccia bene; che il mercato premia il merito; che privilegiare l’utilizzo dei pochi che dispongono di maggiori risorse fa «sgocciolare» reddito e opportunità su coloro che non ne sono dotati; che l’esclusione dei molti è giustificata, anzi auspicata per la maggiore «efficienza» dell’economia, dato che i costi sociali e personali dell’esclusione (disoccupazione e precarizzazione) non sono costi economici (da includere nel Pil).
La classe dirigente non riesce solo a creare regole funzionali ai suoi interessi, ma anche a convincere che i rapporti da lei imposti rispondono alle esigenze dei loro subordinati; accettare la «predicazione della disuguaglianza come valore positivo» significa ratificare di fatto la vittoria culturale dell’individualismo, consumismo, liberismo. Si può uscire da questa trappola solo proponendo una politica alternativa che abbia nel lavoro il segno tangibile dell’uguaglianza e della libertà. In questa tensione etico-religiosa – i riferimenti a papa Francesco e al pensiero cattolico e socialista sono frequenti – si colloca la proposta «minimalista» di Carra per «convincerci e convincere» che l’uguaglianza è oggi possibile e necessaria e che per raggiungerla non vi è bisogno di obiettivi radicali di rivolgimento, ma percorsi che la ricostruiscano «a partire da tutti gli aspetti della vita quotidiana delle persone».
La ricerca di Carra si appoggia sulle analisi, e sugli indicatori di Benessere Equo e Sostenibile (Bes), elaborate dalla Commissione Istat-Cnel alla quale ha partecipato come membro. Sulla base dell’architettura del Bes, egli individua gli obiettivi volti a contrastare le molteplici situazioni di disuguaglianze che si presentano nei microcontesti sociali, familiari e culturali della vita quotidiana. I settori del lavoro, del benessere economico, della salute e dell’istruzione sono quelli nei quali più forte è l’incidenza delle disuguaglianze e sono quindi i campi sui quali si concentra la sua attenzione e la sua proposta di microprogetti che viene sviluppata adottando tre chiavi di lettura delle disuguaglianze (di genere, di generazione, territoriali).
Nel libro l’azione pubblica fa riferimento a una testa, a un governo nazionale, che non sembra avere tra i suoi obiettivi quelli auspicati e a gambe, gli enti locali, non sempre dotati di adeguate competenze e volontà (Fabrizio Barca potrebbe meglio qualificare questo aspetto) e tanto meno autonomia finanziaria; non meno secondario è il contesto culturale che falcidia tutte le proposte non conformi all’esistente visione di politica economica. Ma, se non si accetta l’egemonia politica e culturale dominante, come non l’accetta Carra, l’ambizioso progetto del libro richiede di trovare teste e gambe in grado di dare una risposta positiva all’aspirazione di più uguaglianza e più benessere; in sostanza, il nodo è come e dove sono i poteri, le forze (sociali, politiche, di movimento) capaci di mobilitarsi, all’interno di una visione globale, in uno sforzo comune per più uguaglianza e più benessere?
La narrativa controversa come il decennio. «Periodo così cupo e controverso nell’immaginario collettivo, anche il momento di massima applicazione dei principi costituzionali» (Gabriele Vitello, L’album di famiglia. Gli anni di piombo nella narrativa italiana). Il manifesto, 23 novembre 2014
 «L'obiettivo esplicito e perseguito (e purtroppo raggiunto) dal neoliberismo era (è) quello di voler essere non solo una teoria economica ma una autentica antropologia, per la edificazione di un uomo nuovo neoliberista la cui vita fosse (sia) solo economica». Una recensione dell'ultimo libro di Marco Revelli.
«L'obiettivo esplicito e perseguito (e purtroppo raggiunto) dal neoliberismo era (è) quello di voler essere non solo una teoria economica ma una autentica antropologia, per la edificazione di un uomo nuovo neoliberista la cui vita fosse (sia) solo economica». Una recensione dell'ultimo libro di Marco Revelli.
Sbilanciamoci.info, 11 novembre 2014
La curva di Laffer e la curva di Kuznets. Sono questi gli obiettivi centrali dell’analisi di Marco Revelli nel suo ultimo saggio breve sul tema della disuguaglianza, uscito tra gli Idòla di Laterza e che riprende e sviluppa un tema al centro dell’attenzione (Luciano Gallino, Mario Pianta, Joseph Stiglitz e ora anche Thomas Piketty) con un titolo ad effetto ma sempre replicato dalla realtà: La lotta di classe esiste e l’hanno vinta i ricchi. Vero! La curva di Laffer e quella di Kuznets: due favole economiche nate in epoche diverse (la prima, nel 1974 e – secondo una leggenda metropolitana probabilmente falsa ma capace di colpire l’immaginario collettivo - disegnata da Laffer su un tovagliolo di un noto ristorante di Washington; la seconda, risalente invece al 1955), ma usate come armi pesanti nella costruzione e nella propagazione dell’ideologia neoliberista. Ideologia.
Oppure e forse meglio (e oltre Revelli, ma con Foucault) come biopolitica/bioeconomia neoliberale (concetto che preferiamo), posto che l’obiettivo esplicito e perseguito (e purtroppo raggiunto) dal neoliberismo era (è) quello di voler essere non solo una teoria economica ma una autentica antropologia, per la edificazione di un uomo nuovo neoliberista la cui vita fosse solo economica e a mobilitazione incessante e a flessibilità crescente (lavoratore, consumatore, poi imprenditore di se stesso, precario, nodo della rete), uccidendo il vecchio soggetto illuministico titolare di diritti e trasformandolo in oggetto economico, in merce di se stesso, in capitale umano, in nodo di un apparato. Una biopolitica neoliberista che ovviamente si è subito trasformata in tanatopolitica, perché doveva produrre, per raggiungere il proprio scopo la distruzione (appunto la morte) della società e della socialità, della democrazia politica ed economica, facendo della disuguaglianza il suo target da perseguire e dell’impoverimento la sua disciplina (ancora Foucault) capillare. Qualcosa di paradossale e di assolutamente irrazionale (oltre che di anti-moderno) – appunto: la produzione deliberata di disuguaglianza – ma che tuttavia ha conquistato il cuore di troppi economisti e l’opportunismo di troppi politici diventando spirito del tempo ottuso e ostinato ma capace di volare sull’intero globo.
Questa opzione disegualitaria, se non (scrive Revelli) “apertamente anti-egualitaria”, questa ideologia della disuguaglianza necessaria continua infatti ad essere parte integrante o base strutturante di quella “dogmatica neoclassica che ha offerto il proprio hardware all’ideologia neoliberista fin dall’origine della sua lotta per l’egemonia, alla fine degli anni Settanta e per tutto il corso degli anni Ottanta del secolo scorso”. Disuguaglianze crescenti e quindi e conseguentemente lotta di classe vinta dai ricchi contro il resto del mondo. Attraverso i piani diaggiustamento strutturale del Fondo monetario e della Banca mondiale, le politiche di deregolamentazione dei mercati finanziari e del lavoro, la riduzione dei diritti sociali, oggi l’austerità europea e le riforme strutturali di Draghi, di Angela Merkel e di Matteo Renzi (strutturale: una parola magica per una pedagogia finalizzata alla strutturazione e alla costruzione - è una biopolitica e insieme una forma di costruttivismo - della società come mercato).
Quella uguaglianza che era “l’idea regolativa” o la meta da raggiungere nei trenta gloriosi o nell’età dell’oro del secolo breve secondo Hobsbawm, è stata così rovesciata nel perseguimento dell’obiettivo opposto e contrario, quello appunto della disuguaglianza. Una svolta copernicana, scrive Revelli, che ha avuto “come naturale complemento della supply-side economy – e sua copertura morale – la cosiddetta teoria del trickle-down (letteralmente, ‘gocciolamento)”, per cui se si favoriscono i soggetti che trainano lo sviluppo economico - i capitalisti, i grandi investitori, il potere finanziario – si genera spontaneamente un meccanismo virtuoso “il quale crea ricchezza aggiuntiva e in parte la ridistribuisce per una sorta di ‘forza di gravità’ naturale, senza che l’intervento dello Stato giunga a turbare o inceppare il meccanismo”.
Dunque, la curva di Laffer, favola di uno sconosciuto professore di una periferica business school e diventata poi icona della Reaganomics, sulla base di un ipotetico trade-off tra aliquote ed entrate fiscali. E la curva di Kuznets, secondo la quale un accelerato sviluppo economico produce sì, in una prima fase, disuguaglianze crescenti ma solo fino a un punto di svolta, superato il quale il sistema comincia invece a generare uguaglianza. Nata senza pretendere di avere un valore predittivo né prescrittivo, negli anni Settanta ne venne fatto invece un uso ideologico “al fine di neutralizzare le critiche nei confronti degli effetti disegualitari del modello di sviluppo patrocinato dai fautori della supply-side economy e di propagandare le spregiudicate politiche di imposizione del modello neoliberista ai paesi in via di sviluppo, nonostante gli effetti negativi sui loro equilibri sociali”. Una sua variante venne applicata anche ai temi ambientali, dove era l’inquinamento a scendere, dopo una iniziale fase di sua necessaria crescita.
Due curve-icona, due feticci neoliberisti che Revelli smonta – con una lunga sequenza di statistiche e di analisi empiriche e legando il tema dei redditi calanti ai debiti crescenti (soprattutto privati, come modo per disinnescare politicamente e socialmente l’impoverimento prodotto) – dimostrandone l’assoluta falsità. Le disuguaglianze sono cresciute. La crisi prodotta dal neoliberismo resta crisi e anche l’ambiente è messo sempre peggio, come dimostrato dall’ultimo Rapporto dell’Ipcc dell’Onu. Come falsa era la congettura del gocciolamento.
Citando Keynes e la sua metafora delle giraffe dal collo lungo, Revelli conclude che tale teoria ha semmai “giustificato e incentivato la tendenza bulimica dei colli lunghi”. Favorendo appunto l’avidità delle giraffe dai colli lungi, anzi lunghissimi: gli gnomi di Wall Street e i “velieri corsari dei mercati finanziari”, gli uomini di banca, gli hedge-fund, i conti off-shore (e ora potremmo aggiungere Juncker e il suo Lussemburgo-paradiso fiscale). Mentre le giraffe dal collo corto – che deve restare corto o farsi sempre più corto – continuano a generare una ricchezza “che viene sistematicamente risucchiata in alto, nel circuito da loro inattingibile di una finanza onnipervasiva, diventata principio di organizzazione principale dello stesso assetto produttivo globale e, insieme, proprietaria degli ambiti decisionali strategici, a cominciare da quello politico”.
Revelli, da par suo e con il suo stile, smonta dunque il paradigma (l’ideologia o la biopolitica/tanatopolitica) neoliberista. Ma questo paradigma resta saldamente al potere. Smontare il suo hardware è dunque necessario come necessario è non smettere mai di farlo, altrimenti la sua egemonia e il suo dominio resteranno tali per sempre. Senza dimenticare tuttavia di smontare anche il software (il pensiero unico, il senso comune dominante, l’accettazione del principio per cui non ci sarebbero alternative al capitalismo, la falsa individualizzazione offerta dal consumo, la condivisione in rete, i social network) che incessantemente e contro ogni evidenza, lo giustifica e lo legittima.
 Una preziosa iniziativa per la conservazione e lo studio della cultura ambientalistica italiana: un'ampia antologia degli scritti di Giorgio Nebbia, curati da Luigi Piccioni , disponibili per tutti sul sito della Fondazione Luigi Micheletti. Pubblichiamo la presentazione e il sommario dell'opera .
Una preziosa iniziativa per la conservazione e lo studio della cultura ambientalistica italiana: un'ampia antologia degli scritti di Giorgio Nebbia, curati da Luigi Piccioni , disponibili per tutti sul sito della Fondazione Luigi Micheletti. Pubblichiamo la presentazione e il sommario dell'opera .
Altronovecento, n. 26, ottobre 2014
Il “come” e i“perché” di questo libro
di Luigi Piccioni
Nella vasta produzione scientifica e civile di Giorgio Nebbia - nato a Bologna nel 1926, chimico, professore emerito di merceologia all’Università di Bari, ecologista dalla metà degli anni Sessanta e parlamentare dal 1983 al 1992 - gli scritti riguardanti la storia dell’ambiente e dell’ambientalismo occupano un posto di assoluto rilievo. Oltre a nutrire un vivo interesse per il passato, Nebbia è infatti convinto che tutti i fenomeni naturali, sociali e culturali incorporino un'imprescindibile dimensione storica e che ignorando tale dimensione ci si preclude la possibilità di comprenderli. Nebbia ha finito così col costruire dai primi anni Settanta in poi, pezzo dopo pezzo, il più ricco corpus di scritti di storia ambientale realizzato in Italia, contraddistinto da un esemplare equilibrio tra rigore, chiarezza e leggibilità. Un corpus che attende ancora di essere adeguatamente valorizzato dagli storici ma che merita di essere conosciuto e utilizzato ben al di là dei confini accademici tanto più che esso è rivolto anzitutto alla società civile nel senso più ampio.
L’antologia di 434 pagine che costituisce il quaderno n. 4 della rivista telematica “altronovecento” è composta da 54 articoli e saggi scelti tra gli oltre 350 scritti di storia ambientale pubblicati da Nebbia. L’opera è suddivisa in sette sezioni tematiche che comprendono tra l’altro la storia delle merci, dei rifiuti e delle frodi, quella delle neotecniche come la dissalazione e l’energia eolica, l’analisi in chiave ecologica di ampie fasi o di importanti processi storici, la storia dell’ambientalismo e dei suoi protagonisti, i rapporti tra ecologia e marxismo e, ultima ma non meno importante, la problematica della conoscenza storica in sè: archivi, memoria, uso della storia.
L'antologia è introdotta dal curatore dell’'opera, Luigi Piccioni dell’Università della Calabria, che illustra i criteri di scelta e di ordinamento degli scritti e ricostruisce il profilo del Giorgio Nebbia storico dell’ambiente dell’ambientalismo. Alla realizzazione dell’opera hanno contribuito Pier Paolo Poggio e Fabio Ghidini della Fondazione Luigi Micheletti di Brescia.
Il sommario
Il "come" e i "perché" di questo libro (Luigi Piccioni)
Sezione prima. Il racconto di una vita
La natura e le merci nelle ricerche di Giorgio Nebbia. Pier Paolo Poggio intervista Giorgio Nebbia
Sono un nipote di Ciamician anch'io
Mi ricordo di Franco
Sezione seconda. Le merci: produzione, contraffazioni, rifiuti, inquinamento
Tecnica e ambiente dalle origini al Duemila
Le merci della conquista
Piccola storia delle frodi [con Gabriella Menozzi Nebbia]
Breve storia dei rifiuti
Il caso Bossi e la nascita dell'industria chimica a Milano
Il peggiore di tutti
Love Canal: una bomba a orologeria
Sezione terza. Per una storia delle neotecniche
Breve storia della dissalazione [con Gabriella Menozzi Nebbia]
Breve storia dell'energia solare
Sezione quarta. Fasi, processi, eventi storici
Ecologia e comunismo. Ma davvero non avevano capito niente?
Il secolo XX: per una rilettura ecologica
A ottant'anni dal New Deal
L'ingegneria dello sterminio
Hiroshima anni dopo
Bisogno di storia: crescita, declino e resurrezione (?) dell'energia nucleare in Italia
A anni dalla Populorum progressio
Il Settantatre
Seveso, anni fa
Sezione quinta. L'ecologia e l'ecologismo
Breve storia della contestazione ecologica
L'ecologismo americano. I temi fondamentali
I Limiti dello sviluppo in Italia. Cronache di un dibattito -
Risanamento economico-ambientale e lotta allo spreco. Ripensando il 'progetto a medio termine'
Ecologia e ecologismi
Sezione sesta. L'ambientalismo: precursori e maestri, protagonisti, esperienze collettive
George Perkins Marsh. Prevedere e prevenire, un monito disatteso
Vladimir Vernadskij
Alfred Lotka
Lewis Mumford, alla ricerca di una società neotecnica
Rachel Carson e la primavera dell'ecologia
Un pioniere dell'ecologia: Girolamo Azzi
Bertrand Russell 'ecologo'
Bertrand de Jouvenel
Scienza e pace. Linus Pauling nel centenario della nascita
Nicholas Georgescu-Roegen, un economista del dissenso
Kenneth Boulding: un ricordo
Ricordo di Barry Commoner
Mi ricordo di Aurelio
Ricordo di Laura Conti
Laura Conti, un amore per la vita
Ricordo di Antonio Cederna
Dario Paccino, un ecologo inquieto
Ricordo di Fabrizio Giovenale
Ricordo di Alfredo Todisco
25° anniversario di Italia Nostra
Io e CerviaAmbiente
Auguri Legambiente
Sezione settima. La memoria, la storiografia, gli archivi
Per una definizione di storia dell'ambiente
Importanza degli archivi e della memoria
La ricerca storica come condizione imprescindibile per affrontare il problema delle aree industriali inquinate
"Prefazione" a Walter Giuliano, La prima isola dell'arcipelago
"Prefazione" a Edgar Meyer, I pionieri dell'ambiente
"Presentazione" a Marino Ruzzenenti, Un secolo di cloro e … PCB

Il manifesto, 28 marzo 2014
Se per Aristotele la rappresentazione teatrale produce la purificazione liberatrice delle passioni umane più irrazionali e quindi deleterie, tanto che il più grande dei suoi discepoli, Teofrasto, si spinge a definire la tragedia come la messa in scena della «catastrofe di un destino eroico», allora comprendiamo il motivo di fondo che ha spinto Luciano Canfora a riassumere la questione dell’utopia in questi termini: Aristofane contro Platone. Il teatro del primo, insomma, nella fattispecie della commedia «Ecclesiazuse» («Le donne all’assemblea»), come cura catartica rispetto alle passioni utopistiche, e foriere di regimi liberticidi, contenute nell’opera filosofica e politica del secondo.
Esce in questi giorni l’ennesima fatica del noto filologo barese, con il titolo . Aristofane contro Platone (Laterza, pp. 448, euro 18). L’incontro è stata l’occasione per discuterne gli snodi fondamentali.
La «crisi dell’utopia», come già emergeva nelle pieghe del suo libro precedente («Intervista sul potere», Laterza 2013), sembra più una crisi dello studioso Canfora che, da uomo della sinistra radicale, sente ora di dover evidenziare, pur senza il manicheismo di Popper, eccessi e drammi del pensiero utopistico da Platone a Marx. È così?
Ho sempre avversato l’espressione «sinistra radicale»: a) perché radicale è aggettivo comunque connesso alla figura deteriore di Marco Pannella e dei suoi seguaci; b) perché la autocompiaciuta definizione di «sinistra radicale» è appannaggio di esponenti dannunziani come Bertinotti e Vendola; c) sin dal 1976 ho scritto e cercato invano di far pubblicare su «Rinascita» che i comunisti dopo la seconda guerra mondiale sono diventati, con grande merito, i protagonisti principali della lotta per una democrazia progressiva; non potevano, se non riducendosi a macchiette patetiche, pretendere di rimanere le stesse persone che nel 1917–1920 sognarono l’attualità della rivoluzione e furono sconfitti. Il movimento comunista dopo la seconda guerra mondiale è stato la migliore incarnazione della socialdemocrazia: movimento politico fondato da Carlo Marx e Federico Engels. Per chiarezza: il movimento comunista è agli antipodi della nevrosi radicale. Solo nella confusione mentale sessantottesca i due concetti rischiarono di confondersi.
Veniamo al libro, e alla sua riproposizione della vexata quaestio che vede in Aristofane l’aggressore del nucleo concettuale della «Repubblica» platonica.
Nel 220° anniversario della dissertazione del grande, e dimenticatissimo, studioso tedesco Morgenstern, mi è parso giusto riprendere dalle basi una discussione che si trascinava tra alterne vicende. Ho preferito enucleare i due punti cruciali: 1) tutti ammettono coincidenze, anche verbali, tra la commedia aristofanea «Ecclesiazuse» e il quinto libro della «Repubblica»; 2) l’obiezione che rendeva i moderni esitanti o protesi a ricercare spiegazioni assurde consisteva nella cronologia (Aristofane verrebbe prima). In realtà la data dell’«Ecclesiazuse» è più tardiva di quel che si crede e Platone, per parte sua, aveva già diffuso il nucleo del suo pensiero sulla «kallipolis» prima del viaggio in Sicilia (389 a.C.).
Lei parla di uno «scandalo Platone». Il filosofo greco rivoluzionario al punto di proporre quell’emancipazione egualitaria della donna a cui non pervennero neppure Marx ed Engels. Eppure il pensiero femminista non l’ha amato. Ci spiega il suo punto di vista?
Conviene distinguere due piani: da un lato l’effetto di rottura costituito dalla proposta platonica della parità uomo-donna (libro IV della Repubblica), dall’altro il presupposto intrinsecamente «maschile» della formula «comunanza delle donne» (libro V). Questa formula implica chiaramente una visione distorta che finisce con l’equiparare donne e beni materiali come proprietà. Ed è proprio su questo punto debole, contrastante col presupposto della parità, che fa leva efficacemente Aristofane nella commedia «Le donne all’assemblea», soprattutto nel finale. Come mi è accaduto di scrivere, Aristofane fa saltare la Kallipolis platonica, assumendo come punto di forza proprio questa contraddizione. Resta il fatto che l’intuizione della parità è un enorme passo in avanti nei confronti della mentalità greca di età arcaica e classica: la controprova di ciò è nella ostilità dispiegata dai Padri della chiesa cristiana contro Platone, per l’appunto a causa della propugnata idea della parità uomo-donna.
In più punti del suo libro emerge una rivalutazione del cosiddetto socialismo utopistico, a tratti persino dileggiato da Marx ed Engels. Può spiegarci il senso della sua «riscoperta?»
L’espressione socialismo utopistico spetta soprattutto ad Engels, nel troppo celebre opuscolo «Il passaggio del socialismo dall’utopia alla scienza» (consistente nei primi capitoli dell’anti-Dühring). Nel III capitolo del «Manifesto del partito comunista» – nel quale vengono passati in rassegna i socialismi precedenti – vengono collocati sotto una luce negativa sia i passatisti che auspicano un ritorno alle società arcaiche, bollati come «socialismo medievale», sia i socialisti francesi contemporanei protesi alla attuazione di riforme sociali radicali. Come è chiaro si tratta di cose molto diverse, messe tutte insieme e sommariamente definite tutte utopistiche. Oggi constatiamo che il progetto di trasformazione totale dei rapporti di produzione in senso collettivistico è finito su un binario morto e che invece il gradualismo riformistico della socialdemocrazia appare come la sola forma concreta di rinnovamento della società. Di conseguenza i cosiddetti «utopisti» sono diventati i «realisti» e i loro critici «scientifici» sono rifluiti nel grande mare dell’utopia.
Uno dei tratti più storiograficamente azzardati del suo libro consiste nell’istituzione di un nesso fra la coppia Socrate/Platone e Hegel/Marx. Quali i punti di contatto e di difformità da lei evidenziati?
L’analogia tra le due coppie filosofiche è di immediata evidenza. Marx stesso considera il proprio pensiero un capovolgimento materialistico del nucleo originale del pensiero hegeliano. Inoltre, al di là degli elementi biografici, ricordo il tragitto che un tempo veniva sintetizzato nella formula «da Socrate a Platone, dal concetto all’idea» (capovolgimento in senso idealistico del pensiero di Socrate). La difficoltà, semmai, consiste nel fatto che di Socrate, diversamente che di Hegel, non abbiamo l’opera scritta, bensì le molte parafrasi dovute ai suoi allievi. Il più geniale dei quali, cioè Platone, ha escogitato la trovata di mescolare il suo proprio pensiero con quello del maestro (Socrate è persona loquens di tutti i dialoghi, tranne i Nomoi).
Platone rappresenta la ragione utopistica, costantemente alla ricerca del «sogno di una cosa». Aristofane la ragione beffarda, pronta a colpire la prima con le armi del realismo e dell’ironia. Quali, secondo lei, gli esiti di questa dialettica storica?
La vittoria del realismo beffardo nei confronti di ogni genere di proposta innovativa, bollata come utopistica, è fin troppo facile e abbiamo visto nel corso del tempo ripetersi sistematicamente tale scenario. Il realismo beffardo fa capo al senso comune, che talvolta vien voglia di definire «il sesto senso degli idioti».
Introduzione al libro Rottama Italia, inventato e curato da Tomaso Montanari e Sergio Staino, edito e distribuito gratuitamente da Altreconomia. Testi di 16 sapienti autori e 13 graffianti artisti.
Perché vogliamo che l’Italia cambi verso. Ma davvero. Vogliamo un Paese moderno. E cioè un Paese che guardi avanti. Un Paese che sappia distinguere tra cemento e futuro. E scelga il futuro. Vogliamo un Paese in cui chiamiamo sviluppo ciò che coincide con il bene di tutti, e non con l’interesse di pochi. Un Paese in cui lo sviluppo sia ciò che innalza -e non ciò che distrugge- la qualità della nostra vita. Un Paese che cresca, e non un Paese che divori se stesso. Un Paese capace di attuare il progetto della sua Costituzione. Una Costituzione che da troppo tempo “è ancora un programma, un ideale, una speranza, un impegno di lavoro da compiere”, una Costituzione in cui “è scritta a chiare lettere la condanna dell’ordinamento sociale in cui viviamo” (Piero Calamandrei).
Il decreto Sblocca-Italia è, invece, un doppio salto mortale all’indietro. Un terribile ritorno a un passato che speravamo di aver lasciato per sempre. Un passato in cui “sviluppo” era uguale a “cemento”. In cui per “fare” era necessario violare la legge, o aggirarla. In cui i diritti fondamentali delle persone (come la salute) erano considerati ostacoli superabili, e non obiettivi da raggiungere.
Giuseppe Dossetti avrebbe voluto che nella Costituzio- ne ci fosse questo articolo: “La resistenza individuale e collettiva agli atti dei poteri pubblici che violino le libertà fondamentali e i diritti garantiti dalla presente Costituzione è diritto e dovere di ogni cittadino”.
La prima, e più importante, resistenza allo Sblocca Italia passa attraverso la conoscenza, l’informazione, la possibilità di farsi un’opinione e di farla valere. Discutendone nelle piazze e nei teatri, nelle televisioni e alla radio. Richiamando al progetto della Costituzione i nostri rappresentanti in Parlamento. E, se necessario, anche ricorrendo al referendum: se -alla fine e nonostante tutto- questo sciagurato decreto “Rottama-Italia” diventerà legge dello Stato.
Perché non siamo contro lo Sblocca Italia. Siamo per l’Italia.

«Il manifesto, 8 ottobre 2014
Non era mai accaduto prima d’ora che un nutrito gruppo di intellettuali, giuristi, storici dell’arte, economisti e ambientalisti scrivessero un instant book contro un decreto legge del governo. Non sono mancate critiche a ogni provvedimento legislativo, ma arrivare a produrre un organico libro segnala la gravità contenuti nel decreto. Esce oggi un agile volume informatico Rottamitalia edito da Altreconomia, ideato da Sergio Staino e curato da Tomaso Montanari. Il libro si può scaricare sul sito www.altreconomia.it/rottamaitalia e lo potete trovare anche sulla edizione on line de Il Manifesto.
Sono due i motivi che hanno reso possibile il volume. In primo luogo i contenuti che denunciano la gravità della crisi di prospettiva delle classi dirigenti del paese. Sbaglierebbe infatti chiunque pensasse che siamo di fronte al pensiero di Renzi, di Lupi o di qualsiasi altro esponente di secondo piano del governo. Il decreto è stato scritto direttamente dalle lobby che nel sonno della politica, dominano incontrastate il paese.
Gli articoli che liberalizzazino le possibilità di trivellazioni petrolifere in ogni parte del paese sono da anni richieste dai petrolieri.
Le norme che annullano il potere di controllo delle Soprintendenze nella tutela dell’ambiente sono da anni nell’agenda dalla lobby delle grandi opere. Quelle che mettono le basi per una nuova fase di cementificazione delle città sono volute dalla lobby dei proprietari immobiliari. Le norme che facilitano la vendita del patrimonio immobiliare dello Stato sono chieste a gran voce dal mondo finanziario internazionale. E, infine, un intero capo del provvedimento (il quarto) affida il futuro delle opere pubbliche e delle città alla finanza di rapina responsabile della crisi mondiale di questi anni.
La gravità dello «Sblocca Italia» sta dunque in questo quadro generale. Una classe dirigente incapace di fare i conti con il fallimento delle ricette neoliberiste vuole continuare ancora con le stesse politiche distruggendo ulteriormente la struttura dello Stato. Mentre ad esempio la tassazione sulle imprese e sulle famiglie cresce senza sosta, con alcuni articoli si regalano milioni di euro alle grandi imprese che si spartiscono da decenni il sistema delle grandi opere. Sono infatti previsti generosi sconti fiscali per le società concessionarie. Milioni di euro che passano dalle famiglie italiane sempre più impoverite ai soliti noti. Il caso ha voluto che negli stessi giorni in cui Renzi proponeva tali sconcezze, la Corte dei Conti ha accertato che solo nel periodo 2006 – 2010 per la costruzione della linea «C» della metropolitana di Roma, devono essere restituiti 370 milioni ingiustamente guadagnati perché le regole sono state cancellate e non ci sono più strumenti di controllo. Ciononostante continua la rumorosa invettiva contro la «burocrazia» e con lo Sblocca Italia si allentano ulteriormente le regole. Lo stesso Raffaele Cantone, in sede di audizione parlamentare ha dato l’allarme su questo punto.
Ma il libro segnala anche una importante novità: la maturazione di una visione alternativa del futuro dell’Italia che in questi anni si è alimentata nelle tante vertenze territoriali e che è oggi arrivata ad una convincente sintesi. La premessa al libro firmata da Paolo Maddalena, vice presidente emerito della Corte Costituzionale, si intitola «Fuori della Costituzione» e ragiona sul fatto che il decreto è contrario alla carta fondamentale in tutte le norme che affidano il futuro dei territori e delle città ai privati invece e che svendono il patrimonio pubblico.
Nel libro, insomma, si ritrova il filo del ragionamento sulla piena attuazione della Costituzione elaborato da Salvatore Settis nel suo Paesaggio, Costituzione Cemento(2012) e completato sempre da Settis con Maddalena in Costituzione incompiuta(2013, con Leone e Montanari) e poi ulteriormente perfezionato da Maddalena in Il territorio bene comune degli italiani (2014). Il legame con la Costituzione fornisce un’inedita forza unificante alle tante lotte dei comitati che un’accorta propaganda ha bollato come affette da sindrome del nimby e che sono invece l’unico strumento in mano alla popolazione per opporsi ai Rottamatori d’Italia.
«Rottama Italia» nasce da un’idea di Sergio Staino, ed è stato curato da Tomaso Montanari. Hanno partecipato — gratuitamente– al progetto Ellekappa, Altan, Tomaso Montanari, Pietro Raitano, Giannelli, Mauro Biani, Paolo Maddalena, Giovanni Losavio, Massimo Bray, Maramotti, Edoardo Salzano, Bucchi, Paolo Berdini, Vezio De Lucia, Riverso, Salvatore Settis, Beduschi, Vincino, Luca Martinelli, Anna Donati, Franzaroli, Maria Pia Guermandi, Vauro, Pietro Dommarco, Domenico Finiguerra, Giuliano, Anna Maria Bianchi, Antonello Caporale, Staino, Carlo Petrini.
 Di grande attualità il libro
Di grande attualità il libro
I Signori delle autostrade di Giorgio Ragazzi, edizioni Il Mulino, 2008 di cui avevamo già pubblicato alcuni brani all'esordio. Ora riprendiamo la prefazione di Anna Donati.
Questo libro curato dal prof. Giorgio Ragazzi ricostruisce la storia delle concessionarie autostradali dagli anni ’20 ad oggi in Italia. E’ un libro utile perchè mette in luce con rigore e ricchezza di documentazione una storia mai scritta delle regole, dei sussidi, investimenti, tariffe, durata delle concessioni, che hanno determinato il rapporto tra la Stato e le concessionarie autostradali, pubbliche o private che fossero.
Un rapporto che ha subito molte evoluzioni, partendo dalle prime e limitate concessionarie private degli anni ‘20, alla massiccia estensione della rete con le concessionarie pubbliche degli anni ‘60, fino ad arrivare alle privatizzazioni degli anni ’90, del 78% della rete lunga ormai 6840 km. Una ricostruzione che non tralascia i rilevanti ed irrisolti problemi di regolazione oggi più aperti che mai, oggetto di recenti interventi normativi, che alimentano il dibattito politico e le polemiche tra i diversi soggetti in campo e che proseguiranno di certo nei prossimi anni.
Lo studio dimostra che essendo le concessionarie inizialmente prevalentemente pubbliche, dell’IRI o di enti locali, Ministri ed Anas “sono state sempre molto benevoli nel loro confronti, alle spalle degli utenti” perché in fondo si trattava pur sempre di interesse pubblico.
Ma quando arrivano alla fine degli anni ’90 le privatizzazioni questo atteggiamento non cambia, anzi con la vendita della Società Autostrade si innesta una vera e propria “cuccagna” di cui hanno beneficiato anche gli azionisti privati. Scrive Giorgio Ragazzi che è stato «l’obiettivo di massimizzarne il valore che ha indotto alla proroga generalizzata delle concessioni alla fine degli anni 90 ed all’introduzione di un price cap particolarmente favorevole per le concessionarie, per non parlare delle clausole privilegiate inserite nella convenzione di Autostrade».
E’ andata proprio cosi. Il primo Governo Prodi ha intrapreso la strada della privatizzazione per l’urgenza di fare cassa senza adottare preventivamente norme stringenti di regolazione del settore capaci di tutelare in modo adeguato l’interesse generale, per determinare tariffe e profitti delle concessionarie senza essere “catturato” da interessi privati, da interessi locali e da interessi politici.
Per la verità fin dalle nuove norme del 1992, il Cipe ha emanato diverse direttive per costruire un quadro regolatorio del settore, arrivando alla direttiva interministeriale Ciampi-Costa del 1998, che ha fissato regole innovative e stringenti. Regole che poi, come ben ricostruisce il libro, non sono state applicate se non in modo assai elastico e comunque sempre favorevole alle concessionarie autostradali.
Quando cinque anni dopo, alla prima verifica, sono risultati evidenti l’andamento positivo degli utili e degli extraprofitti, gli aumenti tariffari ed i mancati investimenti, invece di riequilibrare e regolare, il Governo Berlusconi ha nuovamente assecondato le concessionarie. E per evitare le esortazioni a cambiare rotta del Nars, dell’Autorità Antitrust e della Corte dei Conti, è stata approvata con legge in Parlamento la nuova Convenzione di Autostrade per l’Italia, con un emendamento del Governo in un decreto legge in scadenza.
Solo nel 2006, su proposta del secondo Governo Prodi, il Parlamento ha approvato nuove norme di regolazione delle concessionarie autostradali che stabilivano che allo scadere dei piani economico-finanziari e comunque entro un anno tutte le convenzioni dovevano essere riscritte per meglio tutelare l’interesse pubblico. Un autentico e positivo cambio di rotta, che però non ha completamente retto all’offensiva delle concessionarie: contestazioni dalla Commissione Europea e delibere Cipe di attuazione che nel giro di sei mesi hanno limitato drasticamente il campo di applicazione solo a nuovi investimenti.
Ma appena insediato, nel giugno 2008, il nuovo Governo Berlusconi ha già annientato questa riforma delle concessionarie autostradali. Con un semplice emendamento ad un Decreto Legge approvato dal Parlamento, ha modificato le norme ed approvato per “legge” tutte le nuove convenzioni già sottoscritte tra Anas e concessionarie. Un’approvazione “per legge” che elimina il parere del Nars, del Cipe e del Parlamento, che avevano osato avanzare obiezioni e richiesto maggiori garanzie e controlli per l’interesse pubblico nelle nuove convenzioni.
Chi trarrà ì maggiori benefici da questa automatica approvazione è certamente Autostrade per l’Italia, la concessionaria che fa capo al gruppo Benetton, che si vedrà riconoscere aumenti tariffari di almeno il 70% dell’inflazione reale, da sommare a parametri di remunerazione degli investimenti, per tutta la durata della concessione fino al 2038.
Via dunque il price cap, la qualità del servizio, la tutela dei consumatori e la realizzazione degli investimenti correlati alla tariffa: una autentica controriforma a solo vantaggio delle concessionarie e che ridimensiona gli strumenti di controllo e regolazione dello Stato nel settore autostradale, già debolissimi.
Ma proprio questo libro dimostra senza equivoci che nuove regole servono e che devono essere applicate con rigore e senza discrezionalità a tutte le concessionarie, così come devono essere fermate le ulteriori proroghe delle concessionarie, in coerenza con le direttive europee, per evitare il perpetuarsi di limitazioni della concorrenza e del mercato. Del resto i tempi lunghi delle durata di molte concessionarie ( la Società Autostrade per l’Italia scade nel 2038) condizionano evidentemente il futuro del settore.
C’è quindi molta strada da fare per passare dal vecchio sistema di concessioni pubbliche ad un nuovo quadro di regole eque e trasparenti tra Stato ed imprese private. Un capitolo di questo volume contiene riflessioni e proposte per il confronto sul futuro delle concessionarie in Italia.
Prima di tutto, dovrebbe essere istituita una Autorità dei Trasporti, prevista ormai da10 anni, per attuare il sistema di regolazione nelle concessionarie ( e non solo quelle autostradali), così come è avvenuto con successo nel campo dell’Energia e delle Comunicazioni. Strumento di regolazione e di tutela degli utenti indispensabile per evitare che la discrezionalità, le pressioni indebite sulla politica o della politica o peggio ancora quelle clientelari abbiano la meglio. E che attui naturalmente gli indirizzi strategici e le regole adottate dalle scelte politiche.
Secondo, va ridefinito il ruolo dell’Anas come soggetto gestore, oggi invece concedente e regolatore, a volte concessionario, a volte in società miste od in competizione con le stesse concessionarie autostradali.
Terzo, bisogna fare una accurata riflessione sul ruolo odierno delle autostrade nel campo della mobilità e dei trasporti, che non possono essere prolungate e raddoppiate all’infinito come i piani delle Concessionarie chiedono costantemente di fare, in un circolo vizioso di nuovi investimenti per ottenere nuove proroghe. Le autostrade nate per la lunga distanza, per accorciare l’Italia, sono oggi diventate le reti per il trasporto quotidiano di breve e media distanza, ma ugualmente si ripropongono grandi autostrade di transito con sistemi chiusi a casello, indifferenti al territorio da servire. Qui serve una forte innovazione di prodotto, con infrastrutture intelligenti, con sistemi aperti e fortemente connessi con la rete locale, con sistemi di pagamento telematici, oggi possibili con le nuove tecnologie.
Quarto, serve riprendere il suggerimento dal Piano Generale dei Trasporti e della Logistica, riproposto anche nel presente volume, di inserire l’uso del pedaggio come uno strumento di politica dei trasporti e di finanziamento delle infrastrutture sostenibili, che implica quindi la necessità di rescindere il legame stringente ed esclusivo oggi esistente tra pedaggi pagati dagli utenti, ricavi delle concessionarie, ed investimenti sulla stessa rete autostradale. Discorso assai complesso e di non facile attuazione ma in fondo l’accantonamento della società Autobrennero per gli investimenti ferroviari o l’applicazione in Italia della direttiva Eurovignette che dovremo adottare entro un anno per la tassazione del traffico pesante, vanno esattamente in questa direzione.
Per queste ragioni il libro di Giorgio Ragazzi è utile, perché anche in questo campo, solo capendo la nostra storia passata e recente, possiamo guardare responsabilmente al futuro.
12 giugno 2008
Segnalazioni
Qui alcune pagine del libro I Signori delle autostrade.
Sulle questioni inerenti le autostrade del decreto Sblocca Italia si vedano su eddiburg:
di Tito Boeri Autostrade e Fondazioni, i due veri poteri forti, di Ivan Berni Le autostrade verso il nulla non sono il futuro, di Giorgio Ragazzi Per le autostrade la fine della concessione non arriva mai Autostrade dalle concessioni infinite, di Sergio Rizzo La lobby delle società autostradali trova lo svincolo per saltare le gare. Nei nostri archivi altri documenti facilmente raggiungibili con il cerca
 Stralci di un intervento del filosofo marxista Cornelius Castoriadis realizzato durante una conversazione con Christopher Lasch e Michael Ignatieff. Comune-info.net, 24 settembre 2014
Stralci di un intervento del filosofo marxista Cornelius Castoriadis realizzato durante una conversazione con Christopher Lasch e Michael Ignatieff. Comune-info.net, 24 settembre 2014
La versione completa la trovate in libreria: La cultura dell’egoismo. L’anima umana sotto il capitalismo (di C. Castoriadis e C. Lasch). Filosofo marxista e psicoanalista di origine greca, Castoriadis (1922-1997) è stato, tra le altre cose, uno dei fondatori in Francia del gruppo e della rivista “Socialisme ou Barbarie” (1949-1965).
( …. ) Penso che la conflittualità sociale e politica sia stata estremamente importante, anche se, contrariamente al luogo comune marxista, la storia della società non è la storia della lotta di classe. Di solito gli schiavi, gli oppressi, i contadini poveri eccetera, sono rimasti al loro posto, hanno accettato lo sfruttamento e l’oppressione, arrivando a benedire gli zar. Ma la caratteristica specifica del nostro mondo, del mondo occidentale, è stata precisamente questa dinamica interna del conflitto, questo mettere costantemente in discussione la società. Il che ha generato quello che definirei il carattere duale delle società occidentali. I marxisti le chiamano società capitaliste. E questo è un aspetto. L’altro aspetto è che esse sono anche società dove, a partire dal XII secolo, le lotte per l’emancipazione, per la democrazia, per la limitazione dei poteri dello Stato eccetera, si sono sedimentate in istituzioni, in tipi antropologici che non coincidono con i sudditi dello zar, o dell’imperatore cinese, o dell’imperatore azteco.
Ci sono dunque stati questi due elementi. Il secondo elemento, ovvero ilconflitto, per gran parte del XIX secolo e fino agli anni Trenta-Quaranta del XX secolo ha assunto la forma dei movimenti operai, ma anche quella della prima ondata del movimento femminista, quella più genuina. Perché il vero femminismo non è Betty Friedan, ma la prima ragazza che, ignorando le obiezioni della sua famiglia, ha avuto il coraggio di iscriversi alla facoltà di medicina e di guardare i corpi nudi di uomini morti. O la prima donna che nel 1808 è entrata a far parte di un sindacato.
Certo, queste donne, per una ragione o per l’altra, hanno mancato l’obiettivo: a causa del totalitarismo bolscevico per un verso e a causa dell’appiattimento della socialdemocrazia al capitalismo per l’altro. Ed è stata proprio questa deriva che ha portato la gente a concludere che non c’è più niente da fare, per cui tanto vale trincerarsi nel privato. Il che, peraltro, corrisponde al movimento intrinseco del capitalismo: espansione dei mercati, società del consumo, obsolescenza programmata eccetera, e più in generale espansione del dominio sulle persone, non solo in quanto produttori, ma anche in quanto consumatori.
( …. )
La libertà nonè qualcosa di facile, non è un concetto semplice. In un certo senso, se parliamo di libertà vera, direi che ci troviamo di fronte a un concetto tragico. Proprio come la democrazia è un regime tragico. Perché non ci sono limiti esterni, non ci sono teoremi matematici che possano dirti: «è qui che bisogna fermarsi». La democrazia è quel regime politico che ci consente di affermare che noi facciamo le nostre leggi a partire dalla nostra morale, la nostra morale condivisa. Questa morale però, e qui mi rivolgo al mio amico cripto-cristiano Christopher, anche se venisse a coincidere con la legge mosaica o con il Vangelo non varrebbe solo perché è scritta lì, ma perché noi, in quanto corpo politico, l’accettiamo, e facendola nostra diciamo: «non uccidere». L’autorità non viene da Dio. Anche se il 90 per cento della popolazione è credente e accetta l’autorità dei comandamenti divini, per la società politica l’autorità non viene da Dio, ma dalla decisione dei cittadini. I cittadini sono dunque sovrani.
Il manifesto, 24 settembre 2014
Un incontro a Pordenonelegge con la studiosa dell'«istituzione famiglia», in Italia per presentare il suo ultimo libro «L'amore a distanza», scritto con il marito Ulrich Beck.
Il suo nuovo libro «L’amore a distanza», scritto con Ulrich Beck, è un’analisi ricca e sfaccettata dello scenario, profondamente cambiato, delle relazioni d’amore nel mondo globalizzato. Esamina le modificazioni che si sono prodotte, i rischi insiti nei differenti codici culturali di cui, il più delle volte, si è ignari, i paradossi e le opportunità inattese che offrono per alimentare la mixofilia, cioè il piacere di incontrare e interagire con chi è diverso da noi. Lei scrive di «famiglie globali». Cosa intende con questa espressione?
Il «quadro drammaticamente diseguale» che menziona è reso con acutezza quando parla dei trapianti di organi dei poveri del mondo in corpi dei ricchi che possono comprarli, in una «moderna forma di simbiosi» in «paesaggi corporei degli individui» dove «si fondono ’razze’, classi, nazioni e religioni», con i «corpi dei ricchi (che) si trasformano in patchwork composti artificialmente, mentre quelli dei poveri diventano magazzini di ricambio». O quando descrive le donne che devono abbandonare i loro figli e mariti per andare in un altro paese per prendersi cura di figli di persone agiate. Come si può immaginare che questo specchio del capitalismo globale possa migliorare il mondo in cui viviamo?
L’Occidente, come è noto, preferisce in prevalenza non vedere le condizioni di povertà, instabilità, tensioni e guerra in cui vivono tantissimi abitanti del pianeta, e mentre, prescindendo dai fascismi che ricominciano a rispuntare in Europa come conseguenza della crisi e del risentimento che suscita, siamo tutti a parole favorevoli all’uguaglianza e all’apertura, continuiamo a costruire fortezze per proteggerci dalle minacce locali (che spesso assumono le sembianze di uno straniero) e rinsaldiamo i confini dei nostri paesi per impedire che «gli altri» vi entrino, o che ne entrino troppi. In realtà, per un verso, mentre si proclama la fine del cosmopolitismo, che si occupa di norme, noi confidiamo nella cosmopolitizzazione, cioè l’interdipendenza non solo economica e politica, ma anche etica tra singoli, gruppi e nazioni, che si occupa di fatti e che si sviluppa dal basso e dall’interno, in ciò che avviene quotidianamente, e che spesso resta inavvertita. Per esempio, le donne che dal Sud del mondo arrivano in Occidente, prendono atto di una tangibile possibilità di vivere il rapporto con l’uomo su un altro piano, molto meno avvilente per loro.
Pare però che l’Occidente, anche nelle relazioni amorose, si stia avvitando su se stesso in una dimensione individualistica che prescinde dalle «persone», dove il verbo «per-sonare» implica il «sonare attraverso» altre persone, intendendo la libertà come un qualcosa che si realizza insieme agli altri, come scrive Magatti nel suo ultimo libro «Generativi di tutto il mondo, unitevi». Jacques Attali nel 2007 ha pubblicato « Amours», in cui esaltava l’amore multiplo, la poliunione, la polifedeltà e immaginava un futuro di relazioni aperte in cui la bisessualità sarebbe la norma, un netloving in cui «personne n’appartiendra à personne». Ma il «nostro» mondo è solo un ottavo del mondo intero, e altrove il desiderio di una famiglia stabile, di un luogo dove sentirsi davvero «a casa» è particolarmente sentito…
Ogni movimento implica una bidirezionalità, e certo le trasformazioni avvengono attraverso un reciproco condizionamento. Il rispetto e l’onore, che governano le transazioni e gli equilibri di tanta parte del Sud del mondo, sono stati smarriti nella sfrenatezza individualistica della nostra civiltà, ma grazie alle nuove rappresentazioni che emergeranno potremo forse tornare a considerarli valori fondanti.
Sono numerosissimi gli esempi letterari che punteggiano la sua ricerca sociologica, etnografica e antropologica. Si impara molto dal romanzo di Mohsin Hamid «Il fondamentalista riluttante», non solo rispetto allo scontro di civiltà e all’«inversione biografica» di cui lei parla nel libro, ma anche rispetto alla relazione del protagonista con la ricca e fragile ragazza americana di cui si innamora. Zygmunt Bauman sostiene nella sua ultima opera «La scienza della libertà» che la letteratura è una sorella della sociologia. Può essere preziosa perché le permette di cogliere quegli elementi dell’esperienza soggettiva che sono costitutivi del nostro essere nel mondo e che finirebbero altrimenti nel dimenticatoio qualora ci si limitasse ad analisi quantitative puntuali quanto aride. È d’accordo con lui?
Certamente. Infatti, fin dal primo capitolo, puntello il mio studio menzionando tre romanzi che sono diventati dei best-seller e che rendono più vivido il mio discorso. Il primo, di Marina Lewycka, che riprendo poi nel quinto capitolo per parlare delle migranti che cercano marito in paesi più fortunati, rende con evidenza sensibile «l’altra faccia della luna» dell’emigrazione femminile, volitiva e rapace, attraverso la storia di una bellissima donna ucraina di 36 anni che sposa un inglese ottantaquattrenne e ricorrendo alle sue affilate armi di seduzione lo spreme come un limone finché il suo patrimonio si esaurisce e con esso finisce anche il matrimonio.
La nostra sfortuna è stata nella coincidenza storica tra due eventi: da un lato, cresceva la consapevolezza della catastrofe planetaria cui lo sviluppo del capitalismo ci stava conducendo; dall'altro, negli stessi l'ideologia e la prassi di quel devastante sviluppo divenivano dominanti. Il manifesto, 21 settembre 2014
Forse il problema non sarebbe stato insormontabile se fosse emerso in un momento storico diverso ma per grande sfortuna di tutti noi, la comunità scientifica è giunta a formulare la sua diagnosi decisiva sulla minaccia climatica proprio nel momento in cui le élite assaporavano un potere politico, culturale e intellettuale senza paragoni se non con i primi anni Venti del ’900. Governi e scienziati, infatti, hanno cominciato a parlare seriamente di tagli drastici alle emissioni di gas serra nel 1988 — proprio l’anno in cui si profilò quella che si sarebbe chiamata «globalizzazione» e l’anno in cui fu firmato il Nafta, l’accordo sulla più grande intesa commerciale del mondo. All’inizio, tra il Canada e gli Stati Uniti, diventato poi, con l’inclusione del Messico, l’accordo Nafta.
Quando gli storici osserveranno in retrospettiva i negoziati internazionali dell’ultimo quarto di secolo vedranno due processi cruciali spiccare sugli altri. Il primo sarà quello del negoziato mondiale sul clima, che procede avanzando a stento, senza mai raggiungere i propri obiettivi. L’altro sarà il processo di globalizzazione delle grandi imprese, che invece avanza spedito di vittoria in vittoria (…).
I tre pilastri su cui si fondano le politiche di questa nuova era li conosciamo bene: privatizzazione della sfera pubblica, deregolamentazione di tutte le attività di impresa e sgravi fiscali alle multinazionali, tutti pagati con tagli alla spesa statale.
Molto è stato scritto sui costi reali di queste politiche: l’instabilità dei mercati finanziari, gli eccessi dei super ricchi, la disperazione di poveri sempre più sfruttati, lo stato fallimentare di infrastrutture e servizi pubblici. Pochissimo, invece, è stato scritto sul modo in cui il fondamentalismo del mercato, sin dai primi momenti, ha sabotato in maniera sistematica la nostra risposta collettiva al cambiamento climatico, una minaccia che si è profilata proprio quando quella ideologia era al suo apice.
Il problema centrale è che l’abbraccio mortale esercitato in questo periodo dalla logica di mercato sulla vita pubblica fa apparire le reazioni più ovvie e dirette alle questioni climatiche come un’eresia politica. Per fare un esempio: come si può investire massicciamente in servizi pubblici e infrastrutture a emissioni zero in un momento in cui la sfera pubblica viene sistematicamente smantellata e svenduta? I governi come possono regolamentare, tassare e penalizzare pesantemente le aziende di combustibili fossili in un momento in cui qualsiasi manovra del genere viene liquidata come un residuo di comunismo autoritario? E, infine, come si può dare sostegno e tutele al settore delle energie rinnovabili per sostituire i combustibili fossili quando «protezionismo» è diventata una parolaccia?
Se fosse stato diverso, il movimento per il clima avrebbe tentato di sfidare l’ideologia estrema che sta ostacolando tante azioni sensate, avrebbe unito le forze con altri settori per dimostrare che il potere delle corporation, lasciato senza freni, rappresenta una grave minaccia per l’abitabilità del pianeta.
Gran parte del movimento per il clima, invece, ha sprecato decenni preziosi nel tentativo di incastrare la chiave quadrata della crisi climatica nella toppa rotonda del «capitalismo deregolamentato», alla ricerca infinita di soluzioni al problema che fossero fornite dal mercato stesso.
 «Riproposta dal Saggiatore
«Riproposta dal Saggiatore
L’immaginazione sociologica del teorico statunitense, assente nelle librerie da decenni. Un libro ancora attuale nella sua capacità di svelare e denunciare i limiti della parcellizzazione nella produzione culturale». Il manifesto, 4 settembre 2014
Tra biografia e storia
L’altro bersaglio polemico è l’empirismo radicale Lazarsfeld, il sociologo austriaco coautore di uno dei più importanti analisi sulla disoccupazione - I disoccupati di Marienthal - e trasferitosi negli Stati Uniti nel 1933, diventando uno delle figure di primo piano della Columbia University (la stessa dove insegnava Wright Mills) e della sociologia americana. Rispetto alla centralità dei fatti e l’irrilevanza della teoria prospettate da Lazarsfeld, Wright Mills sostiene invece che l’«immaginazione sociologica» è indispensabile, perché consente di cogliere sia le tensioni, i sentimenti individuali, mettendoli però in relazione con lo sviluppo storico e le relazioni allargate che accompagnano il suo stare in società: «l’immaginazione sociologica - scrive Wright Mills - ci permette di afferrare la biografia e storia e il loro mutuo rapporto nell’ambito della società». Inoltre, per relazioni sociali lo studioso americano intende anche il ruolo che hanno le divisioni in classe nello vita individuale, la «composizione sociale» delle élite, nonché il tipo di lavoro che i singoli svolgono. Anche in questo caso, l’ironia e il sarcasmo la fanno da padrone, in particolare modo quando il lettore è invitato a svolgere un esperimento mentale per cercare come sia possibile definire la totalità di una realtà sociale, elevando a modello generale ciò che accade in una piccola e provinciale cittadina, presentando come un aggregato statistico di comportamenti, ignorandone storia, stratificazione sociale e «razziale», flussi migratori, il ruolo svolto dalla religione come anche dell’amministrazione politica locale e da quella federale. In altri termini, le «scienze sociali» devono operare affinché il «presente si presenti come storia», evocando il titolo di un testo che Paul Sweezy scrisse per contrastare la normalizzazione della produzione culturale statunitense dopo l’impegno pubblico degli intellettuali a favore delle riforme sociali e politiche proposte durante il New Deal.
Autonomie universitarie
 Un libro su un tema decisivo per comprendere come la città e il territorio possano divenire più belli e più equi:
Un libro su un tema decisivo per comprendere come la città e il territorio possano divenire più belli e più equi:
Senza proprietà non c’è libertà [falso], di Ugo Mattei (Laterza). Il manifesto, 29 agosto 2014
Il neoliberalismo contemporaneo è un grande consumatore di libertà, ricordava Michel Foucault durante quei corsi che, in presa diretta, provavano a capire cosa stava accadendo sul finire degli anni Settanta, quando la crisi del welfare state cominciava ad essere gestita in modo aggressivo da nuovi protagonisti. Consumare libertà significa evidentemente nutrirsene per il proprio funzionamento: ma, allo stesso tempo, controllarla e governarla continuamente, lasciandone ben poca. Nel suo recente «Senza proprietà non c’è libertà» (Falso!), uscito per la collana Idòla di Laterza (pp. 78, euro 9), Ugo Mattei sceglie come obiettivo polemico il dispositivo principale attraverso cui il liberalismo ha reso «consumabile» la libertà: la costruzione storica di un nesso, tanto stretto quanto menzognero, tra libertà e proprietà. Mattei, coi toni martellanti del pamphlet, mostra come, al contrario, la proprietà sia sempre servita a rimettere ordine contro le tentazioni di una libertà eccedente e a distruggere le possibilità di una libertà in comune. La genesi della sovrapposizione tra libertà e proprietà è facilmente rintracciabile nel costituzionalismo liberale «classico». Lo proclamerà sir William Blackstone a chiare lettere nel tardo Settecento: la difesa della libertà coincide senza scarti con la difesa della proprietà privata. Senza proprietà, che è «dominio dispotico» sulle cose, si cadrebbe inevitabilmente sotto il dominio degli altri.
La legge del potere
Era stato John Locke, un secolo prima, a tracciare le linee fondamentali di questo modello. Prima mossa: la proprietà è la vera garanzia della libertà, da cui discende che il vero soggetto libero è quello proprietario. Attorno alla proprietà si costruisce, anzi, la stessa struttura del soggetto. Il soggetto giuridico è libero in quanto proprietario della propria persona e, prima ancora, del proprio lavoro. In secondo luogo, il sovrano è il garante della libertà/proprietà. Lo Stato è uno strumento finalizzato alla tutela del soggetto proprietario: di qui l’asimmetria storica, fortemente sottolineata da Mattei, tra la forte difesa della proprietà privata nei confronti del pubblico e l’assenza di ogni rimedio quando invece è il pubblico stesso a voler privatizzare. Terzo e fondamentale momento: prima ancora della distinzione tra pubblico e privato, tra sovrano e soggetto, interviene un atto di espropriazione, di rottura del comune, costitutivo di quella stessa distinzione. In altri termini: proprietà e sovranità, lungi dall’opporsi l’una all’altra, sono due aspetti della stessa forza appropriativa, della marxiana accumulazione originaria.
Sono i due aspetti, perfettamente simmetrici, della proprietà privante, di cui Mattei segue le tracce: il primo è quello appropriativo, il secondo la capacità di produrre e forgiare il soggetto proprietario. Al di là dei modi attraverso i quali il diritto ha sempre provato a normativizzare e ad addolcire la sua violenza, l’origine della proprietà richiama comunque il saccheggio, il premio promesso ai soldati per la conquista. Mattei presenta alcuni fotogrammi molto vividi di quella che definisce una tassonomia genocida: dalla proprietà fondiaria individuale inglese, la free tenuresignificativamente fatta risalire a Guglielmo il Conquistatore, alla conquista delle Americhe, quando, ricorda Mattei, sulla Santa Maria venne imbarcato un notaio, pronto a certificare l’avvenuto acquisto a titolo originario; sino alla scena delleenclosures, quando Locke, segretario personale di un grande proprietario terriero, santifica giuridicamente l’appropriazione delle terre.
Dopo il saccheggio
In modo molto appassionato, Mattei ci ricorda anche come tutta questa storia sia stata cancellata dall’insegnamento universitario mainstream del diritto, complice la professionalizzazione spinta delle facoltà di giurisprudenza. Accanto all’origine appropriativa e violenta, la proprietà privante però ha anche l’aspetto, apparentemente più soft, della costruzione del soggetto proprietario: è produzione di soggettività, non solo saccheggio e conquista. Ma anche questa seconda faccia mostra quanto sia fallace il binomio proprietà/libertà: il rapporto con la libertà è molto problematico, infatti, non solo per gli esclusi e gli spossessati, ma persino per i proprietari stessi. La proprietà produce assoggettamento per lo stesso proprietario: Mattei ricorda a buona ragione come la promessa del tutti proprietari della propria casa abbia funzionato, all’inizio della crisi, come potente spinta all’indebitamento. Anche qui, non c’è nessun «pubblico» più o meno «buono» che abbia funzionato da protezione contro i meccanismi di spossessamento: semmai invece è proprio «la simbiosi mutualistica tra Stato e proprietà privata», scrive Mattei, a riprodurne continuamente le condizioni.
Oggi che la proprietà si presenta con il suo volto estrattivo al di fuori di qualsiasi mediazione welfaristica, il confronto si sposta necessariamente sul terreno politico costituente: è evidente, e Mattei lo fa emergere in pieno, che riaprire il discorso dei beni comuni, degli usi, della riappropriazione, è possibile solo attraverso istituzioni con capacità generative che si pongano oltre quella polarità pubblico/privato che ha segnato la storia del costituzionalismo. Terreno costituente, ci sembra, non può qui che significare un processo di rottura di quella polarità, e non semplicemente uno spazio «terzo», più o meno equidistante da pubblico e privato. Mattei parla a questo proposito di una proprietà generativa, sottolineando però con forza che si tratta dell’opposto della proprietà quale la conosciamo: da parte nostra, lasceremmo cadere senza nessun rimpianto anche il nome, se non altro per amor di pulizia concettuale. Ma, al di là delle questioni terminologiche, l’importante ora è che la critica della proprietà riesca a porsi all’altezza delle trasformazioni radicali della proprietà stessa.
Le questioni da affrontare
La forza estrattiva della proprietà ha oggi dimensioni quantitative, ma soprattutto qualitative e intensive, nuove: è oggi diventata estrazione di valore dall’intera società, attraverso molteplici e intricate forme di sfruttamento del lavoro e forme di spossessamento delle risorse, cognitive e materiali. In questo quadro, un radicamento reale sul terreno costituente richiede che si affronti direttamente il problema dell’organizzazione politica di queste lotte e della loro connessione più ampia con le lotte del lavoro vivo in tutte le sue forme. Solo se i movimenti dei beni comuni attraverseranno in pieno, come già hanno a tratti mostrato di saper fare, le questioni generali della cooperazione sociale nella metropoli, della crisi del welfare, del reddito, potremo evitare il rischio che la forza antiproprietaria dei beni comuni sia riassorbita in un pacificato commons management, e che l’«oltre il pubblico e il privato» sia catturato dagli infiniti dispositivi di governo pubblico/privato che garantiscono il funzionamento proprio di quel nuovo estrattivismo che intendiamo combattere.
postilla
Il tema, in sostanza, non è quello della proprietà in se, ma quelli di chi si il soggetto proprietario (privato, pubblico, comune, ecc), quale il rapporto tra i diversi soggetti proprietari e, infine, quale quello dei rapporti di questi con i soggetti fruitori, cioè con l'umanità (se vogliamo fermarci al mondo che conosciamo un po' meglio)
A Roma, il 10 ottobre, seminario della sul rapporto tra politiche abitative, rigenerazione urbana e diritto alla città. Qui trovate il programma. Per partecipare è necessario iscriversi.